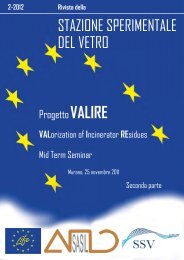luglio-agosto 2012 - Stazione Sperimentale del Vetro
luglio-agosto 2012 - Stazione Sperimentale del Vetro
luglio-agosto 2012 - Stazione Sperimentale del Vetro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RIVISTA <strong>del</strong>la<br />
STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO<br />
<strong>luglio</strong>-<strong>agosto</strong> <strong>2012</strong> - n. 4 vol. 42<br />
sommario<br />
In questo numero ........................................... 2<br />
Riassunti ............................................................... 3<br />
Studi<br />
Nuove<br />
Valutazione<br />
soluzioni<br />
comparativa<br />
per la valorizzazione<br />
<strong>del</strong> rischio occupazionale<br />
di scorie<br />
e<br />
legato<br />
ceneri<br />
all’uso<br />
volanti<br />
di<br />
prodotte<br />
triossido<br />
dagli<br />
arsenico<br />
inceneritori<br />
e dei suoi sostituti<br />
di<br />
nella<br />
rifiuti<br />
produzione<br />
solidi urbani<br />
<strong>del</strong><br />
.....................................................<br />
vetro artistico muranese ............ 5<br />
New<br />
Valentina<br />
solutions<br />
Faggian,<br />
for the<br />
Nicola<br />
valorization<br />
Favaro,<br />
of<br />
Elisa<br />
glassy<br />
Giubilato,<br />
residues<br />
produced<br />
Lisa Pizzol,<br />
by<br />
Petra<br />
municipal<br />
Scanferla,<br />
waste<br />
Antonio<br />
incinerators..........................13<br />
Marcomini<br />
Sandro Hreglich, Roberto Falcone, Antonio Tucci,<br />
Nicola Favaro, Paolo Bertuzzi, Piero Ercole,<br />
Lodovico I risultati Ramon <strong>del</strong> riciclo <strong>del</strong> vetro nel 2011<br />
e le previsioni future..................................................... 15<br />
Sistemi CO.RE.VE. avanzati di recupero termico per forni da vetro.<br />
Sistema ibrido rigenerativo-recuperativo Centauro ..... 18<br />
Alessandro La pratica Mola, chimica Paolo dei vetrai Bortoletto, <strong>del</strong> Rinascimento<br />
Giampaolo Bruno,<br />
Ernesto La preparazione Cattaneo, <strong>del</strong>le Augusto materie Santero prime (I Parte).............. 24<br />
Cesare Moretti<br />
Il Capitolare degli Specchieri <strong>del</strong> 1764 ......................... 26<br />
Paolo Zecchin<br />
Borsa ESG 2014 di Studio<br />
“Giuseppe<br />
12ª Conferenza Europea<br />
Breviari”<br />
<strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
...................................<br />
.............................. 40<br />
38<br />
Innovazioni<br />
Processo innovativo per il riciclo <strong>del</strong> vetro.................... 43<br />
Agenda ................................................................. 40<br />
Associazioni<br />
AIHV ......................................................................... 48<br />
International Commission on Glass... 41<br />
In ricordo di Cesare Moretti ....................................... 55<br />
Glass Trend ................................................................ 56<br />
Dal mondo <strong>del</strong> vetro.................................... 43<br />
a Manifestazioni cura di Elisabetta Barbini ................................................. 60<br />
Agenda ................................................................. 63<br />
Direttore responsabile<br />
Antonio Tucci<br />
Redazione<br />
Elisabetta Erica Ladogana Barbini<br />
email: e-mail: ebarbini@spevetro.it<br />
eladogana@spevetro.it<br />
Impaginazione e grafica<br />
Betti Bertoncello<br />
Direzione e Redazione - Proprietà<br />
<strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Via Briati 10 - 30141 Murano (VE)<br />
Tel.: +39 041 2737011<br />
Fax: +39 041 2737048<br />
email: e-mail: mail@spevetro.it<br />
http:/ / www.spevetro.it<br />
Autorizzazione <strong>del</strong> Tribunale di Venezia n.271 in data 23.01.1971<br />
R.O.C. in data 23.01.1971- 3913 R.O.C. 3913<br />
Rivista Associata alla Unione<br />
Stampa Periodica Italiana<br />
Istruzioni per gli Autori<br />
La Rivista pubblica studi, ricerche ed esperienze sulla<br />
tecnologia e sulla scienza <strong>del</strong> vetro e e dei i materiali ad esso<br />
collegati. Chiunque può mandare elaborati, memorie, ecc. ecc.<br />
La Redazione si riserva o meno la loro pubblicazione.<br />
I testi, corredati da un breve riassunto di circa dieci righe, in<br />
italiano e inglese, dovranno pervenire in forma elettronica<br />
(preferibilmente in Microsoft Word).<br />
Immagini e tabelle dovranno essere in file separati: le<br />
immagini preferibilmente in formato tif o jpg (minimo 300<br />
dpi); le tabelle in Microsoft Excel o Microsoft Word. La<br />
Rivista diventa proprietaria dei lavori pubblicati e questi<br />
non possono essere riprodotti altrove senza autorizzazione.<br />
I testi accettati per la pubblicazione saranno considerati<br />
definitivi. Eventuali sostanziali variazioni dovranno essere<br />
concordati concordate con la Redazione.<br />
La Direzione è estranea alle tesi sostenute nei loro articoli<br />
dai singoli collaboratori. Questi assumono la piena<br />
responsabilità dei loro scritti.<br />
È vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi e <strong>del</strong>le<br />
illustrazioni senza la preventiva autorizzazione <strong>del</strong>la<br />
Redazione.<br />
1
in questo numero<br />
4-<strong>2012</strong><br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
I rivestimenti nanometrici (coating) conferiscono un notevole valore aggiunto al vetro piano utilizzato<br />
in edilizia e in altri settori industriali. Da tempo gli sforzi dei produttori sono indirizzati a migliorare<br />
le Da proprietà questo tecnologiche numero inizia <strong>del</strong> la vetro collaborazione piano per edilizia con per il Consorzio aumentare l’efficienza Recupero <strong>del</strong>le <strong>Vetro</strong> vetrate - COREVE in termini -,<br />
di comfort abitativo e risparmio energetico. Questi miglioramenti tecnologici sono ottenuti attraverso<br />
struttura operante nell’ambito <strong>del</strong> CONAI con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità<br />
l’applicazione di film (o strati) sottili nanometrici (coating) sulla superficie <strong>del</strong> vetro attraverso diverse<br />
<strong>del</strong> recupero e <strong>del</strong> riutilizzo <strong>del</strong> rottame di vetro, considerato ormai la principale materia<br />
tecniche di deposizione.<br />
prima<br />
In questo<br />
nella<br />
primo<br />
produzione<br />
articolo <strong>del</strong>la<br />
di<br />
Rivista<br />
vetro,<br />
(2011):<br />
in particolare<br />
“I fi lm sottili<br />
dei<br />
(coating)<br />
contenitori.<br />
su vetro:<br />
A<br />
caratteristiche,<br />
pag. 15 troverete<br />
materiali<br />
una<br />
e<br />
sintesi metodologie <strong>del</strong>l’ultimo di analisi” rapporto (Daneo, annuale Falcone, Sommariva, con i principali, Vallotto) lusinghieri, a pagina 5, vengono dati <strong>del</strong> descritti 2011. i materiali<br />
utilizzati per i coating, le principali tecniche di deposizione e vengono illustrati i vantaggi e i limiti <strong>del</strong>le<br />
A tecniche completamento analitiche oggi degli maggiormente articoli utilizzate che nei per numeri questo precedenti tipo di indagini. hanno illustrato gli studi<br />
condotti sulle materie prime sostitutive <strong>del</strong>l’arsenico nella produzione di vetro artistico<br />
di Il secondo tipo muranese, articolo a firma presentiamo di Mognato, Barbieri, a pag. 5 Nembro, una indagine Pace: “Una relativa semplice all’Analisi tecnologia per di proteggere Rischio<br />
Comparata, il vetro durante condotta l’attività di in cantiere” collaborazione (pagina 15), con ha il come Consorzio obiettivo Venezia la valutazione Ricerche, <strong>del</strong>l’effetto, tra il triossido in termini<br />
di resistenza, arsenico e <strong>del</strong>la le nuove tecnologia materie proposta, prime utilizzata sostitutive, per rimuovere in rapporto i difetti ai rischi sulla superficie la salute di pannelli umana di<br />
vetro, mediante prove meccaniche. Le prove sono state condotte secondo la norma UNI EN 1288-3:2001<br />
e all’esposizione dei lavoratori.<br />
su pannelli in vetro temprato termicamente e su pannelli di vetro stratificato; i dati ottenuti sono stati<br />
elaborati al fine di valutare la resistenza meccanica <strong>del</strong>le lastre di vetro, dopo trattamento di abrasione e<br />
Il levigatura, dottor Cesare secondo Moretti, la tecnologia da anni proposta attivo da <strong>Vetro</strong>care®. e appassionato collaboratore <strong>del</strong>la nostra Rivista,<br />
ci ha lasciati. Lo ricordiamo a pag. 55 e pubblichiamo la prima parte di uno studio che<br />
ci Nel aveva nostro consegnato consueto spazio pochi storico mesi presentiamo fa, senza l’articolo poterne leggere <strong>del</strong> Prof. le Fiori: bozze; “<strong>Vetro</strong> lo musivo ha riletto <strong>del</strong> VI il dottor secolo<br />
Sandro dagli scavi Hreglich, <strong>del</strong>la Basilica suo principale di San Severo partner a Classe di (Ravenna)”, tante altre ricerche a pagina 22. (pag. 24).<br />
Lo studio di tessere musive provenienti dagli scavi <strong>del</strong>la Basilica di San Severo a Classe ha costituito<br />
Tra l’occasione le Associazioni per un confronto che si fra dedicano le caratteristiche in Italia dei e vetri all’estero musivi allo <strong>del</strong>le studio chiese ravennati e alla promozione e la produzione <strong>del</strong><br />
vetro, vetraria parliamo coeva a Classe, in questo unico numero esempio <strong>del</strong>l’AIHV scoperto di e lavorazione di Glass Trend, di vetro con venuto servizi alla luce rispettivamente<br />
con gli scavi<br />
archeologici nel territorio attorno a Ravenna.<br />
a pag. 48 e a pag. 56.<br />
Nella rubrica “Aggiornamento normativo” (Battaglia, SSV) viene presentata una monografia con<br />
Da<br />
lo scopo<br />
giugno<br />
di riassumere<br />
<strong>2012</strong> la SSV<br />
il contenuto<br />
ha assunto,<br />
<strong>del</strong>la norma<br />
fino a<br />
UNI<br />
settembre<br />
EN 14181:2005<br />
2014, la<br />
“Emissioni<br />
Presidenza<br />
da<br />
<strong>del</strong>l’European<br />
sorgente fissa -<br />
Society Assicurazione of Glass <strong>del</strong>la qualità e organizza di sistemi quindi, misurazione assieme automatici” ad ATIV e il Decreto e all’Università Legislativo n. di 152/06. Parma, A<br />
la pagina 12ª 37 Conferenza il servizio. Europea <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, come dettagliato a pag. 40. È il più importante<br />
appuntamento scientifico internazionale <strong>del</strong> 2014, che si tiene dopo più di vent’anni<br />
nel nostro Paese: è un’occasione di grande rilevanza per offrire alla comunità vetraria<br />
internazionale l’immagine di un settore scientifico, tecnologico e industriale Antonio di prim’ordine. Tucci<br />
Antonio Tucci<br />
2
summaries<br />
riassunti<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
Valutazione comparativa<br />
<strong>del</strong> rischio occupazionale<br />
legato all’uso di triossido<br />
di arsenico e dei suoi<br />
sostituti nella produzione<br />
<strong>del</strong> vetro artistico<br />
muranese<br />
Comparative human<br />
health risk assessment<br />
associated to the use of<br />
arsenic trioxide and its<br />
substitutes in the Murano<br />
glass production<br />
Valentina Faggian, Nicola<br />
Favaro, Elisa Giubilato, Lisa<br />
Pizzol, Petra Scanferla,<br />
Antonio Marcomini<br />
Riv. Staz. Sper. <strong>Vetro</strong> 42<br />
(<strong>2012</strong>), 4, p. 5-14<br />
Il triossido di arsenico, usato come additivo affinante e decolorante nei fusi vetrosi, è classificato<br />
come cancerogeno, mutageno e tossico, e per questo motivo il suo uso potrebbe essere a breve<br />
proibito secondo gli indirizzi <strong>del</strong> recente Regolamento REACH. Dal punto di vista tecnico, l’ossido<br />
di cerio e la loppa d’altoforno sono i candidati più promettenti per la sostituzione <strong>del</strong> triossido di<br />
arsenico. Al fine di valutare se l’uso di questi composti consenta anche di ridurre gli impatti sulla<br />
salute dei lavoratori, si è eseguita un’Analisi di Rischio Comparativa sviluppata attraverso tre fasi:<br />
(1) valutazione dei pericoli per la salute umana connessi all’uso di arsenico triossido o ossido<br />
di cerio e loppa d’altoforno; (2) stima <strong>del</strong>l’esposizione dei lavoratori per inalazione e contatto<br />
dermico alle sostanze di interesse e (3) quantificazione e comparazione dei rischi occupazionali<br />
associati all’uso <strong>del</strong> triossido di arsenico, <strong>del</strong>l’ossido di cerio e <strong>del</strong>la loppa d’altoforno.<br />
Arsenic trioxide, used as additive for refi ning and bleaching melting glass, is classifi ed as a<br />
carcinogenic, mutagenic and toxic substance, therefore its uses could be soon prohibited according<br />
to the recent REACH Regulation. In terms of technical performance, cerium oxide and blast furnace<br />
slag are the most promising candidates for substituting arsenic trioxide. In order to understand if<br />
these substances also allow to reduce occupational health impacts, a Comparative Risk Assessment<br />
was performed, according to the following three phases: (1) assessment of arsenic trioxide health<br />
hazard in comparison with cerium oxide and blast furnace slag; (2) estimation of inhalation and<br />
dermal contact exposure of workers to the substances of interest; (3) quantifi cation of health risks<br />
for glass workers associated to use of arsenic trioxide rather than cerium oxide and blast furnace<br />
slag.<br />
I risultati <strong>del</strong> riciclo<br />
<strong>del</strong> vetro nel 2011<br />
e le previsioni future<br />
The results of recycling<br />
in 2011 and future<br />
projections<br />
CO.RE.VE.<br />
Riv. Staz. Sper. <strong>Vetro</strong> 42<br />
(<strong>2012</strong>), 4, p. 15-23<br />
Il rapporto presenta i risultati sulla quantità di rottame di vetro riciclato nel nostro paese rapportato<br />
all’andamento degli ultimi dieci anni. Con l’aiuto di numerose tabelle, vengono forniti dettagli sul<br />
tasso di riciclo, sulle percentuali di vetro smaltito, sull’andamento <strong>del</strong>le quantità di raccolta dei<br />
rifiuti in vetro, per sistema di recupero e distribuzione geografica. Sono infine illustrati i benefici<br />
ambientali derivanti dal riciclo <strong>del</strong> vetro nel 2011, sia come risparmi energetici diretti e indiretti,<br />
sia come minor consumo di materie prime, sia come riduzione di CO 2<br />
. Gli obiettivi raggiunti sono<br />
stati ampiamente superiori rispetto a quanto fissato dal D.Lvo 152/2006.<br />
The report presents the results on the amount of recycled cullet in our country compared to the<br />
trend of the last ten years. With the help of several tables, many details on the recycling rate, on the<br />
percentage of disposed glass, on the trend of cullet collection according to the method of collection<br />
or to the geographical distribution are provided. Finally, the environmental benefi ts, deriving from<br />
recycling glass in 2011 both as direct and indirect energy savings and as lower consumption of<br />
raw materials or as a CO 2<br />
reduction are described. Achievements are far higher than the ones set<br />
by the D.Lvo 152/2006.<br />
3
4-<strong>2012</strong><br />
summaries<br />
riassunti<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
La pratica chimica dei<br />
vetrai <strong>del</strong> Rinascimento.<br />
La preparazione <strong>del</strong>le<br />
materie prime (I parte)<br />
The chemical practice<br />
of glassmakers in<br />
Renaissance recipe<br />
manuscripts.<br />
The dressing and<br />
treatment of raw<br />
materials (Part 1)<br />
Cesare Moretti<br />
Riv. Staz. Sper. <strong>Vetro</strong> 42<br />
(<strong>2012</strong>), 4, p. 24-39<br />
Nella maggior parte dei manoscritti di ricette vetrarie, un certo numero di capitoli è dedicato<br />
alla preparazione <strong>del</strong>le materie prime da utilizzare nelle composizioni vetrificabili per ottenere i<br />
diversi tipi di vetro. Si è ritenuto interessante, non solo dal punto di vista vetrario ma anche da<br />
quello più generale <strong>del</strong>la storia <strong>del</strong>la chimica, analizzare e interpretare queste istruzioni. I ricettari<br />
esaminati coprono un arco di tempo dal XIV al XVII secolo, a cominciare dai Trattatelli Toscani,<br />
dal manoscritto di Montpellier e dal Ricettario Anonimo, per arrivare al testo di Antonio Neri e ai<br />
manoscritti di Giovanni Darduin e Gasparo Brunoro.<br />
In questa prima parte vengono sintetizzati e commentati i vari procedimenti citati nei ricettari,<br />
mentre nella seconda parte che seguirà verranno trascritti i testi estrapolati dai ricettari.<br />
In most of glass recipe notebooks a number of chapters deal with the preparation of raw materials<br />
to be used in the vitrifi able batch. It is interesting to analyze these treatments not only from the point<br />
of view of glass technology, but also for the history of ancient chemistry.<br />
The chapters regarding the preparation or treatment of raw materials are selected from the<br />
manuscripts and notebooks dating from 14th to 17th centuries and arranged into a list according<br />
to the material involved. The sources are the three parts of Trattatelli Toscani, the Montpellier<br />
manuscript, the Anonymous 16th century manuscript, the Antonio Neri book, the Giovanni Darduin<br />
notebook and the Gasparo Brunoro notebook.<br />
In this Part 1 all the procedures found in the recipe books are synthesized and commented, grouped<br />
per material treated. In the successive Part 2 we will transcribe the texts extrapolated from the<br />
manuscripts.<br />
4
studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
Valutazione comparativa <strong>del</strong> rischio occupazionale<br />
legato all’uso di triossido di arsenico e dei suoi sostituti<br />
nella produzione <strong>del</strong> vetro artistico muranese<br />
Valentina Faggian, Nicola Favaro, Elisa Giubilato, Lisa Pizzol, Petra Scanferla, Antonio Marcomini<br />
1. Introduzione<br />
L’arte <strong>del</strong> vetro di Murano rappresenta un’unicità<br />
nel mondo e questa produzione si colloca da secoli<br />
sull’isola veneziana di Murano, dove si è stabilita<br />
con le caratteristiche di un vero e proprio distretto<br />
industriale. Sebbene questa realtà sia per lo più artigianale,<br />
cioè composta di piccole e micro-imprese,<br />
anch’essa è stata interessata dal recente Regolamento<br />
Europeo REACH [1], che disciplina l’utilizzo<br />
<strong>del</strong>le sostanze chimiche durante tutto il loro ciclo di<br />
vita, al fine di tutelare la salute <strong>del</strong>l’uomo e <strong>del</strong>l’ambiente,<br />
spingendo l’industria europea a sostituire le<br />
sostanze che destano maggiori preoccupazioni con<br />
sostanze meno pericolose.<br />
Tra le molteplici sostanze chimiche che si utilizzano<br />
nella produzione <strong>del</strong> vetro artistico, troviamo<br />
il triossido di arsenico (As 2<br />
O 3<br />
), il quale, introdotto<br />
nella miscela vetrificabile in quantità variabili<br />
da 1 a 1,5 Kg per 100 Kg di sabbia [2], funge da<br />
additivo affinante e ossidante. Il triossido di arsenico<br />
è una sostanza riconosciuta come cancerogena<br />
per inalazione ed ingestione e tossica per tutte<br />
le vie di esposizione; esso diventa particolarmente<br />
pericoloso, nel comparto occupazionale <strong>del</strong> vetro,<br />
quando viene manipolato in forma di polvere fine<br />
durante la preparazione <strong>del</strong>la miscela vetrificabile e,<br />
alla temperatura di fusione <strong>del</strong> vetro, come sostanza<br />
volatile durante la lavorazione <strong>del</strong> fuso di vetro in<br />
fornace. Per queste sue caratteristiche l’As 2<br />
O 3<br />
è stato<br />
identificato dall’Agenzia Europea per le Sostanze<br />
Chimiche (ECHA) come “sostanza estremamente<br />
preoccupante” (Substances of Very High Concern -<br />
SVHC), per la quale, a breve, potrebbe entrare in<br />
vigore il divieto di utilizzo laddove l’uso non sia<br />
specificatamente autorizzato.<br />
Per tutti questi motivi la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong><br />
<strong>Vetro</strong> (SSV), già da alcuni anni, ha dato avvio ad<br />
una collaborazione con gli artigiani muranesi per<br />
testare miscele alternative che utilizzano diversi additivi<br />
in sostituzione <strong>del</strong> As 2<br />
O 3<br />
, ancor oggi utilizzato<br />
in quantità rilevanti (nel 2008 si è registrato un<br />
utilizzo di circa 8 tonnellate). Per valutare le possibili<br />
alternative disponibili è stato promosso dalla<br />
<strong>Stazione</strong> sperimentale <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> un progetto di ricerca<br />
industriale dal titolo “Eliminazione dei composti<br />
<strong>del</strong>l’arsenico dalla miscela vetrificabile nelle produzioni<br />
artistiche muranesi e sostituzione con materie<br />
prime alternative non pericolose”. I risultati ottenuti<br />
dalla ricerca hanno dimostrano che i migliori sostituti<br />
sono il diossido di cerio (CeO 2<br />
) e la loppa d’altoforno.<br />
Nell’ambito di tale progetto, è stata predisposta una<br />
specifica linea di ricerca, i cui principali risultati<br />
vengono riportati nel presente articolo, che riguarda<br />
lo sviluppo di una analisi di rischio sanitario-ambientale,<br />
atta a comparare i rischi associati all’utilizzo<br />
odierno <strong>del</strong>l’ossido arsenioso rispetto alle altre<br />
sostanze sostitutive.<br />
Tale analisi si è sviluppata attraverso: (1) la valutazione<br />
e comparazione dei pericoli per la salute umana<br />
connessi all’uso <strong>del</strong> As 2<br />
O 3<br />
, <strong>del</strong> CeO 2<br />
e <strong>del</strong>la loppa<br />
d’altoforno; (2) lo sviluppo, per tutte le fasi di produzione<br />
<strong>del</strong> vetro, degli scenari di esposizione occupazionale;<br />
(3) la determinazione <strong>del</strong>l’esposizione<br />
a triossido di arsenico e ai sostituti identificati dalla<br />
SSV attraverso l’applicazione di tre diversi mo<strong>del</strong>li<br />
di stima <strong>del</strong>l’esposizione occupazionale (ECETOC<br />
TRA worker, MEASE e ART); (4) la stima e il confronto<br />
<strong>del</strong> rischio per la salute umana dei lavoratori<br />
<strong>del</strong> comparto associato all’esposizione alle sostanze<br />
di interesse.<br />
5
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
2. Materiali e metodi<br />
Per valutare se le sostanze sostitutive presentano un<br />
minore impatto sulla salute umana rispetto al composti<br />
<strong>del</strong>l’arsenico la procedura utilizzata ha previsto<br />
le seguenti attività: l’identificazione di tutte le<br />
fasi <strong>del</strong> ciclo di vita dei prodotti-sistemi indagati, lo<br />
sviluppo dei diagrammi di esposizione occupazionale<br />
e di descrizione degli scenari di esposizione,<br />
la raccolta dei dati di input utili alla stima <strong>del</strong>l’esposizione,<br />
l’identificazione <strong>del</strong> pericolo associato a<br />
ciascuna sostanza analizzata attraverso la scelta dei<br />
valori tossicologici di dose-risposta, la stima <strong>del</strong>l’esposizione<br />
attraverso l’applicazione dei mo<strong>del</strong>li di<br />
esposizione e infine la caratterizzazione <strong>del</strong> rischio.<br />
In Fig. 1 si riporta lo schema concettuale seguito nel<br />
corso <strong>del</strong>la presente ricerca.<br />
2.1. Identificazione <strong>del</strong>le fasi pericolose <strong>del</strong><br />
processo produttivo<br />
Il processo produttivo <strong>del</strong>le vetrerie muranesi può<br />
essere suddiviso in sette fasi principali seguite da<br />
ogni vetreria, comprendenti ciascuna alcune sottofasi,<br />
che possono invece essere diverse a seconda<br />
<strong>del</strong>la tipologia di prodotto lavorato nelle varie vetrerie.<br />
Uno schema-tipo <strong>del</strong> processo produttivo è<br />
presentato in Fig. 2, dove le fasi che potenzialmente<br />
possono causare un’esposizione ai composti <strong>del</strong>l’arsenico<br />
e ad altre sostanze chimiche da parte <strong>del</strong>l’uomo<br />
sono evidenziate con dei riquadri tratteggiati.<br />
Le sotto-fasi di produzione <strong>del</strong> vetro selezionate<br />
come potenzialmente pericolose sono: il trasporto/<br />
pesatura e la miscelazione <strong>del</strong>le sostanze da parte<br />
<strong>del</strong> composizioniere, la carica in fornace da parte<br />
<strong>del</strong> sottofonditore, la fusione/affinaggio <strong>del</strong>la miscela<br />
vetrificabile da parte <strong>del</strong> fonditore e la lavorazione<br />
di piazza da parte <strong>del</strong> levante e <strong>del</strong> maestro,<br />
infine la molatura eseguita sul vetro formato e raffreddato<br />
nel reparto moleria.<br />
Figura 1 - Schema concettuale di sviluppo <strong>del</strong>la linea di ricerca<br />
6
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
Ricevimento<br />
FASE 1<br />
Magazzino<br />
materie prime<br />
Pesatura<br />
macroingredienti<br />
Pesatura<br />
microingredienti<br />
Omogeneizzazione<br />
cariche<br />
FASE 2<br />
ESPOSIZIONE<br />
POTENZIALE<br />
A POLVERI E<br />
VAPORI<br />
Carica forni<br />
fusori<br />
Affinaggio<br />
Manutenzione<br />
forni<br />
Riposo<br />
Forni di<br />
traghettamento<br />
FASE 3<br />
Trattamento<br />
stampi<br />
Lavoro di<br />
piazza<br />
Raffreddamento<br />
stampi<br />
FASE 4<br />
Trattamenti<br />
all’ iride<br />
Trattamenti<br />
termici<br />
Taglio e<br />
Arrotatura<br />
Linee di<br />
scavo<br />
FASE 5<br />
ESPOSIZIONE<br />
POTENZIALE<br />
AD AEROSOL<br />
Taglio con<br />
fiamma<br />
Verniciatura<br />
Lucidatura<br />
Sabbiatura<br />
Satinatura<br />
(Acidatura)<br />
FASE 6<br />
Stoccaggio<br />
Reparto<br />
imballaggio<br />
Spedizione<br />
pontile di carico<br />
FASE 7<br />
Figura 2 - Schema <strong>del</strong>le fasi principali di lavorazione <strong>del</strong> vetro di Murano<br />
2.2. Definizione degli scenari di esposizione<br />
Sulla base <strong>del</strong>le 6 fasi di produzione <strong>del</strong> vetro selezionate<br />
come potenzialmente pericolose e individuate<br />
dallo schema di produzione <strong>del</strong> vetro di Fig. 2, sono<br />
stati sviluppati gli scenari di esposizione schematizzati<br />
nei diagrammi di esposizione riportati in Fig. 3.<br />
Dall’analisi dei diagrammi di esposizione si evince<br />
che le modalità di assunzione principali per i lavoratori<br />
sono l’inalazione di polveri, vapori o aerosol<br />
e il contatto dermico. In mancanza di dati sperimentali<br />
di monitoraggio, per riuscire a stimare l’esposizione<br />
associata alle diverse vie di esposizione è<br />
necessario applicare dei mo<strong>del</strong>li predittivi. I mo<strong>del</strong>li<br />
di stima <strong>del</strong>l’esposizione utilizzati nel presente studio<br />
verranno descritti nel paragrafo 2.5.<br />
Nel presente studio si è deciso di stimare l’esposizione<br />
per ognuna <strong>del</strong>le 6 fasi individuate come<br />
potenzialmente pericolose ipotizzando in un caso<br />
la totale mancanza di sistemi di prevenzione e protezione<br />
(“Scenario senza Misure di Prevenzione e<br />
Protezione”, NoMPP), nell’altro, al contrario, considerando<br />
l’utilizzo <strong>del</strong>le misure di prevenzione e<br />
protezione (“Scenario con Misure di Prevenzione e<br />
Protezione”, MPP).<br />
Lo scenario NoMPP è lo scenario che <strong>del</strong>inea l’ipotesi<br />
peggiore di esposizione alle sostanze oggetto<br />
<strong>del</strong> presente studio, in quanto esso non prende<br />
in considerazione né i dispositivi di protezione individuale,<br />
né le misure di prevenzione <strong>del</strong> rischio.<br />
Viceversa, lo scenario con MPP <strong>del</strong>inea l’ipotesi di<br />
7
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Figura 3 - Diagrammi di esposizione per le diverse sorgenti identifi cate<br />
esposizione in condizioni di sicurezza alle sostanze<br />
oggetto <strong>del</strong> presente studio, in quanto esso prende<br />
in considerazione i dispositivi di protezione individuale<br />
e le misure preventive di gestione <strong>del</strong> rischio<br />
previste per legge.<br />
2.3. Raccolta dei dati di input per ogni fase e<br />
scenario considerato<br />
Per ogni fase <strong>del</strong> processo produttivo e in base allo<br />
scenario analizzato sono stati raccolti i dati di input<br />
da utilizzare per implementare i mo<strong>del</strong>li per la stima<br />
<strong>del</strong>l’esposizione. Le determinanti richieste variano<br />
in base al mo<strong>del</strong>lo preso in considerazione, principalmente<br />
sulla base <strong>del</strong> dettaglio richiesto.<br />
La raccolta dei dati è stata eseguita a partire dalla<br />
consultazione di materiale di letteratura, ed è proseguita<br />
attraverso alcune visite presso una vetreria di<br />
Murano e la richiesta di dati alla SSV.<br />
2.4. Identificazione <strong>del</strong> pericolo associato a<br />
ciascuna sostanza analizzata (scelta dei valori<br />
tossicologici di dose-risposta)<br />
Come indicato dalla guida ECHA (2010) al capitolo<br />
R.8, il parametro tossicologico DNEL, Derived No<br />
Effect Level viene definito come “il livello di esposizione<br />
al di sopra <strong>del</strong> quale l’uomo non dovrebbe<br />
essere esposto” [3] ed è considerato il parametro<br />
dose-risposta di riferimento per la caratterizzazione<br />
<strong>del</strong> rischio.<br />
La derivazione di un DNEL è però alquanto complessa,<br />
soprattutto quando deve essere derivato da<br />
descrittori di dose (principalmente NOAEL o LOAEL)<br />
prodotti da studi su animali e/o per vie di esposizione<br />
differenti da quella di interesse.<br />
Alla luce di quanto affermato, nel caso in esame si<br />
è deciso di utilizzare il valore di DNEL quando è<br />
stato possibile ricavarlo dalla letteratura o derivarlo<br />
8
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
La stima per l’esposizione per inalazione viene<br />
calcolata automaticamente in termini di mg/m 3 per<br />
giornata lavorativa, cioè viene espressa come media<br />
ponderata sulle 8 ore di un turno completo di lavoro.<br />
La stima per contatto dermico è espressa come<br />
carico totale <strong>del</strong>la sostanza chimica assorbito dalla<br />
pelle durante un turno di lavoro (si ipotizza che la<br />
deposizione sia uniforme e che l’assorbimento sia il<br />
100%) e viene riportata come massa per chilogramseguendo<br />
le linee guida fornite dall’ECHA, mentre<br />
è stato utilizzato un valore limite occupazionale<br />
(Occupational Exposure Limit, OEL) se non<br />
era possibile ricavare tale valore. A tal proposito,<br />
per il diossido di cerio è stato utilizzato il valore<br />
di DNEL pubblicato sul sito ECHA nella sezione<br />
ECHA CHEM [4], mentre per il triossido di arsenico<br />
è stato utilizzato un OEL, definito Valore limite<br />
di soglia o ponderale - media ponderata nel tempo<br />
(Threshold limit value - Time weighted average,<br />
TLV - TWA) che è valido esclusivamente per l’esposizione<br />
per inalazione e che viene pubblicato<br />
con cadenza annuale dall’American Conference of<br />
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) degli<br />
Stati Uniti d’America. Per quanto concerne il valore<br />
di TLV utilizzato come limite per l’esposizione<br />
per inalazione a triossido di arsenico, esso è ricavato<br />
per l’ambito occupazionale, per la via di esposizione<br />
inalatoria e per una durata di esposizione cronica.<br />
Per l’esposizione per contatto dermico si sono utilizzati,<br />
per entrambe le sostanze, valori di DNEL.<br />
In particolare, per il diossido di cerio tale valore è<br />
pubblicato sul sito <strong>del</strong>l’ECHA nella sezione ECHA<br />
CHEM, mentre per il triossido di arsenico è stato<br />
derivato nel corso <strong>del</strong> presente studio da un valore<br />
di LOAEL ricavato dallo studio effettuato dal Bio<br />
Research Laboratories (1994) [5] seguendo le linee<br />
guida riportate nel capitolo R.8 <strong>del</strong>la guida ECHA e<br />
attraverso la collaborazione di un tossicologo.<br />
Da sottolineare che, per quanto concerne la via di<br />
esposizione per inalazione, si è scelto di analizzare<br />
esclusivamente il rischio legato agli effetti non cancerogeni<br />
derivanti da esposizione cronica, sebbene<br />
il triossido di arsenico non sia solamente molto tossico,<br />
ma anche cancerogeno per inalazione tanto da<br />
essere classificato in classe 1 secondo IARC [6;7]<br />
e in classe A dall’agenzia americana EPA [8]. Tale<br />
scelta è legata al fatto che non si ritiene significativo,<br />
in sede di analisi di rischio comparativa, confrontare<br />
le due sostanze per gli effetti cancerogeni, vista<br />
la natura non cancerogena, genotossica o mutagena<br />
<strong>del</strong> diossido di cerio [9].<br />
Sulla base di quanto esposto sopra, quando si farà<br />
riferimento alla via di esposizione per inalazione<br />
saranno considerati esclusivamente gli effetti non<br />
cancerogeni derivanti da esposizione cronica alle<br />
sostanze di interesse.<br />
Anche per la via di esposizione dermica si sono considerati<br />
solo gli effetti non cancerogeni derivanti da<br />
esposizione cronica. In questo caso però entrambe<br />
le sostanze non hanno natura cancerogena [9;10].<br />
2.5. Stima <strong>del</strong>l’esposizione<br />
Tra i mo<strong>del</strong>li per la stima <strong>del</strong>l’esposizione riconosciuti<br />
dalle linee guida europee, ne esistono diversi<br />
che potrebbero essere utilizzati per la valutazione<br />
<strong>del</strong>l’esposizione alle sostanze di interesse, ma nel<br />
presente caso di studio ne sono stati selezionati tre<br />
in base alle loro caratteristiche e in base ai requisiti<br />
richiesti per implementarli. Essi sono: ECETOC<br />
Targeted Risk Assessment Tool for worker (ECE-<br />
TOC TRA worker) [11;12], Metals’Estimation and<br />
Assessment of Substance Exposure (MEASE) [13]<br />
e Advanced Reach Tool (ART) [14]. L’ECETOC<br />
TRA worker e il MEASE sono mo<strong>del</strong>li di screening<br />
(cosiddetti “Tier 1”, ovvero Livello 1) che permettono<br />
di ottenere <strong>del</strong>le simulazioni cautelative a fronte<br />
<strong>del</strong>l’introduzione di dati di input generici e facilmente<br />
reperibili. I mo<strong>del</strong>li di esposizione di dettaglio<br />
(i cosiddetti mo<strong>del</strong>li “Tier 2”), come l’ART,<br />
permettono invece l’inserimento e l’analisi di informazioni<br />
sito-specifiche che consentono di ridurre<br />
l’incertezza associata alle stime di esposizione e, di<br />
conseguenza, di arrivare ad una stima <strong>del</strong> rischio più<br />
legata alle situazioni reali di utilizzo <strong>del</strong>le sostanze<br />
in esame. È bene tuttavia sottolineare che il mo<strong>del</strong>lo<br />
ART ha una limitazione importante per il caso in<br />
esame, in quanto non può valutare processi condotti<br />
ad alte temperature (quali quelli in fase di fusione e<br />
lavorazione di piazza).<br />
I mo<strong>del</strong>li selezionati prevedono l’inserimento dei<br />
dati di input per i parametri di interesse (vedi par.<br />
2.3) all’interno di apposite maschere e al termine<br />
<strong>del</strong> processo ciascun mo<strong>del</strong>lo fornisce in automatico<br />
la stima <strong>del</strong>l’esposizione.<br />
9
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
mo di peso corporeo per giornata lavorativa (mg/<br />
(kg bw<br />
*day).<br />
2.6. Caratterizzazione <strong>del</strong> rischio<br />
La caratterizzazione <strong>del</strong> rischio è l’ultima fase <strong>del</strong><br />
processo di valutazione e, nel caso sia quantitativa,<br />
essa si effettua comparando la stima di esposizione<br />
per ognuno degli scenari di esposizione prescelti<br />
con i corrispondenti valori di dose-risposta. In altre<br />
parole, si calcola il rapporto di caratterizzazione<br />
<strong>del</strong> rischio (Risk Characterization Ratio - RCR) tra<br />
il valore di esposizione calcolato con il mo<strong>del</strong>lo di<br />
stima <strong>del</strong>l’esposizione e il valore tossicologico di<br />
dose-risposta (eq. 1).<br />
=<br />
eq.1<br />
Il calcolo <strong>del</strong> RCR deve essere fatto separatamente<br />
per ciascuna <strong>del</strong>le vie di esposizione, mentre il RCR<br />
finale è risultato <strong>del</strong>la somma dei RCR per inalazione<br />
e contatto dermico. L’allegato I <strong>del</strong>la normativa<br />
REACH al punto 6.4 afferma che per ogni scenario<br />
di esposizione il rischio per l’uomo può essere<br />
considerato sotto controllo se i livelli di esposizione<br />
non superano il DNEL, cioè se il valore di RCR è<br />
inferiore ad 1 per ogni via di esposizione e come<br />
somma dei RCR associati a ciascuna via di esposizione<br />
analizzata.<br />
3. Risultati e discussioni<br />
3.1. Risultati <strong>del</strong>la stima <strong>del</strong> pericolo<br />
L’arsenico triossido è altamente tossico e sicuramente<br />
cancerogeno per inalazione [10], mentre per<br />
contatto dermico esistono poche evidenze di una<br />
sua tossicità cronica [15]. Per quanto concerne il<br />
diossido di cerio, non ci sono dati che mettano in<br />
luce effetti cancerogeni o mutageni imputabili a<br />
tale sostanza, mentre diversi studi evidenziano effetti<br />
tossici a carico <strong>del</strong>l’apparato respiratorio per<br />
esposizione cronica per inalazione [9]. Infine, per<br />
quanto riguarda la loppa d’altoforno, gli studi disponibili<br />
escludono una sua natura tossica e/o cancerogena,<br />
tesi avvalorata anche da una completa analisi<br />
di rischio prodotta dalla Steel Slag Coalition [16],<br />
un gruppo composta da 63 aziende coinvolte nella<br />
produzione di acciaio e scorie d’altoforno. Per tale<br />
motivo, quest’ultima è stata considerata non pericolosa<br />
e non si è proceduto alla derivazione di parametri<br />
tossicologici di dose-risposta e alla valutazione<br />
<strong>del</strong>l’esposizione.<br />
I parametri tossicologici di dose-risposta sono stati<br />
definiti invece per l’As2O3 e il CeO2, ma esclusivamente<br />
per gli effetti tossici non cancerogeni per<br />
l’esposizione cronica sia per inalazione che, in via<br />
cautelativa, per contatto dermico. Questi sono rispettivamente<br />
per l’inalazione un TLV-TWA pari a<br />
0,01 mg/m 3 per l’As 2<br />
O 3<br />
e un DNEL pari a 3 mg/m 3<br />
per il CeO 2<br />
, mentre per il contatto dermico si ha un<br />
DNEL pari a 0,003 mg/(kg bw<br />
*day) per l’As 2<br />
O 3<br />
e un<br />
DNEL pari a 8,33 mg/(kg bw<br />
*day) per il CeO 2<br />
.<br />
3.2. Risultati <strong>del</strong>la stima <strong>del</strong>l’esposizione<br />
Attraverso l’utilizzo dei mo<strong>del</strong>li ECTOC TRA worker,<br />
MEASE e ART è stato possibile stimare i valori<br />
di esposizione per i lavoratori in termini di mg/m 3<br />
per l’inalazione e in termini di mg/(kg bw<br />
*day) per il<br />
contatto dermico. Le stime di esposizione ottenute<br />
per le due sostanze, a parità di condizioni operative,<br />
si dimostrano molto simili e per alcune fasi addirittura<br />
uguali. Infatti, il triossido di arsenico e il diossido<br />
di cerio hanno caratteristiche fisiche analoghe<br />
e di conseguenza, secondo l’impianto logico che sta<br />
alla base dei mo<strong>del</strong>li utilizzati, le due sostanze vengono<br />
classificate nella medesima classe di fugacità<br />
e trattate allo stesso modo, portando a risultati simili<br />
in termini di stima <strong>del</strong>l’esposizione. I risultati <strong>del</strong>la<br />
stima <strong>del</strong>l’esposizione per inalazione e per contatto<br />
dermico sono riportati in Tab. I e Tab. II rispettivamente.<br />
Dai valori riportati nelle tabelle, si può notare che<br />
nei processi ad alte temperature il diossido di cerio<br />
volatilizza meno rispetto ai composti <strong>del</strong>l’arsenico,<br />
a causa <strong>del</strong>la sua maggiore temperatura di fusione.<br />
Tale aspetto porta a differenze di uno o due ordini di<br />
grandezza nelle stime di esposizione per inalazione<br />
di triossido di arsenico rispetto al diossido di cerio,<br />
sia col mo<strong>del</strong>lo ECETOC TRA worker, che con il<br />
mo<strong>del</strong>lo MEASE. È possibile affermare con certezza<br />
che le differenze nelle stime di esposizione sono<br />
associabili esclusivamente alla temperatura di fusione.<br />
Infatti, questa è l’unica determinante per la quale<br />
sono stati inseriti valori diversi rispettivamente per<br />
arsenico e cerio.<br />
10
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
Tabella I - Stime di esposizione per inalazione ricavate con i tre mo<strong>del</strong>li di esposizione selezionati<br />
FASI<br />
TRASPORTO/<br />
PESATURA<br />
As As As<br />
INALAZIONE<br />
NoMPP MPP NoMPP MPP NoMPP<br />
ECETOC ECETOC MEASE MEASE ART<br />
As 2 O 3 CeO 2 O 3 CeO As 2 O 3 CeO 2 O 3 CeO O 3 CeO<br />
mg/m 3 2<br />
mg/m 3 mg/m 3 2<br />
mg/m 3 mg/m 3 mg/m 3 2<br />
mg/m 3 2<br />
mg/m 3 2<br />
mg/m 3 2<br />
mg/m 3<br />
30 30 0,06 0,06 30 30 0,075 0,075 4,2 4,2<br />
MISCELAZIONE 15 15 0,003 0,003 1,5 1,5 0,001 0,001 0,84 0,15<br />
CARICA 30 30 0,04 0,04 3 3 0,019 0,019 0,076 0,014<br />
FUSIONE/<br />
AFFINAGGIO<br />
6 0,6 0,03 0,003 0,4 0,06 0,005 0,001 NA NA<br />
LAVORAZIONE 10 1 0,05 0,005 0,2 0,05 0,008 0,002 NA NA<br />
MOLATURA 10 10 0,05 0,05 0,005 0,005
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Dalla valutazione dei risultati di rischio riportati in<br />
Tab. III e IV, è possibile constatare come il triossido<br />
di arsenico sia estremamente più preoccupante <strong>del</strong><br />
diossido di cerio nella lavorazione <strong>del</strong> vetro. Infatti,<br />
anche considerando lo scenario più cautelativo che<br />
prevede l’utilizzo di misure di prevenzione e protezione,<br />
permangono situazioni di rischio non accettabile.<br />
Al contrario, il diossido di cerio non desta mai<br />
preoccupazione nello scenario che considera le misure<br />
di prevenzione e protezione, mentre comporta<br />
rischio non accettabile per alcune fasi nella configurazione<br />
meno cautelativa <strong>del</strong>lo scenario NoMPP,<br />
che per questo motivo è stato ulteriormente indagato<br />
tramite il mo<strong>del</strong>lo di dettaglio ART. L’ART infatti<br />
è stato implementato solo per le fasi di pesatura,<br />
miscelazione e carica, ovvero quelle fasi per cui si<br />
verifica un rischio non accettabile per il cerio.<br />
Dall’analisi dei risultati di stima <strong>del</strong> rischio prodotti<br />
dal mo<strong>del</strong>lo ART, e riportati sempre in Tab. III, risulta<br />
evidente l’estrema differenza tra l’uso <strong>del</strong>l’arsenico<br />
e <strong>del</strong> cerio nella miscela vetrosa. Nel primo<br />
caso, infatti, si verifica un rischio non accettabile<br />
per tutte le fasi analizzate, mentre il cerio presenta<br />
rischio non accettabile per la sola fase di pesatura,<br />
evidenziando come l’esposizione potrebbe richiedere<br />
ulteriori analisi di dettaglio per poter escludere<br />
con certezza la mancanza di un rischio significativo<br />
per la salute umana.<br />
Conclusioni<br />
I risultati <strong>del</strong>l’analisi comparativa di rischio dimostrano<br />
che il triossido di arsenico causa rischi mag-<br />
Tabella III - Caratterizzazione <strong>del</strong> rischio dovuto a inalazione di arsenico triossido o diossido di cerio per ogni fase di produzione.<br />
FASI<br />
TRASPORTO/<br />
PESATURA<br />
MISCELAZIONE<br />
CARICA<br />
FUSIONE/<br />
AFFINAGGIO<br />
LAVORAZIONE<br />
MOLATURA<br />
As 2 O 3 CeO 2<br />
NoMPP MPP NoMPP MPP NoMPP NoMPP MPP NoMPP MPP NoMPP<br />
ECETOC MEASE ART ECETOC MEASE ART<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile accettabile accettabile accettabile<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile<br />
accettabile<br />
accettabile na accettabile accettabile accettabile accettabile na<br />
accettabile na accettabile accettabile accettabile accettabile na<br />
accettabile accettabile na<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile accettabile accettabile na<br />
Tabella IV - Caratterizzazione <strong>del</strong> rischio dovuto a contatto dermico con arsenico triossido o diossido di cerio per ogni fase di<br />
produzione.<br />
As 2 O 3 CeO 2<br />
FASI NoMPP MPP NoMPP MPP NoMPP MPP NoMPP MPP<br />
ECETOC MEASE ECETOC MEASE<br />
TRASPORTO/<br />
PESATURA<br />
MISCELAZIONE<br />
CARICA<br />
FUSIONE/<br />
AFFINAGGIO<br />
LAVORAZIONE<br />
MOLATURA<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
non<br />
accettabile<br />
accettabile accettabile accettabile<br />
accettabile accettabile accettabile<br />
accettabile accettabile accettabile<br />
accettabile accettabile accettabile accettabile<br />
accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile<br />
accettabile accettabile accettabile accettabile accettabile<br />
12
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
giori per la salute dei lavoratori rispetto a quelli<br />
stimati per l’utilizzo <strong>del</strong> diossido di cerio nella lavorazione<br />
<strong>del</strong> vetro. Questa situazione si verifica per<br />
tutte le fasi di produzione e lavorazione <strong>del</strong> vetro e<br />
per entrambi gli scenari di esposizione analizzati in<br />
questo lavoro.<br />
Le differenze tangibili, riscontrate tra le stime <strong>del</strong><br />
rischio associato all’uso di triossido di arsenico e le<br />
stime associate all’uso <strong>del</strong> diossido di cerio, dipendono<br />
solo marginalmente dai valori di esposizione<br />
alle sostanze analizzate, in quanto l’esposizione risulta<br />
simile o uguale per tutte le fasi di lavorazione<br />
<strong>del</strong> vetro, bensì sono maggiormente riconducibili<br />
alla tossicità <strong>del</strong>le due sostanze. Il diossido di cerio<br />
è, infatti, molto meno tossico <strong>del</strong> triossido di arsenico<br />
sia per inalazione che per contatto dermico. Inoltre,<br />
sebbene in questo studio si sia deciso di analizzare<br />
esclusivamente il rischio legato agli effetti non<br />
cancerogeni, i composti inorganici <strong>del</strong>l’arsenico, a<br />
differenza <strong>del</strong> diossido di cerio, sono riconosciuti<br />
come cancerogeni. Di conseguenza, l’utilizzo <strong>del</strong><br />
diossido di cerio comporta rischi meno rilevanti per<br />
la salute, non solo perché presenta un rischio per effetti<br />
non cancerogeni accettabile per tutte le fasi di<br />
produzione <strong>del</strong> vetro (ad eccezione <strong>del</strong>la sola fase di<br />
pesatura), ma anche perché non cancerogeno. È poi<br />
significativo evidenziare che il diossido di cerio viene<br />
utilizzato in quantità minori rispetto all’arsenico<br />
triossido (circa l’80-90% <strong>del</strong> peso in meno), e viene<br />
mescolato con la loppa d’altoforno, che risulta essere<br />
non pericolosa. Questa combinazione forma una<br />
valida e più sicura alternativa all’uso <strong>del</strong> triossido di<br />
arsenico. Ciò nonostante, è comunque buona norma<br />
ricordare che, a scopo cautelativo, per i lavoratori è<br />
importante proteggere le vie respiratorie, soprattutto<br />
in fase di composizione <strong>del</strong>la miscela, dotandosi di<br />
sistemi di protezione idonei.<br />
Con la consapevolezza <strong>del</strong>l’importante risultato<br />
messo in luce dall’analisi di rischio comparativo,<br />
si ritiene doverosa e importante una discussione<br />
sull’incertezza legata alla stima <strong>del</strong>l’esposizione.<br />
I mo<strong>del</strong>li utilizzati, infatti, nonostante siano i più<br />
avanzati finora sviluppati, permettono di analizzare<br />
scenari che non sempre riescono a descrivere<br />
in maniera dettagliata tutte le caratteristiche di un<br />
ambiente di lavoro reale, che presenta modalità dif-<br />
ferenti caso per caso. Per valutare quanto e in che<br />
modo le stime di esposizione dei mo<strong>del</strong>li si discostano<br />
dall’esposizione effettiva dei lavoratori, un’ulteriore<br />
attività da sviluppare dovrebbe consistere nel<br />
confronto dei valori stimati dai mo<strong>del</strong>li con un database<br />
di valori medi espositivi misurati durante apposite<br />
campagne di monitoraggio sul luogo di lavoro.<br />
Ringraziamenti<br />
Tale specifico studio sviluppato nell’ambito <strong>del</strong><br />
progetto “Eliminazione dei composti <strong>del</strong>l’arsenico<br />
dalla miscela vetrifi cabile nelle produzioni artistiche<br />
muranesi e sostituzione con materie prime alternative<br />
non pericolose” promosso dalla <strong>Stazione</strong><br />
<strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> è stato finanziato dal Ministero<br />
<strong>del</strong>l’Ambiente e <strong>del</strong>la Tutela <strong>del</strong> Territorio e<br />
<strong>del</strong> Mare Divisione V - Certificazione ambientale,<br />
prodotti chimici e acquisti pubblici verdi.<br />
Bibliografia<br />
[1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 <strong>del</strong> Parlamento<br />
europeo e <strong>del</strong> Consiglio, Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>del</strong>l’Unione europea <strong>del</strong> 30.12.2006, L 396, page 1.<br />
[2] Montagnani R, Campagna M, Gasparello S, Hreglich<br />
A, Apostoli P. (2006). L’esposizione ad arsenico<br />
nella produzione artigianale <strong>del</strong>la bacchetta di<br />
vetro. Risultati <strong>del</strong> monitoraggio biologico e indicazioni<br />
preventive. G Ital Med Lav Erg 28(2):158-162.<br />
[3] ECHA (2010). Guidance on information requirements<br />
and chemical safety assessment. ECHA,<br />
Helsinki, Finland. Allegato I, 1.0.1.<br />
[4] ECHA CHEM. Database <strong>del</strong>le sostanze registrate<br />
presso l’ECHA disponibile al seguente sito:<br />
http://echa.europa.eu/web/guest/information-onchemicals/registered-substances<br />
(consultato il<br />
20/03/<strong>2012</strong>).<br />
[5] BRL - Bio-Research Laboratories (1994). Final<br />
report for a 90-day inhalation neurotoxicity and<br />
toxicity study by exposure to a dry powder aerosol<br />
of ceric oxide in the albino rat. Prodotto da Bio-Research<br />
Laboratories, Montreal, Canada per Rhone-<br />
Poulenc Inc.<br />
13
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
[6] IARC (1980). Monographs on the Evaluation<br />
of Carcinogenic Risks to Humans. vol. 23, Some<br />
Metals and Metallic Compounds. IARC, Lyon.<br />
[7] IARC (2004). Monographs on the Evaluation<br />
of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 84, Some<br />
Drinking-water Disinfectants and Contaminants,<br />
including Arsenic.<br />
[8] US EPA (1984). Health Assessment Document<br />
for Arsenic. Research Triangle Park, NC: U.S. Environmental<br />
Protection Agency. EPA600823021F.<br />
[9] US EPA (2009). Toxicological review of Cerium<br />
Oxide and Cerium Compounds - Environmental<br />
Protection Agency. Washington. Disponibile al:<br />
http://www.epa.gov/iris/toxreviews/1018tr.pdf (consultato<br />
il 20/03/<strong>2012</strong>).<br />
[10] ATSDR (2007). Toxicological Profi le for Arsenic<br />
- Agency for Toxic Substances and Disease<br />
Registry. U.S. Department of Health and Human<br />
Services, Public Health Services. Disponibile al:<br />
http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp.asp?id<br />
=22&tid=3 (consultato il 20/03/<strong>2012</strong>).<br />
[11] ECETOC (2004). Target Risk Assessment. Brussels,<br />
Belgium, European Centre for Ecotoxicology and<br />
Toxicology of Chemicals. Technical Report no. 93.<br />
[12] ECETOC (2009). Addendum to ECETOC Targeted<br />
Risk Assessment Report No. 93. ISSN-0773-<br />
8072-107.<br />
[13] EBRC (2007). MEASE - Occupational Exposure<br />
Assessment Tool for REACH. Disponibile<br />
al: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/<br />
projects-and-references/mease.php (consultato il<br />
20/03/<strong>2012</strong>).<br />
[14] Fransman W, Cherrie J, van Tongeren M,<br />
Schneider T, Tischer M, Schinkel J, Marquart H,<br />
Warren N, Kromhout H, Tielemans E (2009). Development<br />
of a mechanistic mo<strong>del</strong> for the Advanced<br />
REACH Tool (ART). TNO Quality of Life (The Netherlands)<br />
Report n. V8667.<br />
[15] IPCS (2001). Environmental Health Criteria<br />
no. 224: Arsenic and Arsenic Compounds. World<br />
Health Organisation, International Programme on<br />
Chemical Safety. Disponibile al: http://www.who.<br />
int/ipcs/publications/ehc/ehc_224/en/ (consultato il<br />
20/03/<strong>2012</strong>).<br />
[16] Proctor DM, Shay EC, Fehling KA, Finley BL<br />
(2002). Assessment of human health and ecological<br />
risks posed by the uses of steel-industry slags in the<br />
environment. Human and Ecological Risk Assessment,<br />
8, 4, pp. 681-711.<br />
Autori<br />
Valentina Faggian, Elisa Giubilato, Lisa Pizzol, Petra<br />
Scanferla, Antonio Marcomini<br />
Consorzio Venezia Ricerche, Venezia<br />
e-mail: sp.cvr@vegapark.ve.it<br />
Nicola Favaro<br />
<strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, Murano<br />
e-mail: nfavaro@spevetro.it<br />
14
studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
I risultati <strong>del</strong> riciclo <strong>del</strong> vetro nel 2011<br />
e le previsioni future<br />
Nel 2011 la quantità di rifiuti d’imballaggio in vetro riciclata è cresciuta rispetto al<br />
2010 <strong>del</strong> 6,7%, passando da 1.471 Kt a 1.570 Kt. Il tasso di riciclo ha superato il 68%.<br />
Imballaggi in vetro immessi al consumo: 2.306.951 t.<br />
15
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
SERIE STORICA DEI RISULTATI DI RICICLO NEL PERIODO 2002 - 2011 (Kton)<br />
Immesso<br />
al consumo<br />
1.970 2.107 2.141 2.117 2.133 2.157 2.139 2.065 2.153 2.307<br />
Riciclo 1.037 1.122 1.203 1.211 1.256 1.303 1.390 1.362 1.471 1.570<br />
I risultati di riciclo sono stati ampiamente superiori rispetto all’obiettivo a suo tempo<br />
fissato dal D.lgs. 152/06.<br />
PROGRAMMA RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 2013 (Kton)<br />
Previsioni di riciclo<br />
80%<br />
75%<br />
70%<br />
65%<br />
60%<br />
55%<br />
50%<br />
Immesso<br />
al consumo<br />
2.307 2.249 2.272<br />
Riciclo 1.570 1.596 1.626<br />
Obiettivi<br />
di Riciclo<br />
68,1% 71,0% 71,6%<br />
16
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
Raccolta<br />
Nel 2011 la raccolta differenziata nazionale dei rifiuti di imballaggio in vetro è cresciuta<br />
<strong>del</strong> 6%, raggiungendo 1.682.000 ton.<br />
ANDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI D'IMBALLAGGIO IN VETRO PERIODO 2002 - 2011<br />
Kton<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
ANNO<br />
Il Coreve, attraverso apposite convenzioni locali, ha gestito direttamente 1.386.000 ton.<br />
di rifiuti d’imballaggio in vetro, corrispondenti all’82% <strong>del</strong>la raccolta differenziata <strong>del</strong><br />
vetro in Italia.<br />
RACCOLTA IMBALLAGGI DI VETRO 2011: 1.682.000 Ton.<br />
296 Kton<br />
1.386 Kton<br />
17
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Sono 6.083 i Comuni convenzionati con Coreve (circa il 75% <strong>del</strong> totale), direttamente<br />
o attraverso il proprio gestore <strong>del</strong>egato. Gli abitanti coinvolti superano i 50.100.000 e<br />
risultano pari a circa l’84% <strong>del</strong>la popolazione italiana.<br />
ANDAMENTO CONVENZIONI - CONFRONTO 2011/2010<br />
2011<br />
% sul<br />
totale<br />
2010<br />
% sul<br />
totale<br />
Δ Δ %<br />
Comuni 6.083 75% 5.894 73% 189 3%<br />
Popolazione servita 50.140 84% 49.090 82% 1.050 2%<br />
Convenzioni attive 359 - 343 - 16 4%<br />
RACCOLTA DEL ROTTAME DI VETRO DA IMBALLAGGIO<br />
SUDDIVISA PER MACRO-AREE (Kton) - ANNO 2011<br />
Kton<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Nord Centro Sud TOTALE<br />
Gestione<br />
Indipendente<br />
Gestione<br />
Consortile<br />
Raccolta<br />
complessiva<br />
Resa<br />
Pro Capite<br />
182 47 67 296<br />
911 223 252 1.386<br />
1.093 270 319 1.682<br />
39,9 22,9 15,3 28,0<br />
18
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
Riciclo<br />
Nell’ultimo anno, il riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta<br />
nazionale ha raggiunto il quantitativo di 1.570.404 ton.<br />
A questo risultato ha concorso l’utilizzo <strong>del</strong>la sabbia di vetro ottenuta dal recupero<br />
secondario dei cascami dei lettori ottici di cernita degli inerti diversi dal vetro (ceramiche,<br />
porcellane, pietre ecc.) e <strong>del</strong>le frazioni fini, come sabbia di vetro, il cui impiego nei<br />
settori industriali, anche diversi da quello vetrario, è leggermente diminuito.<br />
Nella figura seguente è riportato il riciclo totale di rifiuti d’imballaggio nazionale suddiviso<br />
per settori industriali di utilizzo.<br />
Settore<br />
<strong>Vetro</strong> Cavo<br />
Come emerge dal grafico, il settore vetrario rimane tuttora il naturale sbocco per il riciclo<br />
dei rifiuti d’imballaggio in vetro raccolti in ambito nazionale che, dalla nascita <strong>del</strong><br />
Coreve sino a oggi, è cresciuto di circa il 49%, a fronte di una crescita dei quantitativi<br />
di vetro complessivamente riciclati <strong>del</strong> 41%.<br />
19
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
ANDAMENTO DEL RICICLO DEI RIFIUTI D'IMBALLAGGIO<br />
NEL SETTORE VETRARIO - PERIODO 2002-2011 (Kton)<br />
Kton<br />
2.200<br />
2.000<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
riciclo<br />
tot<br />
riciclo<br />
imb<br />
1.453 1.556 1.647 1.719 1.843 1.852 1.820 1.764 1.908 2.052<br />
1.037 1.122 1.203 1.211 1.256 1.286 1.376 1.351 1.441 1.548<br />
In questi anni le aziende vetrarie si sono attrezzate, non solo per garantire la completa<br />
valorizzazione <strong>del</strong> vetro raccolto dai comuni in modo differenziato, ma hanno addirittura<br />
incrementato ulteriormente la loro capacità di riciclo.<br />
Le importazioni e il vetro non imballaggio (vetro piano) vanno a coprire, quindi, fabbisogni<br />
che altrimenti rimarrebbero insoddisfatti, soprattutto quelli di rottame di vetro<br />
incolore.<br />
20
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
RICICLO TOTALE PER FLUSSI DI PROVENIENZA NEL SETTORE VETRARIO<br />
Kton<br />
2.200<br />
2.000<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Importazioni<br />
<strong>Vetro</strong><br />
piano<br />
Riciclo<br />
imballaggi<br />
Riciclo<br />
totale<br />
173 221 259 300 246 264 202 231 201 223<br />
244 213 184 208 341 302 242 182 265 282<br />
1.037 1.122 1.203 1.211 1.256 1.286 1.376 1.351 1.441 1.548<br />
416 434 444 508 1.843 1.852 1.820 1.764 1.908 2.052<br />
21
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Risparmi ambientali nel settore vetrario: sintesi risultati 2011<br />
Il riciclo <strong>del</strong> vetro nel ciclo di produzione in vetreria, nel corso <strong>del</strong> 2011, ha consentito<br />
di ottenere notevoli vantaggi ambientali, che riepiloghiamo nella tabella a seguire:<br />
Risparmi energetici indiretti, pari a circa:<br />
Risparmi energetici diretti, pari a circa:<br />
Risparmi energetici complessivi, anno 2011<br />
192.032 TEP* (rispetto all’impiego di sole<br />
materie prime di origine minerale)<br />
116.159 TEP (rispetto all’impiego di sole<br />
materie prime di origine minerale)<br />
308.191 TEP pari a circa 3.097.887 barili di<br />
petrolio<br />
Minor consumo di materie prime minerali**,<br />
a parità di vetro prodotto, pari a circa:<br />
3.181.000 tonnellate di cui:<br />
Sabbia 1.968.854 ton.<br />
Soda<br />
566.165 ton.<br />
Calcare<br />
359.419 ton.<br />
Dolomite 174.939 ton.<br />
Feldspato 57.571 ton.<br />
Altre<br />
54.052 ton.<br />
Riduzione diretta di emissioni di CO 2<br />
eq<br />
(materie prime e fonti energetiche):<br />
Riduzione indiretta di emissioni di CO 2<br />
eq<br />
(materie prime e fonti energetiche):<br />
847.686 tonnellate di CO 2<br />
eq<br />
1.183.667 tonnellate di CO 2<br />
eq<br />
Riduzione totale emissioni di CO 2<br />
eq,<br />
anno 2011:<br />
2.031.352 tonnellate di CO 2<br />
equivalenti, pari<br />
alla circolazione evitata, per un anno, di circa<br />
1.289.747 autovetture utilitarie Euro5 (con<br />
una percorrenza media di 15.000 Km)<br />
*: TEP (tonnellate equivalenti di petrolio)<br />
**: pari ad un volume di 1.871.001 metri cubi<br />
22
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI<br />
L’obiettivo di riciclo raggiunto nell’anno 2011 è pari al 68,1% <strong>del</strong>l’immesso al consumo.<br />
Nella seguente tabella sono riepilogati gli elementi utilizzati per il calcolo <strong>del</strong> tasso<br />
di riciclo 2011:<br />
U.M. 2011<br />
Immesso al consumo ( t ) 2.306.951<br />
Riciclo ( t ) 1.570.302<br />
Recupero energetico ( t ) -<br />
Recupero totale ( t ) 1.570.302<br />
% Recupero totale<br />
su immesso al consumo<br />
( % ) 68,3 %<br />
Nella tabella successiva è riportata la serie storica dei risultati di riciclo nel periodo<br />
2002 - 2011:<br />
U.M. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Immesso al<br />
consumo<br />
(kt) 1.970 2.107 2.141 2.117 2.133 2.157 2.139 2.065 2.153 2.403<br />
Riciclo (kt) 1.037 1.122 1.203 1.211 1.256 1.303 1.390 1.362 1.471 1.570<br />
Recupero<br />
energetico<br />
(kt) - - - - - - - - - -<br />
Recupero<br />
totale<br />
% Recupero<br />
totale su<br />
immesso al<br />
consumo<br />
(kt) 1.037 1.122 1.203 1.211 1.256 1.303 1.390 1.362 1.471 1.570<br />
% 52,6 53,2 56,2 57,2 58,9 60,4 65,0 66,0 68,3 68,3<br />
Nel periodo considerato, a fronte di una crescita <strong>del</strong>l’immesso al consumo degli imballaggi<br />
in vetro <strong>del</strong> 22%, le quantità riciclate sono aumentate di oltre il 51%.<br />
Fonte: CO.RE.VE. Consorzio Recupero <strong>Vetro</strong> - info@coreve.it<br />
Ufficio Stampa: Massimo Tafi<br />
uffi ciostampa@coreve.it - tel. 02 48012961 - cell. 335 7171005<br />
23
4-<strong>2012</strong><br />
studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
LA PRATICA CHIMICA DEI VETRAI DEL RINASCIMENTO<br />
La preparazione <strong>del</strong>le materie prime (I Parte)<br />
Introduzione e descrizione dei procedimenti<br />
Cesare Moretti<br />
Introduzione<br />
Nella maggior parte dei manoscritti di ricette vetrarie<br />
un certo numero di capitoli è dedicato alla<br />
preparazione <strong>del</strong>le materie prime da utilizzare nelle<br />
composizioni vetrificabili per ottenere i diversi tipi<br />
di vetro (da quelli incolori sino alla vasta gamma<br />
di vetri colorati, trasparenti e opachi). Si è ritenuto<br />
interessante, non solo dal punto di vista vetrario, ma<br />
anche da quello più generale <strong>del</strong>la storia <strong>del</strong>la chimica,<br />
analizzare e interpretare queste istruzioni, verificando<br />
le eventuali differenze tra ricettari diversi.<br />
L’esito di tale indagine viene riportato in questo lavoro<br />
che è suddiviso in due parti:<br />
prima parte, in cui vengono presentate l’introduzione<br />
e la descrizione dei procedimenti di preparazione<br />
<strong>del</strong>le materie prime riportati in otto diversi ricettari<br />
databili tra il 14° e il 17° secolo;<br />
seconda parte, in cui vengono trascritti i testi integrali<br />
dei procedimenti di preparazione <strong>del</strong>le materie<br />
prime riportati nei vari ricettari, con relativi commenti<br />
di dettaglio sulle ricette effettuati dall’autore.<br />
In questa ricerca sono stati considerati i ricettari, di<br />
origine o derivazione veneziana, cioè i tre Trattatelli<br />
Toscani (14°-15° secolo), il manoscritto rinvenuto<br />
all’Ecole de Médicine de Montpellier (datato 1536),<br />
il ricettario Anonimo <strong>del</strong> Cinquecento, il testo di<br />
Antonio Neri (1612), il ricettario di Giovanni Darduin<br />
(1644) e il ricettario di Gasparo Brunoro (ms.<br />
redatto a Danzica nel 1645).<br />
In questi ricettari i capitoli dedicati alla preparazione<br />
<strong>del</strong>le materie prime sono numerosi: 17 nei Trattatelli<br />
Toscani, 11 nel Montpellier, 13 nell’Anonimo,<br />
32 in Neri, 16 nel Darduin, 36 in Brunoro.<br />
I materiali di cui si danno istruzioni per la preparazione<br />
risultano essere ben 32, incluse anche alcune<br />
materie sussidiarie (cioè quelle che servono alla<br />
preparazione <strong>del</strong>le materie primarie) come gli acidi<br />
(aqua forte, aqua regia). Come si vedrà dall’elenco,<br />
si va dall’Acqua forte allo Zolfo, passando per tutta<br />
una serie di materie come gli ossidi di ferro, di rame,<br />
di piombo, di stagno, di manganese, di cobalto e i<br />
cosiddetti “sali”, prodotti di lisciviazione come il<br />
sal alcali, il sale di tartaro, il sale di soda (sale di<br />
vetro o bollito). Importanti e circostanziati sono poi<br />
i trattamenti dei metalli come l’argento e l’oro, metalli<br />
che vengono “calcinati” per poterli introdurre<br />
in forma adeguata nella ricetta vetrificabile per fare<br />
vetri come il calcedonio (invenzione <strong>del</strong> 15° secolo)<br />
e il rosechiero o rubino all’oro (invenzione <strong>del</strong> 17°<br />
secolo).<br />
Lo studio iniziale è consistito nella estrazione, dagli<br />
otto ricettari, dei vari capitoli relativi alla preparazione<br />
dei materiali, associandoli in un elenco alfabetico,<br />
a seconda <strong>del</strong> materiale trattato.<br />
Antonio Neri, al capitolo 37 1 , illustra perfettamente<br />
la filosofia che spingeva i vetrai a preparare essi<br />
stessi i loro materiali fondamentali; egli infatti dice:<br />
…è necessario prima insegnare le preparationi di<br />
alcune cose minerali per tale compositione, che<br />
se bene alcune di esse si trovano publicamente da<br />
comprare, tuttavia desideroso che l’opera riesca di<br />
tutta perfettione, mi è paruto a proposito mostrare il<br />
1<br />
Il titolo <strong>del</strong> capitolo 37 di Neri è: Modo di calcinare il tartaro e unirlo con il Rosechiero che fa apparire i vaghi scherzi di molti colori<br />
con ondeggiamenti in essi, e gli da l’opaco come hanno de naturali orientali<br />
24
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
L’antimonio (antimonio)<br />
La preparazione <strong>del</strong>l’antimonio (ved. Figura 2), elemento<br />
importante sia nella primitiva tecnica di decolorazione<br />
<strong>del</strong> vetro per la sua azione ossidante sul<br />
ferro (sostituito poi dal biossido di manganese), sia<br />
soprattutto nella produzione di vetri opachi bianchi<br />
e gialli (per formazione di antimoniato di calcio o<br />
di antimoniato di piombo), deriva dalla probabile<br />
difficoltà ad usare il solfuro di antimonio (stibina),<br />
cioè il minerale più diffuso in natura. I vetrai veneziani<br />
“bruciavano” il solfuro di antimonio prima<br />
<strong>del</strong>l’inserimento nella ricetta (vedi Moretti e Hremodo<br />
più esquisito e chimico, acciò i periti e curiosi<br />
possino fare da loro ogni cosa e più perfetta e con<br />
minore spesa, perché non è dubbio alcuno che in<br />
questa arte quando le materie sono bene preparate<br />
e che i colori dei metalli sono bene aperti e separati<br />
dalla loro impurità e terrestreità, quali per ordinario<br />
impediscono l’ingresso di loro tinture nel vetro e<br />
la loro unio ne per minima, all’hora tingono il vetro<br />
di colori vivi splendenti e va ghi, che di gran lunga<br />
sempre avanzano quelli che volgarmente e ordinariamente<br />
si fanno nelle fornace.<br />
Bisogna tenere presente che l’industria chimica in<br />
grado di fornire prodotti chimicamente definiti e di<br />
composizione costante nel tempo si sviluppa solo<br />
nel 19° secolo; in precedenza i materiali utilizzati<br />
erano prodotti naturali di composizione variabile e<br />
con diversi gradi di impurezze e/o inquinanti che<br />
potevano mettere in discussione la bontà dei risultati<br />
e che quindi dovevano essere sottoposti ad un<br />
procedimento di purificazione, come dice appunto il<br />
Neri nella nota qui riportata. Non solo, alcuni prodotti<br />
dovevano essere ricavati da altri con un processo<br />
chimico artigianale (calcinazione, dissoluzione,<br />
distillazione, concentrazione, precipitazione ecc.),<br />
spesso di derivazione alchemica.<br />
La derivazione alchemica è particolarmente intuibile<br />
nelle procedure spesso complicate (forse più<br />
complicate <strong>del</strong> necessario) e ripetitive illustrate da<br />
Antonio Neri, che alchimista in effetti lo era.<br />
In questa prima parte <strong>del</strong> lavoro si cerca di mettere<br />
in evidenza i processi principali citati nelle ricette<br />
(e i dubbi che si pongono in alcuni casi). Lo scopo<br />
è quello di dare una panoramica sintetica dei vari<br />
procedimenti, raggruppati per materiale e per tecnologia<br />
simile. È stato costruito inoltre il quadro sinottico<br />
che segue questa panoramica per facilitare<br />
la comprensione dei processi e permettere dei più<br />
agevoli confronti.<br />
Nella seconda parte <strong>del</strong> lavoro, i commenti di dettaglio<br />
sulle ricette integralmente trascritte sono riportati<br />
nelle note alle trascrizioni.<br />
Descrizione dei procedimenti<br />
La preparazione degli acidi<br />
(aqua forte e aqua regia)<br />
Per l’acqua forte o acido nitrico (ved. Figura 1) la<br />
prescrizione prevede il trattamento <strong>del</strong> salnitro con<br />
allume di rocca oppure vetriolo romano (entrambi<br />
sono dei solfati) con la misteriosa aggiunta di un’oncia<br />
per libbra di arsenico cristallino; la reazione avviene<br />
in fase solida, entro bocce di vetro (storte) ben<br />
lutate, con sviluppo di vapori di ossidi di azoto di<br />
colore rossastro, che dovrebbero poi sciogliersi in<br />
acqua (in un recipiente collegato) a formare l’acido<br />
nitrico. La ricetta di Neri, mentre è molto dettagliata<br />
sul modo di lutare le giunture <strong>del</strong>la storta, ad evitare<br />
la fuoriuscita dei gas di azoto, non dà spiegazioni<br />
dettagliate su come i gas vengano a contatto con<br />
l’acqua, né è chiara la funzione <strong>del</strong>l’arsenico cristallino<br />
che a suo dire è materia segreta e non ordinaria<br />
che oltre a dare più forza a l’acqua aiuta a cavare<br />
meglio gli spiriti dei materiali.<br />
L’acqua regia, di cui tratta ancora Neri, ricetta ripetuta<br />
anche da Brunoro, viene fatta aggiungendo <strong>del</strong><br />
cloruro ammonico all’acqua forte, formando quindi<br />
una miscela di acido nitrico e acido cloridrico.<br />
L’acetato di piombo (anima di Saturno)<br />
Si forma per trattamento <strong>del</strong> litargirio o <strong>del</strong>la biacca<br />
con acido acetico. L’acetato idrato di piombo,<br />
bianco (Zucchero di Saturno) viene poi calcinato<br />
e si ottiene una variante (probabilmente nella forma<br />
cristallina) di minio (Zolfo o Rosso di Saturno),<br />
sempre di colore rosso come il cinabro. In alcune<br />
ricette si suggerisce di non utilizzare questa variante<br />
di minio ottenuto partendo dalla biacca, per motivi<br />
non chiari.<br />
25
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Fig. 1: Distillazione nella preparazione <strong>del</strong>l’acqua forte (acido Nitrico). Immagine tratta da pag. 442 (Libro X) di<br />
Georgius Agricola, De Re Metallica, 1556, H.C. Hoover, L.H. Hoover, Dover Publications, Inc. - New York 1950<br />
26<br />
Fig. 2: Processo di distillazione per separare il mercurio (quick silver) dalla ganga, tratta da pag. 427 (Libro IX) di<br />
Georgius Agricola, De Re Metallica, 1556, H.C. Hoover, L.H. Hoover, Dover Publications, Inc. - New York 1950
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
glich 1984 e 2005). Una soluzione, precedente in<br />
ordine di tempo e originale in quanto non citata in<br />
altri ricettari, è quella indicata nella ricetta 22 <strong>del</strong><br />
Brunoro, che consiste nel calcinare il solfuro di antimonio<br />
misto a cloruro ammonico e tartaro per ottenere,<br />
probabilmente, in superficie un sale di antimonio<br />
di colore giallo (probabilmente antimoniuro di<br />
potassio) che viene usato come colorante <strong>del</strong> vetro,<br />
mentre sotto la superficie si formerebbe <strong>del</strong> tartaro<br />
emetico (tartrato potassico e antimonile) da utilizzare<br />
in medicina.<br />
L’argento e la medicina per il calcedonio<br />
(argento calcinato)<br />
Le tecniche per il trattamento <strong>del</strong>l’argento metallico<br />
onde renderlo “calcinato” o come sale, cioè in forma<br />
più solubile nel vetro, sono tra i capitoli più ampiamente<br />
trattati nei ricettari. L’argento è fondamentale<br />
per la produzione <strong>del</strong> vetro calcedonio, probabile<br />
invenzione di Anzolo Barovier (metà <strong>del</strong> 15° secolo),<br />
un vetro tuttora molto ricercato ma di difficile<br />
produzione. Le ricette che parlano <strong>del</strong> trattamento<br />
<strong>del</strong>l’argento sono una quindicina e le tecniche sono<br />
molto varie e presentano un notevole interesse dal<br />
punto di vista chimico: la più semplice consiste nella<br />
dissoluzione <strong>del</strong> metallo in acqua forte con aggiunta<br />
poi di sale comune o di acqua di mare così<br />
da far precipitare il cloruro d’argento; altra tecnica,<br />
interessante, consiste nel mettere a contatto <strong>del</strong>la<br />
soluzione di nitrato d’argento una piastra di rame,<br />
sulla quale, per scambio cationico, si andranno a<br />
depositare fiocchi di argento colloidale. Altro modo<br />
consiste nel calcinare l’argento misto a zolfo (tecnica<br />
che ricorre come vedremo anche per altri metalli)<br />
con probabile formazione di solfuro d’argento.<br />
Ancora, si può calcinare una lega di argento e stagno<br />
con formazione di una calcina di ossido di stagno e<br />
d’argento, con il che si raggiungerebbe lo scopo di<br />
avere un composto di argento e stagno utile alla formazione<br />
<strong>del</strong> colore nel vetro.<br />
Infine si può fare una amalgama di argento in mercurio<br />
cui si aggiunge <strong>del</strong> sale comune, facendo poi<br />
evaporare il mercurio (ved. Figura 3) si otterrebbe<br />
ancora una volta il cloruro d’argento. Alcune di queste<br />
ricette sono rese ancora più complesse dall’inserimento<br />
anche di altri ossidi o elementi coloranti per<br />
aggiungere ulteriori tonalità cromatiche. La miscela<br />
risultante viene indicata come una “medicina” per<br />
fare appunto il calcedonio.<br />
Acciaio (azzal)<br />
Consiste nella ossidazione a caldo <strong>del</strong>l’acciaio per<br />
ottenere superficialmente un ossido di ferro che, ancora<br />
caldo, viene subito immerso in aceto (a quale<br />
scopo, non è chiaro).<br />
Azzurro (azuro)<br />
Con due tecniche diverse si prepara un colorante<br />
azzurro per il vetro, partendo dalla zaffera (ossido<br />
di cobalto misto a silice) che, trattata con olio di<br />
tartaro, viene calcinata. La seconda tecnica è meno<br />
chiara, in quanto non si capisce se viene trattata con<br />
sale comune direttamente la zaffera, oppure l’azzurro<br />
prima preparato.<br />
Azzurro come quello d’Alemagna<br />
Si tratta di fare una imitazione <strong>del</strong>l’azzurro d’Alemagna<br />
(azzurro <strong>del</strong>la Magna - carbonato basico di<br />
rame) calcinando o distillando mercurio misto a zolfo<br />
e a cloruro ammonico, senza comprendere cosa si<br />
possa ottenere.<br />
Cristallo di Rocca e ciottoli di quarzo<br />
(cogoli <strong>del</strong> Tesin)<br />
Il cristallo di rocca o di montagna, la roccia di quarzo<br />
(in alcune ricette indicata come pietra bianca o<br />
marmo bianco) e i ciottoli raccolti nell’alveo <strong>del</strong> fiume<br />
Ticino dovevano essere frantumati e trasformati<br />
in polvere sottile per poter essere usati come vetrificante<br />
nelle ricette, quindi venivano prima portati<br />
al calor rosso in apposito forno, poi versati in acqua<br />
fredda; si aveva una prima grossolana frantumazione,<br />
seguita dal trattamento in mortaio di porfido o di<br />
vetro. Il cristallo di rocca serviva come vetrificante<br />
soprattutto nella produzione dei vetri fatti per imitare<br />
le pietre dure (zoje false), mentre il quarzo dei<br />
ciottoli <strong>del</strong> fiume Ticino veniva utilizzato, per la sua<br />
purezza, per fare il vetro “cristallo”, vetro trasparente<br />
quasi incolore, sviluppato nella metà <strong>del</strong> XV<br />
secolo a Murano.<br />
Crocum ferri o Croco di Marte (ossido di ferro)<br />
Questa è una <strong>del</strong>le preparazioni più frequenti nei<br />
ricettari esaminati, ne sono state rinvenute una ventina.<br />
La tecnica consiste nel calcinare <strong>del</strong> ferro in<br />
lastra o in limature nel forno a riverbero (calchera)<br />
sino ad ossidazione <strong>del</strong>lo stesso. Le varianti di questa<br />
procedura consistono nel trattare prima la limatura<br />
con aceto o con acqua forte o con acqua regia e<br />
27
4-<strong>2012</strong><br />
studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
nel calcinare il sale ottenuto per precipitazione dalla<br />
soluzione. Altra soluzione consiste nel calcinare la<br />
limatura di ferro o acciaio con zolfo (in un caso misto<br />
a sale comune) con aggiunta poi di aceto, o con<br />
immersione <strong>del</strong> calcinato caldo in aceto.<br />
Ferretto di Spagna e Ramina, gli ossidi di rame<br />
Numerose ricette si riferiscono alla preparazione <strong>del</strong><br />
cosiddetto “ferretto di Spagna”, altre invece alla “ramina”<br />
rossa o alla ramina di tre cotte (nera); sono<br />
una decina per tipo. Esaminando i titoli e il contenuto<br />
di queste ricette si evidenziano due interrogativi.<br />
Il primo è cosa si intendesse esattamente per Ferretto<br />
di Spagna, cioè se esso indicasse un ossidulo di<br />
rame di colore rosso o un ossido rameico di colore<br />
nero; in effetti M.P. Merrifield dà l’interpretazione<br />
che con tale nome si intendesse l’ossidulo rosso<br />
(vedi nota 92 nella trascrizione), di colore analogo<br />
alla Hematite, ossido di ferro (da cui l’ambiguità <strong>del</strong><br />
nome “ferretto” riferito all’ossido di rame).<br />
Il secondo quesito è di capire perché certe volte<br />
l’ossido di rame viene chiamato ferretto di Spagna e<br />
altre ramina rossa o ramina di tre cotte; quindi non<br />
è chiaro in cosa consista la differenza tra ferretto e<br />
ramina.<br />
Le tecniche per fare il ferretto consistono nel calcinare<br />
rame in lamine sottili (in alcuni casi miste<br />
a zolfo o a vetriolo) in crogioletto o pentola coperti,<br />
quindi in carenza di ossigeno e con formazione<br />
quindi <strong>del</strong>l’ossidulo rosso; l’ossidulo poi, trattato<br />
con aceto, si trasformerebbe (con la licenza <strong>del</strong> dubbio)<br />
in ossido nero. In altra tecnica, se la calcinazione<br />
avviene in crogiolo aperto, con presenza di<br />
ossigeno, l’ossido nero formatosi verrebbe estinto<br />
ancora caldo in olio di lino per ridurlo ad ossidulo<br />
rosso.<br />
Le tecniche per fare la ramina rossa (Cu 2<br />
O) consistono<br />
ancora nel calcinare il rame ridotto in lamine<br />
sottili, a temperatura inferiore a quella di fusione<br />
(1083°C), in ambiente con carenza di ossigeno (ambiente<br />
chiuso, murato) e/o nel gettare l’ossido formatosi<br />
in aceto, così da mantenerlo in forma ridotta.<br />
La ramina di tre cotte, ossido rameico nero (CuO),<br />
viene ottenuta o dalla ramina rossa per ulteriore calcinazione<br />
in ambiente o contenitore aperto (tegami<br />
di terracotta) o direttamente dal metallo (in scaglie<br />
o lamine “grossette”) ossidato in ambiente aperto.<br />
Altra tecnica singolare, che ricorda quella citata per<br />
l’argento, consiste nello sciogliere il rame in acqua<br />
forte e nell’immergere poi nella soluzione una piastra<br />
di ferro; per scambio cationico si avrebbe deposito<br />
sul ferro di fiocchi di rame colloidale.<br />
Manganese<br />
Il manganese, posto in una cazza di ferro, viene arrostito<br />
sulla bocca <strong>del</strong> forno, quindi annaffiato ancora<br />
caldo con <strong>del</strong>l’aceto, lavato con acqua ed essiccato.<br />
Si segnala anche la preparazione di un composto<br />
colorante (da aggiungere alla miscela vetrificabile)<br />
ottenuto dalla fusione di una miscela di manganese,<br />
sale di vetro e sale di tartaro, che sarebbe quindi costituito<br />
da un manganato di sodio e potassio.<br />
Metalli<br />
In una ricetta <strong>del</strong> Montpellier si indica che si possono<br />
calcinare i metalli ferro, rame, argento e oro, con<br />
l’aggiunta di solfuro di arsenico (orpimento), in un<br />
vaso di vetro posto nella cenere.<br />
In altra ricetta, l’oro in foglia, messo in crogiolo<br />
coperto, alternato a sale comune, viene calcinato in<br />
forno a riverbero: si ottiene oro frangibile da usare<br />
assieme all’argento per fare il rubino all’oro.<br />
L’ottone, lega di rame, zinco e stagno, diversamente<br />
chiamato Orpello, Tremolante o Canterello a seconda<br />
<strong>del</strong>lo spessore <strong>del</strong>le lamelle, posto in crogioletti<br />
coperti viene calcinato a formare una miscela di ossido<br />
di rame (CuO) e ossidi di zinco e stagno che<br />
danno al vetro un bel colore verde; se nel crogiolo si<br />
alternano anche strati di zolfo, sembrerebbe formarsi<br />
l’ossidulo (Cu 2<br />
O), sempre assieme agli ossidi di<br />
zinco e stagno, utilizzato per i vetri rossi trasparenti,<br />
i gialli e il calcedonio.<br />
Piombo (Litargirio e Minio)<br />
Il litargirio o monossido di piombo (PbO) di colore<br />
giallo si ottiene calcinando il piombo metallico portato<br />
a temperatura di fusione (327°C) in fornello; il<br />
minio o tetrossido di piombo (Pb 3<br />
O 4<br />
) di colore rosso<br />
si otteneva invece calcinando la biacca (carbonato<br />
basico di piombo) mista a sale comune. Nel precedente<br />
capitolo relativo all’anima di Saturno si è visto<br />
che il minio o Rosso di Saturno si otteneva, con un<br />
percorso più lungo, sempre dalla biacca, ma passando<br />
però prima attraverso la formazione <strong>del</strong>l’acetato<br />
di piombo, che poi veniva calcinato.<br />
Nella chimica industriale il minio viene ottenuto invece<br />
calcinando a temperatura più elevata (480°C)<br />
il litargirio.<br />
28
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
Fig. 3: Processo di distillazione nella preparazione <strong>del</strong>l’antimonio o solfuro di antimonio, da pag. 429 (Libro IX) di<br />
Georgius Agricola, De Re Metallica, 1556, H.C. Hoover, L.H. Hoover, Dover Publications, Inc. - New York 1950<br />
Fig. 4: Forno di arrostimento <strong>del</strong> minerale di stagno, da pag. 349 (Libro VIII) di Georgius Agricola, De Re Metallica,<br />
1556, H.C. Hoover, L.H. Hoover, Dover Publications, Inc. - New York 1950<br />
29
4-<strong>2012</strong><br />
studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Piombo e stagno (calcina di piombo stagno)<br />
Piombo e stagno metallici, in rapporti diversi a seconda<br />
<strong>del</strong> vetro da ottenere (lattimo e smalti o gialli<br />
allo stannato di piombo) vengono calcinati assieme<br />
in “fornello”; la “calcina” ottenuta viene ben lavata<br />
con acqua, il residuo dei metalli viene calcinato<br />
nuovamente sino a completa ossidazione con<br />
formazione di ossido stannico (SnO 2<br />
- cassiterite)<br />
e/o stannato di piombo (a seconda <strong>del</strong> rapporto tra<br />
piombo e stagno). Sono da sottolineare le indicazioni<br />
circa le origini <strong>del</strong> Piombo, che di solito proviene<br />
da Ragusa, mentre lo Stagno viene dalla Fiandra;<br />
in altre ricette si dice che si usa il peltro (splaiter)<br />
come fonte di piombo, e si definisce lo stagno come<br />
quello <strong>del</strong> canaletto o di restelo, definizioni riferite<br />
alle modalità di raccolta <strong>del</strong> metallo nel processo di<br />
riduzione dall’ossido.<br />
Stagno (calcina di stagno di colore beretin)<br />
Lo Stagno metallico messo in un contenitore a forma<br />
di elmo (posto sopra un treppiede) viene portato<br />
a fusione (231,85°C) per riscaldamento a legna, si<br />
forma una schiuma scura che macinata viene ulteriormente<br />
calcinata a formare l’ossido stannoso<br />
(SnO) di colore grigio (beretin) (ved. Figura 4).<br />
Precipitato da usare per il rosechiero<br />
Strana ricetta in base alla quale si preparerebbe un<br />
prodotto (riducente?) da usare per il vetro rosso trasparente;<br />
<strong>del</strong> mercurio viene sciolto in acqua forte<br />
particolare (contiene ad abundantiam anche vetriolo,<br />
allume di rocca e ulteriore salnitro), la soluzione<br />
viene poi calcinata sulla cenere per far evaporare il<br />
mercurio, senza comprendere cosa si possa ottenere.<br />
Sal alcali<br />
Il “sal alcali” è un prodotto non univocamente definito,<br />
in qualche caso esso corrisponde al “sale di<br />
soda”. In una ricetta <strong>del</strong>l’Anonimo, unica <strong>del</strong> suo<br />
genere, il sal alcali sarebbe invece un idrato di sodio<br />
o di potassio ottenuto trattando la cenere (sodica o<br />
potassica) con la calcina viva.<br />
Sale decrepitato, fusibile<br />
Due ricette <strong>del</strong> ricettario anonimo trattano di questo<br />
sale che si ottiene per trattamento <strong>del</strong> sale comune,<br />
prima “decrepitandolo”, cioè eliminando per riscaldamento<br />
le molecole d’acqua che i cristalli di cloruro<br />
sodico contengono e poi sciogliendolo in acqua;<br />
dalla soluzione riprecipita un sale <strong>del</strong>iquescente<br />
(“fusibile come cera”). Meccanismo chimicamente<br />
poco chiaro.<br />
Sale di Tartaro<br />
Se la lisciviazione <strong>del</strong>le ceneri sodiche (allume catina)<br />
trova una giustificazione nella eliminazione dei<br />
composti contenenti impurezze importanti di ferro e<br />
di composti organici, la lisciviazione <strong>del</strong> tartaro <strong>del</strong>le<br />
botti, dopo la sua calcinazione, ci sembra abbia<br />
meno significato in quanto tale prodotto contiene<br />
tenori molto limitati di ossido di ferro (0,07%); è<br />
comunque confermato da alcune ricette che il tartaro<br />
calcinato veniva lisciviato ottenendo un prodotto<br />
che veniva aggiunto direttamente alla cenere sodica<br />
oppure alla lisciva <strong>del</strong>la stessa per avere (secondo<br />
l’opinione di Neri) un fondente più abbondante e di<br />
qualità migliore.<br />
Sale di vetro o cenere lisciviata (bollito)<br />
La lisciviazione <strong>del</strong>le ceneri (allume catina o polverino<br />
e barilla di Alicante) serviva ad avere un<br />
fondente esente da impurezze di ferro e composti<br />
organici che davano un colore non gradito al vetro.<br />
La cenere, pestata sottile in mortaio di pietra con pestello<br />
di legno e setacciata, veniva sciolta in acqua e<br />
bollita in caldaia ben stagnata, per farne lisciva; eliminato<br />
l’insoluto, questa veniva poi concentrata per<br />
far precipitare il sale (carbonato sodico) che veniva<br />
poi asciugato in tegami non vetrificati (ved. Figure<br />
5 e 6).<br />
Con la stessa tecnica venivano lisciviate le ceneri di<br />
altri arbusti quali la felce, i gusci e le gambe di fave,<br />
i cavoli, i rovi, la saggina, i giunchi e le cannucce di<br />
laguna, la borràgine; si otteneva un fondente a base<br />
soprattutto potassica. Neri giudica che, ad esempio<br />
con la felce, si poteva ottenere un fondente che dava<br />
un vetro cristallo più dolce <strong>del</strong>l’ordinario.<br />
Soda da vetro<br />
La cenere di felce viene fusa e fatta colare, serve<br />
come fondente.<br />
Tartaro <strong>del</strong>le botti (feccia di vino, gripola)<br />
Il tartaro <strong>del</strong>le botti di vino rosso posto in forno a<br />
riverbero o in pentole di terracotta, sopra i carboni<br />
accesi, viene fatto bruciare sino a che non fuma più<br />
(con l’attenzione di non spingere la calcinazione oltre<br />
un certo punto): il tartaro deve restare nero per<br />
30
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
Fig. 5: La preparazione <strong>del</strong>la soda, da pag. 561 (Libro XII) di Georgius Agricola, De Re Metallica, 1556, H.C. Hoover,<br />
L.H. Hoover, Dover Publications, Inc. - New York 1950<br />
Fig. 6: Bollitura di soluzioni saline sfruttando sorgenti naturali di vapori caldi, da pag. 555 (Libro XII) di Georgius<br />
Agricola, De Re Metallica, 1556, H.C. Hoover, L.H. Hoover, Dover Publications, Inc. - New York 1950<br />
31
4-<strong>2012</strong><br />
studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
dei residui carboniosi, non deve diventare bianco.<br />
Con ciò mantiene la funzione riducente utile nella<br />
produzione di vetri come i rossi al rame o per fare i<br />
gialli ambra.<br />
Verderame<br />
Il Verderame, o Verdigris, acetato basico di rame, si<br />
ottiene trattando rame in foglie sottili con sale ammonico<br />
e aceto; oppure trattando lastre di rame con<br />
vapori di aceto o ancora con i vapori che si sviluppano<br />
dalla fermentazione <strong>del</strong> letame. Il Verderame<br />
viene citato nella ricetta 65 <strong>del</strong>l’Anonimo per fare il<br />
ferretto di Spagna.<br />
Vetriolo<br />
Vetriolo romano purificato per dissoluzione e ricristallizzazione<br />
viene usato per fare, assieme al salnitro,<br />
un’acqua forte “potentissima”.<br />
Vetriolo di Venere si ottiene calcinando in crogioletto<br />
lamine di rame alternate a zolfo; sciolto in acqua<br />
il vetriolo ottenuto lo si fa ricristallizzare, usando<br />
le feccie nere (costituite probabilmente da ossido di<br />
rame) mescolate a <strong>del</strong>la zaffera per colorare il vetro<br />
in “acquamarina meravigliosa”.<br />
Zaffera<br />
La zaffera era costituita da ossido di Cobalto diluito,<br />
in varie proporzioni, con sabbia silicea. L’ossido<br />
puro veniva lisciviato più volte con acqua contenente<br />
sale comune oppure veniva calcinato nell’era o<br />
nel forno stesso e raffreddato poi con aceto.<br />
Zolfo, solfare<br />
Lo zolfo veniva trattato con una lisciva di soda oppure<br />
lisciva di calcina e cenere di faggio per purificarlo<br />
e ottenere lo zolfo fisso (concentrato) e/o<br />
bianco, non combustibile (utilizzato per fare il rosechiero).<br />
Con altra tecnica si trattano i fiori di zolfo in olio<br />
comune e poi si aggiunge aceto fortissimo che fa<br />
precipitare lo zolfo fisso (usato sempre per il rosechiero).<br />
Considerazioni finali<br />
Considerando le diverse tecnologie chimiche utilizzate<br />
dai vetrai nel trattare o preparare i loro materiali,<br />
che abbiamo qui sinteticamente riassunto, dobbiamo<br />
notare che alcune metodiche si ripetono con<br />
una certa frequenza.<br />
Ad esempio, l’operazione di calcinare un metallo<br />
misto a zolfo è indicata per l’argento, il mercurio<br />
(nella preparazione <strong>del</strong>l’azzurro come quello di Alemagna),<br />
l’acciaio e il ferro, il rame (per fare il ferretto<br />
di Spagna e il Vetriolo di Venere) e l’ottone (per<br />
fare l’ossidulo di rame).<br />
Altra tecnica di uso frequente è il raffreddamento<br />
(spegnimento, immersione) dei calcinati in aceto,<br />
così per la limatura di acciaio (nel fare il Crocum<br />
ferri), il manganese e la zaffera; l’aceto serve anche<br />
a dei lavaggi, come nel caso <strong>del</strong>la limatura di ferro<br />
lavata prima o dopo la calcinazione. L’aceto ricorre<br />
inoltre in molti trattamenti, come nella formazione<br />
<strong>del</strong>l’Anima di Saturno per attacco <strong>del</strong> Litargirio,<br />
<strong>del</strong>la Biacca o <strong>del</strong> Ferretto di Spagna e per formare<br />
il Verderame per attacco sul rame metallico; ancora<br />
aceto troviamo nel trattamento dei fiori di zolfo<br />
bolliti in olio comune per farne precipitare lo zolfo<br />
fisso.<br />
32
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
Dell’utilizzo <strong>del</strong>lo scambio cationico tra una soluzione<br />
di un sale e un metallo, abbiamo già messo<br />
in evidenza la particolarità che ricorre sia nel caso<br />
<strong>del</strong>l’argento (piastra di rame a contatto con una soluzione<br />
di nitrato d’argento), sia nel caso <strong>del</strong> rame<br />
(piastra di ferro a contatto con una soluzione di<br />
nitrato di rame); si ha passaggio <strong>del</strong> metallo dalla<br />
soluzione alla piastra con deposito di fiocchi colloidali<br />
utilizzabili nella ricetta vetrificabile meglio <strong>del</strong><br />
metallo, in quanto più solubili o di più facile dispersione.<br />
Altra particolarità che è stata già segnalata, riguarda<br />
la calcinazione <strong>del</strong> solfuro di antimonio con tartaro<br />
e cloruro ammonico; l’ipotesi sui prodotti ottenuti<br />
in tale reazione non è stata verificata praticamente,<br />
ed è quindi è da prendere con riserva.<br />
In conclusione, le reazioni chimiche che risultano<br />
evidenziate nelle prescrizioni presenti nei ricettari<br />
vetrari sono molto interessanti, in quanto danno una<br />
idea <strong>del</strong>la chimica così come praticata nei secoli dal<br />
14° al 17°, in una fase di passaggio dall’alchimia<br />
alla chimica a fini produttivi; sarebbe auspicabile e<br />
utile effettuare una verifica con analoghe prescrizioni<br />
presenti in ricettari relativi ad altri settori.<br />
Resta un senso di ammirazione per i nostri antenati<br />
vetrai, che per avere il materiale vetro necessario<br />
alla lavorazione manuale dovevano prima prepararsi<br />
le sostanze da inserire nella composizione vetrificabile,<br />
sommando quindi insieme una capacità di<br />
manipolazione plastica <strong>del</strong> vetro ad una conoscenza,<br />
per quanto necessario, dei processi chimici.<br />
QUADRO SINOTTICO<br />
DEI PROCEDIMENTI<br />
Acqua forte<br />
Acido Nitrico (per sciogliere l’Argento e il Mercurio)<br />
a) Salnitro + allume di rocca o vetriolo romano + Arsenico<br />
cristallino ( Neri 38)<br />
Acqua regia<br />
Acido Nitrico e Acido Cloridrico (per sciogliere l’oro e i metalli<br />
nobili)<br />
a) Acqua forte + sale ammonico a più riprese, eliminando<br />
la “terrestreità” insoluta (Neri 40, Brunoro 11)<br />
Anima di Saturno<br />
Acetato di piombo (in alternativa al minio per fare gli smalti)<br />
a) Litargirio + Aceto distillato, precipita l’acetato di<br />
piombo lattiginoso (Neri123, Brunoro 21)<br />
b) Biacca (cerussa) + Aceto distillato (si forma sale o<br />
zucchero di Saturno cioè l’acetato idrato di piombo, bianco,<br />
che viene poi calcinato a formare lo Zolfo o rosso di<br />
Saturno cioè una variante di Minio di colore rosso come il<br />
cinabro (Neri 91, Brunoro 93)<br />
Antimonio<br />
Antimoniuro di potassio e tartaro emetico (?) – colorante giallo<br />
e medicina<br />
a) Sale ammonico + tartaro + antimonio solfuro + calcinazione<br />
(Brunoro 22)<br />
Argento calcinato:<br />
a) Dissoluzione in acqua forte e aggiunta sale comune<br />
o acqua di mare con formazione di cloruro d’argento<br />
(Montpellier 65, Darduin 99)<br />
b) Dissoluzione in acqua forte e scambio cationico con<br />
<strong>del</strong> rame metallico con sviluppo di fiocchi di argento colloidale<br />
sul rame stesso (Brunoro 1)<br />
c) Calcinazione <strong>del</strong>l’argento misto a zolfo - aggiunta al<br />
calcinato di Bolo Armeno, Cinabro e ossido di rame, per<br />
avere la “medicina” per fare il calcedonio (Montpellier 78,<br />
Brunoro 176, Anonimo 15)<br />
d) Calcinazione di una lega tra argento e stagno fusi assieme<br />
(Brunoro 51)<br />
e) Calcinazione <strong>del</strong>l’amalgama di argento e mercurio,<br />
mista a sale comune, sino ad evaporazione <strong>del</strong> mercurio;<br />
si aggiunge poi cloruro di mercurio, sale ammonico, cinabro<br />
e zolfo sempre per preparare la “medicina” per il<br />
calcedonio (Brunoro 178, Montpellier 91, Anonimo 105)<br />
f) Dissoluzione <strong>del</strong>l’argento e, a parte, di mercurio in<br />
acqua forte; riunite le soluzioni, si aggiungono altri coloranti<br />
come la zaffera, il manganese, il ferretto di Spagna,<br />
il Croco di Marte, l’ossido di rame, lo smalto azzurro, il<br />
cantarello, il vetriolo ecc. sempre per fare il calcedonio<br />
(Neri 42, Neri 43, Neri 44) (Brunoro 54)<br />
33
4-<strong>2012</strong><br />
studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Azzal (acciaio)<br />
a) Calcinazione di una barra di acciaio, raffreddata,<br />
spenta, in aceto<br />
Azzurro<br />
a) Zaffera in olio di tartaro, seccata al fuoco (Montpellier<br />
31)<br />
b) Azzurro (o zaffera?) trattato con sale comune<br />
Azzurro come quello d’Alemagna<br />
c) Calcinazione (o distillazione) di Argento vivo + fiori<br />
di zolfo + sale ammonico (Neri 111, Brunoro 23)<br />
Cristallo di Rocca e ciottoli di quarzo<br />
a) Si calcina il Cristallo di Rocca (di Montagna) in crogiolo<br />
coperto, quando caldo lo si getta in acqua fredda<br />
per fare una prima frantumazione, macinazione da continuare<br />
poi su porfido o su mortaio di vetro (Brunoro 14).<br />
In Brunoro 15, per un probabile errore di trascrizione, si<br />
asserisce di gettare il Cristallo di Rocca infuocato nell’acqua<br />
regia<br />
b) Pietra bianca o marmo bianco cioè ciottoli di quarzo<br />
o cristallo di rocca o montagna, scaldata al calor rosso in<br />
fornetto, viene gettata in acqua per frantumarla grossolanamente<br />
(Primo Tratt. Toscano 31, Secondo Tratt. Toscano<br />
25, Terzo Tratt. Toscano 10), granuli ridotti a polvere<br />
sottile su mola di porfido (Terzo Tratt. Toscano 10)<br />
Crocum ferri o Croco di Marte<br />
(ossido di ferro)<br />
a) Lastre di ferro messe nella calchera (forno a riverbero)<br />
per almeno 24 ore, si forma ossido superficiale (Secondo<br />
Tratt. Toscano 7 e 26)<br />
b) Limatura di ferro trattata con acqua forte (acido nitrico),<br />
si evapora la soluzione e si calcina il precipitato in<br />
forno a riverbero (Secondo Tratt. Toscano 37) (Neri 18)<br />
c) Limatura di ferro trattata con acqua regia, segue evaporazione<br />
(Neri 19) (Brunoro 10 e 282)<br />
d) Limatura di ferro lavata con aceto forte, viene poi calcinata<br />
in forno di riverbero (Secondo Tratt. Toscano 38)<br />
(Brunoro 7) (Neri 17 e Brunoro 121 fanno solo il trattamento<br />
con aceto senza la calcinazione)<br />
e) Limatura di ferro o acciaio mista a zolfo, calcinata<br />
in tegame non vetrificato, aggiungendo poi aceto (Terzo<br />
Tratt. Toscano 6)<br />
f) Limatura di acciaio calcinata (Montpellier 55) e gettata<br />
in aceto (Anonimo 95, Darduin 108)<br />
g) Ferrugine pesto misto a sale comune e zolfo, impastato<br />
con aceto a farne pani da calcinare in forno per 8 o 10<br />
giorni (Montpellier 58)<br />
h) Limatura di acciaio mista a zolfo, messa in crogiolo e<br />
calcinata in fornello e poi ricalcinata nell’era <strong>del</strong>la fornace<br />
(Neri 16) (Brunoro 18)<br />
i) Limatura di acciaio mista a zolfo, messa in crogiolo e<br />
calcinata e poi gettata in aceto (Anonimo 66)<br />
Ferretto di Spagna (ossido di rame)<br />
a) Si calcina il rame in pentola non vetrificata, coperta<br />
(quindi in carenza di ossigeno), si forma l’ossidulo “rosso<br />
come sangue” (o crocum di rame), che poi viene trattato<br />
con aceto col che si ottiene un ossido (nero o rosso?) che<br />
colora il vetro in verde (Terzo Tratt. Toscano 7)<br />
b) Si calcinano lamine sottili di rame miste a zolfo in<br />
crogioletti da orefici coperti, lutati, in forno a vento; si<br />
ottiene ossido di colore nericcio-rossiccio che dovrebbe<br />
essere ancora l’ossidulo (Neri 14) (Brunoro 283) (Brunoro<br />
4)<br />
c) Calcinazione di lamine sottili di rame miste a vetriolo<br />
(di Venere o Romano?) in crogiolo (aperto?) vicino<br />
all’occhio <strong>del</strong>la fornace; dovrebbe in questo caso formarsi<br />
l’ossido CuO ( Neri 15) (Brunoro 5)<br />
d) Calcinazione di lamine sottili di rame miste a zolfo<br />
in crogioletto in fornace, si forma ossido nero che, estinto<br />
in olio di lino, si trasforma in ossidulo Cu 2<br />
O rosso come<br />
sangue (Anonimo 64)<br />
e) Verderame (acetato di rame) o Ferretto di Spagna (ossido<br />
di rame) trattato con aceto, concentrata la soluzione<br />
precipitano i cristalli (lapilli) di acetato di rame (?) (Anonimo<br />
65)<br />
f) Calcinazione di lamine di rame tra due mattoni nel<br />
forno e poi si fa bollire in aceto l’ossido ottenuto (Anonimo<br />
96) (simile a Darduin 296)<br />
Manganese<br />
a) Manganese di Piemonte posto in cucchiaio (cassa) di<br />
ferro, arrostito nella bocca <strong>del</strong>la fornace poi sbruffato con<br />
aceto, lavato con acqua ed essiccato (Neri 13, Brunoro 9)<br />
b) Miscela colorante preparata (con calcinazione e fusione)<br />
con sale di cristallo, sale di tartaro e manganese,<br />
probabilmente si forma un manganato di sodio e di potassio<br />
(Brunoro 327)<br />
Metalli in genere<br />
a) Si calcina in vaso di vetro, messo nella cenere, un<br />
metallo ( ferro, rame, argento, oro) cui viene aggiunto<br />
<strong>del</strong>l’orpimento (solfuro di arsenico) (Montpellier 37) - ricetta<br />
confusa<br />
Oro<br />
a) Oro in foglia (ottenuto battendo dei ducati ) messo<br />
in crogiolo coperto, alternato a sale comune, calcinato in<br />
fuoco di riverbero; si ottiene oro calcinato frangibile da<br />
usare con l’argento per fare il rubino (?) (Darduin 98)<br />
Orpello, Tremolante, Cantarello<br />
(lega di rame, zinco e stagno)<br />
a) L’orpello o Tremolante tagliato in pezzetti e messo<br />
34
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
in crogioletto coperto e lutato a calcinare ma senza che<br />
fonda, si forma un ossido di rame (CuO o Cu 2<br />
O ?) misto<br />
ad ossido di zinco e stagno che dà al vetro un colore intermedio<br />
tra l’acqua marina e il colore <strong>del</strong> cielo (Neri 20)<br />
b) Il Cantarello tagliato in piccoli pezzi, messo in crogiolo<br />
a strati alterni con zolfo, calcinato, poi, pesto e<br />
setacciato, viene ricalcinato in tegame di terra coperto e<br />
forma l’ossidulo di rame misto a ossido di zinco e stagno,<br />
da usare per i vetri rossi trasparenti, i gialli e il calcedonio<br />
(Neri 21, Brunoro 6)<br />
Piombo (Litargirio e Minio)<br />
a) Piombo metallico portato a fusione (327°C) in fornello<br />
(?) si ossida a monossido di colore giallo (Litargirio)<br />
che viene estratto man mano (Neri 62, Brunoro 12)<br />
b) Biacca alternata a strati di sale comune purificato,<br />
calcinata per nove giorni, porta alla formazione <strong>del</strong> Minio<br />
di colore rosso come il cinabro (Montpellier 53)<br />
Piombo e stagno (calcina di piombo stagno)<br />
a) Piombo e Stagno metalli calcinati assieme in fornello,<br />
il calcinato viene lavato con acqua per ricuperare i residui<br />
metallici sottili da ricalcinare. Con la calcina, fritta<br />
di cristallo e tartaro si fa il vetro base o Materia per fare<br />
tutti gli smalti (Neri 93, Brunoro 13)<br />
b) Piombo e stagno metallici calcinati in gran fuoco,<br />
senza i lavaggi di cui sopra (Darduin 96 e 97)<br />
Precipitato (da usare per il rosechiero)<br />
a) Acqua forte, vetriolo romano, salnitro, allume di rocca,<br />
argento vivo, il tutto in beuta per sciogliere il mercurio,<br />
poi a caldo sulla cenere per calcinarlo e avere un<br />
additivo da usare per fare il rosso trasparente o rosechiero<br />
Ramina rossa e ramina di tre cotte<br />
(ossidi di rame)<br />
a) Lamine sottili di rame, calcinate, si forma l’ossido<br />
rosso che viene gettato in urina per raffreddarlo e mantenerlo<br />
in forma ridotta (Montpellier 77)<br />
b) Lamine sottili di rame, murate (in fornello o nell’era,<br />
ma a temperatura tale che non si abbia fusione <strong>del</strong> metallo)<br />
quindi messe in ambiente con carenza di ossigeno, si<br />
ha formazione <strong>del</strong>l’ossidulo rosso (Neri 24) (Brunoro 16)<br />
c) La ramina rossa o di prima cotta (ossidulo), messa<br />
su tegami di terracotta, viene ulteriormente calcinata in<br />
fornello o nell’era, per trasformarla nell’ossido rameico o<br />
di terza cotta di colore nero (Neri 25)<br />
d) Scaglie di rame, prodotte dai calderai nel battere il<br />
rame, vengono lavate con acqua e poste in tegami di terra<br />
cotta nell’era <strong>del</strong> forno; si forma direttamente l’ossido<br />
nero (quindi senza passare attraverso l’ossido rosso) (Neri<br />
28) (Brunoro 3)<br />
e) Lamine “grossette” di rame poste nel fornello ad alta<br />
temperatura si ossidano superficialmente; l’ossido viene<br />
tirato via, pestato e setacciato e ricalcinato (non è chiaro<br />
se ricalcina l’ossido o la lamina cui ha tolto l’ossido superficiale)<br />
(Darduin 102)<br />
f) Procedimento diverso, si scioglie il rame in acqua<br />
forte, poi si immerge nella soluzione una piastra di ferro,<br />
si ha scambio cationico tra rame e ferro, con deposito di<br />
rame colloidale, polverulento (Brunoro 2)<br />
Sal alcali<br />
a) Cenere + calcina viva (ossido di calcio), si fa lisciva e<br />
si ottiene probabilmente <strong>del</strong>l’idrato sodico<br />
Sal decrepitato, fusibile, preparato<br />
a) Si scioglie <strong>del</strong> sale comune in acqua e si fa bollire<br />
sino a precipitazione <strong>del</strong> sale; si ripete più volte e si ottiene<br />
<strong>del</strong> sale fusibile come cera (cioè <strong>del</strong>iquescente) (Terzo<br />
Tratt. Toscano 58)<br />
b) Variante <strong>del</strong>la precedente, in quanto il sale viene prima<br />
scaldato a secco (finchè scoppietta, per togliergli quindi<br />
la decrepitazione, cioè far uscire l’acqua madre contenuta<br />
nei cristalli); seguono poi ripetute dissoluzione in<br />
acqua e riprecipitazioni. Si ottiene un sale <strong>del</strong>iquescente,<br />
fusibile come cera (Anonimo 68)<br />
c) Sale comune trattato con calce viva, si calcina la miscela<br />
e poi si scioglie in acqua, si filtra, si raffredda e si fa<br />
precipitare; il prodotto ottenuto dovrebbe essere l’idrato<br />
sodico che però viene chiamato ancora, come nei due casi<br />
precedenti, sale fusibile (Anonimo 70)<br />
Sal di tartaro<br />
a) Tartaro <strong>del</strong>le botti di vino rosso, calcinato senza che<br />
divenga bianco, in “pignata” di terra tra carboni accesi o<br />
nel fornello, sciolto in acqua e fatta lisciva, che filtrata,<br />
viene poi concentrata così che precipiti il sale di tartaro;<br />
l’operazione si ripete più volte sino ad ottenere un sale<br />
bianchissimo che verrà aggiunto in proporzione <strong>del</strong> 10%<br />
alla cenere sodica (al polverino di allume catina oppure<br />
alla Barilla, soda di Alicante) per fare un Cristallo fino<br />
(Brunoro 24, Neri 11)<br />
Sale di vetro o cenere lisciviata<br />
a) Le cenere sodica (precisata come Polverino o Barilla<br />
di Alicante, nel Neri) viene pestata sottile in mortaio<br />
di pietra, con pestello di legno (per non inquinarla con<br />
mortai di metallo), viene poi setacciata e sciolta in acqua<br />
e bollita in caldaia ben stagnata, per farne lisciva (mescolando<br />
sempre con mestolo non metallico, di legno);<br />
si filtra e si elimina l’insoluto. Sono previste aggiunte di<br />
tartaro per migliorare la qualità e quantità <strong>del</strong> sale ottenuto.<br />
La lisciva viene poi concentrata per far precipitare<br />
il sale, che viene tolto man mano e messo ad asciugare in<br />
tegami non vetrificati (Terzo Tratt.Toscano 1 e 2) (Neri 1)<br />
(Anonimo 1 e 103) (Brunoro 54)<br />
b) Cenere di felce viene lisciviata come quella sodica,<br />
35
4-<strong>2012</strong><br />
studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
darà un sale fondente potassico che Neri dice produrre un<br />
vetro Cristallo più dolce <strong>del</strong>l’ordinario; aggiunge anche<br />
che, non mettendoci il tartaro come nelle precedenti ricette,<br />
se ne può fare un vetro di colore giallo dorato splendido<br />
(Neri 5)<br />
c) Cenere di diversi arbusti (gusci e gambe di fave, cavoli,<br />
rovi, saggina, giunchi e cannucce di laguna) lisciviata<br />
dà luogo a un sale fondente (a base potassica) (Neri<br />
6) (Brunoro 109)<br />
d) Cenere di borrana (borràgine) lisciviata dà egualmente<br />
un sale per farne fondente, in questo caso ne fa pani<br />
da fritta con aggiunta di quarzo e limatura d’ottone per<br />
ottenere un vetro <strong>del</strong> colore rosso <strong>del</strong>la lacca (Primo Tratt.<br />
Toscano 36)<br />
e) Con il sale <strong>del</strong>la calcina (che serve forse per legare i<br />
mattoni dei muri o per l’intonaco) costituito probabilmente<br />
da carbonato di calcio mescolato al sale di polverino in<br />
proporzione <strong>del</strong> 2%, si ottiene un fondente che darà <strong>del</strong><br />
vetro comune o <strong>del</strong> cristallino o <strong>del</strong> cristallo assai “vago<br />
e bello” (Neri 7)<br />
Soda da vetro<br />
a) Cenere di felce fusa in crogiolo, viene fatta colare da un<br />
pertugio e usata come fondente (Primo Tratt.Toscano 34)<br />
Solfere fisso (vedi zolfo)<br />
Stagno (calcina di stagno)<br />
a) Stagno metallico messo in un catino metallico a forma<br />
di elmo, viene scaldato all’aperto per calcinare e ricalcinare<br />
lo stagno a ossido stannoso (finchè diventa grigio<br />
ovvero beretin) (Darduin 100)<br />
Tartaro<br />
a) Tartaro <strong>del</strong>le botti (feccia di vino - gripola) viene posta<br />
in forno a riverbero (calchera) ben caldo si lascia ardere<br />
(calcinare) sino che diventa nero - serve per fare il vetro<br />
giallo ambra (Secondo Tratt. Toscano 8 e 27)<br />
b) Il tartaro di vino rosso, in pezzi, non la polvere, messo<br />
in pignatte di terra nuove tra i carboni accesi, si fa bruciare<br />
sino a quando non fuma più (Neri 41, Brunoro 17,<br />
Darduin 102). Del tartaro calcinato se ne aggiunge dieci<br />
libbre per caldaia alla lisciva di cenere per fare il cristallo<br />
(Brunoro 8)<br />
Verderame<br />
a) Rame in foglia sottile, tagliato a piccoli pezzi, oppure<br />
limatura di rame viene mescolato a sale ammonico (come<br />
cimentazione) e trattato quindi con aceto, per 11 giorni<br />
(Secondo Tratt. Toscano 44)<br />
b) In alternativa si copre un vaso contenente aceto e orzo<br />
con una lamina di rame, posto il tutto al sole, in pochi<br />
giorni si formerà sulla lastra il verderame o acetato di<br />
rame (Secondo Tratt. Toscano 44)<br />
c) Una lastra di rame posta in una olla, messa ben chiusa<br />
sotto il letame, viene attaccata dai vapori corrosivi (ossido<br />
di azoto, ammoniaca ecc.) che si sviluppano dal letame<br />
stesso (Darduin 109)<br />
Vetriolo<br />
a) Si purifica il vetriolo romano (solfato di ferro) per<br />
eliminarne le feccie gialline (zolfo?) e fare ricristallizzare<br />
il solfato in lapilli, che si userà per fare, col salnitro, l’acqua<br />
forte (Neri 39)<br />
b) Si calcinano in crogioletto lamine di rame alternate<br />
a zolfo; si ha formazione di vetriolo di Venere (solfato di<br />
rame) o ossido di rame (?) (Neri 31 e 131 e 132) che si<br />
scioglie in acqua e si fanno precipitare i lapilli (cristalli)<br />
(Neri 133). Le fecce di colore nero (ossido di rame?) mescolate<br />
a zaffera servono per fare una acquamarina meravigliosa.<br />
Ricette tutte confuse, poco chiare.<br />
Zaffera<br />
a) La zaffera, ossido di cobalto (in questo caso puro,<br />
non miscelato a sabbia silicea), viene lisciviata per tre<br />
volte con acqua contenente sale comune (Primo Tratt. Toscano<br />
25)<br />
b) Si calcina la zaffera (anche in questa ricetta l’ossido<br />
di cobalto sembra puro) prima in tegami di terra, entro la<br />
camera <strong>del</strong> forno (nell’era?) e poi, posta in un cazza di<br />
ferro, entro al forno, raffreddandola quindi con getti di<br />
aceto; poi macinata e lavata con acqua (Neri 12, Brunoro<br />
19)<br />
c) Si calcina la zaffera nella calchera (forno a riverbero)<br />
con un calo in peso <strong>del</strong> 16% (Darduin 209)<br />
Zolfo, solfare<br />
a) Si tratta lo zolfo con una lisciva di soda per purificarlo<br />
e ottenere lo zolfo “fisso” (concentrato, depurato,<br />
buono per fare il rosechiero)<br />
b) Si bollono i fiori di zolfo in olio comune per un’ora,<br />
poi si aggiunge aceto fortissimo che fa precipitare lo zolfo<br />
fisso (utile sempre per il rosechiero) (Neri 126, Brunoro<br />
20)<br />
c) In una lisciva di calcina (?) e cenere di faggio si fa<br />
bollire lo zolfo, che diventa bianco e non combustibile (?),<br />
fisso utile per fare il rosechiero (rosso al rame usato negli<br />
smalti su oro) (Neri 130)<br />
36
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
GLOSSARIO<br />
Delle materie citate nelle ricette<br />
(Versione 8 giugno 2006)<br />
Acciale: acciaio<br />
Aceto distillato: aceto di vino, distillato<br />
Acqua forte: acido nitrico misto ad acido solforico (?)<br />
Acqua regia: acido nitrico misto ad acido cloridrico<br />
Acqua salsa: acqua di mare<br />
Allume di rocca, allume di rocho: kalinite, solfato idrato di<br />
alluminio e potassio<br />
Amalgama: amalgama tra mercurio e metalli nobili (argento, oro)<br />
Anima di Saturno: acetato neutro di piombo ottenuto per trattamento<br />
<strong>del</strong> Litargirio con aceto<br />
Antimonio: antimonio ossido o solfuro<br />
Antimonio crudo: antimonio solfuro, stibina<br />
Argento fino: argento ad alto titolo<br />
Argento vivo: mercurio<br />
Arsenico cristallino: triossido di arsenico As 2<br />
O 3<br />
Arzento di coppella: argento ottenuto da fusione ossidante di<br />
una lega piombo argento in un forno a riverbero detto coppella<br />
Arzento sulimado: argento vivo sublimato, sublimato corrosivo,<br />
cloruro di mercurio HgCl 2<br />
Azzal (limadura): acciaio<br />
Azzurro d’Alemagna (azuro <strong>del</strong>la Magna): carbonato basico<br />
di rame<br />
Azzurro oltremarino: azzurro di Berlino, il più bello e puro<br />
colore azzurro <strong>del</strong>l’antichità (civiltà mesopotamiche, Egitto),<br />
si otteneva macinando la pietra preziosa lapislazzuli<br />
Biacca, sbiacca: carbonato basico di piombo<br />
Calcina: calcina di piombo, calcina di stagno, calcina di piombo<br />
stagno, è il risultato <strong>del</strong>l’ossidazione a caldo dei metalli<br />
piombo e stagno da soli o mescolati assieme. Nella calcina di<br />
piombo-stagno si ha presenza di stannato di piombo mescolato<br />
a biossido di stagno (cassiterite). La calcina di piombo stagno<br />
serviva alla produzione dei vetri opachi bianchi (lattimo)<br />
e gialli (anime)<br />
Canterello: detto anche orpello, tremolante, ottone (lega di<br />
rame e zinco) in fogli sottili<br />
Capo morto di vetriolo: residuo che rimane nel fondo dei recipienti<br />
in cui si è fatta la distillazione <strong>del</strong> vetriolo, costituito da<br />
ossido di ferro<br />
Cenaprio, cinabro: solfuro di mercurio di colore rosso (HgS)<br />
Cerussa di piombo, cerusa: biacca, carbonato basico di piombo,<br />
PbCO 3<br />
Corchoni: vedi croco di ferro<br />
Cristallo di rocca o cristallo di Montagna: quarzo ialino (SiO 2<br />
)<br />
trasparente, incolore, si presenta in natura in cristalli ben formati<br />
che possono raggiungere il peso di qualche chilogrammo<br />
Croco di ferro, crocum ferri: detto anche Croco di Marte o<br />
Zafferano di Marte, sostanza di colore rossastro in buona parte<br />
costituita da ossido di ferro (Fe 2<br />
O 3<br />
)<br />
Croco di Marte: vedi croco di ferro<br />
Croco di rame: detto anche croco di Venere, ossido di rame<br />
Fereto o Ferretto di Spagna: ossido di rame<br />
Ferro (limatura di): limature di acciaio<br />
Gialolin de vero de piombo: giallolino, prodotto vetroso, basso<br />
fondente, chiamato “anima” dai vetrai, opacizzato in giallo<br />
mediante antimoniato di piombo e/o stannato di piombo<br />
Gripola ovvero tartaro: gruma <strong>del</strong>le botti di vino, di solito vino<br />
rosso, utilizzata come riducente nei vetri rossi al rame<br />
Lacca chermisi: lacca tratta dal kermes, anche Lacca di Firenze<br />
Limagia di ferro: limatura di ferro<br />
Litargirio: Monossido di piombo giallo, PbO<br />
Lume di piuma: allume di piuma, solfato di ferro e potassio<br />
Manganese di Piemonte: pirolusite, biossido di manganese,<br />
usato in piccole percentuali come decolorante, o, in tenori più<br />
elevati, come colorante ametista<br />
Marmo bianco: probabilmente riferito a ciottoli di quarzo e<br />
non a calcare, carbonato di calcio 8di norma non indicato nei<br />
ricettari sino al 19° secolo)<br />
Mercurio: mercurio metallico (Hg) usato per fare amalgama<br />
coi metalli come oro e argento<br />
Minio: tetrossido di piombo rosso, Pb 3<br />
O 4<br />
Oro: oro metallico usato per fare il rosechiero o rubino all’oro,<br />
dal 17° secolo<br />
Orpimento: auripigmento, solfuro di arsenico giallo bruno<br />
(As 2<br />
S 3<br />
)<br />
Pietra bianca: quarzo in ciottoli o in roccia<br />
Piombo da Ragusi (Ragusa): piombo metallico proveniente da<br />
Ragusa (Dalmazia)<br />
Piombo splaiter: piombo o lega di piombo (peltro)<br />
Polverino: allume catina in polvere<br />
Rame: rame metallico (Cu)<br />
Rame nero: ossido rameico (CuO) di colore nero detto anche<br />
rame di terza cotta<br />
Ramina rossa; protossido di rame Cu 2<br />
O di colore rosso, detto<br />
anche ramina di prima cotta<br />
Ritargirio, ritrigerio: Litargirio, monossido di piombo PbO<br />
Salarmoniaco, sale armonico: sale ammonico, cloruro d’ammonio,<br />
NH 4<br />
Cl<br />
Sale comune: cloruro sodico<br />
Sale di piombo bianco: idrocerussite, carbonato idrato di<br />
piombo, 2PbCO 3<br />
. Pb(OH)<br />
2<br />
Sale di Saturno bianco,dolce come zucchero: vedi Anima di<br />
Saturno<br />
Sale di tartaro: sale, a base di carbonato di potassio, ottenuto<br />
dalla lisciviazione <strong>del</strong> tartaro calcinato<br />
Salnitro, salnitrio: nitrato potassico, KNO 3<br />
Soda di Alicante, barilla: ceneri <strong>del</strong>la pianta salsola sativa<br />
Solfere citrino: zolfo<br />
Stagno <strong>del</strong> canaletto: stagno metallico<br />
Stagno de Fiandra: stagno metallico proveniente dalla Fiandra<br />
Tartaro calcinato: carbonato di potassio K 2<br />
CO 3<br />
Vetriolo di Venere: vetriolo azzurro.solfato idrato di rame,<br />
CuSO 4<br />
.5H 2<br />
O<br />
Vitriolo Romano: vetriolo verde, solfato idrato di ferro,<br />
37
4-<strong>2012</strong><br />
studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
FeSO 4<br />
.7H 2<br />
O<br />
Zafaro, zaffaro: ossido di cobalto, CoO, diluito in sabbia silicea<br />
Zelamina: giallamina, calamina: carbonato di zinco ZnCO 3<br />
Zolfo di Saturno (Rosso di saturno): tetrossido di piombo<br />
Pb 3<br />
O 4<br />
, minio<br />
Zucchero di Saturno: acetato idrato di piombo,<br />
Pb(C 2<br />
H 2<br />
O 2<br />
)<br />
2 .3H 2 O<br />
CHIMICA VETRAI - Bibliografia<br />
Ricettari<br />
Anonimo, Recette per fare vetri colorati et smalti<br />
d’ogni sorte havute in Murano 1536, Ms. n. H486, Biblioteque<br />
de l’Ecole de Medicine di Montpellier (Francia)<br />
Antonio Neri, L’arte Vetraria <strong>del</strong> Neri - a cura di Rosa<br />
Barovier Mentasti - Edizioni “Il Polifilo” Milano, 1980<br />
Antonio Neri, L’arte Vetraria - Introduzione e cura di<br />
Ferdinando Abbri, 2001, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze<br />
Dell’Arte <strong>del</strong> vetro per Musaico- tre trattatelli dei secoli<br />
XIV e XV ora per la prima volta pubblicati. Trattato<br />
Primo, anonimo; Trattato Secondo, Benedetto di Baldassarre<br />
Obriachi, fiorentino; Trattato Terzo, anonimo, <strong>del</strong><br />
MCCCCXLIII. Ristampa dal Manoscritto n. 797 all’Archivio<br />
di Stato di Firenze; testo pubblicato da Gaetano<br />
Milanesi nel 1864 a Bologna, ristampa fotomeccanica nel<br />
1968, Editrice Forni - Bologna<br />
Giovanni Darduin, In nomine Domini Nostri Jesu<br />
Christi Beataeque Virginis Matris Mariae, anno a Nativitate<br />
Domini Millesimo Sexcentesimo Quadrigesimo<br />
Quarto, die secunda mensis Martii, Joannes Darduino<br />
quondam Nicolai : Copie de tutti li secreti de smalti cavate<br />
dalli libri et altre carte <strong>del</strong>la buona memoria di mio<br />
padre…, Archivio di Stato, Venezia (Miscellanea di atti<br />
diversi manoscritti, F. 41)<br />
Manoscritto Anonimo <strong>del</strong> ‘500, proprietà privata<br />
Manoscritto 5461 <strong>del</strong>la Biblioteca Casanatense in<br />
Roma, redatto a Danzica il 13 gennaio 1645 (Sperimentato.<br />
da Gasparo Brunoro detto 3 Corone da Muran di<br />
Venezia, mastro di Cristal e di colori famosissimi…)<br />
Saggi e Fonti<br />
1. AA.VV., 1986, La fabbrica dei colori: pigmenti e<br />
coloranti nella pittura e nella tintoria, Il Bagatto, Roma<br />
2. Georgius Agricola, De re Metallica, Tradotto da Hoover<br />
H.C., Hoover L.H. dall’edizione latina <strong>del</strong> 1556, Dover<br />
Publications, Inc. - New York 1950 (prima edizione:<br />
The mining Magazine, London 1912)<br />
3. Gettens R.J. 1986, in La fabbrica dei colori: pigmenti<br />
e coloranti nella pittura e nella tintoria, Il Bagatto, Roma<br />
4. Gettens R.J.,Stout G.L., 1966, Painting materials. A<br />
short encyclopedia, Dover Publications, New York (ristampa<br />
<strong>del</strong>l’originale <strong>del</strong> 1942 edito da D. Van Nostrand<br />
Company)<br />
5. Harley R.D., 1970, Artists pigments c. 1600-1835, a<br />
study in english documentary sources, New York, American<br />
Elsevier Pub. Co., p. 89<br />
6. Mainieri F.R., 2002, Il cinabro, in R. Varoli-Piazza (a<br />
cura di) Raffaello, La Loggia di Amore e Psiche alla Farnesina,<br />
Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (MI), pag. 181-197<br />
38
4-<strong>2012</strong> studies<br />
studi<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
7. Merrifield, M. P., 1999, Medieval and Renaissance<br />
Treatises on the Arts of painting , Dover Publications Inc.<br />
New York (prima edizione Londra 1849)<br />
8. Moretti C., 2002, Glossario <strong>del</strong> vetro Veneziano, dal<br />
Trecento al Novecento, Marsilio editori, Venezia<br />
9. Moretti C., Gratuze B., 1999, Vetri rossi al rame e avventurina.<br />
Confronto di analisi e ricette, Rivista <strong>Stazione</strong><br />
<strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, n. 3, pagg. 147-160<br />
10. Moretti C., Hreglich S., 1984, Opacifi cation and colouring<br />
of glass by the use of “anime”, Glass Technology,<br />
vol. 25, n. 6, p.p. 277-282<br />
11. Moretti C., Hreglich S., 2005, Tecniche di produzione<br />
dei vetri opachi impiegate dai vetrai veneziani tra il XV<br />
e XX secolo, Rivista <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, n.<br />
5-2005, p. 15-32<br />
12. Moretti C., Toninato T., 1987, “Cristallo” e “<strong>Vetro</strong> di<br />
piombo” da ricettari <strong>del</strong> ‘500, ‘600, ‘700, Rivista <strong>Stazione</strong><br />
<strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, n. 1, pagg. 31-40<br />
13. Moretti C., Toninato T., 2001, Ricette vetrarie <strong>del</strong><br />
Rinascimento, Trascrizione da un manoscritto anonimo<br />
veneziano, Marsilio editori, Venezia<br />
14. Moretti C., Salerno C.S., Tommasi Ferroni S., 2004,<br />
Ricette Vetrarie Muranesi- Gasparo Brunoro e il manoscritto<br />
di Danzica, Istituto centrale <strong>del</strong> restauro/Nardini<br />
editore<br />
15. Salerno C.S., Tommasi Ferroni S., 1999, Pigmenti a<br />
base di vetro nella pittura rinascimentale e barocca da<br />
ricettari muranesi editi ed inediti, Rivista <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong><br />
<strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, n. 6, pp. 293-302<br />
16. Salerno C.S., Tommasi Ferroni S., 1998, Pigments a<br />
base de verre dans la peinture de la Renaissance et du Baroque<br />
d’après des traités de Murano édités et inédits, Atti<br />
Congresso Art et Chimie, La Couleur, Parigi, pagg. 43-47<br />
17. Salerno C.S., 2001, Lo smaltino e i gialli di fornace:<br />
loro produzione e i metodi di applicazione, Atti <strong>del</strong> Convegno<br />
Fotonica y Arte, Barcellona, maggio 2001, pag. 51<br />
18. Stout, G.L., 1966, Artists Pigments, c. 1600-1835, a<br />
study in english documentary sources, New York, American<br />
Elsevier Pub. Co., p. 129<br />
19. Zecchin L., 1986, Il Ricettario Darduin, un codice<br />
vetrario <strong>del</strong> seicento trascritto e commentato, edito a cura<br />
di A. Tucci e M. Verità (<strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>)<br />
e R. Barovier Mentasti, da Arsenale editrice, Venezia,<br />
pagg. 265<br />
20. Zecchin L., 1987, <strong>Vetro</strong> e Vetrai di Murano, Volume<br />
I, editore Arsenale editrice, Venezia<br />
21. Zecchin L., 1989, <strong>Vetro</strong> e Vetrai di Murano, Volume<br />
II, editore Arsenale editrice, Venezia<br />
22. Zecchin L., 1990, <strong>Vetro</strong> e Vetrai di Murano, Volume<br />
III, editore Arsenale editrice, Venezia<br />
Enciclopedie - Dizionari - Manuali<br />
Dizionario <strong>del</strong> dialetto veneziano di Giuseppe Boerio<br />
(1829) seconda edizione aumentata e corretta, Venezia,<br />
Premiata Tipografia di Giovanni Cecchini editore, 1856<br />
(ristampa anastatica Aldo Martello Editore, Milano, 1971)<br />
Dizionario <strong>del</strong> restauro e <strong>del</strong>la diagnostica, Cristina<br />
Giannini, Roberta Roani, Nardini editore, 2003 (seconda<br />
edizione)<br />
Dizionario di Alchimia - Paracelso, Gino Testi, a cura<br />
di Stefano Andreani, ristampa 1998, Edizioni Mediterranee<br />
Roma<br />
Dizionario di Merciologia e di Chimica Applicata,<br />
Vittorio Villavecchia, 1902, A. Donath editore, Genova<br />
Enciclopedia Internazionale <strong>del</strong>la Chimica, 1969,<br />
Edizioni PEM<br />
Glossare-index des termes techniques utilisés dans<br />
la Sedacina, in Pascale Barthelemy, 2002, La Sedacina<br />
ou l’œuvre au crible- L’alchinìmie de Guillaume Sedacer,<br />
carme Catalan de la fi n du XIVe siécle, I, Études et outils,<br />
S.E.H.A. Paris, ARCHÈ Milano, 2002, pp. 209-327<br />
Il Vocabolario Treccani, 1997, Istituto <strong>del</strong>la Enciclopedia<br />
Italiana<br />
L’Encyclopedie de Diderot et D’Alembert, Recueil<br />
des planches, sur les Sciences, les Arts liberaux, et les<br />
Arts Mècaniques avec leur explication, Paris, Henri Veyrier,<br />
1955<br />
La Piccola Treccani, Dizionario Enciclopedico, 1997<br />
Istituto <strong>del</strong>la Enciclopedia Italiana<br />
Lessico Farmaceutico Chimico, G. B. Capello, Venezia<br />
1748, edit. Domenico Lovisa ( Bibliot. Marciana<br />
Venezia, 32C119)<br />
Manuale di Chimica, N. A. Lange, 1970, Uses Utet -<br />
Sansoni Edizioni Scientifiche- Firenze<br />
39
4-<strong>2012</strong><br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Together with:<br />
- XXIX A.T.I.V. Conference<br />
- GlassTrend Seminar<br />
- ICG Annual Meeting<br />
- ESG Annual Meeting<br />
- ICG Technical Committees<br />
Parma (Italy), 22-25 September 2014<br />
L’ESG - European Society of Glass - è l’unico organismo europeo esclusivamente dedicato a promuovere<br />
e diffondere la scienza <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> e la tecnologia <strong>del</strong>l’industria di riferimento. È una struttura<br />
no-profit, senza una sede fissa e una struttura stabile, costituita nell’ottobre 1990 e ne fanno parte<br />
istituti e imprese di quattordici nazioni diverse, rappresentati in un Council e uno Steering Committee<br />
che si riuniscono di norma una volta l’anno.<br />
La <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> è socio fondatore <strong>del</strong>l’ESG e ne ha assunto la Presidenza<br />
per il biennio <strong>2012</strong>-2014. In questo periodo la SSV è impegnata a organizzare assieme all’<br />
ATIV - Associazione Tecnici Italiani <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, organismo senza finalità di lucro che ha lo scopo<br />
istituzionale di promuovere scambi e approfondimenti tecnico-scientifici nel settore e conta circa<br />
80 associati -, la dodicesima edizione <strong>del</strong>la Conferenza Internazionale che si tiene ogni due anni nel<br />
Paese che assume la Presidenza <strong>del</strong>l’Associazione.<br />
La SSV ha già organizzato a Venezia nel 1993 la seconda Conferenza ESG sul tema “Fundamentals<br />
on Glass Science and Technology”, che ha tenuto i suoi lavori presso la Scuola Grande San Giovanni<br />
Evangelista; l’edizione 2014 avrà luogo a Parma, presso il Campus Universitario, in collaborazione<br />
con la locale Università, dal 22 al 24 settembre. Scopo <strong>del</strong>l’iniziativa è quello di presentare e discutere<br />
mezzi e possibilità di migliorare le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti vetrari nelle loro<br />
diverse applicazioni.<br />
40
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong> 4-2011<br />
Il Campus Universitario <strong>del</strong>l'Università di Parma<br />
Le precedenti edizioni, che si sono svolte nel 2008 a Trenčin (Slovacchia), nel 2010 a Magdeburgo<br />
(Germania) e nel <strong>2012</strong> a Maastricht (Olanda), hanno registrato una presenza media di 550 persone,<br />
prevalentemente di estrazione industriale ed accademica, con particolare partecipazione di tecnici e<br />
studiosi di aerea germanica.<br />
Il Comitato Organizzatore ha operato la scelta di adottare criteri di massima economicità per le spese<br />
di organizzazione, sia per rispetto alle condizioni generali <strong>del</strong> Paese, sia per incrementare la presenza<br />
di tecnici, ricercatori e studenti; si ritiene che comunque nel 2014 le presenze saranno inferiori a<br />
quelle registrate nelle precedenti edizioni.<br />
La Conferenza intende approfondire sei temi individuati sulla base di specifiche necessità industriali<br />
e <strong>del</strong>le tendenze scientifiche più attuali:<br />
1. Tecnologia <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
2. <strong>Vetro</strong> e Ambiente<br />
3. Proprietà e Misure<br />
4. Vetri Speciali<br />
5. Igiene e Sicurezza<br />
6. <strong>Vetro</strong> in Edilizia e Architettura.<br />
41
4-<strong>2012</strong><br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Per la migliore riuscita <strong>del</strong>l’evento, che rappresenta una vetrina importante per la comunità vetraria<br />
nazionale e occasione di confronto, dopo più di vent’anni, con il settore accademico e industriale<br />
internazionale, è stato costituito un Comitato Scientifico Internazionale composto da 13 persone,<br />
di cui 7 italiani:<br />
o Ruud Beerkens Direttore tecnico generale CelSian Glass & Solar B.V.<br />
o Paolo Colombo Università di Padova - Ingegneria<br />
o Alicia Duran Istituto di Ceramica Vidrio Madrid<br />
o Piero Ercole Consulente Vetrario<br />
o Nicola Favaro Direttore dei Laboratori SSV<br />
o Angelo Montenero Università di Parma - Dip. Chimica<br />
o Fabiano Nicoletti Honorary President of ICG<br />
o John Parker Università di Sheffield<br />
o Gianni Royer Carfagni Università di Parma - Ingegneria<br />
o Bianca Maria Scalet CRC Siviglia<br />
o Masahiro Tsatsumisago Osaka Prefecture University Sakai<br />
o Roger Ulrich Direttore HVG Francoforte<br />
o René Vacher Université de Montpellier<br />
Il Comitato Organizzatore è composto da SSV, ATIV e Università degli Studi di Parma, con il<br />
supporto di Assovetro. La Presidenza <strong>del</strong>la Conferenza è congiuntamente assicurata da Stefano Manoli,<br />
Direttore Generale Delegato <strong>del</strong>la SSV e Alessandro Bandini, Presidente ATIV.<br />
Durante la Conferenza si terranno i lavori di alcune organizzazioni, nazionali ed internazionali: attualmente<br />
sono previste riunioni di ATIV, <strong>del</strong> Glass Trend Seminar, l’Annual Meeting di ICG con le<br />
periodiche riunioni dei Technical Committees e i lavori annuali di ESG.<br />
Per la partecipazione è importante ricordare le seguenti scadenze:<br />
31 dicembre 2013 presentazione dei lavori con abstract in inglese (lingua ufficiale) con indicazione<br />
di preferenza (orale o poster)<br />
31 gennaio 2014 notifica <strong>del</strong>l’accettazione <strong>del</strong>l’abstract<br />
30 giugno 2014 iscrizione con pagamento a condizioni di favore<br />
31 <strong>luglio</strong> 2014 presentazione <strong>del</strong>la versione finale <strong>del</strong> lavoro, orale o poster.<br />
Tutti i lavori presentati entro quest’ultima data saranno pubblicati in versione elettronica e resi disponibili<br />
ai partecipanti. Le presentazioni successive saranno invece scaricabili, alla fine <strong>del</strong>la manifestazione,<br />
dal sito www.esg2014.it.<br />
Alcuni articoli selezionati saranno inoltre pubblicati sulla Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong><br />
<strong>Vetro</strong> (formato elettronico) e su Glass Worldwide, giornale ufficiale <strong>del</strong>l’ATIV (formato cartaceo).<br />
I lavoro <strong>del</strong>la Conferenza e gli eventi collaterali si svolgeranno nell’arco di quattro giorni di cui tre,<br />
da martedì 23 settembre e giovedì 25, dedicati alle varie sezioni nelle quali si articolerà la manifestazione.<br />
Nei locali ove si terrà la Conferenza saranno allestiti spazi commerciali per agevolare la comunicazione<br />
<strong>del</strong>le aziende che intendono promuovere le proprie attività, e a breve verrà predisposto<br />
un programma per gli sponsor. È prevista una cena sociale in una location caratteristica <strong>del</strong> territorio<br />
parmense e gli accompagnatori potranno dedicarsi alla visita <strong>del</strong>le numerose attrattive locali.<br />
Informazioni generali:<br />
www.esg.2014.it<br />
info@esg2014.it<br />
42
innovazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
Processo innovativo<br />
per il riciclo <strong>del</strong> vetro<br />
Si apre un nuovo mercato, in grado di dare vita<br />
a un business interessante a livello industriale<br />
Che il vetro da raccolta differenziata venga riciclato per il circa il 70% dei consumi nazionali è noto a<br />
molti. Che sia un materiale unico, perché riciclabile al 100%, all’infinito e senza alcun decadimento<br />
qualitativo bensì senza aggiunta di materie prime vergini, altrettanto. Ma non tutti sanno che, grazie<br />
alla ricerca in un Ateneo d’eccellenza italiano, per il Consorzio <strong>del</strong> Recupero <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> sarà forse presto<br />
possibile andare oltre gli importanti traguardi già raggiunti e riciclare fino al 100% anche quella quantità<br />
di scarti vetrosi che, fino ad oggi, erano destinati per ragioni qualitative allo smaltimento in discarica,<br />
soprattutto per la presenza d’inquinanti purtroppo non compatibili con le attività di riciclo tradizionali,<br />
principali (settore vetrario per oltre il 99%) o secondarie (settore ceramico, laterizi, per meno <strong>del</strong>l’1%).<br />
Come? Grazie a Pa.Di.Ve.R, un materiale innovativo, brevettato di recente, capace di contenere, in peso,<br />
dal 70% al 90% di vetro di scarto oggi non riciclabile ed essere perfino lavorato “a secco” per la realizzazione<br />
di rivestimenti ed elementi ecosostenibili d’arredo e di design, come piastrelle, top per cucine,<br />
sanitari e altri manufatti per l’edilizia. Alla base <strong>del</strong>la scoperta, c’è anche l’ingegnerizzazione <strong>del</strong>le<br />
formulazioni di questo impasto che necessita, durante fase di consolidamento a caldo, di temperature decisamente<br />
più basse (dai 200°C ai 350°C in meno) di quelle richieste dai tradizionali processi ceramici.<br />
Pa.Di.Ve.R è frutto <strong>del</strong>la “Ricerca made in Italy” effettuata da EcoTecnoMat, lo “spin off” <strong>del</strong>l’Università<br />
di Reggio Emilia e Modena, con un partner privato (M. Ingrami). Lo spin off è nato allo scopo<br />
d’individuare materiali e tecnologie innovativi o impieghi alternativi dei rifiuti, come il vetro di scarto,<br />
oggi destinati alla discarica.<br />
Il Presidente di EcoTecnoMat, Nino Campani, dichiara: “Non esiste al mondo un impasto costituito da<br />
una così alta percentuale di vetro di recupero e da processi e fasi di lavorazione così sostenibili e versatili,<br />
se si esclude la tradizionale rifusione <strong>del</strong> vetro per produrre nuovi contenitori. Con questo impasto<br />
si apre ora un nuovo mercato, in grado di dare vita a un business interessante a livello industriale e di<br />
favorire e promuovere l'occupazione attraverso lo sviluppo di fi liere innovative in termini di processo e<br />
di prodotto.”<br />
• Si chiama Pa.Di.Ve.R ed è un impasto unico in grado di far recuperare e riutilizzare, a secco,<br />
fi no all’ultima scheggia, anche il vetro di scarto<br />
• L’ha messo a punto EcoTecnoMat. - “spin off” <strong>del</strong>l’Università di Reggio Emilia e Modena -<br />
che lavora all’individuazione di impieghi alternativi <strong>del</strong> vetro destinato alla discarica<br />
• Finanziatori <strong>del</strong>l’attività di ricerca commissionata a EcoTecnoMat sono ANCI (Associazione<br />
Nazionale Comuni Italiani) e il Consorzio Recupero <strong>Vetro</strong> - CoReVe - il cui obiettivo comune<br />
è migliorare costantemente la raccolta e il riciclo <strong>del</strong> vetro.<br />
43
4-<strong>2012</strong><br />
innovazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Esempi di superfi ci ceramiche e rivestimenti in Pa.Di.Ve.R<br />
Con Pa.Di.Ve.R le aziende che operano negli ambiti <strong>del</strong>l’ecodesign, <strong>del</strong>la bioarchitettura, <strong>del</strong>le ceramiche<br />
o dei materiali da rivestimento e <strong>del</strong>l’arredamento, così come le imprese di costruzione e così<br />
via, hanno la possibilità di entrare in un nuovo scenario industriale e di ottenere una serie di vantaggi<br />
economici anche grazie al miglioramento <strong>del</strong>l’efficienza energetica. Questo impasto garantisce inoltre<br />
l’accesso alle certificazioni ECOLABEL (il marchio europeo di qualità ecologica) e LEED (il sistema<br />
statunitense di classificazione <strong>del</strong>l’efficienza energetica e <strong>del</strong>l’impronta ecologica degli edifici).<br />
Gianpaolo Caccini, Presidente di Coreve, dichiara: “Pa.Di.Ve.R rappresenta una realtà molto promettente<br />
per l’impiego secondario <strong>del</strong> vetro di scarto, che potrebbe permettere a questo rottame - opportunamente<br />
bonifi cato e processato - di essere anch’esso riciclato in un nuovo ciclo produttivo e di ridiventare<br />
una risorsa”. Continua Caccini: “Speriamo così di riuscire a riciclare effi cacemente anche quelle<br />
frazioni di scarto che non trovano oggi una nuova vita in vetreria, a causa <strong>del</strong>le scarse caratteristiche<br />
qualitative di partenza o perché perse nelle operazioni di trattamento e rimozione <strong>del</strong>le impurità.”<br />
Molti i vantaggi che la ricerca oggi in corso di EcoTecnoMat, finanziata dal fondo per le sperimentazioni<br />
istituito da un accordo Anci-Coreve, può contribuire ad apportare. Tra questi, i principali sono:<br />
- riduzione <strong>del</strong>l’estrazione di materie prime tradizionali per l’edilizia - attività notoriamente “energivora”<br />
- e dei relativi costi;<br />
- risparmi energetici molto elevati per l'abbassamento <strong>del</strong>le temperature necessarie per la ‘cottura’;<br />
44
innovazioni Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
Oggetto di design (ciotola) in Pa.Di.Ve.R<br />
- risparmio economico per gli investimenti industriali grazie all’impiego di macchine formatrici<br />
già esistenti nell'industria alimentare e <strong>del</strong>la ceramica;<br />
- promozione di una “società <strong>del</strong> riciclo”, come chiede l’Europa, caratterizzata da mercati e consumatori<br />
più consapevoli, ma anche da cittadini e amministratori pubblici che sostengano il settore<br />
degli acquisiti verdi.<br />
Più il vetro raccolto in modo differenziato in Italia sarà di buona qualità, migliori saranno i risultati di<br />
riciclo, minori gli scarti prodotti durante le fasi di trattamento e i costi da sostenere, maggiori al tempo<br />
stesso i vantaggi ambientali ed economici che ne derivano. Questo è il compito <strong>del</strong> Coreve che, oltre a<br />
fare campagne di sensibilizzazione rivolte sia ai cittadini sia alle istituzioni, da anni si occupa insieme ad<br />
ANCI anche di finanziare (con un fondo a ciò dedicato) progetti sperimentali volti a diffondere le migliori<br />
pratiche nella raccolta differenziata e individuare impieghi alternativi <strong>del</strong> vetro destinato alla discarica.<br />
Tutto questo potrebbe rappresentare un grande passo in avanti in un’epoca che guarda alla Green Economy<br />
come a una possibile strategia per uscire dalla crisi di molti comparti produttivi (come quello<br />
ceramico e <strong>del</strong>l’edilizia in generale, per esempio) e per garantire uno sviluppo più sostenibile <strong>del</strong>la<br />
nostra società e dei consumi, partendo da un ambito territoriale ben identificato e dalle sue peculiarità.<br />
Il principio è quello <strong>del</strong>l’urban mining, cioè <strong>del</strong> rifiuto inteso come risorsa da estrarre da veri e propri<br />
giacimenti metropolitani.<br />
45
4-<strong>2012</strong><br />
innovazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Questo progetto, nato a Modena, guarda quindi a un futuro prossimo in cui anche dal vetro di scarto (non<br />
idoneo a produrre nuovi imballaggi in vetro) potranno essere realizzati prodotti di qualità, che andranno<br />
dai rivestimenti e complementi d’arredo (come piastrelle, top per cucina, lampade, sanitari ecc.) ad altri<br />
manufatti per l’edilizia e il settore <strong>del</strong>le costruzioni (laterizi, autobloccanti, pavimentazioni stradali,<br />
arredi urbani ecc.).<br />
Lampade (design) realizzate in pasta di vetro<br />
In particolare, con l’industrializzazione di materiali promettenti quali Pa.Di.Ve.R, le aziende che operano<br />
negli ambiti <strong>del</strong>l’eco-design, <strong>del</strong>la bioarchitettura, <strong>del</strong>le ceramiche o dei materiali da rivestimento<br />
e <strong>del</strong>l’arredamento, così come le imprese di costruzione, potrebbero avere la possibilità di entrare in un<br />
nuovo scenario industriale e ottenere una serie di vantaggi economici, connessi non solo all’efficienza<br />
energetica e all’approvvigionamento di materie prime locali a basso impatto ambientale, ma anche dal<br />
sostegno <strong>del</strong> mercato e dei cosiddetti acquisti verdi <strong>del</strong>la pubblica amministrazione (D.M. 203/2003 e<br />
ss.mm.ii).<br />
È quindi fondamentale che tutti gli attori interessati svolgano un ruolo attivo e concreto, per la corretta<br />
gestione dei rifiuti e per il buon esito di queste iniziative di potenziale sviluppo economico.<br />
46
innovazioni Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
Oggetto promozionale tipico <strong>del</strong> territorio modenese, in pasta di vetro<br />
CO.RE.VE - Consorzio Recupero <strong>Vetro</strong> - è il consorzio senza fi ni di lucro che ha per scopo il raggiungimento<br />
degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifi uti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio<br />
nazionale. È stato istituito dai principali gruppi vetrari italiani il 23 ottobre 1997 in ottemperanza al<br />
Decreto Legislativo 22/97 per gestire il ritiro dei rifi uti in vetro provenienti dalla raccolta differenziata,<br />
per predisporre le linee guida per le attività di prevenzione e per garantire l’avvio al riciclo <strong>del</strong> vetro<br />
raccolto. Un’organizzazione moderna i cui obiettivi sono la costante ricerca di nuove soluzioni che possano<br />
migliorare e ottimizzare la catena di montaggio <strong>del</strong> rottame di vetro.<br />
Per ulteriori informazioni:<br />
CO.RE.VE. Consorzio Recupero <strong>Vetro</strong> - info@coreve.it<br />
Ufficio Stampa: Massimo Tafi<br />
uffi ciostampa@coreve.it - tel. 02 48012961 - cell. 335 7171005<br />
47
4-<strong>2012</strong><br />
associazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
A.I.H.V.<br />
Association Internationale pour l'Histoire du Verre<br />
Comitato Nazionale Italiano<br />
Presentazione <strong>del</strong> Comitato Nazionale Italiano <strong>del</strong>l’AIHV<br />
Il Comitato Nazionale Italiano <strong>del</strong>l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (A.I.H.V.) è<br />
una Associazione culturale senza scopo di lucro, il cui fine è di proporre e adottare ogni iniziativa atta a<br />
far avanzare gli studi storici, archeologici, artistici e museografici (ivi inclusi i problemi di tecnologia e<br />
di conservazione) nel campo <strong>del</strong>la plurimillenaria storia <strong>del</strong> vetro, alla cui fioritura l’Italia in generale e<br />
Venezia in particolare hanno dato nel corso dei secoli contributi determinanti.<br />
Il Comitato persegue, in ambito italiano, gli scopi <strong>del</strong>la Association Internationale pour l’Histoire du<br />
Verre fondata a Liegi (Belgio) nel 1956, con la quale mantiene costanza di rapporti anche attraverso la<br />
nomina di un <strong>del</strong>egato italiano nel Comitato Esecutivo <strong>del</strong>la stessa. È una libera associazione di studiosi,<br />
esperti, docenti, funzionari preposti alla tutela dei beni culturali e a istituzioni scientifiche e museali<br />
pubbliche e private, che riconoscono nella storia <strong>del</strong>l’arte vetraria e <strong>del</strong>la sua tecnologia una <strong>del</strong>le testimonianze<br />
più antiche e significative <strong>del</strong>la civiltà mediterranea ed europea.<br />
Il Comitato Italiano nacque nel 1978 a Venezia su impulso <strong>del</strong> veneziano Astone Gasparetto, appassionato<br />
studioso <strong>del</strong>la secolare storia <strong>del</strong> vetro <strong>del</strong>la sua città. Dopo Astone Gasparetto, venne guidato da<br />
Giandomenico Romanelli, da Wladimiro Dorigo e da Ermanno Arslan; esso svolge da alcuni anni<br />
una intensa attività scientifica e culturale che si è concretata in molteplici iniziative di notevole interesse,<br />
come il XIV Congresso Internazionale <strong>del</strong>la A.I.H.V. (Venezia e Milano, 1998) e le Giornate Nazionali<br />
di Studio sul vetro.<br />
Negli anni, il Comitato ha sviluppato un progetto scientifico editoriale sempre più articolato e complesso<br />
che si è concretizzato nella catalogazione e nella successiva pubblicazione <strong>del</strong> Corpus <strong>del</strong>le Collezioni<br />
<strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>. Si tratta di una operazione culturale eccezionale per mole e sistematicità, che mette a disposizione<br />
degli studiosi un eccezionale patrimonio di studio e bibliografico, che non ha confronti in altre<br />
nazioni d’Europa.<br />
Nel 1994 esce il primo volume <strong>del</strong> Corpus <strong>del</strong>le collezioni archeologiche <strong>del</strong> vetro nel Veneto, dedicato<br />
ai vetri antichi <strong>del</strong> Museo <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> di Murano. L’impresa, realizzata grazie all’impegno dei Presidenti e<br />
dei Membri dei consiglio direttivo che si sono succeduti negli anni e alla preziosa collaborazione degli<br />
studiosi che hanno realizzato lo studio e la catalogazione dei vetri per i diversi volumi, è poi continuata<br />
con la pubblicazione di altri volumi dedicati ai vetri dei Musei di Adria (1996), Padova (1998), Concordia<br />
e Polesine (1998), Verona (1999), Este (2000), Belluno-Treviso-Vicenza (2003), cui segue un<br />
48
associazioni Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
volume complessivo di sintesi sulle collezioni venete nel 2004. Per il completamento <strong>del</strong>la catalogazione<br />
<strong>del</strong>le collezioni archeologiche in questa regione sono in fase di studio gli ultimi due volumi, che riguarderanno<br />
i vetri <strong>del</strong> Museo Nazionale Archeologico di Quarto d’Altino.<br />
L’iniziativa negli ultimi anni ha superato i confini regionali, coinvolgendo altre Regioni: in Lombardia<br />
sono stati editi tre volumi per i Musei di Cremona e Pavia (altri sono in studio), in Friuli Venezia Giulia<br />
il volume <strong>del</strong> Museo Archeologico di Udine e i tre volumi dei vetri <strong>del</strong> Museo Nazionale Archeologico<br />
di Aquileia (il terzo e ultimo è uscito in maggio 2009); altri progetti riguarderanno le collezioni dei Musei<br />
di Trieste, di Cividale e <strong>del</strong> territorio. È in programma un volume di carattere fotografico che illustri<br />
i migliori oggetti integri presenti nei Musei di Udine ed Aquileia. Anche in queste Regioni, come nel<br />
Veneto, fondamentale è stato l’apporto finanziario pubblico e <strong>del</strong>le fondazioni bancarie.<br />
Già il volume <strong>del</strong> Museo di Udine e quelli di Cremona e di Pavia comprendevano materiali post classici;<br />
nel 2006 poi, il Comitato ha avviato un progetto più sistematico <strong>del</strong> Corpus <strong>del</strong>le collezioni <strong>del</strong> vetro<br />
post-classico nel Veneto con la pubblicazione dei vetri <strong>del</strong>l’Ottocento custoditi presso il Museo <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
di Murano. Il progetto, assai ambizioso, intende provvedere ad una catalogazione sistematica <strong>del</strong>le collezioni<br />
di vetro nel territorio successiva a quella archeologica. Tra il 2006 e il 2011 sono usciti 4 volumi<br />
dedicati ai vetri attribuiti dagli autori alla fabbrica di Antonio Salviati. Questa collana, oltre a presentare<br />
materiali inediti, rappresenta per gli studiosi, collezionisti e appassionati di vetro artistico un punto di<br />
partenza per confronti, spunti di ricerca e approfondimenti.<br />
Il Comitato ha dato seguito ad altri importanti iniziative: dal 1990 sono stati<br />
editi sei Contributi storico-tecnici, tra i quali ricordiamo i glossari <strong>del</strong> vetro<br />
archeologico e post-classico, le indagini analitiche sulle origini <strong>del</strong>la vetraria<br />
veneziana e la disamina di alcuni dei numerosi ricettari vetrari muranesi.<br />
Dal 1995, con cadenza quasi annuale, sono state organizzate in tutta Italia le<br />
“Giornate Nazionali di studio sul vetro”, ormai momento d’incontro obbligato<br />
per quanti in Italia studiano le problematiche <strong>del</strong> vetro. La prima edizione<br />
si svolse a Venezia (1995), seguita da Milano (1996 e 1997), Napoli (1998<br />
e 2001), Massa Martana (1999), Genova (2000), Spoleto (2002), Ferrara<br />
(2003), Pisa (2004), Bologna (2005). Nel 2006, si è organizzato un incontro<br />
di studio a Udine in ricordo di Wladimiro Dorigo, mentre nel 2007 le Giornate<br />
ebbero luogo a Venezia, nella splendida cornice <strong>del</strong> Museo Correr. Nel<br />
2009, le Giornate di Studio si sono tenute a Trieste e a Pirano (Slovenia) e per<br />
la prima volta hanno rivestito un carattere internazionale, avendo coinvolto<br />
l’Istituto per il Patrimonio Mediterraneo <strong>del</strong>l’Università Primorska, di Capodistria (Slovenia) oltre che i<br />
Musei Civici di Trieste, e con il sostegno <strong>del</strong>la Soprintendenza per i Beni Archeologici <strong>del</strong> Friuli Venezia<br />
Giulia. Nel 2010 le Giornate di Studio si sono tenute a Trento e nel 2011 all’Università <strong>del</strong>la Calabria,<br />
nei pressi di Cosenza. Nei convegni viene approfondito il tema <strong>del</strong> vetro come oggetto archeologico,<br />
d’uso comune, prodotto d’arte, come oggetto tecnologico, con analisi tecnico-scientifiche pubblicate nei<br />
relativi Atti.<br />
Il Comitato Italiano ha un sito web, www.storia<strong>del</strong>vetro.it, che viene continuamente aggiornato con le<br />
notizie che riguardano la sua attività e dove recentemente sono stati inseriti aggiornamenti bibliografici<br />
che riguardano i titoli di articoli sulla storia <strong>del</strong> vetro pubblicati nelle Riviste, negli Atti dei Congressi e<br />
in volumi dedicati, negli anni dal 2000 al 2006, e dal quale sono ricuperabili i Bollettini di Informazione<br />
Vetraria pubblicati dal Comitato a partire dal 1993.<br />
49
4-<strong>2012</strong><br />
associazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Il Comitato Italiano, nato e cresciuto a Venezia, ha articolato<br />
la propria attività grazie ad un consiglio reclutato in tutte le<br />
regioni italiane, tenendo contatti importanti con Università<br />
e Centri di Ricerca di tutta Italia; molti soci partecipano attivamente<br />
ai Congressi organizzati in campo internazionale<br />
sia dalla AIHV Internazionale che da altri organismi dedicati<br />
allo studio <strong>del</strong>la storia <strong>del</strong> vetro nei suoi vari aspetti.<br />
Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi ed è<br />
attualmente composto dai seguenti membri (2011-2014):<br />
Presidente:<br />
Vice Presidente:<br />
Segretaria:<br />
Delegata alla collana ‘800 :<br />
Tesoriere:<br />
Consiglieri:<br />
Presidente Onorario:<br />
Revisori dei Conti:<br />
Cesare Moretti<br />
M.Giuseppina Malfatti<br />
Maria Grazia Diani<br />
Francesca Seguso<br />
Guido Zanin<br />
Luciana Mandruzzato, M. Cristina Tonini, Marina Uboldi,<br />
Annamaria Larese<br />
Ermanno Arslan<br />
Cesare Angelantoni, Sandro Pezzoli<br />
Pubblicazioni disponibili<br />
AIHV Association Internationale pour l’Histoire du Verre<br />
Comitato Nazionale Italiano<br />
Pubblicazioni (elenco aggiornato al 31 dicembre 2011):<br />
Corpus <strong>del</strong>le Collezioni Archeologiche <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> nel Veneto<br />
1. Giovanna Luisa Ravagnan, Vetri antichi <strong>del</strong> Museo Vetrario di Murano,1994 (€ 31,00)<br />
2. Simonetta Bonomi, Vetri antichi <strong>del</strong> Museo Archeologico nazionale di Adria, 1996 (€ 31,00)<br />
3. Girolamo Zampieri, Vetri antichi <strong>del</strong> Museo Civico Archeologico di Padova, 1998 (€ 39,00)<br />
4. Annamaria Larese, Enrico Zerbinati, Vetri antichi di raccolte concordiesi e polesane, 1998<br />
(€ 39,00)<br />
5. Giuliana Facchini, Vetri <strong>del</strong> Museo Archeologico <strong>del</strong> teatro Romano di Verona e di altre collezioni<br />
veronesi, 1999 (€ 41,00)<br />
6. Alessandra Toniolo, Vetri antichi <strong>del</strong> Museo Archeologico di Este, 2000 (€ 46,00)<br />
7. Claudia Casagrande, Francesco Ceselin, Vetri antichi <strong>del</strong>le province di Belluno, Treviso e Vicenza,<br />
2003 (€ 50,00)<br />
8. Annamaria Larese, Vetri antichi <strong>del</strong> Veneto, 2004 (€ 60,00)<br />
50
Atti <strong>del</strong>le Giornate Nazionali di Studio<br />
1^ Giornata nazionale di Studio (Venezia, 2 dicembre 1995), Il vetro dall’antichità all’età contemporanea,<br />
a cura di Gioia Meconcelli Notarianni e Daniela Ferrari, 1996 (€ 18,00)<br />
2^ Giornate Nazionali di Studio (Milano, 14-15 dicembre 1996), Il vetro dall’antichità all’età contemassociazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
Corpus <strong>del</strong>le Collezioni <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> post-classico nel Veneto<br />
1. Aldo Bova, Attilia Dorigato, Puccio Migliaccio, Vetri artistici <strong>del</strong> primo Ottocento, Museo <strong>del</strong><br />
<strong>Vetro</strong> di Murano, Marsilio editori 2006 (€ 30,00)<br />
2. Attilia Dorigato, Aldo Bova, Puccio Migliaccio, Vetri artistici. Antonio Salviati 1866-1878,<br />
Museo <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> di Murano - Catalogo Generale II, Marsilio editori 2008 (€ 35,00)<br />
3. Attilia Dorigato, Puccio Migliaccio (con la collaborazione di Vladimiro Risca), Antonio Salviati<br />
1866-1877, Museo <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> di Murano-vol.II, Marsilio editori 2010 (€ 35,00)<br />
4. Aldo Bova, Puccio Migliaccio, Vetri artistici. Antonio Salviati e la Compagnia Venezia Murano,<br />
in corso di stampa, marzo 2011 (€ 35,00)<br />
Corpus <strong>del</strong>le Collezioni <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> in Lombardia<br />
1. Aa. Vv., Cremona e Provincia, 2004<br />
2.1 Claudia Maccabruni, Maria Grazia Diani, con la collaborazione di Francesca Rebajoli, Pavia.<br />
Età Antica, 2004<br />
2.2 Cristina Tonini, Pavia. Età Medievale e Moderna, 2004<br />
Corpus <strong>del</strong>le Collezioni <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> in Friuli Venezia Giulia<br />
1. Maurizio Buora e altri, Vetri antichi <strong>del</strong> Museo Archeologico di Udine - I vetri <strong>del</strong>la collezione<br />
Di Toppo e materiali da altre collezioni e da scavi recenti, 2004 (€ 50,00)<br />
2. Luciana Mandruzzato, Alessandra Marcante, Vetri antichi <strong>del</strong> Museo Archeologico Nazionale di<br />
Aquileia - La vetreria da tavola, 2005 (€ 50,00)<br />
3. Luciana Mandruzzato, Alessandra Marcante, Vetri Antichi <strong>del</strong> Museo Archeologico Nazionale di<br />
Aquileia - Balsamari, olle, pissidi, 2007 (€ 50,00)<br />
4. Luciana Mandruzzato (a cura), testi di Annalisa Giovannini, Luciana Mandruzzato, Alessandra<br />
Marcante (e Fulvia Ciliberto). Vetri Antichi <strong>del</strong> Museo Archeologico Nazionale di Aquileia -<br />
Ornamenti e oggettistica e vetro pre- e post-romano, 2009 (€ 50,00)<br />
Collana Contributi Storico tecnici<br />
1. Tullio Toninato, Marco Verità, Riscontri analitici sulle origini <strong>del</strong>la vetraria veneziana, 1990<br />
(€ 5,00, soci 3,75), esaurito<br />
2. Tullio Toninato, Cesare Moretti, Ricettari muranesi (XVI-XX secolo), 1991 (€ 5,00, soci 3,75),<br />
esaurito<br />
3. Vincenza Orfanelli, Stefania Vellani, I vetri di Monte Bibele (Monterenzio-Bologna), 1992<br />
(€ 5,00, soci 3,75), esaurito<br />
4. Daniela Ferrari, Annamaria Larese, Gioia Meconcelli Notarianni, Marco Verità (traduzione in<br />
inglese D.B. Whitehouse), Glossario <strong>del</strong> vetro antico, 1998 (€ 5,00)<br />
5. Daniela Stiaffini, Repertorio <strong>del</strong> vetro post-classico, 2004 (€ 13,00)<br />
6. Daniela Ferrari, Annamaria Larese, Gioia Meconcelli Notarianni, Marco Verità (traduzione in<br />
francese di Marie-Dominique Nenna e Veronique Arveiller-Dulong), Glossario <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> Archeologico,<br />
2004 - poche copie rimaste<br />
51
4-<strong>2012</strong><br />
associazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
poranea: aspetti tecnologici, funzionali e commerciali (c/o Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche<br />
di Milano: fax +39 02 86452796)*<br />
3^ Giornata Nazionale di Studio (Milano, 31 ottobre 1997), Il vetro fra antico e moderno. Le più recenti<br />
scoperte archeologiche. Un secolo di produzione e designer <strong>del</strong> vetro italiano (1897-1997), a cura di<br />
Daniela Ferrari, Gioia Meconcelli,1999 (€ 15,00)<br />
4^ Giornate Nazionali di Studio (Napoli, 5-7 marzo 1998), Il vetro in Italia meridionale e insulare (Primo<br />
Convegno multidisciplinare), a cura di Ciro Piccioli e Francesca Sogliani, 1999 (€ 43,70 c/o interservicesas@libero.it)*<br />
5^ Giornata Nazionale di Studio (Massa Martana - PG, 30 ottobre 1999), Vetri di ogni tempo, produzione,<br />
commerci, iconografi e, a cura di Daniela Ferrari, 2001 (€ 15,00)<br />
6^ Giornate Nazionali di Studio (Genova 11-12 marzo 2000), La circolazione <strong>del</strong> vetro in Liguria:<br />
produzione e diffusione. Comunicazione su aggiornamenti e novità <strong>del</strong> vetro in Italia, a cura di Daniela<br />
Ferrari e Bruno Massabò, 2003 (€ 18,00)<br />
7^ Giornate Nazionali di Studio (Napoli, 5-6-7 dicembre 2001), Il vetro in Italia meridionale ed insulare<br />
(Secondo Convegno multidisciplinare), a cura di Ciro Piccioli e Francesca Sogliani, 2003 (c/o interservicesas@libero.it)*<br />
8^ Giornate Nazionali di Studio (Spoleto, 20-21 aprile 2002), Il vetro nell’Alto Medioevo, a cura di Daniela<br />
Ferrari, 2005 (€ 18,00)<br />
9^ Giornate Nazionali di Studio (Ferrara, 13-14 dicembre 2003), Il vetro nell’Alto Adriatico, a cura di<br />
Daniela Ferrari, Anna Maria Visser Travagli, 2007 (€ 20,00, soci 15,00), poche copie<br />
10^ Giornate Nazionali di Studio (Pisa, 12-14 novembre 2004), Trame di luce. Vetri da fi nestra e vetrate<br />
dall’età romana al Novecento, a cura di Daniela Stiaffini e Silvia Ciappi, 2010 (€ 20,00)<br />
11^ Giornate Nazionali di Studio (Bologna, 16-18 dicembre 2005), Produzione e distribuzione <strong>del</strong> vetro<br />
nella storia: un fenomeno di globalizzazione, Giugno 2011<br />
12^ Giornate Nazionali di Studio (Venezia, 19-21 ottobre 2007), Il <strong>Vetro</strong> nel Medioevo tra Bisanzio,<br />
l’Islam e l’Europa, in corso di stampa<br />
13^ Giornate Nazionali di Studio (Trieste-Piran, 30-31 maggio 2009), La diffusione e la produzione <strong>del</strong><br />
vetro sulle sponde <strong>del</strong> Mare Adriatico nell’antichità, a cura di Maurizio Buora, 2010 (€ 20,00), esaurito<br />
da ristampare, si può inviare in PDF<br />
14^ Giornate Nazionali di Studio (Trento, 16-17 ottobre 2010), Per un corpus dei bolli in Italia; Castello<br />
<strong>del</strong> Buonconsiglio Trento, in corso di stampa<br />
15^ Giornate Nazionali di Studio (Cosenza, 9-11 giugno 2011), in corso di redazione<br />
Atti Incontri di Studio<br />
Incontro di Studio in Ricordo di Wladimiro Dorigo, La statistica applicata all’archeologia, Udine, Castello,<br />
Sala <strong>del</strong>la Contadinanza, 11 novembre 2006, Atti in Quaderni Friulani di Archeologia n. 16 (2006)<br />
(€ 15,00), poche copie rimaste<br />
<strong>Vetro</strong> Notizie, Bollettino Annuale di Informazione Vetraria<br />
n. 1, 1993; n. 5, 1997; n. 6, 1998 (numero speciale); n. 7, 1999; n. 8, 2000; n. 9, 2001 (€ 5,00)<br />
Gli studiosi interessati possono ordinare le pubblicazioni (ad eccezione di quelle esaurite o contrassegnate<br />
con*) inviando una e-mail a: info@storia<strong>del</strong>vetro.it. I soci godono di uno sconto <strong>del</strong> 30%.<br />
Il sito web <strong>del</strong> Comitato nazionale Italiano AIHV (www.storia<strong>del</strong>vetro.it) contiene varie sezioni con utili<br />
informazioni sulla organizzazione e sulle attività <strong>del</strong> Comitato.<br />
52
associazioni Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
A.I.H.V. - Association Internationale<br />
pour l'Histoire du Verre<br />
L’AIHV è stata fondata nel 1956 da Joseph Philippe, all’epoca Direttore <strong>del</strong> Museo Curtius di Liegi<br />
(Belgio). Il primo congresso <strong>del</strong>l’associazione, che si chiamava allora “Journées internationales du<br />
verre”, ebbe luogo in questa stessa città nel 1958, in occasione <strong>del</strong>l’Esposizione Internazionale 1 .<br />
L’AIHV è una associazione internazionale consacrata esclusivamente allo studio <strong>del</strong> vetro, alla sua<br />
utilizzazione, alla sua storia e alle sue qualità estetiche, dall’antichità ai nostri giorni. Obiettivo <strong>del</strong>l’Associazione<br />
è riunire archeologi, storici <strong>del</strong>l’arte, artisti, collezionisti, conservatori museali, scienziati e<br />
ricercatori dediti alla storia <strong>del</strong> vetro di tutti i paesi <strong>del</strong> mondo.<br />
Ogni tre anni viene organizzato un Congresso, che permette di presentare <strong>del</strong>le comunicazioni sulle<br />
ricerche in corso e di visitare esposizioni dedicate al vetro; inoltre, in occasione dei congressi si organizzano<br />
visite in musei, gallerie e collezioni private: si tratta di interessanti occasioni di incontro, in un<br />
ambiente piacevole, che permettono di condividere il comune interesse dei partecipanti per la storia <strong>del</strong><br />
vetro. L’ultimo congresso si è svolto a Salonicco, in Grecia, nel settembre 2009.<br />
I precedenti si sono svolti a: Leida (1962); Damasco (1964); Ravenna e Venezia (1967); Praga (1970);<br />
Colonia (1973); Berlino e Lipsia (1977); Londra e Liverpool (1979); Nancy (1983); Madrid e Segovia<br />
(1985); Basilea (1988); Vienna (1991); Paesi Bassi (1995); Venezia e Milano (1998); New York e Corning<br />
(2001); Londra (2003); Anversa (2006).<br />
Il prossimo Congresso AIHV, che sarà il 19°, si terrà a Pirano, in Slovenia, nel settembre <strong>2012</strong>.<br />
L’Associazione è retta da uno Statuto basato sulla legge Olandese. Le lingue ufficiali sono l’inglese, il<br />
tedesco e il francese; in occasione <strong>del</strong>le conferenze e nelle relative pubblicazioni di Atti, gli Annales, le<br />
comunicazioni possono essere presentate in queste tre lingue. Per le normali comunicazioni destinate ai<br />
soci si utilizzano invece soltanto l’inglese e il francese.<br />
L’adesione all’AIHV è aperta a tutti gli interessati; gli studenti sono ammessi gratuitamente, mentre per<br />
gli altri è prevista una quota annuale di iscrizione. Attualmente gli iscritti sono circa 500, appartenenti a<br />
33 paesi. L’AIHV è diretta da un Consiglio Direttivo e da un Comitato Esecutivo, eletti dall’Assemblea<br />
Generale dei soci, che si riunisce in occasione di ciascun Congresso internazionale.<br />
Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo (2009-<strong>2012</strong>)<br />
Attualmente il Consiglio Direttivo è così composto:<br />
Presidente (dal 2003):<br />
Vice Presidente:<br />
Tesoriere:<br />
Segreteria Generale:<br />
Membri:<br />
Marie-Dominique Nenna (Francia)<br />
Irena Lazar (Slovenia)<br />
Huib Tijssens (Olanda)<br />
Jane Sha<strong>del</strong> Spillmann (USA)<br />
Despina Ignatiadou (Grecia), David Whitehouse (USA).<br />
53
4-<strong>2012</strong><br />
associazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Membri <strong>del</strong> Comitato Esecutivo sono:<br />
Fatma Marii (Giordania), Yoko Shindo Takahsahi (Giappone),<br />
Maria Grazia Diani (Italia), Sylvia Fuenfschilling<br />
(Svizzera), Lisa Pilosi (USA), Marianne Stern (Olanda) e<br />
i presidenti dei Comitati Nazionali <strong>del</strong>l’AIHV.<br />
Presidenti sono stati: Axel von Saldern (1983-1991)<br />
David Whitehouse (1991-1995)<br />
Gioia Meconcelli Notarianni (1995-1998)<br />
Jennifer Price (1998-2003).<br />
Comitati Nazionali<br />
In alcuni paesi, i soci AIHV hanno formato dei Comitati Nazionali. Il Consiglio Direttivo incoraggia<br />
sempre i soci dei paesi che non hanno tali Comitati ad organizzarli; questi Comitati organizzano Conferenze<br />
ed iniziative per promuovere la storia <strong>del</strong> vetro tra un Congresso internazionale AIHV e il successivo.<br />
Attualmente sono attivi i seguenti Comitati nazionali:<br />
Regno Unito: British Committee - www.historyofglass.org.uk<br />
Italia: Comitato Nazionale Italiano AIHV - www.storia<strong>del</strong>vetro.it<br />
Francia: Association Française pour l’Archéologie du Verre - A.F.A.V. - www.afaverre.fr<br />
Israele: National Committee<br />
Pubblicazioni<br />
L’AIHV pubblica direttamente gli Atti dei Congressi Internazionali, negli “Annales du Congrès de l’Association<br />
Internationale pour l’Histoire du Verre”. I volumi degli Annales sono gratuiti per i soci che<br />
sono in regola con la quota associativa, mentre gli studenti li possono acquistare a metà prezzo, durante<br />
il periodo di preparazione <strong>del</strong>la loro tesi di laurea 2 .<br />
Inoltre l’AIHV ha pubblicato (fino al 1983) nove “Bullettins des Journées Internationales du Verre”, per<br />
diffondere le notizie circa le più recenti scoperte e per presentare le collezioni di vetri dei seguenti paesi:<br />
Polonia, Siria, Cecoslovacchia, Belgio, Tunisia, Germania, Regno Unito, Italia.<br />
Attualmente, con periodicità semestrale, l’AIHV invia ai soci una newsletter elettronica, che comprende<br />
i principali aggiornamenti circa le conferenze, le esposizioni temporanee e i principali aggiornamenti<br />
bibliografici sulla storia <strong>del</strong> vetro, dall’età preromana alla contemporaneità, oltre all’archeometria e alla<br />
conservazione.<br />
Note<br />
1<br />
Una sintesi <strong>del</strong>la storia <strong>del</strong>l’AIHV si trova nella Prefazione a fi rma di Marie-Dominique Nenna, negli Annales <strong>del</strong> Congresso<br />
di Anversa, pubblicati nel 2009 (pp. ix-xiii).<br />
2<br />
Per informazioni sulla disponibilità attuale dei volumi si veda il sito uffi ciale www.aihv.org.<br />
54
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
4-<strong>2012</strong><br />
In ricordo di Cesare Moretti<br />
Ricordare Cesare Moretti è<br />
da un certo di punto di vista ripercorrere<br />
i rapporti tra SSV e<br />
l’industria <strong>del</strong> vetro muranese.<br />
Continuo è stato infatti, sia<br />
con Cesare che con le vetrerie,<br />
il rapporto di collaborazione, e<br />
frequenti i momenti di scambio<br />
di reciproco interesse e stimolo<br />
tra la scienza e la tecnologia, tra<br />
l’innovazione e la tradizione, tra<br />
le conoscenze di base e la pratica<br />
quotidiana di impresa.<br />
Dopo aver conseguito la laurea<br />
in Chimica Industriale a Padova,<br />
Cesare Moretti, nella seconda<br />
metà degli anni 50, ha svolto alla<br />
SSV un periodo di addestramento<br />
presso il laboratorio chimico,<br />
allora nucleo originario <strong>del</strong>l’Istituto,<br />
da cui si sono poi sviluppate<br />
altre competenze. La sua attività<br />
professionale non si è però<br />
realizzata in ambito veneziano,<br />
ove operava la società vetraria<br />
di proprietà <strong>del</strong>la famiglia, ma si<br />
è indirizzata verso nuove esperienze<br />
e sfide di tipo industriale.<br />
In quegli anni sorgeva a San Vito<br />
al Tagliamento, in Friuli, una<br />
nuova società, la Sirix Intervitrum<br />
SpA, specializzata nella<br />
produzione di tubo di vetro continuo<br />
per uso prevalentemente<br />
farmaceutico. Cesare Moretti ne<br />
assunse la direzione tecnica, che<br />
mantenne per molti anni anche<br />
quando la società venne assorbita<br />
dal gruppo Bormioli Rocco di<br />
Parma, e contribuì a migliorare<br />
una tecnologia complessa impiegata<br />
in pochi stabilimenti in<br />
tutto il mondo.<br />
Costanti furono i rapporti con la<br />
SSV, sia perché frequenti i suoi<br />
soggiorni a Venezia, sia per la familiarità<br />
e la frequentazione con<br />
i tecnici <strong>del</strong>l’Istituto che aveva<br />
conosciuto e apprezzato nei suoi<br />
“stage” e che hanno consentito di<br />
approfondire conoscenze specifiche<br />
ed affinare competenze nel<br />
settore <strong>del</strong>la resistenza chimica<br />
<strong>del</strong> vetro e <strong>del</strong> rapporto contenitore/farmaco,<br />
fondamentale per<br />
assicurare al mercato un prodotto<br />
affidabile e chimicamente<br />
idoneo all’impiego per cui viene<br />
progettato e realizzato.<br />
Per alcuni anni il dottor Moretti<br />
è stato componente <strong>del</strong> Comitato<br />
Tecnico Scientifico <strong>del</strong>la SSV,<br />
organismo costituito per dare<br />
rappresentanza alle esigenze tecniche<br />
<strong>del</strong>l’industria con l’obiettivo<br />
di promuovere iniziative e<br />
indirizzare investimenti e risorse<br />
nell’interesse <strong>del</strong>le vetrerie.<br />
La sua prevalente attenzione,<br />
diventata esclusiva con l’abbandono<br />
di cariche e responsabilità<br />
industriali, è stata però orientata<br />
allo studio <strong>del</strong>la storia <strong>del</strong>la tecnologia<br />
vetraria, frutto ed eredità<br />
<strong>del</strong>la sua originale formazione,<br />
di cui era molto orgoglioso.<br />
È autore di varie pubblicazioni<br />
su temi di carattere tecnico e<br />
storico (ricettari vetrari, materie<br />
prime, metodi di indagine tecniche<br />
di lavorazione). Sostenitore<br />
e assiduo collaboratore <strong>del</strong>la<br />
nostra Rivista, ha qui pubblicato,<br />
negli anni, numerosi studi e<br />
articoli divulgativi.<br />
Membro <strong>del</strong>l’Association International<br />
pour l’Histoire du Verre<br />
e <strong>del</strong> Comitato Nazionale Italiano<br />
<strong>del</strong>la stessa AIHV, nel 2002<br />
entra a far parte <strong>del</strong> Consiglio direttivo,<br />
ne diviene Presidente nel<br />
2008 ed è confermato alla presidenza<br />
nel 2011. La sua presenza<br />
all’interno <strong>del</strong> Comitato Italiano<br />
<strong>del</strong>l’AIHV ha rappresentato un<br />
rilancio <strong>del</strong>le iniziative associative,<br />
frutto di un costante appassionato<br />
impegno, volto a promuovere<br />
le iniziative editoriali, come le<br />
Giornate Nazionali di Studio sul<br />
<strong>Vetro</strong>, celebrate annualmente, e i<br />
contatti con i colleghi, sviluppati<br />
attraverso una fitta rete di relazioni<br />
nazionali e internazionali.<br />
Dalla sua fondazione, nel 2010, è<br />
stato membro <strong>del</strong> Comitato Promotore<br />
<strong>del</strong>l’iniziativa “Altino -<br />
Vetri di Laguna”.<br />
Curioso, appassionato, aperto al<br />
dialogo e impegnato nella diffusione<br />
<strong>del</strong>le conoscenze: questi<br />
gli aspetti che hanno sempre<br />
caratterizzato la sua attività e la<br />
sua ricerca. È così che vogliamo<br />
ricordarlo.<br />
55
4-<strong>2012</strong><br />
associazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
GLASS TREND<br />
Glass Technology REsearch and New Developments<br />
Glass Trend è un Consorzio di Ricerca e Sviluppo costituito nel 2001 e raggruppa rappresentanti <strong>del</strong>l’industria<br />
<strong>del</strong> vetro, istituzioni di ricerca e innovazione, nonché fornitori di macchine, impianti e servizi con<br />
l’obiettivo di trovare e promuovere applicazioni <strong>del</strong>le scienze e <strong>del</strong>la tecnologia <strong>del</strong> materiale al settore<br />
industriale.<br />
Il Consorzio ha quindi il fine di aggregare e stimolare risorse e iniziative per valorizzare le opportunità<br />
e i punti di forza <strong>del</strong> vetro a vantaggio dei produttori, dei fornitori e dei consumatori attraverso azioni e<br />
progetti pre-competitivi di ricerca, innovazione e di trasferimento di know-how.<br />
I settori di punta cui si volge l’attenzione di Glass Trend sono la fusione <strong>del</strong> vetro, la tecnologia di processo,<br />
le materie prime, il riciclo, la formatura <strong>del</strong> vetro, l’efficienza energetica, l’impatto ambientale:<br />
lo stesso nome testimonia nella lingua inglese la mission <strong>del</strong> Consorzio, “Glass Technology REsearch<br />
and New Developments”.<br />
A giugno <strong>2012</strong> aderivano al Consorzio 49 membri di 18 differenti paesi, tutti presenti in un Council che<br />
definisce le attività e le iniziative ed elegge un General Managing Board (4 membri) che si occupa di predisporre<br />
il programma annuale, studiare nuove attività, definire i costi di iscrizione. L’Advisory Board (5<br />
membri) determina invece il programma dei seminari, la selezione e la valutazione di rapporti e di studi,<br />
l’individuazione di nuovi temi di ricerca e sviluppo e definisce gli Study Tours e ogni altra iniziativa.<br />
Le attività <strong>del</strong> Consorzio si sviluppano principalmente su quattro direttrici:<br />
1. organizzazione di seminari su temi specifici di interesse industriale;<br />
2. organizzazione di visite guidate a impianti e stabilimenti;<br />
3. progetti di ricerca e innovazione industriale;<br />
4. organizzazione di corsi di specializzazione e perfezionamento ad alto livello sulla tecnologia <strong>del</strong><br />
vetro e la produzione.<br />
Nel primo caso segnaliamo le ultime iniziative che si sono svolte in concomitanza con altre manifestazioni<br />
scientifiche e in occasione <strong>del</strong>le riunioni <strong>del</strong> Council, senza quindi ricorrere a costi aggiuntivi a<br />
carico dei consorziati:<br />
-<br />
Glass Melt Quality & Glass Defects<br />
-<br />
Reach & Raw Materials & Recycling in the Glass Industry<br />
-<br />
Glass, Furnaces and Refractory Materials<br />
56
associazioni Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
-<br />
Sensor & Control in Glass Furnaces<br />
-<br />
Mathematical Mo<strong>del</strong>ling of Glass Melting Process<br />
-<br />
Energy Efficient & Environmentally Sound Glass Production<br />
-<br />
Heat Transfer & Heat Energy.<br />
Nel corso <strong>del</strong> <strong>2012</strong> verrà organizzato un Seminario su Alternative Raw Materials and Advanced Batch<br />
Pre-treatment for Glass Melting.<br />
Le visite guidate sono organizzate su temi specifici e riguardano impianti industriali e centri di ricerca e<br />
innovazione di particolare richiamo. Nel corso <strong>del</strong> <strong>2012</strong> è stato organizzato un tour tecnico in Italia, descritto<br />
nelle pagine seguenti. Negli anni precedenti sono state visitate industrie con particolari esperienze<br />
nel risparmio energetico e controllo ambientale (Germania, Spagna e Stati Uniti).<br />
I progetti di ricerca riguardano temi individuati dal Board e dal Council e sono organizzati su un periodo<br />
bi o triennale, con la partecipazione di aziende e centri di ricerca che finanziano l’iniziativa, ma sono i<br />
soli beneficiari dei risultati.<br />
Sono in corso i seguenti progetti, che contano dai sei agli otto partners e prevedono più fasi di lavoro,<br />
rese via via operative dai positivi risultati immediatamente precedenti e che comprendono anche sperimentazioni<br />
su base industriale:<br />
-<br />
LowNox Regenerative Glass Furnace (2006-2010)<br />
-<br />
Sulphur Chemistry in Alkali Free/Lean Glasses (LCD, E-glass, borosilicate glasses) (2007-2009)<br />
-<br />
Batch Pelletizing & Pellet Pre-heating by Glass Furnaces Flue Gases (2008-2010).<br />
Ricerche più recenti sono in fase di avvio o di avanzata fase progettuale e riguardano:<br />
-<br />
Energy Balance Mo<strong>del</strong>ling of Glass Furnaces<br />
-<br />
Refractory-glass Melt Interaction: Blister Formation<br />
-<br />
Gui<strong>del</strong>ines for Refractory Selection of Glass Furnaces<br />
-<br />
Novel Feeder & Fore-hearth Conception to Obtain Improved Glass Homogenization and<br />
Energy Savings<br />
-<br />
Control of Color & Optimizing Batch Chemistry and Fining for Amber Component Glasses<br />
Fining & Transparency of <strong>Vetro</strong>Clean (Solar) Glass.<br />
Altri temi sono allo studio e verranno definiti in accordo con i consorziati. Sono proposti argomenti quali<br />
affinaggio, controllo di formazione alla goccia, feeders ad alta efficienza energetica.<br />
I corsi vengono organizzati su richiesta <strong>del</strong>le società presso i propri stabilimenti e riguardano la tecnologia<br />
<strong>del</strong> vetro o il processo produttivo. Il prossimo avrà luogo a Eindhoven, Olanda, nel settembre<br />
<strong>2012</strong>; durerà cinque giorni e verterà sui temi: proprietà <strong>del</strong> vetro, fusione, forni, emissioni ed efficienza<br />
energetica, chimica <strong>del</strong> vetro.<br />
L’iscrizione al Glass Trend è libera e comporta una quota annuale pari a Euro 3.500,00 circa.<br />
I consorziati hanno diritto a partecipare a tutte le attività <strong>del</strong> Consorzio e a contribuire allo sviluppo dei<br />
temi di attività. La partecipazione alle conferenze è gratuita (2 rappresentanti) e i tour prevedono una<br />
riduzione per i consorziati.<br />
57
4-<strong>2012</strong><br />
associazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Presidente è Ruud Beerkens (CelSian); i riferimenti per eventuali contatti<br />
sono:<br />
Elize Harmelink<br />
CelSian Glass & Solar b.v.<br />
De Rondom 1<br />
5612 AP Eindhoven<br />
P.O. Box 6235<br />
5600 HE Eindhoven, The Netherlands<br />
Tel. +31-88 866 2501<br />
elize.harmelink@celsian.nl<br />
Prof. Ruud Beerkens<br />
Glass Trend Study Tour<br />
7-11 maggio <strong>2012</strong><br />
Glass Trend ha recentemente organizzato, in collaborazione con SSV, uno Study Tour in alcuni siti<br />
industriali <strong>del</strong>l’Italia <strong>del</strong> Nord, iniziativa periodicamente realizzata dal consorzio. Vi ha partecipato un<br />
gruppo di tecnici di società consorziate, con un minimo di 8 persone e un massimo di 15 persone nei<br />
diversi giorni, provenienti da Slovacchia, Belgio, Francia, Spagna, Italia, Repubblica Ceca e Olanda e<br />
appartenenti al settore produzione e tecnologia di processo <strong>del</strong>l’industria <strong>del</strong> vetro.<br />
Primo appuntamento il 7 maggio a Brusnengo (Biella) per visitare la Sasil, specializzata nella fornitura<br />
di materie prime per vetro e ceramica e nella tecnologia di riciclo <strong>del</strong> rottame, in particolare per purificare<br />
e macinare scarti altrimenti destinati a discarica e impiegati nella produzione di contenitori e lana di<br />
vetro. Interesse ha suscitato l’illustrazione <strong>del</strong> processo di produzione, <strong>del</strong> sistema di preriscaldamento<br />
<strong>del</strong>la miscela e i progetti per la produzione di vetro schiuma partendo dalle scorie di impianti di incenerimento<br />
di rifiuti solidi urbani.<br />
Nella serata <strong>del</strong> 7 maggio il prof. Ruud Beerkens, capo <strong>del</strong>egazione, ha illustrato ai componenti <strong>del</strong><br />
viaggio, nel corso di un seminario specifico, due temi legati a “Concepts for energy & emission friendly<br />
glass melting - evolution or devolution in glass melting” e “Overview of methods to recover Energy from<br />
fl ue gases of glass furnaces - impact on glass furnace energy consumption”.<br />
L’indomani, 8 maggio, si è svolta una visita allo stabilimento Bormioli Luigi di Abbiategrasso specializzato<br />
nella produzione di articoli per profumeria e cosmetica e contenitori di alta gamma per liquori.<br />
Il forno è equipaggiato con il sistema Centauro, messo a punto da Stara Glass, un sistema ibrido che<br />
utilizza aria preriscaldata da recuperatori (sezione a bassa temperatura) e rigeneratori (end-port) per<br />
un intervallo di temperature più elevate fino a 1200°-1250°C, in grado di soddisfare anche altre utenze<br />
all’interno <strong>del</strong>la fabbrica.<br />
58
associazioni Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
È stata poi raggiunta la Refel a San Vito al Tagliamento (PN), società appartenente al gruppo RHI che<br />
produce refrattari elettrofusi soprattutto per l’industria <strong>del</strong> vetro, ma anche per l’industria siderurgica,<br />
<strong>del</strong> cemento, <strong>del</strong>la ceramica.<br />
Giovedì 10 maggio è stato<br />
visitato il nuovo stabilimento<br />
<strong>del</strong>la Sangalli, ubicato a San<br />
Giorgio di Nogaro, che ha<br />
iniziato nel giugno 2011 l’attività<br />
di produzione <strong>del</strong> vetro<br />
float chiaro ed extra chiaro,<br />
nonché specializzata nella laminazione,<br />
in uno stabilimento<br />
molto moderno e ad alta efficienza<br />
energetica, con un impianto di controllo emissioni comprendente uno scrubber (Ca(OH)2) per<br />
De Sox, un precipitatore elettrostatico per le polveri e un SCR (De NOx).<br />
L’ultima giornata, venerdì 11 maggio, è stata<br />
dedicata a visitare i laboratori <strong>del</strong>la SSV a<br />
Murano con particolare attenzione alle esperienze<br />
maturate nel settore <strong>del</strong>le proprietà<br />
chimiche e fisiche <strong>del</strong> vetro, <strong>del</strong>lo studio <strong>del</strong>le<br />
materie prime anche alternative, <strong>del</strong>le emissioni<br />
e <strong>del</strong> risparmio energetico (2 laboratori<br />
mobili), <strong>del</strong>la mo<strong>del</strong>listica e <strong>del</strong>la resistenza<br />
meccanica. Sono stati inoltre illustrati i progetti<br />
di ricerca in corso sviluppati in proprio e<br />
in collaborazione con finanziamenti pubblici.<br />
Tutti i partecipanti hanno espresso vivo interesse<br />
per le opportunità di visita e approfondimento e tramite il prof. Beerkens hanno manifestato apprezzamento<br />
per le iniziative e le realizzazioni visitate.<br />
Precedenti esperienze <strong>del</strong> gruppo Glass Trend hanno riguardato un tour negli Stati Uniti sui nuovi approcci<br />
alla fusione <strong>del</strong> vetro (2007) e in Germania e Spagna sul recupero degli affluenti gassosi e controllo<br />
emissioni (2010).<br />
59
4-<strong>2012</strong><br />
manifestazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
Giornata A.T.I.V.<br />
Il nuovo quadro normativo italiano nell’uso strutturale<br />
<strong>del</strong> vetro. Cosa cambierà?<br />
Parma, 21 giugno <strong>2012</strong><br />
Nelle aperture <strong>del</strong>le mie case il<br />
vetro occupa il posto che la pietra<br />
preziosa assume tra gli altri<br />
materiali… Il supermateriale<br />
vetro, come lo utilizziamo ora, è<br />
una meraviglia. Aria nell’aria,<br />
per bloccare l’aria o mantenerla<br />
all’interno. Luce nella luce, per<br />
diffondere o deviare la luce…<br />
Con queste parole Frank Lloyd<br />
Wrigth sintetizzava l’enorme potenzialità<br />
espressiva <strong>del</strong> vetro.<br />
Negli ultimi anni il vetro si sta<br />
affermando anche come vero e<br />
proprio materiale strutturale, per<br />
la costruzione di travi portanti,<br />
scale, parapetti, solai, coperture<br />
di grande luce, e la straordinaria<br />
eleganza di queste strutture si<br />
combina perfettamente con l’alto<br />
contenuto tecnologico di edifici<br />
ultramoderni, nonché col restauro<br />
conservativo o la ristrutturazione<br />
di monumenti di particolare<br />
pregio storico-architettonico.<br />
<strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, in collaborazione con<br />
il Dipartimento di Chimica Generale<br />
e Inorganica, Chimica<br />
Fisica, Chimica Analitica e il<br />
Dipartimento di Ingegneria Civile<br />
e <strong>del</strong>l’Ambiente <strong>del</strong> Territorio<br />
e Architettura <strong>del</strong>l’Università<br />
degli Studi di Parma con il<br />
patrocinio <strong>del</strong>l’Ordine degli Architetti,<br />
Pianificatori Paesaggisti<br />
Conservatori <strong>del</strong>la Provincia<br />
di Parma e l’Ordine degli Ingegneri<br />
<strong>del</strong>la Provincia di Parma.<br />
L’iniziativa s’inserisce nell’ambito<br />
<strong>del</strong>le attività istituzionali<br />
<strong>del</strong>l’Associazione per promuovere<br />
la formazione, la specializzazione<br />
e l’aggiornamento<br />
tecnico scientifico dei tecnici<br />
vetrai e dei professionisti che<br />
quotidianamente si trovano a lavorare<br />
con questo splendido materiale.<br />
Quest’incontro è stato<br />
un’occasione per diffondere<br />
la cultura <strong>del</strong>la progettazione<br />
e approfondire gli aspetti<br />
normativi che caratterizzano<br />
le costruzioni in vetro. Esistono<br />
ottime scuole di ingegneria<br />
che insegnano a costruire con<br />
legno, acciaio, cemento armato<br />
ma sono pochissime le occasioni<br />
di approfondimento per le costruzioni<br />
in vetro. Per costruire<br />
con il vetro bisogna essere molto<br />
Si intitola “Il nuovo quadro normativo<br />
italiano nell’uso strutturale<br />
<strong>del</strong> vetro. Cosa cambierà?”<br />
la Giornata che è stata organizzata,<br />
presso il Centro Congressi<br />
Santa Elisabetta al Campus<br />
<strong>del</strong>l’Università di Parma il<br />
21 giugno scorso, dall’A.T.I.V.<br />
- Associazione Tecnici Italiani<br />
60
manifestazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
più precisi che con altri materiali:<br />
le tolleranze sono limitate, le<br />
movimentazioni <strong>del</strong>icate, i ritocchi<br />
in opera quasi impossibili e<br />
la preparazione di tutta la filiera<br />
produttiva e costruttiva gioca un<br />
ruolo fondamentale.<br />
Nell’ambito di questa Giornata,<br />
una serie d’interventi dei più<br />
affermati studiosi provenienti<br />
da Università italiane hanno illustrato<br />
e spiegato le norme per<br />
la progettazione, l’esecuzione<br />
e il controllo di costruzioni con<br />
elementi strutturali in vetro, le<br />
problematiche generali legate<br />
alla progettazione strutturale <strong>del</strong><br />
vetro. In particolare, sono state<br />
sviscerate le problematiche legate<br />
ai sistemi di facciata continua<br />
in vetro ad alta tecnologia<br />
e le innovazioni di progetto e<br />
prodotto in un quadro normativo<br />
complesso.<br />
Il Prof. Gianni Royer Carfagni<br />
<strong>del</strong>l’Università degli Studi di<br />
Parma ha aperto la giornata con<br />
un intervento mirato alla progettazione,<br />
esecuzione e controllo<br />
di costruzioni ed elementi strutturali<br />
in vetro, distinguendo tra<br />
norme di prodotto e norme per<br />
le costruzioni e indicando i requisiti<br />
essenziali per la sicurezza<br />
in uso e la resistenza meccanica<br />
e la stabilità. Non esiste un’unica<br />
norma per l’utilizzo <strong>del</strong> vetro<br />
strutturale, quanto piuttosto un<br />
quadro di norme tecniche complesso<br />
e articolato che presiede<br />
alla marcatura CE <strong>del</strong>l’involucro<br />
vetrato e dei suoi componenti.<br />
Il Prof. Royer ha quindi completato<br />
la presentazione con un’attenta<br />
analisi sui requisiti di base<br />
<strong>del</strong>la norma CPR 305/2011 che<br />
fissa le condizioni armonizzate<br />
per la commercializzazione<br />
dei prodotti da costruzione, sulla<br />
marchiatura dei prodotti CE,<br />
sulle norme tecniche armonizzate,<br />
sulla PR EN 13474 che è il<br />
progetto di norma europea, tuttora<br />
non approvata, e sulle raccomandazioni<br />
<strong>del</strong> CNR.<br />
Secondo il Prof. Franco Mola<br />
<strong>del</strong> Politecnico di Milano, il vetro<br />
è un materiale largamente<br />
utilizzato nell’architettura, che<br />
ha trovato, negli ultimi decenni,<br />
un impiego sempre più vasto in<br />
un ambito fortemente connotato<br />
sotto l’aspetto strutturale. Lo<br />
sviluppo <strong>del</strong>l’impiego di vetro<br />
trova la sua ragione nell’avanzamento<br />
<strong>del</strong>la tecnologia connessa<br />
alla sua produzione, al suo<br />
sinergico inserimento in sistemi<br />
costruttivi affidabili, nonché<br />
al progresso <strong>del</strong>le conoscenze<br />
nell’ambito <strong>del</strong>la scienza dei<br />
materiali, <strong>del</strong>la sperimentazione<br />
e nella formulazione di raffinati<br />
mo<strong>del</strong>li di comportamento teorici.<br />
Considerando le caratteristiche<br />
proprie <strong>del</strong> vetro quale materiale<br />
strutturale, la progettazione<br />
di strutture in vetro deve essere<br />
condotta con grande attenzione<br />
e richiede conoscenze particolari,<br />
in genere non necessarie nel<br />
progetto di strutture con altri<br />
materiali fragili. Per migliorare<br />
le caratteristiche <strong>del</strong> vetro quale<br />
materiale strutturale, sono stati<br />
prodotti nuovi tipi di vetro (vetro<br />
temperato, vetro stratificato,<br />
vetro retinato, tenacizzato, armato...)<br />
che ne hanno permesso<br />
un impiego sempre più esteso,<br />
specialmente nella costruzione<br />
di edifici alti o aventi geometrie<br />
complesse e particolari. Ma l’utilizzo<br />
di vetri altamente tecnici<br />
nella progettazione di edifici<br />
complessi richiede analisi raffinate<br />
e approfondite per evitare<br />
insuccessi, le cui conseguenze<br />
possono essere particolarmente<br />
gravose in termini di sicurezza<br />
e rischi economici. Il Prof. Mola<br />
ha quindi illustrato i principi generali<br />
riguardanti la progettazione<br />
di edifici alti (ad esempio, la<br />
progettazione <strong>del</strong>le facciate di<br />
Palazzo Lombardia) e la struttura<br />
di una facciata di particolare<br />
complessità. L’analisi di un insuccesso<br />
generato dalla rottura<br />
di una lastra e le conclusioni finali<br />
sulla misura <strong>del</strong>la sicurezza<br />
hanno completato la presentazione.<br />
Il Prof. Luigi Biolzi <strong>del</strong> Politecnico<br />
di Milano ha tenuto<br />
un’interessante relazione sulle<br />
problematiche generali legate<br />
alla progettazione strutturale in<br />
vetro. Dopo aver illustrato alcune<br />
<strong>del</strong>le realizzazioni più significative<br />
a livello mondiale di<br />
strutture in vetro, ha indicato le<br />
potenzialità <strong>del</strong> vetro come materiale<br />
strutturale, ma non solo.<br />
Il vetro, infatti, ha la capacità<br />
di trasmettere immagini da un<br />
ambiente all’altro (trasparenza),<br />
luci, colori, sagome (traslucenza)<br />
e informazioni (stampe,<br />
ologrammi, proiezioni). Il vetro<br />
ha la capacità di variare colore,<br />
caratteristiche chimiche e fisiche<br />
in funzione <strong>del</strong>l’ambiente<br />
circostante (vetri elettrocromici,<br />
gascromici, a cristalli liquidi…);<br />
il vetro ha inoltre le proprietà di<br />
riflessione, trasmissione o rifrazione,<br />
caratteristiche che possono<br />
essere esaltate e utilizzate per<br />
molti scopi (ad esempio, vetri<br />
dicroici).<br />
Il Prof. Biolzi ha quindi completato<br />
la sua presentazione con<br />
61
4-<strong>2012</strong><br />
manifestazioni<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
l’analisi <strong>del</strong> comportamento <strong>del</strong><br />
vetro come materiale da costruzione,<br />
indicando come aumentare<br />
la sicurezza <strong>del</strong>le strutture in<br />
vetro migliorando le caratteristiche<br />
<strong>del</strong> materiale o inserendo in<br />
parallelo elementi resistenti.<br />
Il Dr. Ennio Mognato, <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong><br />
<strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, ha<br />
presentato le prove di qualificazione<br />
di vetri per uso strutturale,<br />
illustrando le direttive <strong>del</strong>le normative<br />
che saranno introdotte<br />
nel corso dei prossimi mesi.<br />
Il Prof. Paolo Rigone, <strong>del</strong>l’Unione<br />
Nazionale Costruttori<br />
Serramenti Alluminio Acciaio<br />
Leghe (Uncsaal), ha presentato<br />
una relazione sulle innovazioni<br />
di progetto e prodotto di facciate<br />
continue vetrate, in un quadro<br />
normativo complesso parlando<br />
di funzioni, tecnologie costruttive,<br />
prestazioni e normative tecniche.<br />
La facciata di un edificio,<br />
che rappresenta l’involucro, è il<br />
filtro complesso e multifunzionale<br />
tra esterno e interno rispetto<br />
all’edificio, e ha la funzione di<br />
trasmettere alla struttura portante<br />
i carichi permanenti (peso<br />
proprio) e accidentali (vento, sisma,<br />
urti), di difendere gli spazi<br />
interni dagli agenti esterni, di regolare<br />
la trasmissione dei flussi<br />
energetici tra interno ed esterno,<br />
di consentire l’illuminazione naturale<br />
e la visibilità, di permettere<br />
di conformare gli spazi interni<br />
e di regolare il passaggio di persone<br />
e cose. L’involucro di vetro<br />
deve avere le seguenti prestazioni:<br />
resistenza meccanica, tenuta<br />
all’acqua, permeabilità all’aria,<br />
prestazioni di interfaccia (dilatazioni,<br />
deformazioni <strong>del</strong>la struttura<br />
portante, collegamento alla<br />
struttura portante, coordinamento<br />
<strong>del</strong>le tolleranze...), comportamento<br />
termico, controllo <strong>del</strong>l’irraggiamento<br />
solare, controllo<br />
<strong>del</strong> flusso luminoso, isolamento<br />
acustico, comportamento al fuoco,<br />
durabilità e affidabilità.<br />
L’Ing. Francesco Lorenzi <strong>del</strong>la<br />
Società Focchi SpA ha dedicato<br />
la presentazione all’importanza<br />
<strong>del</strong>la normativa armonizzata per<br />
costruttori di facciate e produttori<br />
di serramenti, mettendo in luce<br />
quelle che sono al momento le<br />
normative di riferimento seguite<br />
nell’esecuzione di una facciata,<br />
mentre l’Ing. Massimo Fioraso<br />
<strong>del</strong>la Società Fischer Italia<br />
ha tenuto una relazione sull’evoluzione<br />
dei sistemi di fissaggio,<br />
introducendo a conclusione<br />
l’Arch. Giorgio Strappazzon<br />
che ha illustrato il progetto <strong>del</strong><br />
nuovo Orto Botanico di Padova.<br />
Nel Corso <strong>del</strong>la Giornata<br />
A.T.I.V., che ha visto la presenza<br />
di circa una settantina di partecipanti<br />
rappresentanti di industrie<br />
vetrarie, progettisti, serramentisti,<br />
è stato inoltre presentato<br />
“Progettare con il <strong>Vetro</strong> Strutturale”,<br />
il corso di formazione<br />
<strong>del</strong>la durata di due giorni che si<br />
terrà nella primavera <strong>del</strong> 2013<br />
presso l’Università degli Studi<br />
di Parma, rivolto all’intera filiera<br />
produttiva e costruttiva<br />
<strong>del</strong>le strutture in vetro.<br />
Il Corso verterà sulle seguenti<br />
tematiche:<br />
•Mo<strong>del</strong>lazione <strong>del</strong>la resistenza<br />
meccanica <strong>del</strong> vetro. Interpretazione<br />
statistica.<br />
•Ridondanza, robustezza, requisito<br />
“fail safe”. Strutture<br />
di prima, seconda e terza<br />
classe.<br />
•Azioni particolari sulle vetrature.<br />
Azione sismica; stati<br />
di coazione per variazioni<br />
termiche.<br />
•Metodi di primo, secondo<br />
e terzo livello per il dimensionamento<br />
<strong>del</strong>le strutture di<br />
vetro.<br />
•Mo<strong>del</strong>li di calcolo.<br />
•Regole pratiche di progettazione.<br />
•Esempi.<br />
•Procedure di accettazione e<br />
controllo. Ruolo <strong>del</strong> progettista,<br />
<strong>del</strong> direttore dei lavori,<br />
<strong>del</strong> collaudatore e <strong>del</strong>l’esecutore.<br />
Per ulteriori informazioni:<br />
Segreteria A.T.I.V.<br />
ativ@ativ-online.it<br />
62
agenda<br />
Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 4-<strong>2012</strong><br />
Agenda <strong>2012</strong><br />
September<br />
5-7<br />
12-14<br />
19-20<br />
23-26<br />
October<br />
1-2<br />
1-3<br />
23-26<br />
November<br />
15-16<br />
Agenda 2013<br />
March<br />
20-22<br />
March<br />
20-22<br />
June<br />
2-7<br />
July<br />
1-5<br />
September<br />
3-4<br />
September<br />
3-5<br />
September<br />
10-12<br />
October<br />
23-26<br />
Agenda 2014<br />
Cambridge<br />
UK<br />
Las Vegas (NV)<br />
USA<br />
Aachen<br />
Germany<br />
Goslar<br />
Germany<br />
Arques<br />
France<br />
Cincinnati (OH)<br />
USA<br />
DÜsseldorf<br />
Germany<br />
Parma<br />
Italy<br />
Mumbai<br />
India<br />
Mexico City<br />
Mexico<br />
San Diego (CA.)<br />
USA<br />
Prague<br />
The Czech Republic<br />
Orlando (Fl)<br />
USA<br />
Dubai<br />
UAE<br />
Las Vegas (NV)<br />
Atlanta (GA)<br />
USA<br />
Milano<br />
Italy<br />
SGT Annual Meeting <strong>2012</strong><br />
www.sgt.org<br />
GlassBuild America<br />
e-mail: attend@glassbuildingamerica.com - www.glassbuildamerica.com<br />
55th Colloquium on Refractories<br />
ECREF - European Centre for Refractories GmbH<br />
www.feuerfest-kolloquium.de<br />
10th International Symposium on Crystallization from Glasses and Liquids.<br />
e-mail: joachim.deubener@tu-clausthal.de - www.crystallization-<strong>2012</strong>.de<br />
XXII ICF/EDG Technical Exchange Conference hosted by Arc International<br />
73rd Conference on Glass Problems - Annual Conference organized by the Glass Manufacturing<br />
Industry Council (GMIC) in conjuction with Alfred University<br />
www.introequipcon.com<br />
Glasstec <strong>2012</strong><br />
International Trade Fair for Glass Production - Processing - Products<br />
www.glasstec-online.com<br />
XXVII A.T.I.V. Conference: “From a grain of sand to the strength of a structure”<br />
Hollow & Flat Glass Session: innovations in raw materials.<br />
Engineering & Architectural Sessions: special glass structures<br />
Centro Congressi Santa Elisabetta Campus Universitario<br />
www.ativ-online.it<br />
Glasspex India 2013<br />
Every two years Glasspex India will offer international companies the ideal platform for a targeted<br />
presentation to the Indian glass market<br />
Bombay Convention & Exhibition Centre<br />
www.glasspex.com<br />
GlassLat 2013 Mexico<br />
The only exhibition in Mexico specializing in architectural and automotive glass industry<br />
Centro Banamex<br />
www.glasslat.com<br />
PacRim 10, 10th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology<br />
e-mail: mmaham@ceramics.org - www.pacrim10.org<br />
XXIII International Congress on Glass<br />
e-mail: secretary@czech-glass-society.cz<br />
Glass Solutions 2013<br />
www.quartzltd.com<br />
Gulf Glass 2013 - Dubai World Trade Centre<br />
www.glassinthegulf.com<br />
GlassBuild America<br />
Annual, all-encompassing event that will bring the entire glass and fenestration industries together<br />
in one venue for the first time in North America<br />
www.glassbuildamerica.com<br />
Vitrum<br />
International trade show specialized in machinery, equipment and systems for flat, bent and hollow<br />
glass and in glass and processed products for industry - Fiera Milano<br />
www.vitrum-milano.it<br />
September<br />
22-25<br />
Parma<br />
Italy<br />
ESG 2014: A.T.I.V. (Associazione Tecnici Italiani <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>) - <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><br />
e-mail: ferrari@ativ-online.it - www.ativ-online.it<br />
63