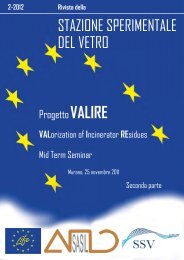n°6 anno 2011 - Stazione Sperimentale del Vetro
n°6 anno 2011 - Stazione Sperimentale del Vetro
n°6 anno 2011 - Stazione Sperimentale del Vetro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RIVISTA <strong>del</strong>laSTAZIONE SPERIMENTALE DEL VETROnovembre-dicembre <strong>2011</strong> - n. 6 vol. 41sommarioIn questo numero ........................................... 2Riassunti ............................................................... 3StudiStudiSostituzione <strong>del</strong>l’arsenico nelle miscele vetrificabiliper la produzione di vetro cristallo ................................. 3Nuove soluzioni per la valorizzazione di scorieRoberto Falcone, Sandro Hreglich, Bruno Profi loe ceneri volanti prodotte dagli inceneritoridi rifiuti solidi urbani ..................................................... 5Storia di un marchio contraffatto a VeneziaNew solutions for the valorization of glassy residuesnel XVIII secolo ......................................................... 19produced by municipal waste incinerators..........................13Riccardo CellaSandro Hreglich, Roberto Falcone, Antonio Tucci,Nicola Favaro, Paolo Bertuzzi, Piero Ercole,Lodovico RamonRubricaMetodologie di analisiTaratura Sistemi avanzati e verifica di degli recupero SME ...................................... termico per forni da vetro. 31a Sistema cura di ibrido Walter rigenerativo-recuperativo BattagliaCentauro ..... 18Alessandro Mola, Paolo Bortoletto, Giampaolo Bruno,Ernesto Cattaneo, Augusto SanteroAttualità Borsa di Studio“GiuseppeNuove dotazioni allaBreviari”SSV ............................................................................... 3835Agenda ................................................................. 38Agenda ................................................................. 40Dal mondo <strong>del</strong> vetro.................................. 39Internationala cura di Elisabetta BarbiniCommission on Glass... 41Indice <strong>del</strong> volume XLI.................................. 53Dal mondo <strong>del</strong> vetro.................................... 43a cura di Elisabetta BarbiniIl Capitolare degli Specchieri <strong>del</strong> 1764 ......................... 26Paolo ZecchinDirettore responsabileAntonio TucciRedazioneElisabetta Barbiniemail: ebarbini@spevetro.itImpaginazione e graficaBetti BertoncelloDirezione e Redazione - Proprietà<strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Via Briati 10 - 30141 Murano (VE)Tel.: +39 041 2737011Fax: +39 041 2737048email: mail@spevetro.ithttp:/ / www.spevetro.itAutorizzazione <strong>del</strong> Tribunale di Venezia n.271 in data 23.01.1971R.O.C. in data 23.01.1971- 3913 R.O.C. 3913Rivista Associata alla UnioneStampa Periodica ItalianaIstruzioni per gli AutoriLa Rivista pubblica studi, ricerche ed esperienze sullatecnologia e sulla scienza <strong>del</strong> vetro e e dei i materiali ad essocollegati. Chiunque può mandare elaborati, memorie, ecc. ecc.La Redazione si riserva o meno la loro pubblicazione.I testi, corredati da un breve riassunto di circa dieci righe, initaliano e inglese, dovr<strong>anno</strong> pervenire in forma elettronica(preferibilmente in Microsoft Word).Immagini e tabelle dovr<strong>anno</strong> essere in file separati: leimmagini preferibilmente in formato tif o jpg (minimo 300dpi); le tabelle in Microsoft Excel o Microsoft Word. LaRivista diventa proprietaria dei lavori pubblicati e questinon possono essere riprodotti altrove senza autorizzazione.I testi accettati per la pubblicazione sar<strong>anno</strong> consideratidefinitivi. Eventuali sostanziali variazioni dovr<strong>anno</strong> essereconcordati concordate con la Redazione.La Direzione è estranea alle tesi sostenute nei loro articolidai singoli collaboratori. Questi assumono la pienaresponsabilità dei loro scritti.È vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi e <strong>del</strong>leillustrazioni senza la preventiva autorizzazione <strong>del</strong>laRedazione.1
in questo numero6-<strong>2011</strong>Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>I rivestimenti nanometrici (coating) conferiscono un notevole valore aggiunto al vetro piano utilizzatoin edilizia e in altri settori industriali. Da tempo gli sforzi dei produttori sono indirizzati a migliorareleInproprietàquesto numerotecnologiche<strong>del</strong>la Rivista<strong>del</strong> vetropubblichiamo,piano per ediliziaa paginaper aumentare3, l’articolol’efficienza“Sostituzione<strong>del</strong>le<strong>del</strong>l’arsenicovetrate in termininellemiscele di comfort vetrificabili abitativo per e risparmio la produzione energetico. di vetro Questi cristallo”, miglioramenti di Roberto tecnologici Falcone, Sandro sono ottenuti Hreglich attraverso e BrunoProfilo. l’applicazione di film (o strati) sottili nanometrici (coating) sulla superficie <strong>del</strong> vetro attraverso diversetecniche di deposizione.Nell’ambito <strong>del</strong> progetto di ricerca industriale denominato “Eliminazione dei composti <strong>del</strong>l’arsenicoIn questo primo articolo <strong>del</strong>la Rivista (<strong>2011</strong>): “I fi lm sottili (coating) su vetro: caratteristiche, materiali edalla metodologie miscela di vetrifi analisi” cabile (Daneo, nelle Falcone, produzioni Sommariva, artistiche Vallotto) muranesi a pagina e sostituzione 5, vengono con descritti materie i materiali primealternative utilizzati per non i coating, pericolose”, le principali sono state tecniche eseguite di deposizione prove di laboratorio e vengono illustrati e su scala i vantaggi industriale e i limiti in forni <strong>del</strong>le atecniche analitiche oggi maggiormente utilizzate per questo tipo di indagini.crogiolo e a vasca per verificare la possibilità di eliminare l’ossido di arsenico nelle miscele vetrificabiliper Il secondo vetro cristallo articolo silico-sodico-calcico a firma Mognato, Barbieri, prodotto Nembro, nelle vetrerie Pace: di “Una Murano. semplice L’ossido tecnologia di arsenico per proteggere costituisceil vetro composto durante ideale l’attività per l’affinaggio di cantiere” e (pagina la decolorazione 15), ha come <strong>del</strong> obiettivo cristallo muranese. la valutazione I risultati <strong>del</strong>l’effetto, sin qui in ottenuti terminidi resistenza, <strong>del</strong>la tecnologia proposta, utilizzata per rimuovere i difetti sulla superficie di pannelli dih<strong>anno</strong> permesso di verificare che la sua sostituzione con materie prime alternative non tossiche qualivetro, mediante prove meccaniche. Le prove sono state condotte secondo la norma UNI EN 1288-3:2001solfato, su pannelli loppa in e vetro ossido temprato di cerio termicamente è possibile. e su pannelli di vetro stratificato; i dati ottenuti sono statielaborati al fine di valutare la resistenza meccanica <strong>del</strong>le lastre di vetro, dopo trattamento di abrasione elevigatura, secondo la tecnologia proposta da <strong>Vetro</strong>care®.Nel nostro abituale spazio storico, presentiamo l’articolo di Riccardo Cella “Storia di un marchiocontraffatto Nel nostro consueto a Venezia spazio nel XVIII storico secolo”, presentiamo a pagina l’articolo 19. Esso riguarda <strong>del</strong> Prof. un Fiori: tema “<strong>Vetro</strong> di attualità: musivo la contraffazione<strong>del</strong> VI secoloe dagli i sistemi scavi di <strong>del</strong>la protezione Basilica <strong>del</strong>le di San produzioni. Severo a L’Autore Classe (Ravenna)”, ricostruisce a un pagina processo 22. avvenuto a Venezia nel 1780relativoLo studioaddiunatesserecausamusiveintentataprovenientida un produttoredagli scavidi perle<strong>del</strong>lacontroBasilicaundiconcorrenteSan SeverocheaavevaClasseabusivamenteha costituitol’occasione per un confronto fra le caratteristiche dei vetri musivi <strong>del</strong>le chiese ravennati e la produzioneutilizzatovetraria coevail proprioa Classe,marchiounicodiesempiofabbrica,scopertocontraffacendolo.di lavorazione di vetro venuto alla luce con gli scaviCome archeologici si può notare, nel territorio il problema attorno è antico a Ravenna. e coloro che oggi soffrono situazioni analoghe possono verificarecome e con quali tempi e modalità la Repubblica di Venezia interveniva per proteggere il valore <strong>del</strong>leNella rubrica “Aggiornamento normativo” (Battaglia, SSV) viene presentata una monografia conproduzionilo scopo dieriassumere<strong>del</strong>le esportazioni.il contenuto <strong>del</strong>la norma UNI EN 14181:2005 “Emissioni da sorgente fissa -Assicurazione <strong>del</strong>la qualità di sistemi di misurazione automatici” e il Decreto Legislativo n. 152/06. AA pagina pagina 3731, il servizio. il documento “Taratura e verifica dei Sistemi di Monitoraggio <strong>del</strong>le Emissioni” - a cura diWalter Battaglia - descrive le modalità con cui il nostro laboratorio ambientale effettua tali attività.Antonio TucciAntonio Tucci2
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>6-<strong>2011</strong>Sostituzione <strong>del</strong>l’arsenico nelle miscele vetrificabiliper la produzione di vetro cristalloRoberto Falcone, Sandro Hreglich, Bruno Profi loIntroduzioneL’ossido di arsenico viene diffusamente utilizzatonella produzione di vetro artistico. Nei vetri silicosodico-calciciquesto ossido è impiegato con successocome affinante e ossidante essendo le temperaturedi reazione perfettamente compatibili con letemperature di fusione dei forni per vetro artistico. Aseguito <strong>del</strong>la direttiva europea “Registration EvaluationAuthorization Chemical Substances” (REACH,1907/2006/EEC) l’utilizzo di questa sostanza nonsarà più consentito o, quanto meno, molto limitatonel prossimo futuro. Con il Progetto di ricercaindustriale denominato “Eliminazione dei composti<strong>del</strong>l’arsenico dalla miscela vetrifi cabile nelle produzioniartistiche muranesi e sostituzione con materieprime alternative non pericolose”, finanziatoda Ministero <strong>del</strong>lo sviluppo economico, Ministero<strong>del</strong>l’ambiente, Ministero <strong>del</strong>la salute, Camera diCommercio di Venezia e <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong><strong>Vetro</strong>, è stata avviata un’attività di sperimentazionemirata ad eliminare l’arsenico dalla miscele vetrificabiliper vetro artistico, sostituendolo con altrematerie prime non tossiche per l’uomo e per l’ambiente.In questo articolo si riportano i risultati di provesperimentali eseguite su scala di laboratorio e industrialerelative alla produzione di vetro cristallo sodico-calcicoutilizzando solfati come materie primeaffinanti alternative all’ossido di arsenico. L’utilizzodei solfati come affinanti nei vetri sodico-calciciindustriali (come contenitori alimentari e lastre divetro float) è una procedura ben consolidata. Tuttaviaqueste produzioni si realizzano a temperaturesignificativamente più elevate (1500°C-1600°C) rispettoalla maggior parte <strong>del</strong>le produzioni artistiche(1300°C-1400°C ). Per realizzare una efficace azioneaffinante dei solfati è necessario quindi introdurreun agente riducente nella miscela vetrificabile.Fusioni sperimentali di miscele vetrificabili per laproduzione di vetro cristallo silico-sodico-calcicosono state effettuate sostituendo l’ossido di arsenicocon solfati associati a composti riducenti qualigrafite, carburo di silicio, loppa d’altoforno (BlastFurnace Slag). Piccole quantità di ossido di ceriosono inoltre state introdotte per contrastare l’effettonegativo dei riducenti sul colore residuo <strong>del</strong> vetro.Le prove eseguite h<strong>anno</strong> prodotto risultati incoraggianti;tuttavia, per una buona qualità <strong>del</strong> vetroè necessario definire un adeguato ciclo termico <strong>del</strong>processo di fusione che preveda, durante la fase diaffinaggio, temperature superiori a quelle normalmenteimpiegate.1. Il cristallo di MuranoL’origine <strong>del</strong> cristallo muranese risale al XV secolo,quando il famoso vetraio muranese Angelo Baroviercreò un vetro trasparente e incolore con eccellenticaratteristiche di limpidezza ed omogeneità che lorendevano simile ai cristalli di quarzo naturali (cristallodi rocca) [1]. Sino ad allora a Murano si produceva,ad imitazione <strong>del</strong> cristallo, il “vitrum blanchum”che, a causa <strong>del</strong>la presenza di significativequantità di impurità nelle materie prime (ossido diferro), doveva subire un processo di decolorazionefisica con aggiunta di quantità significative di colorantecomplementare (ossido di manganese, dettosapone dei vetrai); il risultato era un vetro sufficientementeincolore ma con ridotta trasmissione luminosa(vetro ingrigito). Nella produzione <strong>del</strong> “cristallo”le impurità <strong>del</strong>le materie prime erano ridotte3
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>grazie ad un processo di depurazione <strong>del</strong> fondente(generalmente ceneri di piante), che consentiva diottenere un vetro con colore residuo molto meno intensoe quindi facilmente neutralizzabile con quantitàdi decolorante molto inferiori. Il risultato era unvetro con una elevata trasparenza comparabile perlimpidezza al cristallo di rocca.La tradizione <strong>del</strong> vetro cristallo è mantenuta vivaancora oggi dai vetrai muranesi con la produzionedi splendidi manufatti artistici (Fig. 1). Il cristalloè un vetro silico-sodico-calcico prodotto in forni acrogiolo (Fig. 2), utilizzando materie prime ad elevatapurezza. I principali componenti <strong>del</strong>la miscelavetrificabile sono sabbia di silice, soda Solvay (sodiocarbonato), marmo (calcio carbonato), potassa(potassio carbonato), borace pentaidrato, ossido diarsenico e nitrati. Nella Tab. 1 si riporta, a titolo diesempio, la composizione chimica tipica di un vetrocristallo muranese.Fig. 2 - Forno a crogiolo tradizionale muraneseTab. 1 - Composizionetipica di un vetro cristallomuranese (% in peso)SiO 271.0Al 2O 30.5Na 2O 16.0K 2O 3.0CaO 6.5As 2O 30.5Fe 2O 3tot 0.015B 2O 31.5Fig. 1 - Scultura in cristallo muranese4
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>6-<strong>2011</strong>2. L’arsenico nel cristallo muraneseOltre che dalla elevata purezza <strong>del</strong>le materie prime,la qualità <strong>del</strong> cristallo dipende anche da altri parametrilegati al processo produttivo, in particolarel’omogeneità e lo stato ossidoriduttivo (redox).Per garantire l’elevata omogeneità è necessarioche l’affinaggio <strong>del</strong> vetro durante la fase finale <strong>del</strong>lafusione sia particolarmente efficiente. Durante iprimi stadi <strong>del</strong>la fusione <strong>del</strong> vetro, le reazioni deicarbonati presenti nella miscela vetrificabile d<strong>anno</strong>luogo alla formazione di numerose piccole bolle dianidride carbonica che devono essere eliminate dalvetro fuso. L’eliminazione <strong>del</strong>le bolle è favorita edaccelerata dall’introduzione nella miscela vetrificabiledi sostanze - gli affinanti - che, nella fase finale<strong>del</strong> processo di fusione, quando la temperaturaraggiunge il suo massimo valore, si decompongonosviluppando bolle di grandi dimensioni (<strong>del</strong>l’ordinedi alcuni millimetri) all’interno <strong>del</strong>la massa fusa. Aparità di viscosità <strong>del</strong> fuso, la velocità ascensionaledi una bolla è direttamente proporzionale al quadrato<strong>del</strong> suo raggio [2]; ne consegue che, nel loro motoverso la superficie <strong>del</strong> bagno, le bolle prodotte dagliaffinanti assorbono e trascinano le bolle più piccolefavorendone l’eliminazione dal fuso.L’ossido di arsenico trivalente (As 2O 3) è l’agenteaffinante più efficiente che, normalmente associatoa nitrati alcalini, viene utilizzato nelle miscelevetrificabili per vetro cristallo [3]. La sua azioneaffinante è il risultato di una sequenza di reazionichimiche che avvengono a diversi stadi <strong>del</strong> processodi fusione a diverse temperature [4, 5]. Durante ladecomposizione dei componenti <strong>del</strong>la miscela vetrificabile,l’ossido di arsenico trivalente reagisce conil nitrato di sodio ossidandosi a pentossido secondola probabile reazione:4NaNO 3+ 2As 2O 3→ 2Na 2O + 2As 2O 5+ 4NO ↑ + O 2↑ (1)Questa reazione sviluppa quantità significative digas (ossigeno e ossidi di azoto) che rimescolano lamiscela parzialmente fusa (batch stirring). Quandola fusione <strong>del</strong>la miscela vetrificabile è completatala temperatura viene innalzata (T > 1300°C) per favorirel’affinaggio <strong>del</strong> vetro; a queste temperaturel’ossido di arsenico trivalente è più stabile e, di con-seguenza, il pentossido si decompone tornando allafase trivalente:As 2O 5→ As 2O 3+ O 2↑ (2)Questa reazione produce una grande quantità di ossigenoche può formare nuove bolle o diffondereall’interno di bolle preesistenti più piccole aumentandonele dimensione e incrementando enormementela loro velocità ascensionale. Il successivoabbassamento termico verso la temperatura di lavorazionesposta l’equilibrio <strong>del</strong>la reazione (2) di nuovoverso sinistra, con tendenza alla formazione <strong>del</strong>lafase pentavalente. Essendo l’ossigeno disciolto nelvetro già stato consumato, la domanda può esseresoddisfatta dalla diffusione di ossigeno da bolle residueeventualmente presenti nel fuso che vengonodefinitivamente riassorbite.Le temperature di reazione <strong>del</strong>l’ossido di arsenicosono in perfetto accordo con le tipiche temperaturedi fusione dei forni per vetro artistico che, di norma,non superano i 1400°C. Per questo motivo l’ossidodi arsenico rappresenta l’affinante ideale per questotipo di produzione.Dal punto di vista <strong>del</strong> colore residuo lo stato ossidoriduttivo<strong>del</strong> vetro gioca un ruolo molto importantenella qualità <strong>del</strong> prodotto finale. La produzione<strong>del</strong> cristallo richiede infatti condizioni di fusionefortemente ossidanti al fine di minimizzare la colorazioneverde-blu dovuta al ferro ferroso che vienepercepita con un’intensità circa tre volte superiorerispetto alla tonalità giallo chiara prodotta da unaquantità equivalente di ferro ferrico [6] (decolorazionechimica, Fig. 3).Fig. 3 - Variazione <strong>del</strong> colore prodotto dal ferro in un vetrosodico-calcico in funzione <strong>del</strong> rapporto redox5
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Da questo punto di vista, l’ossido di arsenico svolgeanche una importante azione ossidante (reazione2) con effetto positivo sulla decolorazione finale <strong>del</strong>vetro.La direttiva europea “Registration EvaluationAuthorization Chemical Substances” (REACH,1907/2006/EEC) limiterà drasticamente l’utilizzodi questa sostanza nel prossimo futuro.Il Progetto di ricerca industriale denominato “Eliminazionedei composti <strong>del</strong>l’arsenico dalla miscelavetrifi cabile nelle produzioni artistiche muranesi esostituzione con materie prime alternative non pericolose”,finanziato da Ministero <strong>del</strong>lo sviluppo economico,Ministero <strong>del</strong>l’ambiente, Ministero <strong>del</strong>lasalute, Camera di Commercio di Venezia e <strong>Stazione</strong><strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> (SSV), prevede l’avvio<strong>del</strong>la sperimentazione per la sostituzione <strong>del</strong>l’ossidodi arsenico nella produzione <strong>del</strong> vetro artistico.Nell’ambito di questo progetto, la SSV ha realizzatouna serie di prove su scala di laboratorio e industrialeper verificare la possibilità di eliminare l’arsenicodalla produzione vetraria muranese sostituendolocon solfati e altri composti non tossici.2. L’affinaggio con i solfatiI solfati sono attualmente utilizzati come affinantinella produzione industriale di vetri silico-sodicocalciciper contenitori alimentari (bottiglie, vasi) elastre (vetro float) secondo una procedura consolidatada diversi decenni. Il composto normalmenteutilizzato è il solfato di sodio (Na 2SO 4), ma inalcuni casi può essere utilizzato anche solfato dicalcio (CaSO 4); a temperature relativamente basse(< 1100°C) il solfato di sodio fonde formando unafase liquida immiscibile. A temperature più elevate(> 1400-1450°C) reagisce decomponendosi in ossidodi sodio e anidride solforosa e ossigeno secondola reazione [7]:Na 2SO 4→2 Na 2O + O 2↑ + 2 SO 2↑ (3)L’anidride solforosa e l’ossigeno liberati dalla decomposizione<strong>del</strong> solfato diffondono all’interno<strong>del</strong>le piccole bolle di anidride carbonica, aumentandoneil volume e favorendo la loro risalita verso lasuperficie <strong>del</strong> vetro fuso.Se un agente riducente (ad esempio carbone) vieneaggiunto alla miscela vetrificabile questo, a temperatureinferiori a 1000°C, reagisce con ossigeno eanidride carbonica formando monossido di carboniosecondo le reazioni [8]:C + O 2→ CO 2(4)C + CO 2→ 2CO (5)A temperature comprese tra 1100°C e 1300°C,il solfato di sodio reagisce con il monossido dicarbonio decomponendosi in ossido di sodio,anidride solforosa e anidride carbonica secondo lareazione [9]:Na 2SO 4+ CO → Na 2O + SO 2↑ + CO 2↑ (6)In questo caso, l’azione affinante dei gas prodottidalla reazione si realizza a temperature inferiori, teoricamentepiù adeguate ai cicli termici tipici <strong>del</strong>laproduzione di vetro artistico.3. Fusioni sperimentali di laboratorioSulla base di questi dati, si è deciso di eseguire fusionisperimentali di miscele vetrificabili per vetrocristallo, sostituendo l’ossido di arsenico con solfatodi sodio associato ad un composto riducente peradeguare le temperature di affinaggio ai cicli termicidi forni per vetro artistico.I riducenti associati al solfato di sodio scelti per leprove sono il carburo di silicio (SiC), il silicio metallico(Si) la grafite (C) e la loppa d’altoforno (BlastFurnace Slag, BFS). La loppa, denominata commercialmentevitrite, è una materia prima secondaottenuta dal trattamento (essicazione, omogeneizzazione,macinazione e deferrizzazione, selezione granulometrica)<strong>del</strong>la scoria d’altoforno, sottoprodotto<strong>del</strong>la produzione <strong>del</strong>la ghisa. L’utilizzo <strong>del</strong>la loppacome materia prima seconda nell’industria <strong>del</strong> vetroin America risale agli anni ’50 <strong>del</strong> secolo scorso,mentre fu introdotta in Europa solo a partire daglianni ’70. Da un punto di vista chimico (Tab. 2), laloppa è costituita prevalentemente da silice e ossidodi calcio, minori quantità di allumina e ossido di6
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>magnesio; altri ossidi sono presenti in tracce (< 1%in peso). Queste materie prime contengono inoltrezolfo quasi tutto sotto forma di solfuro (circa 1%in peso) e piccole quantità di carbone. L’impiego dipiccole quantità di loppa (4-5%) nelle miscele vetrificabiliper vetro cavo industriale accelera, a paritàdi temperatura, i processi di fusione ed affinaggio,con conseguente beneficio in termini di risparmioenergetico [10].Sono state preparate e fuse quattro miscele vetrificabilisenza ossido di arsenico e con solfato di sodioe un diverso componente riducente per ciascuna miscela;le composizioni <strong>del</strong>le miscele sono riportatenella Tab. 3. Le fusioni sono state eseguite utilizzandoun forno elettrico e crogioli silico-alluminosi,h<strong>anno</strong> avuto durata di tre ore con una temperaturamassima di 1350°C e temperatura di ricottura paria 520°C.Tab. 2 - Intervalli di concentrazione deicomponenti <strong>del</strong>le loppe per vetreria (% in peso)minimomassimoSiO 235.0 38.4Al 2O 311.4 12.8Na 2O 0.2 0.4K 2O 0.3 0.4CaO 35.9 45.4MgO 7.0 10.8Fe 2O 3tot 0.2 0.4MnO 0.3 0.8TiO 20.4 0.6Stot 0.9 1.3C < 0.1 0.2Nella Fig. 4 sono mostrati i provini di vetro ottenuti;le foto documentano come i vetri migliori in terminidi affinaggio siano i provini prodotti utilizzandocarburo di silicio e loppa. Nella Tab. 4 si riportanole analisi chimiche dei vetri eseguite mediante spettrometriadi fluorescenza dei raggi X (XRF); inoltre,mediante spettrofotometria è stato determinato il tenorein ferro ferroso (FeO), riportato anch’esso intabella assieme alla percentuale di ferro ferroso rispettoal ferro totale (redox <strong>del</strong> vetro). Dai dati riportatisi evidenzia che tutti i vetri sono caratterizzati davalori <strong>del</strong> redox molto elevati, che oscillano intornoal 60% e che producono nel vetro un colore residuodi tonalità blu non accettabile per un cristallo.Tab. 3 - Composizione <strong>del</strong>le miscele vetrificabili,fusioni di laboratorio (parti in peso)1 2 3 4Sabbiasilicea100 100 100 100Soda 40 40 40 40Borace 6 6 6 6Calciocarbonato16.5 16.5 16.5 16.5Sodiosolfato0.8 0.8 0.8 0.8Potassiocarbonato4.5 4.5 4.5 4.5Carburodi silicio0.03 - - -Siliciometallico- 0.05 - -Grafite - - 0.02 -Loppa - - - 0.51 23 4Fig. 4 - Provini dei vetri ottenuti con le fusioni 1, 2, 3 e 47
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Tab. 4 - Composizione chimica e redox deicampioni di vetro ottenuti con le miscele 1, 2, 3 e 4(% in peso)1 2 3 4SiO 272.0 71.5 72.0 72.0Al 2O 30.2 0.2 0.1 0.2Na 2O 17.0 17.5 17.0 17.0K 2O 2.0 1.8 2.0 2.0CaO 6.5 6.6 6.6 6.7B 2O 31.5 1.5 1.4 1.4SO 3tot 0.27 0.29 0.31 0.29Fe 2O 3tot 0.013 0.013 0.014 0.014FeO 0.0075 0.007 0.007 0.0075% Fe 2+ /Fetot 64 60 55 59Per cercare di neutralizzare l’effetto negativo <strong>del</strong>riducente sullo stato ossidoriduttivo <strong>del</strong> vetro equindi sul colore residuo <strong>del</strong> vetro, si è deciso diaggiungere alla miscela vetrificabile piccole quantitàdi ossido di cerio tetravalente come agenteossidante. Questo composto ad alta temperatura(T > 1350-1400°C) si riduce a ossido trivalente liberandoossigeno in grado di ossidare il ferro ferrosoa ferro ossido, secondo la reazione [11, 12]:4CeO 2→ 2Ce 2O 3+ O 2(5)Sono state quindi preparate tre miscele, una miscela“tradizionale” con ossido di arsenico e nitrati e duecon solfato di sodio associato rispettivamente a carburodi silicio e loppa; in entrambe le miscele contenentisolfato è stata inserita una piccola quantità diossido di cerio, pari a 0.1 parti in peso per 100 partidi sabbia (Tab. 5).Nella Fig. 5 sono riportate le foto dei provini dei trevetri prodotti, mentre le composizioni e i valori <strong>del</strong>redox sono riportati in Tab. 6. I dati mostrano unevidente miglioramento <strong>del</strong> rapporto redox nei duevetri prodotti con solfati rispetto alla prima serie difusioni senza ossido di cerio. Tuttavia, i valori sonoancora troppo elevati rispetto al valore di riferimen-Tab. 5 - Composizione <strong>del</strong>le miscele vetrificabili5, 6 e 7 (parti in peso)5 6 7Sabbiasilicea100 100 100Sodiocarbonato37.3 40 40Borace 6 6 6Calciocarbonato16.5 16.5 16.5Sodiosolfato- 0.8 0.8Potassiocarbonato4.5 4.5 4.5Sodionitrato4.7 - -Arsenicoossido0.6 -Carburodi silicio- 0.03 -loppa - - 0.5Cerioossido- 0.1 0.1to <strong>del</strong> vetro affinato con ossido di arsenico e nitratodi sodio (30% e 22% contro 6%). In Fig. 6 sonoriportate le coordinate colorimetriche nel pianoCIEa*b* 1976 [13]; il grafico mostra che il vetro5 prodotto con ossido di arsenico si posiziona nellazona <strong>del</strong> giallo, mentre il vetro 6 prodotto con solfatie carburo di silicio è spostato verso il verde; il vetro7, prodotto con solfati e loppa, occupa una posizioneintermedia.Sulla base di questi risultati è stata effettuata una terzaserie di fusioni <strong>del</strong>la miscela con loppa e ossido di cerio,con modalità analoghe alle precedenti ma diverse temperaturemassime: 1340°C, 1380°C, 1420°C e 1450°C.Nei vetri ottenuti è stato determinato il rapporto redox.Nel grafico di Fig. 7 si riporta la variazione <strong>del</strong> rapportoredox al variare <strong>del</strong>la temperatura di fusione e, per i diversivetri, la tonalità <strong>del</strong> colore residuo. Il grafico evidenziache, per ottenere valori di redox inferiori a 10%e un colore residuo in linea con il cristallo prodotto conossido di arsenico, è necessario raggiungere durante ilciclo di fusione temperature superiori a 1400°C.8
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Fig. 5 - Provini dei vetri ottenuti con le fusioni 5, 6 e 7Tab. 6 - Composizione chimica e redox deicampioni di vetro ottenuti con le miscele 5, 6 e 7(% in peso)5 6 7SiO 271.0 72.0 71.8B 2O 31.5 1.4 1.5Al 2O 30.3 0.1 0.3Na 2O 17.3 17.0 17.0K 2O 2.0 2.0 2.1CaO 6.7 6.6 6.6As 2O 30.5 - -SO 3tot - 0.28 0.30CeO 2- 0.05 0.055Fe 2O 3tot 0.017 0.016 0.017FeO 0.0005 0.0043 0.0033% Fe 2+ /Fetot 6 30 22Fig. 7 - Variazione <strong>del</strong> redox (% ferro ferroso su ferro totale)e <strong>del</strong> colore residuo al variare <strong>del</strong>la temperatura massima difusione576Fig. 6 - Coordinate CIE ab dei vetri 5, 6 e 7 (spessore 10 mm)9
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>4. Fusioni su scala industriale in forno a crogioliSulla base dei risultati ottenuti dalle prove fusionein laboratorio sono state effettuate alcune prove difusione su scala industriale, sostituendo l’ossido diarsenico con solfati, loppa e ossido di cerio nellemiscele vetrificabili normalmente utilizzate. NellaTab. 7 si riportano i dati relativi ai cicli termici <strong>del</strong>lefusioni eseguite presso due vetrerie di Murano e lequantità di solfato, loppa e ossido di cerio utilizzatenella miscela. Inoltre sono riportate le concentrazionidi zolfo totale, ossido di cerio, ferro totale eferro ferroso e il rapporto redox dei vetri prodotti.Per quanto riguarda la vetreria A che produce vetroper oggettistica, il tempo e le temperature di fusione<strong>del</strong>la miscela vetrificabile sono stati sostanzialmentemantenuti identici a quelli impiegati con la miscelavetrificabile tradizionale; il processo di affinaggioè stato invece condotto a temperature più elevate dicirca 30°C. La vetreria B che produce vetro per il-luminazione ed istallazioni per arredo urbano, purmantenendo in tutto il ciclo di fusione le stesse temperaturesia in fusione che in affinaggio, ha dovutoprolungare la fase di affinaggio di circa 30 minuti.In entrambi i casi sono stati prodotti vetri omogeneie ben affinati. Il vetro prodotto dalla vetreria A contemperature di affinaggio superiori a 1400°C e minorequantità di loppa si caratterizza per un minorecontenuto in ferro ferroso e un migliore rapporto redox(4.5% rispetto a 10% <strong>del</strong> vetro B). Per cercaredi migliorare la qualità <strong>del</strong> vetro B che presentavaun colore residuo verde è stata quindi eseguita unaseconda fusione nelle medesime condizioni, riducendola quantità di loppa da 1.5 kg a 1.0 kg per 100kg di sabbia. Nella Fig. 8 sono messi a confrontodue provini prodotti nelle due fusioni; nel vetro disinistra, prodotto con 1.0 kg di loppa, si osserva unasignificativa riduzione <strong>del</strong> colore residuo.Tab. 7 - Dati relativi ai cicli termici, alle quantità di solfato, loppa e ossido di cerio utilizzate nelle miscelevetrificabili e ai valori di zolfo totale, ossido di cerio, ferro totale, ferro ferroso e rapporto redox dei vetriprodotti presso le vetrerie A e B di MuranoVETRERIA AVETRERIA BPeso miscela (kg) 117 277<strong>Vetro</strong> prodotto (kg) 97 230Resa <strong>del</strong>la miscela (%) 83 83Temperatura iniziale di fusione (°C) 1348 1320Temperatura finale di fusione (°C) 1392 1350Temperatura massima di fusione (°C) 1400Temperatura di affinaggio (°C) 1458 1360Tempo di fusione (ore) 5Tempo di affinaggio (ore) 29Sodio solfato (kg per 100 kg di sabbia) 0.7 1.2Loppa (kg per 100 kg di sabbia) 0.5 1.5Cerio ossido (kg per 100 kg di sabbia) 0.1 0.1SO 3tot 0.29 0.28CeO 20.07 0.09Fe 2O 3tot 0.012 0.017FeO 0.0005 0.0015% Fe 2+ /Fetot 4.5 1010
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>6-<strong>2011</strong>Fig. 8 - Provini prodotti nella vetreria B con 1.0 kg di loppa (a sinistra) e 1.5 kg di loppa (a destra)5. Fusioni su scala industriale in forno a vascaNella Tab. 8 si riportano i dati relativi ai cicli termici<strong>del</strong>le fusioni eseguite presso una vetreria di Murano(vetreria C) dotata di un forno a vasca discontinuodi circa 1,2 tonnellate. Nella stessa tabella sono riportateanche le quantità di solfato, loppa e ossido dicerio utilizzate nella miscela, assieme alle concentrazionidi zolfo totale, ossido di cerio, ferro totalee ferro ferroso e il rapporto redox dei vetri prodotti.Per quanto riguarda la vetreria C, il tempo e le temperaturedi fusione e di affinaggio sono stati sostanzialmenteidentici a quelli impiegati con la miscelavetrificabile tradizionale.Il vetro prodotto era omogeneo e ben affinato; inoltre,come evidenziato dal basso contenuto di FeO,anche la qualità <strong>del</strong>la decolorazione era buona; èstato possibile quindi effettuare la normale produzionecon la tecnica <strong>del</strong>la mo<strong>del</strong>lazione manuale <strong>del</strong>vetro a caldo (vedi Fig. 9).Nella vetreria C, durante il ciclo di fusione sonostate eseguite anche le analisi <strong>del</strong>le emissioni effettuandoi prelievi a monte <strong>del</strong>l’impianto di abbattimentofumi, in tre fasi distinte:fase 1 (infornaggio miscela vetrificabile;fase 2 (fine fusione miscela vetrificabile);fase 3 (fine affinaggio fuso vetroso).I risultati ottenuti sono riportati in Tab. 8 confrontaticon i limiti di legge stabiliti per le vetrerie artisticheTabella 8 - VETRERIA CPeso miscela (kg) 450<strong>Vetro</strong> prodotto (kg) 382Resa <strong>del</strong>la miscela (%) 84.8Temperatura iniziale di fusione (°C) 1380Temperatura finale di fusione (°C) 1400Temperatura massima di fusione (°C) 1400Temperatura di affinaggio (°C) 1430Tempo di fusione (ore) 8Tempo di affinaggio (ore) 3.5Sodio solfato (kg per 100 kg di sabbia) 1.0Loppa (kg per 100 kg di sabbia) 0.53Cerio ossido (kg per 100 kg di sabbia) 0.1SO 3tot 0.44CeO 20.06Fe 2O 3tot 0.0101FeO
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Fig. 9 - Esempio di produzione <strong>del</strong>la vetreria CTab. 9 - Analisi emissioni fusione vetreria CInquinantiEmissioni fase 1 Emissioni fase 2 Emissioni fase 3mg/Nm 3 13% O 2 mg/Nm 3 13% O 2 mg/Nm 3 13% O 2LIMITImg/Nm 3 13% O 2SO 21.12 1.20 1.20 600antimonio 0.07 0.72 0.10 0.500Emissionimedie miscelacon arsenicoarsenico 0.41 1.93 0.38 0.500 15.50bario 0.30 0.27 0.35 0.500cerio 0.02 0.009 0.02 0.50012
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>I dati in particolare di antimonio ed arsenico relativiai prelievi effettuati in tre distinti momenti (infornaggiomiscela, fine fusione miscela e fine affinaggio),indicano che solo il prelievo effettuato durantela fase centrale <strong>del</strong> processo di fusione ha dato valorisuperiori ai limiti, probabilmente a causa <strong>del</strong>la presenzain tracce di questi elementi nella sovrastruttura<strong>del</strong> forno e nel rottame di vetro rifuso durante ilprocesso di fusione.Il vetro prodotto dalla vetreria C è stato inoltre sottopostoal test di cessione secondo la Norma UNI-EN 12457 utilizzata per individuare la tipologia <strong>del</strong>ladiscarica in cui conferire il materiale a fine vita; inTab. 10 sono riportati i risultati ottenuti.Tab. 10 - Test di cessione secondo normaUNI EN 12457vetro testatomg/kgValori Limitemg/kgAs < 0.06 0.5Ba 19.93* 20Cd < 0.03 0.04Cr < 0.03 0.5Cu < 0.03 2Hg 0.01Mo < 0.06 0.5Ni < 0.03 0.4Pb < 0.06 0.5Sb < 0.03 0.06Se < 0.06 0.1Zn 0.1 4Cloruri
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Bibliografia1. M. Verità, 1985, L’invenzione <strong>del</strong> cristallo muranese:una verifi ca analitica <strong>del</strong>le fonti storiche,Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, n. 1,pp. 17-292. V.G. Levich, 1962, Physiochemical hydrodynamics.Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ USA3. E. Moretti, F. Nicoletti, 1979, L’impiego <strong>del</strong>lematerie prime nelle vetrerie artistiche di Murano e<strong>del</strong>la terraferma veneziana, Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong><strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, n. 5, pp. 376-3824. M.B. Volf, 1984, Chemical approach to glass. Elsevier,Amsterdam and New York5. R. Pyare, S. Prasad Singh, A. Singh, P. Nath,1982, The As 3+ - As 5+ equilibrium in borate and silicateglasses, Physics and Chemistry of Glasses, vol.23, n. 5, pp. 158-1686. C.R. Bamford, 1977, Color generation and controlin glass. Elsevier, Amsterdam7. R. Falcone, S. Ceola, A. Daneo, S. Maurina,<strong>2011</strong>, The role of sulfur compounds in coloringand melting kinetics of industrial glass, Reviews inMineralogy and Geochemistry, vol. 73, pp. 113-1418. J. Kloužek , M. Arkosiová, L. Němec, P. Cincibusová,2007, The role of sulphur compounds in glassmelting, Glass Technology A, vol. 48, pp. 176-1829. R.G.C. Beerkens, K. Kahl, 2002, Chemistry ofsulphur in soda-lime-silica glass melts, Physics andChemistry of Glasses, vol. 43, n. 4, pp. 189-19810. S. Hreglich, M. Scan<strong>del</strong>lari, M. Verità, 1979, Impiego<strong>del</strong>le scorie d’altoforno come materia primanella produzione <strong>del</strong> vetro, Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong><strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, n. 9, pp. 205-21411. V. Gottardi, G. Paoletti, M. Tornati, 1962, Theratio Ce 3+ /Ce 4+ in the melting of different glassesand its infl uence on their properties, Advances inGlass Technology, pp. 412-42312. R. Basso, S. Hreglich, F. Nicoletti, L. Tedesco,M. Verità, 1985, L’impiego di CeO 2nei processidi affi naggio - ossidazione dei vetri industriali, inalternativa all’As 2O 3, Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong><strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, n. 4, pp. 161-16413. P. Polato, P. Segato, A. Daneo (1989), Determinationof color difference or “colorlessness” forglasses using the spectrophotometric method, Rivista<strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, n. 1, pp.81-90AutoriRoberto Falcone, Sandro Hreglich, Bruno Profi lo<strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>, Muranorfalcone@spevetro.it14
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Sostituzione <strong>del</strong>l’arsenico nelle miscele vetrificabili per la produzione di vetro cristalloNelle pagine precedenti abbiamo presentato i primirisultati <strong>del</strong>lo studio relativo alla sostituzione<strong>del</strong>l’arsenico nelle produzioni di vetro artistico inparticolare muranese, problema di particolare attualitàvisto l’orientamento <strong>del</strong>le autorità europeea eliminare o a limitare in modo molto controllatol’impiego di tale sostanza. Le produzioni lagunariutilizzano da sempre i sali <strong>del</strong>l’arsenico per otteneretonalità, stabilità <strong>del</strong> colore e purezza <strong>del</strong> cristallo efinora senza alternative. Il progetto messo a puntoda SSV aveva l’obiettivo di trovare validi sostitutisenza penalizzare il prodotto, ma individuando alternativedi facile impiego, poco costose, flessibilialle tecnologie impiegate e soprattutto sostenibili.Nei prossimi numeri <strong>del</strong>la Rivista pubblicheremo leesperienze condotte sui vetri colorati e le indaginisul ciclo di vita <strong>del</strong> prodotto e le sue ripercussionisulla salute. Allo scopo di rendere sintetico e immediatoil risultato <strong>del</strong>le indagini e il contesto in cuiil progetto è stato ideato, programmato, finanziatoe realizzato, presentiamo di seguito alcune schededi sunto. Per ogni informazione di dettaglio, o peri suggerimenti relativi alle differenti situazioni produttivee tecnologiche, gli uffici di SSV sono a disposizione.(a cura di N. Favaro)Distretto<strong>del</strong><strong>Vetro</strong>ArtisticodiMurano 260aziende,dicui30industriali 1200addetti Fatturatodi100milionidiEuro Produzionedi Oggettiartistici Lampadari Specchi Oggettiallume15
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Utilizzo<strong>del</strong>l’arseniconellaproduzionedivetroartisticoMuranese• L’arsenico(anidridearseniosa)vienedatempoutilizzatonellaproduzionedivetroartisticodMuranese (cristallo)• Lesueproprietàchimicofisicheconsentonodiprodurreunvetrodiqualitàsuperiore:i– privodibolle– perfettamentetrasparente– facilmentelavorabileUtilizzo<strong>del</strong>l’arseniconellaproduzionedivetroartisticoMuranese• Ilcristalloèunvetrosodocalcicoprodottoconmaterieprimedialtissimaqualità• Leprincipalimaterieprimeutilizzatesono:– sabbiasilicepurissima– sodiocarbonato(soda)– Sodiocarbonato(marmo)– borace– anidridearseniosa+nitrati– altro16
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Utilizzo<strong>del</strong>l’arseniconellaproduzionedivetroartisticoMuranese Produzionedivetro AnidridearseniosautilizzataDati2008circa10.000tonnellatecirca8tonnellateStima2010• Anidridearseniosautilizzata circa5tonnellateDiminuzionedovutaallariduzione<strong>del</strong>laproduzionedovutaallacrisieconomicaeall’utilizzodisostanzealternative,qualiantimonioNascita<strong>del</strong>progetto Durantelaconsultazioneperl’inserimento<strong>del</strong>triossidodiarseniconell’elencoXIV <strong>del</strong>RegolamentoREACH (sostanzesottoposteadautorizzazione)èemersaunacondizionei )è di iespositivapreoccupante SSV hapropostounostudioperlasostituzione,ovepossibile,<strong>del</strong>studio per sostituzione ove possibile <strong>del</strong>triossidodiarsenicoconsostanzemenopericolose Ilprogettonascedall’esperienza<strong>del</strong>laSSV p inprogettianaloghigvoltiallasostituzionedisostanzepericolose(metalli)conmenopericolose Ilprogettomiraafornirenuovesoluzioniall’industria<strong>del</strong>vetro,i l i i ll’i t i dl tecosostenibiliesocialmenteaccettabili,inunotticadiinnovazionetecnologica17
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Descrizione<strong>del</strong>ProgettoObiettivo: sviluppare<strong>del</strong>le “lineeguidaoperative operative” peragevolareilpassaggiodaproduzionicheprevedonol’usodiarsenicoaproduzionicheutilizzanocompostialternativinonutilizzano composti alternativi nonpericolosi,noncostosiefacilmentereperibiliTimetable: Iniziogiugno2010 Chiusuradicembre<strong>2011</strong>Descrizione<strong>del</strong>ProgettoPartner: ConsorzioVeneziaRicerche AziendeMuranesi FornitoriMaterieprimeEntiSostenitori MinisteroSviluppoEconomico Ministero<strong>del</strong>l’Ambiente Ministero<strong>del</strong>laSalute CameradiCommerciodiVenezia <strong>Stazione</strong><strong>Sperimentale</strong><strong>del</strong><strong>Vetro</strong>18
studiesstudiStoria di un marchio contraffattoa Venezia nel XVIII secoloRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>6-<strong>2011</strong>Riccardo CellaSfogliando le pagine <strong>del</strong>la raccolta di saggi di LuigiZecchin 1 sulla storia <strong>del</strong> vetro veneziano si puòosservare il marchio di fabbrica <strong>del</strong>la ditta “DomenicoRoan e figli”, attiva a Venezia nel Settecento; sivede un albero (“l’albero d’oro”) e una descrizionein caratteri greci <strong>del</strong>la produzione <strong>del</strong>la manifatturae <strong>del</strong>la sua ubicazione nella Dominante (Fig. 1).Fig. 1 - Marchio <strong>del</strong>la ditta “Domenico Roan e Figli”Questa insegna è stata nel 1780 protagonista di unacuriosa vicenda dai tratti purtroppo molto attuali. Èben nota, infatti, la campagna avviata da un ventenniocirca dai vetrai muranesi contro le contraffazioni,culminata nel riconoscimento normativo regionale<strong>del</strong> “Marchio <strong>Vetro</strong> Artistico di Murano”, che“garantisce al consumatore la sicurezza di aver acquistatoun prodotto realizzato nell’isola di Murano,secondo le tecniche tradizionali dei Maestri vetraimuranesi” 2 . Il meccanismo di tutela è molto semplicee prevede che la titolarità esclusiva <strong>del</strong> marchiosia <strong>del</strong>la Regione Veneto, la quale lo concede in usoalle aziende produttrici di vetro artistico nell’isoladi Murano dopo aver verificato il rispetto di una seriedi requisiti; il marchio, in buona sostanza, garantisceal consumatore che i prodotti commerciatisono stati prodotti interamente nell’isola di Murano,“secondo criteri che pur innovativi, siano coerenticon la tradizione muranese” 3 . Gli elementi principalida tenere in considerazione sono quindi due:innanzitutto la Regione, cioè l’autorità pubblica, èproprietaria <strong>del</strong> marchio e garante <strong>del</strong> rispetto di determinatecondizioni da parte <strong>del</strong>la aziende a cui lostesso viene concesso e, in secondo luogo, la tutelariguarda la “territorialità” <strong>del</strong>l’intero ciclo produttivoper contrastare la vendita di prodotti e l’utilizzodi semilavorati fabbricati altrove.Cambiano i tempi, ma non cambiano i problemi;duecentotrenta anni fa come oggi le imitazioni e lecontraffazioni più o meno riuscite rappresentavanouna spina nel fianco difficile da togliere per i produttoridi alta qualità e ancora duecentotrenta annifa come oggi la creazione di un marchio a garanzia<strong>del</strong>la qualità sembrava essere uno strumento in gradodi contribuire a risolvere il problema. La vicendache si va a raccontare ci mostra in che modo fossestrutturata la tutela dei marchi di produzione e quali19
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>fossero i principali pericoli per i produttori di altaqualità. Per dare conto di questa storia mi sono avvalso<strong>del</strong>le carte relative a un processo intentato daGio Batta quondam Domenico Roan contro FrancescoPadovan (entrambi attivi nel commercio <strong>del</strong>leperle a lume) nell’estate <strong>del</strong> 1790 presso i Censori,la magistratura veneziana che dal 1762 ebbe competenzasull’intero sistema vetrario <strong>del</strong>la Dominante4 . Le carte conservate in questo fondo archivisticosono di pregevole interesse giacché, attraverso i processicelebrati davanti a questo tribunale, è possibilerendere conto di quelle “piccole cronache” 5 capacidi svelare in maniera assai vivace molti aspetti <strong>del</strong>lavita quotidiana di uomini e donne comuni di quelperiodo.Sappiamo con certezza che fin dal XV secolo i vetraiveneziani adottarono con sempre maggior frequenzaun’identificazione grafica, cioè un’insegna,per le loro botteghe; tra il ‘500 e il ‘600 il fiorire diqueste insegne raggiunse il culmine per poi affievolirsisenza spegnersi nel ‘700 6 . L’uso di insegne eracomunque diffuso anche tra i perleri, che le utilizzavanoanche per rendere riconoscibili le proprie merciinserendo un cartoncino riproducente il marchionei pacchi spediti ai propri clienti.Ma torniamo al marchio <strong>del</strong>la famiglia Roan. Unaprima registrazione era stata effettuata nel 1727 dalpadre di Domenico, Iseppo quondam Zuanne, perlercon bottega a San Lio; purtroppo non sono conservatiesemplari <strong>del</strong> marchio depositato da Iseppo,tuttavia è rimasta copia <strong>del</strong> costituto 7 con cui venneregistrato: “Iseppo Roan q. Zuanne Perler a San Lio,et in ordine al Proclama ut supra pubblicato, disseaver levato per segno <strong>del</strong>la sua Bottega l’Alberod’Oro, si una, come più, d’Oro, d’Argento, dipintadi rilievo, d’intaglio, e come meglio a lui parerà epiacerà non potendo detta insegna esser levata daaltri <strong>del</strong>la stessa Professione” 8 .Nel 1778 il figlio di Domenico, Gio Batta, informavala magistratura <strong>del</strong>la Giustizia Vecchia, pressocui era tenuto un registro <strong>del</strong>le insegne <strong>del</strong>le botteghe,“di aver trasportato la sua insegna <strong>del</strong>l’Alberod’Oro [...] nella casa di sua abitazione, in Corte Rottaa San Severo” 9 . Sotto la direzione di Domenicola manifattura aveva quindi modificato il marchiointestandolo proprio a quest’ultimo e ai suoi figli.Alla morte di Domenico la bottega era andata ineredità al figlio Gio Batta, il quale si era limitatoa trasferirla al nuovo indirizzo. Qual era l’obiettivo<strong>del</strong>la registrazione <strong>del</strong> marchio? Lo dice chiaramenteGio Batta nel memoriale presentato per l’apertura<strong>del</strong> processo: la notifica veniva effettuata “acciòaltri <strong>del</strong>l’Arte non se ne potesse servire e con talemarca le nostre manifatture sono sempre esitate sinel Veneto, che negli Esteri Stati” 10 . Perlomeno inquesto caso il pericolo maggiore era quindi interno11 ; poteva cioè accadere che fabbricatori minoricercassero di vendere i propri prodotti, presumibilmentedi minor qualità, contraffacendo i marchi diaccompagnamento utilizzati nelle spedizioni. Lamagistratura deputata alla registrazione e conservazionedei marchi era la Giustizia Vecchia, che fino al1762 ebbe giurisdizione anche sulle “arti figlie” <strong>del</strong>sistema vetrario veneziano 12 . Come si è detto, dopoquell’<strong>anno</strong> l’intero settore <strong>del</strong> vetro passò sotto lecompetenze dei Censori e ciò costituì un cambiamentoistituzionale molto importante: di fatto la magistraturagiudicante i conflitti promossi dai perlerinon coincideva più con quella deputata alla tuteladei marchi.Due domande sorgono spontanee: chi era Gio BattaRoan? Che ruolo aveva nella corporazione? Appartenevaad una “antica” famiglia di perleri, come luistesso affermava; rappresentava infatti la terza generazionedi una famiglia che almeno dai primi <strong>del</strong>Settecento aveva iniziato a lavorare nella commercializzazione<strong>del</strong>le perle 13 . Gio Batta era un “capomaestro negoziante”, faceva quindi parte di quellacategoria di perleri che di fatto acquisì il controllo<strong>del</strong>la vita <strong>del</strong>la corporazione nel XVIII secolo. Costoroerano gli artigiani più ricchi, in grado di anticiparei capitali necessari per la gestione <strong>del</strong>l’attività el’acquisto <strong>del</strong>la materia prima. Il capitolare <strong>del</strong>l’Artediscriminava i perleri in due gruppi in questi termini:“negozianti sar<strong>anno</strong> quelli che h<strong>anno</strong> a soministrarei lavori, e gli operari quelli che si possonoricevere e fare” 14 . La divisione nasceva dalla constatazioneche “da una tal promiscuità ne nasceva chenella gran moltitudine di capo mistri vi fossero moltioperari che privi di forza e capitali non facevano ilnegozio che per figura et apparenza, sottometendo ipropri lavori alle leggi arbitrarie et indiscrette dei insidiadori<strong>del</strong>l’Arte che niente cercando di mantenerein riputazione le manifatture, solo miravano a far20
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>6-<strong>2011</strong>sopra d’esse ingordi e esorbitanti profitti”. Fu cosìproibita “la simultaneità <strong>del</strong>le due figure di operaioe di negoziante, ordinandosi che per quel tempo chealcuno avrà far l’operaio non possa fare il negoziante,e quello che avrà esser negoziante non possa farl’operaio” 15 . La decisione tuttavia non fece altro cheacuire la stratificazione interna alla corporazione,rafforzando il controllo dei negozianti sugli operai.Gio Batta apparteneva quindi all’élite corporativa efu molto abile a sfruttare la sua posizione per ottenereun importante successo politico all’interno<strong>del</strong>l’associazione di mestiere; come il padre a metà<strong>del</strong> Settecento 16 , anche lui era infatti riuscito a farsieleggere gastaldo e nel 1789 lo troviamo impegnatoa dirimere alcuni conflitti tra i suoi confratelli inmerito all’organizzazione <strong>del</strong>la fornitura <strong>del</strong> grassoutilizzato per alimentare la lucerna con cui venivanolavorate le perle 17 .Gio Batta era quindi uno dei “pezzi da novanta” <strong>del</strong>lacorporazione, apparteneva a una famiglia di lungatradizione artigiana, era sufficientemente ricco e politicamenteinfluente; nel 1780, tuttavia, il volumedei suoi traffici iniziò a segnare il passo senza ungiustificabile motivo, vista la congiuntura attraversatadal commercio <strong>del</strong>le perle in quel periodo 18 .Mentre si arrovellava sui motivi di una crisi apparentementeinspiegabile, giunse una lettera datata25 febbraio da un suo cliente di Breslavia 19 , AdamoFischer, nella quale quest’ultimo si lamentava nonsolo <strong>del</strong> ritardo di certe spedizioni di merce, ma anchedi essere venuto a sapere che alcuni rivenditoriebrei avevano ricevuto mercanzie simili provenientidai suoi laboratori; si chiedeva il tedesco per qualemotivo quei mercanti avessero avuto la precedenzae quale ragione avesse spinto il Roan a trattarlo così“spezzosamente” 20 . A Gio Batta la cosa non tornava:non aveva infatti mai intrattenuto rapporti commercialicon ebrei in quella città. Intenzionato a far lucesu ciò che stava accadendo, l’11 marzo scrisse alFischer assicurandogli di non aver mai fatto quellespedizioni e pregandolo di informarsi e ragguagliarlosu chi avesse inviato quella merce, per quale doganafosse passata e di mandargli un “attestato conli confronti fatti di nostra ed altra marca, se è simileo se è degrada, così pure il carattere scritto sopra lecarte, se è simile al nostro, mentre tutto deve esseredi una mano” 21 . Il 19 aprile successivo Fischerinviava al nostro perler le informazioni ricercate,rassicurandolo sul fatto che a Breslavia i mercantiebrei si erano accorti <strong>del</strong>la qualità inferiore dei prodottiin questione e avevano smascherato la truffa.Aveva inoltre saputo che era stata spedita una bottedi duecento pacchi di “rubin” 22 accompagnata dalmarchio <strong>del</strong>l’Albero d’Oro; non era tuttavia riuscitoa procurarsi un esemplare da spedire a Venezia, maconsigliava di procedere con le opportune indaginiper capire chi stesse abusando <strong>del</strong>la sua insegna,gettando in discredito il buon nome <strong>del</strong>la sua manifattura23 .La caccia al colpevole non ebbe sviluppi significativifino all’agosto successivo, quando nei pressi diRialto, mentre era in compagnia <strong>del</strong> perler PietroZan Cortese, Gio Batta venne avvicinato da Antonioquondam Zuanne Gaspari, un negoziante di perleche abitava nella parrocchia di San Luca. Questigli mostrò una stampa con l’incisione <strong>del</strong>l’Alberod’Oro speditagli dieci mesi prima da un suo committentedi Breslavia, che gli aveva richiesto unafornitura di perle di quella marca. Come spessoaccade, attraverso le carte processuali non solo èpossibile ricostruire genuini spaccati <strong>del</strong>la vita quotidiana<strong>del</strong>l’epoca, ma ci è anche consentito sentirela viva voce dei protagonisti. Quando Antonio chiesea Gio Batta se avesse mai visto quel marchio, sisentì rispondere da uno stupito Roan “no volè che laconosca, la xe la mia insegna”. Antonio continuò ilracconto spiegandogli di essersi rifiutato di violarele norme inviando manifatture di altrui produzione eche in seguito al suo diniego la corrispondenza conla Germania si era interrotta; il suo cliente tedescoaveva infatti trovato a Venezia un altro negoziantecapace, per così dire, di interpretare le regole conmaggior elasticità. Dopo alcune indagini Antonioaveva scoperto chi era e aveva scelto un momentoben preciso per parlare con Gio Batta: a pochi passidi distanza infatti qualcuno seguiva con apprensioneil confabulare dei due 24 .L’uomo si chiamava Francesco Padovan, un negoziantedi perle che abitava in Barbaria <strong>del</strong>le Tole.Quando aveva visto Roan e Gaspari chiacchierare,si era avvicinato immaginando, o forse temendo,quale fosse l’oggetto <strong>del</strong>la discussione, e alla vista<strong>del</strong> marchio aveva capito che era meglio tagliare lacorda. Lo racconta ai giudici proprio il Roan: “dissi[al Gaspari] chi è questo che fa tal cosa? e lui mi21
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>rispose oh bella non avei visto quello che g’era qua,indicandomi un tal Francesco Padovan, [...] il qualeera in poca distanza, e quando vidde la detta carta sisbandò”.Intanto il racconto di Antonio continuava. La stampache aveva con se era originale, ma a casa avevaanche una copia falsificata datagli da LudovicoPriuli detto Santi che faceva lo stampatore in Corte<strong>del</strong> Spezier a Santa Giustina e riforniva l’Arte deiperleri di “santi”, cioè le bolle che accompagnavanoi carichi di canna di vetro nelle spedizioni da Muranoa Venezia a garanzia <strong>del</strong>la legittimità <strong>del</strong>la spedizione25 . Lo stampatore gli aveva raccontato che ottoo nove mesi prima il Padovan gli aveva chiesto diindicargli un incisore che gli fabbricasse uno stampodi rame con quel marchio e successivamente gliaveva ordinato circa mille stampe <strong>del</strong>lo stesso.Il pomeriggio <strong>del</strong>lo stesso giorno il Roan si erarecato a casa <strong>del</strong> Gaspari per vedere di persona ilmarchio fasullo; in effetti il falso e l’originale eranopressoché indistinguibili, fatta eccezione per le dimensioni:il rame di stampa commissionato dal Padovanera molto più piccolo di quello autentico. Ilcolpevole, o presunto tale, aveva un nome e c’eranodei testimoni per sostenere l’accusa: tutto o quasiera pronto per poter inoltrare una denuncia pressoi Censori.Il 9 agosto la denuncia <strong>del</strong> Roan diede inizio a unprocesso che si svolse con la consueta celerità checaratterizzava i procedimenti avviati dai Censori inquesti casi. Il giorno successivo assieme a Gio Battavenne chiamato a testimoniare anche il Gaspari, chedepositò la stampa col marchio falsificato speditaglida Breslavia e in precedenza mostrata al Roan 26(Fig. 2).Il 12 agosto venne il turno <strong>del</strong>lo stampatore Priuli;i giudici volevano avere informazioni più chiare sulsuo incontro col Padovan e sull’identità <strong>del</strong>l’incisoreche aveva fabbricato lo stampo. Ludovico Priuliconfermò quanto detto negli interrogatori precedentie specificò che la stampa dei marchi aveva seguitouna precisa tempistica; duecento circa un <strong>anno</strong> prima,dopo tre mesi altre trecento e nel luglio appenapassato ulteriori cinquecento: gli affari non andavanocerto male al Padovan! Ludovico inoltre fornìFig. 2 - Stampa falsa <strong>del</strong> marchio Roan spedita ad AntonioGaspari da Breslaviaanche le generalità <strong>del</strong>l’incisore: si trattava di DomenicoColussi che risiedeva in una casa in Campodei Due Pozzi nella parrocchia di San Martino 27 .Il 13 agosto anche quest’ultimo si portò a rendereconto ai Censori di quanto sapesse <strong>del</strong>la questionee <strong>del</strong> suo ruolo nella contraffazione. Il Colussi dissedi essere stato portato proprio dal Priuli in casa <strong>del</strong>Padovan, il quale gli aveva chiesto di “cavar un ramesimile da una stampa che [gli] diede, la qual contenevaun Albero, con <strong>del</strong>le parole greche”. Il lavoroera costato quaranta lire pagate anticipatamentealla presenza di Ludovico e l’incisore era pronto agiurare di non aver più visto il Padovan e di essereestraneo a qualsiasi truffa o raggiro 28 .22
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>6-<strong>2011</strong>Il 19 agosto Gio Batta fornì ai giudici anche unastampa autentica <strong>del</strong>la ditta (Fig. 3). Ormai c’eratutto: le prove materiali <strong>del</strong> reato e le dichiarazionidei testimoni. Francesco Padovan era sì riuscito afar perdere le sue tracce al Gaspari e al Roan, manon sarebbe potuto scappare ancora per molto algiudizio Censori; molto probabilmente capì che lasituazione non era <strong>del</strong>le più semplici e decise quindidi portarsi volontariamente davanti ai giudici.Il 25 agosto presentò quindi un costituto nel qualeconfessava di aver fatto incidere un rame “conl’insegna di un Albero d’Oro e Parole greche affettaunicamente alla ditta di Domenico Roan e figli Negoziantiperleri”, si obbligava a “non ordinar più inavvenir rami simili e di non vender o estrarre manifatture<strong>del</strong>la sua Arte impacchettate o marcate conl’insegna medesima” e assicurava di non averealtri stampi oltre a quello dato in consegnaai funzionari <strong>del</strong> tribunale 29 . Lo stesso giorno iCensori Antonio Cappello, Cristoforo Loredan eMarc’Antonio Diedo prendevano atto <strong>del</strong>la confessione<strong>del</strong> Padovan e dichiaravano “consumato”,cioè concluso, il processo aperto a suo carico 30 .I problemi per il Roan e per il suo marchio non eranotuttavia finiti. Nell’inverno <strong>del</strong> 1780, infatti, i Censoriavevano dato ordine a tutti i negozianti di perle dipresentare presso i loro uffici le matrici in rame deipropri marchi, molto probabilmente proprio per verificarel’esistenza di episodi simili di contraffazione.In quest’occasione aveva attratto l’attenzione diGio Batta un rame su cui era incisa un’insegna moltosimile alla sua: l’albero e il fregio di contorno eranopraticamente identici, l’unica differenza, “la sola ingannevoledifferenza”, era data dall’iscrizione in cuisi leggeva la parola “Vite” anziché “Albero” (Fig. 4).Questa volta l’autore <strong>del</strong> plagio era un negoziante diperle non veneziano (nei documenti viene indicatoFig. 3 - Stampa autentica presentata da Gio Batta Roan alprocessoFig. 4 - Insegna di Pietro Sermonti imitante il marchio di GioBatta Roan23
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>con l’appellativo di “estero”) di nome Pietro Sermontidetto il Fiorentino. Non si era ancora asciugatol’inchiostro sulle carte <strong>del</strong> processo a carico<strong>del</strong> Padovan, che si rivelava necessario un secondoricorso alle magistrature per evitare altri grattacapicon i clienti esteri. Le motivazioni <strong>del</strong>la richiesta diGio Batta erano le stesse indicate nell’estate appenapassata e, per perorare con più efficacia la sua causa,fece un più che esplicito riferimento alle disposizioniemanate in seguito a quella vicenda. Anche questavolta i Censori decisero in favore <strong>del</strong> Roan, chetuttavia si rese conto <strong>del</strong>la necessità di trovare unasoluzione definitiva ai ripetuti tentativi di imitazione<strong>del</strong> suo marchio 31 .A giocare a sfavore <strong>del</strong> Roan probabilmente erastato anche il cambio di magistratura competentesull’attività di produzione <strong>del</strong>le perle. Finché lagiurisdizione sui perleri era stata di pertinenza <strong>del</strong>laGiustizia Vecchia, presso cui esisteva un registro deimarchi di fabbrica, contraffazioni di questo generenon erano state rilevate di frequente (o perlomenoi documenti ne tacciono); con il passaggio sotto latutela dei Censori l’attività di vigilanza contro lafalsificazione molto probabilmente si rivelò menoefficiente. In che senso e per quale motivo? Il peccatooriginale <strong>del</strong>la nuova architettura istituzionalederivava appunto dal fatto che il registro dei marchinon era nella pronta disponibilità <strong>del</strong>l’autoritàche li doveva tutelare e creava una zona grigia in cuile competenze <strong>del</strong>le diverse magistrature potevanonon essere immediatamente chiare; questa sorta di“frizione burocratica” da un lato impediva l’immediatoriconoscimento <strong>del</strong>la falsificazione e dall’altrogarantiva al contraffattore un lasso di tempo (tra l’inizio<strong>del</strong>l’attività di contraffazione e la sua scopertae conseguente sanzione) in cui poter incamerare iprofitti derivanti da quel commercio illecito; di certoprima o poi sarebbe stato scoperto, ma, come abbiamovisto, la sanzione era di fatto inesistente in casodi volontaria ammissione di colpa. Un’indicazione asostegno di questa ipotesi viene proprio dalla mossafatta successivamente dal Roan. Il 14 gennaio <strong>del</strong>1781 Gio Batta decise infatti di chiedere ai Censoriun riconoscimento legale simile a quello ottenuto dasuo nonno cinquantaquattro anni prima 32 . Non sappiamose la scelta si sia dimostrata efficace com’eranelle intenzioni <strong>del</strong> Roan, visto che l’esistenza dinorme scritte non significa quasi mai un pedissequorispetto <strong>del</strong>le stesse, tuttavia va segnalato che trale carte dei Censori relative agli anni successivi al1780 non mi è stato possibile trovare altre supplicheo processi riguardanti questa materia: forse inquesto caso la difesa <strong>del</strong> marchio aveva dato provadi funzionare?Il caso presentato può essere utile per avviare unariflessione e, lungi dal voler dare giudizi definitivi,per aprire ulteriori stimolanti interrogativi. Va in primoluogo osservata la modernità <strong>del</strong>lo strumento;possiamo dire che il marchio costituiva una sortadi “proprietà intellettuale” <strong>del</strong>la ditta? Di certo laterminologia ha un che di anacronistico, giacché laformalizzazione di un simile diritto è il frutto <strong>del</strong>pensiero giuridico di fine Ottocento 33 . A essere difesonon era il marchio in sé, ma il suo particolareutilizzo quale mezzo di identificazione <strong>del</strong> produttore.Le magistrature, in sostanza, non tutelavano ilmarchio quanto “opera <strong>del</strong>l’ingegno”, ma piuttostocome segno capace di associare il prodotto al suoproduttore; in conseguenza di ciò, la sanzione noncolpiva tanto un utilizzo generico <strong>del</strong> marchio daparte di terzi, ma piuttosto un impiego <strong>del</strong>lo stessoche rompesse questo legame di riconoscimento.L’artigiano certamente ne poteva disporre come credevae non a caso Iseppo Roan quando registrò perla prima volta l’insegna affermava di volerne fruire“come meglio a lui parerà e piacerà”. Le pubblicheautorità (prima la Giustizia Vecchia e poi i Censori)si limitavano a garantire che l’utilizzo di tale marchiofosse di pertinenza <strong>del</strong> titolare; i meccanismierano semplici: una normativa che ne riconoscessel’esclusività <strong>del</strong>l’uso, un registro che ne sancisse la“proprietà” e l’istituzione di una corte che sanzionassegli eventuali illeciti. È possibile individuareuna strategia nell’utilizzo <strong>del</strong> marchio da parte deidiversi produttori? La risposta può essere abbozzataconsiderando il registro dei marchi <strong>del</strong> 1782 conservatopresso i Censori 34 e procedendo con un confrontotra le insegne depositate da due negozianti dialta qualità, Gio Batta Roan e Giorgio Barbaria 35 , edue perleri, i già citati Pietro Sermonti e FrancescoPadovan. I primi due negozianti registrarono un solomarchio (Fig. 5); era per loro necessario identificarsicon un unico simbolo grafico per evitare confusionee mancata riconoscibilità da parte dei clienti.Questo comportamento trovava ragione appuntonelle caratteristiche <strong>del</strong>la propria produzione, che24
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Fig. 5 - Marchio di Giorgio Barbaria25
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>richiedevano una precisa associazione tra produttoree marchio.Diversa fu la strategia adottata da Sermonti e Padovan.Entrambi adottarono due marchi, oltre al tentativodi imitazione <strong>del</strong>l’insegna <strong>del</strong> Roan (Figg. 6 e7). Non commerciavano perle di alta qualità e quindinon necessitavano di essere precisamente identificatidagli acquirenti; non è quindi da escludere cheproprio l’utilizzo di insegne diverse fosse una strategiaper commercializzare meglio i loro prodotti anchecercando di sfruttare la riconoscibilità di marchialtrui. In questo senso va segnalato anche il tentativoda parte <strong>del</strong> Padovan di depositare presso il nuovoregistro predisposto dai Censori un nuovo marchioancora una volta simile a quello utilizzato dal Roan.Il fatto che sia conservata solo la bozza disegnata amano fa tuttavia pensare a un tempestivo intervento<strong>del</strong>le magistrature, che ne impedirono la stampa e lacircolazione (Figg. 8).L’utilizzo di marchi era nel Settecento molto piùdiffuso di quanto si possa pensare. Vale la pena disegnalare il caso di Giovanni Battista Viero, titolaredi una manifattura di ceramiche ad Angarano nel Vicentino.Nel 1796 acquistò uno stabile a Ca’ Boinanel territorio di Nove. La mossa era molto astuta; glipermise infatti di aggiungere al proprio marchio difabbrica (“GBV”) il nome di Nove, che aveva giàreso celebri le ceramiche <strong>del</strong>la ditta Antonibon, leader<strong>del</strong> settore in area veneta nel XVIII secolo conun giro d’affari di scala internazionale 36 . In questacircostanza, tuttavia, si trattava di un marchio chepiù o meno direttamente tutelava la “territorialità”di un prodotto fabbricato in una precisa area geografica(non va comunque trascurata l’ipotesi cheper il consumatore i termini “Antonibon” e “Nove”fossero ormai sinonimi per quanto riguarda le ceramiche),mentre nel caso <strong>del</strong> Roan l’identificazioneriguardava il produttore, a sua volta garante <strong>del</strong>laqualità degli oggetti da lui commerciati.Figure 6a e 6b - Marchi adottati da Pietro Sermonti26
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Figure 7a e 7b (sopra e a destra) - Marchi adottati da FrancescoPadovanFigure 8a e 8b (a sinistra e sopra) - Bozza di Francesco Padovanimitante il marchio di Gio Batta Roan27
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Il tema <strong>del</strong>la qualità, o meglio <strong>del</strong> suo riconoscimentoda parte <strong>del</strong>l’acquirente, rappresenta forseil punto centrale per spiegare il funzionamento <strong>del</strong>marchio nel caso appena presentato. Come si è vistol’illecito commesso dal Padovan divenne palesegrazie alla segnalazione <strong>del</strong> Fischer, il quale in unprimo momento era venuto a conoscenza <strong>del</strong>la mercegiunta nei magazzini dei mercanti ebrei di Breslaviae successivamente aveva acclarato assieme aquesti ultimi che oggetti di così bassa qualità nonpotevano essere usciti dalla bottega <strong>del</strong> Roan. Il primocontrollo quindi veniva esercitato proprio dallarete di clienti <strong>del</strong> perler, la cui efficienza ed efficaciain questo senso dipendevano da due elementi.Il primo, ovviamente, è l’interesse degli acquirentiad avere merce di prima qualità da commerciare suipropri mercati di riferimento; il secondo, molto piùcritico, è la capacità di questi ultimi di riconoscerela bontà dei prodotti acquistati. I compratori <strong>del</strong> nostroperler erano “gente <strong>del</strong> mestiere”, non clientioccasionali; era quindi il loro “know how commerciale”il primo elemento di contrasto a episodi dicontraffazione. Viene quindi da pensare che il valoredei meccanismi di contrapposizione all’attività diimitazione di marchi e prodotti potesse dipendere (eforse lo possa ancora) non solo dai pur insostituibilistrumenti normativi, ma anche e soprattutto dallacreazione di un sistema imperniato proprio sull’acquirentefinale, il quale tuttavia per espletare questafunzione non poteva essere un generico compratore,ma un cliente fe<strong>del</strong>e che, una volta edotto riguardole peculiarità e i pregi <strong>del</strong> prodotto, se ne facesseprimo garante <strong>del</strong>la qualità.Note1. L. Zecchin, <strong>Vetro</strong> e vetrai di Murano: studi sullastoria <strong>del</strong> vetro di Murano, 3 vv., Venezia, 1987,1 v., p. 93. Le fotoriproduzioni sono state eseguitedalla Sezione di fotoriproduzione <strong>del</strong>l'Archivio diStato di Venezia su concessione <strong>del</strong> Ministero per iBeni e le Attività Culturali.2. Il virgolettato è tratto dal sito www.muranoglass.com, nel quale è possibile recuperare le informazionie la normativa relative a questo marchio.3. Si veda il Regolamento per la concessione consultabilenel sito indicato nella nota precedente.4. Per una completa presentazione <strong>del</strong>le competenzedi questo magistrato si veda A. Da Mosto, L’Archiviodi Stato di Venezia: indice generale, storico, descrittivoed analitico, Roma, 1937, p. 177. Prima <strong>del</strong>1762 la corporazione dei perleri era alle dipendenzadei Provveditori e Sopraprovveditori alla GiustiziaVecchia (cfr. Ivi, pp. 191-193)5. Mi permetto di mutuare il virgolettato dal felicetitolo di una recente raccolta postuma di articolipubblicati sul “Corriere <strong>del</strong>la Sera” e sul “Sole - 24Ore” da Carlo M. Cipolla tra il 1985 e il 1997, ricordandoche la storia resta, come afferma GiovanniVigo nell’introduzione al libro, “l’unico patrimoniodal quale possiamo attingere qualche goccia di sapienzaper orientare la nostra azione” (C.M. Cipolla,Piccole cronache, Bologna, 2010, p. 13).6. L. Zecchin, <strong>Vetro</strong> e vetrai di Murano, op. cit., 1v.,p. 180. Luigi Zecchin approfondisce il tema <strong>del</strong>leinsegne dei vetrai in tutti i tre volumi <strong>del</strong>l’opera,fornendo anche utili notizie sulle vicende <strong>del</strong>le famiglietitolari, che molto spesso assunsero propriol’insegna <strong>del</strong>la fornace a sopr<strong>anno</strong>me o addiritturacognome (p. 181).7. Per “costituto” si intende “un atto <strong>del</strong> quale ci serviamoper rischiarare qualche dubbio che nascesse,rapporto ad un giudicio”; cfr. M. Ferro, Dizionario<strong>del</strong> diritto comune e veneto, 2 vv., Venezia, 1845.8. Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi ASVE),Censori, busta 8, Copia costituto di Iseppo Roan relativoalla marca <strong>del</strong> 23 agosto 1727.9. ASVE, Censori, busta 8, 9 agosto 1780, Memorialepresentato da Gio Batta Roan e Ivi, Copia costitutodi Gio Batta Roan <strong>del</strong> 16 ottobre 1778 pertrasferimento insegna.10. Ivi, 9 agosto 1780, Memoriale presentato da GioBatta Roan.28
studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>11. Con ciò non si vuole escludere la minaccia rappresentatada soggetti non corporati e in particolaredai “trafficanti Ebrei, Greci ed Armeni” come sievince da P. Zecchin, “Il Capitolare dei Perleri <strong>del</strong>1764”, Rivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>,3 (<strong>2011</strong>), pp. 23-33.12. L’arte “madre” era costituita dai vetrai muranesiche di fatto preparavano tutti i semilavorati per lequattro “arti figlie”: i produttori di finestre, quelli dispecchi e i fabbricatori di perle e conterie (perleri emargariteri). Sul rapporto tra queste arti e i vetraimuranesi si veda F. Trivellato, Fondamenta dei vetrai:lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Seie Settecento, Roma, 2000, pp. 131-169.13. ASVE, Censori, busta 8, 9 agosto 1780, Memorialepresentato da Gio Batta Roan.14. ASVE, Censori, busta 41, Capitolare <strong>del</strong>l’Artedei Perleri.15. Per alcune utili considerazioni sui conflitti natiin merito alla decisione di istituzionalizzare la divisionetra i due gruppi si veda P. Zecchin, “Il Capitolaredei Perleri <strong>del</strong> 1764”, op. cit., pp. 23-33.16. Lo sappiamo da una supplica presentata daDomenico Roan in cui ricorda il “tempo <strong>del</strong>la miagastaldia e cariche primarie da me puntualmentesostenute a favor <strong>del</strong>l’arte al fine d’obbedire a veneratisupremi decreti, e ad oggetto di estirpare licontraffacenti che provocano il totale eccidio <strong>del</strong>laprofessione”. Il documento è conservato in ASVE,Inquisitori di Stato, busta 822, Documenti Perleri,fascicolo R; il documento non è datato, ma sicuramenterisale a un periodo successivo al 1751.17. ASVE, Censori, busta 11, 31 luglio 1789.18. Per l’andamento <strong>del</strong>le esportazioni di generi vetrarinell’ultimo trentennio <strong>del</strong> Settecento si veda F.Trivellato, Fondamenta dei vetrai, op. cit., pp. 230-231. L’autrice evidenzia che tra il 1769/70 e il 1796la crescita complessiva <strong>del</strong>le esportazioni di perle alume fu pressoché continua.19. Oggi Breslavia si trova nella Polonia sud-occidentale,ma dal 1741 al termine <strong>del</strong>la Seconda GuerraMondiale fu sotto il dominio tedesco.20. ASVE, Censori, busta 8, 15 febbraio 1779/80,Copia <strong>del</strong>la lettera spedita da Adamo Fischer a GioBatta Roan.21. Ivi, 15 marzo 1780, Copia <strong>del</strong>la lettera speditada Gio Batta Roan a Adamo Fischer.22. Perle di vetro rosso ottenuto con l’oro; cfr. C.Moretti (a cura di), Glossario <strong>del</strong> vetro veneziano:dal Trecento al Novecento, Venezia, 2001.23. ASVE, Censori, busta 8, 19 aprile 1780, Copia <strong>del</strong>lalettera spedita da Adamo Fischer a Gio Batta Roan.24. Ivi, 10 agosto 1780, Interrogatorio di Gio Battaquondam Domenico Roan presso la magistraturadei Censori.25. Affinché le canne per la produzione di perle alume venissero vendute dai vetrai muranesi ai soliperleri <strong>del</strong>la corporazione veneziana era stato congegnatoun sistema che prevedeva i seguenti passaggi:1) il perler che necessitava di canna di vetro sirecava dal gastaldo <strong>del</strong>l’Arte per ottenere un “santo”;2) si recava quindi dai fornitori di canna presentiesclusivamente a Murano, i quali, attraverso il“santo”, potevano essere sicuri <strong>del</strong> fatto che l’artigianoappartenesse alla corporazione; 3) in caso diispezioni durante il viaggio da Murano a Venezia, il“santo” garantiva la legalità <strong>del</strong> trasporto di tale semilavorato;4) una volta finito il viaggio e scaricatala merce il perler riconsegnava il “santo” al gastaldo.26. ASVE, Censori, busta 8, 10 agosto 1780, Interrogatoriodi Antonio quondam Zuanne Gaspari, perlerdi 61 anni abitante in Salizada a San Luca.27. Ivi, 12 agosto 1780, Interrogatorio di Ludovicoquondam Alvise Priuli, stampatore di rame abitantea Santa Giustina in Corte <strong>del</strong>lo Spezier.28. Ivi, 13 agosto 1780, Interrogatorio di Domenicoquondam Zuanne Colussi, incisore di rame.29. Ivi, 25 agosto 1780, Costituto di Francescoquondam Santo Padovan, negoziante perler.30. Ivi, 25 agosto 1780, Ammissione <strong>del</strong> costituto edichiarazione di conclusione <strong>del</strong> processo da partedei Censori.31. Ivi, 1 dicembre 1780, Supplica di Gio Batta Roan.32. Ivi, 14 gennaio 1781, Supplica di Gio Batta Roan.33. Attualmente col termine “proprietà intellettuale”si fa riferimento alla tutela giuridica di beni immaterialirelativi all’attività creativa/inventiva umana,come ad esempio le opere artistiche e letterarie, leinvenzioni industriali, i mo<strong>del</strong>li di utilità, il designe i marchi; la normativa garantisce a creatori e inventoriil monopolio <strong>del</strong>lo sfruttamento <strong>del</strong>le lorocreazioni/invenzioni e fornisce una serie di strumentilegali per tutelarsi contro possibili abusi. Cfr. P.Auteri, G. Floridia, V.M. Mangini, G. Olivieri, M.Ricolfi, P. Spada, Diritto industriale: proprietà intellettualee concorrenza, Torino, 2009. Sull’ambiguità<strong>del</strong>la terminologia con riferimento al settoreceramico veneto seicentesco e settecentesco si veda29
6-<strong>2011</strong>studiesstudiRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>G. Favero, “Privilegi d’industria e diritti di proprietànelle manifatture di ceramica <strong>del</strong>la Repubblicadi Venezia, XVII-XVIII secolo”, Quaderni Storici,136/a. XLVI (<strong>2011</strong>), pp. 185-220.34. ASVE, Censori, busta 47, fascicolo 4, Marchi<strong>del</strong>li Negozianti <strong>del</strong>l’Arte de’ Perleri 1782.35. Su Giorgio Barbaria si veda F. Trivellato, Fondamentadei vetrai, op. cit., pp. 247-263.36. Sulla ceramica nella terraferma veneta mi limitoa segnalare N. Stringa, La famiglia Manardi e laceramica a Bassano nel ‘600 e ‘700, Bassano <strong>del</strong>Grappa, 1987, G. Ericani, P. Marini, La ceramicanel Veneto: la terraferma dal XIII al XVIII secolo,Verona, 1990; G. Ericani, P. Marini, N. Stringa, Laceramica degli Antonibon, Milano, 1990, G. Favero,“Old and New Ceramics: Manufacturers, Products,and Markets in the Venetian Republic in the Seventeenthand Eighteenth Centuries” in P. Lanaro (acura di), At the Center of the Old World: Trade andManufacturing in Venice and Venetian Mainland:1400-1800, Toronto, 2006.AutoreRiccardo Cellariccardocella@tiscali.it30
ubricaRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>6-<strong>2011</strong>Metodologia di analisiTaratura e verifica degli SMEPREMESSAPROCEDURENel presente documento sono riportate le modalitàcon cui il laboratorio ambientale di SSV effettuale attività di verifica in campo dei Sistemidi Monitoraggio <strong>del</strong>le Emissioni (SME) previstedal D.lgs. n°152/06, qualora non sia espressamenterichiesto la taratura e verifica dei sistemidi monitoraggio secondo la norma UNI EN14181:2005.In tal caso va implementato un nuovo approcciodi taratura e verifica dei sistemi già illustrato edescritto in questa Rivista (1/<strong>2011</strong> Gen./Feb., p.37).Verifiche in campo degli SMELe verifiche da effettuare sui Sistemi di Monitoraggio<strong>del</strong>le emissioni (SME), ai sensi <strong>del</strong>l’allegatoVI Parte V <strong>del</strong> D.lgs. n°152/06, sono leseguenti:• la correttezza <strong>del</strong>la sezione e <strong>del</strong> punto di prelievo• Indice di Accuratezza Relativa (I AR) * (punto4.4) con il calcolo <strong>del</strong> coefficiente di correlazionetra le misure fornite dallo strumento sottoverifica ed una di riferimento su un campionedi gas prelevato nel medesimo punto• la linearità <strong>del</strong>la riposta sull’intero campo dimisura* (punto 4.1)• correttezza <strong>del</strong> sistema di acquisizione• la taratura per i sistemi a misura indiretta (es.polveri)* (punto 4.2)(*) In grassetto le verifiche da effettuare confrequenza almeno annuale ai sensi <strong>del</strong> succitatoDecreto Legislativo n°152/06 (comma 4 AllegatoVI Parte V).Correttezza <strong>del</strong>la sezione e <strong>del</strong> puntodi prelievoApplicabilitàLa presente procedura si applica per verificare ilposizionamento <strong>del</strong>le sonde di prelievo per sistemidi monitoraggio estrattivi.Viene effettuata in sede di installazione <strong>del</strong> sistemadi monitoraggio o a seguito di sostanzialimodifiche al percorso ed alla dinamica dei fuminel camino.DescrizioneIl comma 3 <strong>del</strong>l’allegato VI Parte V <strong>del</strong> D.lgs.n°152/06, riguardo la correttezza <strong>del</strong>la sezionee <strong>del</strong> punto di prelievo, fa riferimento alla NormaUNI 10169 (Ed.1993) che elenca una seriedi requisiti di tipo fisico-geometrico che devonoessere soddisfatti.Per valutare la conformità dei punti di prelievopredisposti con quanto previsto dalla normativa,si verifica sperimentalmente l’uniformità <strong>del</strong>ladistribuzione degli effluenti, per ogni sezione diprelievo, secondo la Norma ISO 10396 (1993)“Stationary sources emissions - Sampling for theautomated determination of gas concentrations”.A tal fine, su ogni camino viene effettuata unaserie di determinazioni <strong>del</strong>la concentrazione diossigeno, prelevando i fumi secondo un reticoloconforme alla Norma UNI 10169, per verificareche:31
6-<strong>2011</strong>rubricaRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>I. in tutti i punti di detto reticolo la concentrazionemisurata risulti:C med× 0.85 ≤ C mis≤ C med≤ 1.15ove:C misvalore di concentrazione misuratoC medmedia dei valori misurati sul reticoloII. le concentrazioni di O 2misurate in corrispondenza<strong>del</strong>l’affondamento <strong>del</strong>la sonda<strong>del</strong>lo SME risultino pari al valore medioCmed ± 10% di quelle determinate sul reticolorelativo.Per le determinazioni sperimentali sono utilizzati:• una sonda• un analizzatore di O 2Indice di accuratezza relativaXi valore assoluto <strong>del</strong>la differenza <strong>del</strong>le concentrazionimisurate dai due sistemi nella provai-esima.M è la media aritmetica degli N valori XiMr è la media dei valori <strong>del</strong>le concentrazioni rilevatadal sistema di riferimentoIc è il valore assoluto <strong>del</strong>l’intervallo di confidenzacalcolato per la media degli N valoriXi; ossiaN è il numero <strong>del</strong>le misure effettuateIctn tn è il t di student calcolato per un livello di fiducia<strong>del</strong> 95% e per (n) gradi di libertà pari a(N-1). I valori di tn sono riportati nella tabellaseguente in funzione <strong>del</strong> numero di N <strong>del</strong>lemisure effettuate.SNApplicabilitàLa determinazione <strong>del</strong>l’indice di accuratezzarelativo si applica, con periodicità almeno annualeai sensi <strong>del</strong>l’allegato VI Parte V <strong>del</strong> D.lgs.n°152/06, agli analizzatori di tipo in situ con misuradiretta ed agli analizzatori di tipo estrattivoa misura diretta.DescrizioneLa verifica in campo <strong>del</strong>l’Indice di Accuratezzarelativo viene determinato eseguendo una seriedi misure parallelamente su due sistemi di analizzatoriequivalenti, campionando i fumi nellostesso punto o nell’area equivalente <strong>del</strong> condottodi emissione ed elaborando i dati secondo la formulaseguente:Dove:IAr 100 1M IcMrN t nN t nN t n7 2.447 12 2.2013 4.303 8 2.365 13 2.1794 3.182 9 2.306 14 2.1605 2.776 10 2.262 15 2.1456 2.571 11 2.229 16 2.131S è la deviazione standard dei valori Xi, cioèS Ni1Xi MN 1Il sistema si ritiene verificato ed efficiente se l’Indicedi Accuratezza relativo è superiore all’80%.Per i rilievi vengono utilizzati• analizzatori in continuo certificati• campionatore isocinetico per le polveri232
ubricaRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Modalità operativeI segnali provenienti dalla strumentazione di riferimentoe da quella in prova vengono raccoltie memorizzati come media su un’ora. L’elaborazionedei dati viene realizzata mediante un softwarededicato.La durata <strong>del</strong>le prove è programmata in funzione<strong>del</strong>le condizioni contingenti <strong>del</strong>l’impianto inesame, garantendo comunque un minimo di 3…9acquisizioni, di 30 minuti ciascuna su almeno2…3 livelli emissivi.Prima di ogni rilevazione vengono eseguite unaverifica di zero “azoto” e una calibrazione dinamicacon miscele standard.Coefficiente di correlazioneApplicabilitàIl calcolo <strong>del</strong> coefficiente di correlazione di unparametro e di una grandezza misurata si applicaa tutte le misure provenienti da analizzatoriper i quali non esistono certificazioni strumentalima solo di “installazione”, quale condizionepiù restrittiva rispetto a quelle dettate dal D.lgs.n°152/06.DescrizioneLa retta di correlazione si ottiene per interpolazionecol metodo dei minimi quadrati dei valoririlevati con più misure su diversi livelli emissivi.LinearitàApplicabilitàLa verifica di linearità si effettua sugli analizzatoricon periodicità almeno annuale (VerifichePeriodiche comma 4 allegato VI parte V <strong>del</strong>D.lgs. n°152/06), o dopo interventi manutentiviconseguenti a guasto.DescrizioneLa verifica <strong>del</strong>la linearità, indicata <strong>del</strong>l’allegatoVI Parte V <strong>del</strong> D.lgs. n°152/06 come “rispostastrumentale su tutto il campo di misura”, vieneeseguita in conformità alla noma UNI EN14181:2005, riproducendo, tramite diluitore ebombole di gas di riferimento certificate, 5 livellidi concentrazione (tipicamente 0, 20, 40, 60,80% <strong>del</strong> valore di fondo scala impostato per lostrumento).Per ogni livello di concentrazione sono state eseguiteuna serie di ripetizioni (il cui numero dipendedalle tempistiche di acquisizione e dallemodalità di registrazione <strong>del</strong>l’analizzatore).Sulla base dei dati rilevati ai 5 livelli di concentrazione,si determina la retta di taratura teorica ela deviazione dei valori letti dal sistema di monitoraggioin continuo (AMS) dalla suddetta retta(residui).La risposta strumentale viene considerata linearenel caso in cui le deviazioni non superino il 5%<strong>del</strong> valore di fondo scala impostato.L’interpolazione può essere lineare o parabolica,al fine di garantire un coefficiente di correlazionequanto più prossimo all’unità. Il coefficiente dicorrelazione è considerato sufficiente se R 2 > 0.8.33
6-<strong>2011</strong>rubricaRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Strumentazione e metodiTaraturaLa strumentazione e i metodi utilizzati per l’esecuzione<strong>del</strong>le Verifiche in campo degli analizzatori<strong>del</strong> sistema di monitoraggio in continuosono conformi al D.lgs. n°152/06; e in particolarei metodi in discontinuo utilizzati sono metodiCEN (art. 271 <strong>del</strong> D.lgs. n°152/06) e accreditatiACCREDIA secondo la norma EN ISO/IEC17025 (comma 3 <strong>del</strong>l’Allegato VI alla Parte V<strong>del</strong> D.lgs. n°152/06).ApplicabilitàLa presente procedura si applica agli analizzatoriin situ che forniscono una misura indiretta <strong>del</strong>laconcentrazione (tipicamente i misuratori <strong>del</strong>lepolveri), e viene effettuata con periodicità almenoannuale ai sensi <strong>del</strong> allegato VI Parte V <strong>del</strong>D.lgs. n°152/06.DescrizioneCorrettezza <strong>del</strong>l’acquisizione dei segnaliApplicabilitàLa verifica <strong>del</strong>la correttezza <strong>del</strong>l’acquisizione deisegnali si applica a tutte le misure acquisite dalsistema di monitoraggio prima di qualsiasi elaborazione.DescrizioneTale verifica viene effettuata confrontando, altermine <strong>del</strong> relativo “set” di prove, i valori acquisiticon quelli registrati, nel medesimo periodo,dall’elaboratore <strong>del</strong>la cabina di monitoraggio.Al termine <strong>del</strong>le prove vengono confrontati i valoriacquisiti dal sistema in oggetto con quelli acquisitidal sistema di riferimento.Le verifiche sono effettuate per ogni connessioneanalogica.La taratura consiste nella determinazione <strong>del</strong>lacurva di correlazione tra la risposta strumentaleed i valori forniti da un secondo sistema manualeo automatico.La curva viene definita con riferimento al volume<strong>del</strong>l’effluente nelle condizioni di pressione,temperatura e percentuale di ossigeno effettivamentepresenti nel condotto e senza detrazione diumidità (cioè in mg/Nm 3 e sul tal quale). I valorideterminati automaticamente dal sistema, in basea tale curva, sono poi riportati alle condizioni diriferimento prescritte dalla legge.La curva di correlazione si ottiene per interpolazione,col metodo dei minimi quadrati dei valoririlevati con più misure su diversi livelli emissivi.L’interpolazione può essere lineare o parabolica,al fine di garantire un coefficiente di correlazionequanto più prossimo all’unità.a cura di Walter BattagliaIl test si considera positivo se gli scarti risultanoinferiori a 0.5% in valore assoluto, e se l’indicedi accuratezza relativo calcolato risulta almeno99.9 %.34
attualitàRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>NUOVE DOTAZIONI ALLA SSVL’attività di SSV nel settore ambientaleè iniziata nella primametà degli anni ’70 quando l’industria<strong>del</strong> vetro ha affrontato, alpari di altri settori produttivi, leproblematiche di protezione ambientaleche le autorità cominciavanoa mettere in atto.È stato così costituito un laboratoriospecializzato e formato unteam di tecnici che h<strong>anno</strong> neglianni maturato importanti esperienzee competenze nel settore,prevalentemente specializzandosinegli aspetti legati alle emissioniin atmosfera.In quasi 40 anni di attivitàsono stati effettuati poco menodi 3000 interventi presso glistabilimenti di produzione <strong>del</strong>vetro per misurare le emissioni,verificare le condizioni di processoe definire la conformità ailimiti imposti per legge.Fin dall’inizio, per effettuare taliinterventi la <strong>Stazione</strong> si è dotatadi un laboratorio mobile appositamenteattrezzato per effettuaregli interventi richiesti con efficacia,in sicurezza e senza interferirecon le attività produttive<strong>del</strong>lo stabilimento.Nel corso <strong>del</strong> <strong>2011</strong>, SSV ha varatoun progetto interno di sviluppodi nuove metodologie diprelievo emissioni ambientalied analisi rapide per consentirealle industrie committenti di disporredei risultati <strong>del</strong>le indaginiin tempi più veloci, e in alcunicasi in tempo reale, per verificaree, se necessario, intervenire suiparametri di processo coinvolti.Tale approccio prevede l’analisisul campo dei principali parametriemissivi, in particolare acidocloridrico, acido fluoridrico e ossididi zolfo.Per implementare questo nuovoservizio, SSV ha investito nuovistrumenti analitici portatilie in un nuovo e più attrezzatolaboratorio mobile in gradodi garantire robustezza (più di100 interventi l’<strong>anno</strong>, con più35
6-<strong>2011</strong>attualitàRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>di 50.000 Km di percorrenza) eaffidabilità, e soprattutto dotatodi un attrezzato laboratorioanalitico in grado di operare incondizioni di umidità e temperaturecontrollate, senza ricorrereal supporto esterno per le utilitiesnecessarie allo svolgimento<strong>del</strong>l’attività.È stato appositamente progettatoun laboratorio installato su un cabinatoIVECO DAILY, sfruttandoquindi una meccanica già collaudatada anni. La monoscoccaè in vetroresina per ottimizzareil rapporto peso/prestazioni, atutto vantaggio <strong>del</strong>l’allestimentointerno completamente rivestitocon pannelli di legno multistratoper migliorare l’isolamento e36
attualitàRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>6-<strong>2011</strong>l’ancoraggio di scaffalature, mobilioe apparecchiature fisse.Il nuovo laboratorio che viene illustratocon le foto qui riportateè in servizio dalla fine <strong>del</strong> <strong>2011</strong>e ha già consentito di operare inpiù siti confermando le aspettativedi miglioramento <strong>del</strong> servizioin termini di qualità, tempestivitàe affidabilità.Il vecchio laboratorio mobilenon è stato tuttavia dismesso equindi SSV può contare su unaraddoppiata capacità di intervento,la prima per iniziative tradizionali,la seconda con un rinnovatoparco strumentale per leesigenze più sofisticate espressedalle industrie committenti.37
6-<strong>2011</strong>agendaRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Agenda 2012Marzo28-30Aprile2-5Aprile/Maggio28-3Maggio15-1616-1920-24Giugno3-6KyotoGiapponeShanghaiCinaAlbuquerque (NM)Stati UnitiMexico CityMessicoSan PaoloBrasileSt. Luis (MO)Stati UnitiMaastrichOlandaInternational Workshop on Photoluminescence of Rare-Earths:Photonic Materials Device (PRE’12)email: pre12@pre12.org - web:www.pre12.orgChina Glass 2012 - CCS (The Chinese Ceramic Society)email:cersoc@public3.bta.net.cn - web: www.ceramso.com55th SVC Annual Conference (Society of Vacuum Coaters)web: www.svc.orgGlassman Latin Americaemail: tammybreese@quartzltd.co.uk - web: www.glassmanevents.comGlass South America Tecnologia&Design (10th edition) - NürnbergMesse Brasilemail:glass@nm-brasil.com.br - web:www.glassexpo.com.brGOMD 2012: Glass&Optical Materials Division Spring Meetingemail: mmahan@ceramics.org - web: www.matscitech.org11th ESG Conference, European Society of Glass Science and Technology(incorporating: the 86th DGG Annual Meeting, ICG Annual Meeting, GlassTrend Seminar “Glass Technology”, Plansee Session and a session “Laserapplications”)email: dgg@hvg-dgg.de - web: www.hvg-dgg.de13-16 MoscowRussia2124-28Luglio2-62-615-19Settembre5-7Ottobre23-26Novembre15-16Agenda 2013ParmaItaliaBredaOlandaSt. MaloFranciaMontpellierFranciaChicagoStati UnitiCambridgeRegno UnitoDÜsseldorfGermaniaParmaItaliaMir stekla 2012 - 14th International Exhibition for Glass Products,Manufacturing, Processing and Finishing Technologyemail: info@expocentr.it - web: www.expocentre-europe.atGiornata A.T.I.V.: Il nuovo quadro normativo italiano sull’uso strutturale <strong>del</strong>vetro. Cosa cambierà?Centro Congressi Santa Elisabetta Campus Universitarioweb: www.ativ-online.itICCG 2012, International Conference on Coatings on Glass and Plasticsemail: koich10@attglobal.net - web: www.iccg.euISNOG 2012International Symposium on Non-Oxide Glasses and New Optical Glassesemail: jean-luc.adam@univ-rennes1.frFourth ICG Summer Schoolemail: j.m.parker@sheffi eld.ac.ukFourth International Congress on Ceramicsemail: mmahan@ceramics.org - web: ceramics.org/?page_id=6128SGT Annual Meeting 2012web: www.sgt.orgGlasstec 2012International Trade Fair for Glass Production - Processing - Productsweb: www.glasstec-online.comXXVII A.T.I.V. Conference: From a grain of sand to the strength of a structure -Centro Congressi Santa Elisabetta Campus Universitarioemail: info@ativ-online.it - web: www.ativ-online.itLuglio1-5PragaRepubblica CecaXXIII International Congress on Glassemail: secretary@czech-glass-society.cz38
dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Nel periodo 2014-2020, il programmaeuropeo Horizon 2020raggrupperà i finanziamenti UEper la ricerca e l'innovazione inun unico quadro di riferimento,favorendo la trasformazione <strong>del</strong>lescoperte scientifiche in prodottie servizi innovativi destinatia migliorare la vita di tutti igiorni e a creare nuove opportunitàcommerciali.Lo scorso 30 novembre, la CommissioneEuropea ha adottato laproposta che riconosce - nell’ambitodi Horizon 2020 - il ruolofondamentale <strong>del</strong>la normazionenel supportare l’innovazione; gliorganismi europei di formazioneCEN, CENELEC ed ETSI sonoinfatti impegnati a svolgere unruolo chiave, contribuendo attivamenteal raggiungimento degliobiettivi <strong>del</strong>l’Innovation Union ea contrastare le barriere tecnicheall’innovazione in Europa.Nella nuova proposta per Horizon2020, la normazione vienemenzionata nei tre pilastri dipriorità: tecnologie di avanguardia,leadership industriale e sfidesociali. Le norme e i processidi normazione sono identificaticome strumenti in grado di aiutaread accelerare la diffusionedi prodotti e servizi innovativisul mercato.Il ruolo chiave <strong>del</strong>la normazionecome un collegamento tra la ricerca,l’innovazione e il mercato,è stato riconosciuto in recentiiniziative politiche da parte ditutte le istituzioni <strong>del</strong>l’UE e unnumero sempre maggiore di ricercatorie di imprese comprendeil ruolo giocato dalle normee cerca di includere nei progettidi ricerca l’analisi prenormativae le attività di normazione.L’attuazione di Horizon 2020avrà l’obiettivo di risponderealle crescenti opportunità e alleesigenze in campo scientifico etecnologico, industriale, politicoe sociale.I finanziamenti previsti da Horizon2020 riguardano tre obiettivifondamentali:• garantire il primato <strong>del</strong>l'Europanel settore scientifico a livellomondiale;• assicurare la leadership <strong>del</strong>l'industria europea nel campo<strong>del</strong>l'innovazione;• affrontare temi di grandeattualità in settori quali salute,sicurezza alimentare, agricolturasostenibile, ricerca marina emarittima e bioeconomia, energiasicura, trasporti intelligenti,azione per il clima, uso efficiente<strong>del</strong>le risorse e materie prime,società solidali.Fonte:UNINOTIZIEMercato einnovazione:il ruolo fondamentale<strong>del</strong>le norme europee39
6-<strong>2011</strong> dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>Si chiudecon successola XVII edizionedi VitrumGrazie alla partecipazione vivacee animata <strong>del</strong>le maggioriaziende <strong>del</strong> settore, Vitrum -Salone internazionale specializzato<strong>del</strong>le macchine, attrezzatureed impianti <strong>del</strong> vetropiano e cavo; <strong>del</strong> vetro e deiprodotti trasformati per l’industria- in programma dal 26al 29 ottobre <strong>2011</strong> a Rho FieraMilano, si è dimostrato ancorauna volta un appuntamento preziosoper gli operatori <strong>del</strong> settoreper confrontarsi sull’andamento<strong>del</strong> mercato e sulle ultime novitàmesse a punto dalle aziende.I dati confermano l’interessedei visitatori per la manifestazione.L’affluenza registrata hasuperato le previsioni iniziali:20.255 ingressi totali, attestandosiall’incirca sugli stessi valori<strong>del</strong>la precedente edizione<strong>del</strong> 2009, di cui 10.478 italiani e9.777 stranieri. In particolare, èstato registrato un incremento divisitatori esteri <strong>del</strong> 3,30% rispettoal 2009.Ogni due anni Vitrum richiamavisitatori da tutto il mondo e siimpone come punto di riferimentoindiscusso, riuscendo adaffiancare alla tradizione vetrariaitaliana la presentazione di tecnichee tecnologie d’avanguardia.26.727 metri quadrati di areaespositiva netta, con un incremento<strong>del</strong>l’1,34% rispetto all’ultimaedizione <strong>del</strong> 2009, h<strong>anno</strong>ospitato 482 espositori provenientida 26 paesi differenti.Con un aumento <strong>del</strong> 5,96% diespositori esteri rispetto allascorsa edizione, le principaliaree di provenienza degli espositorisono Italia, Germania, Cina,seguite da Regno Unito e StatiUniti.Un posto di primo piano è statoriservato agli operatori italiani.Per l’edizione <strong>2011</strong>, circail 68.63% <strong>del</strong>l’area espositivaè stata dedicata alle ultime novitàMade in Italy. Si è respirataun’atmosfera molto positivatra gli stand dei 251 espositoriitaliani, che h<strong>anno</strong> potuto contareanche quest’<strong>anno</strong> su contattipreziosi per il business dei prossimimesi.Così conferma Renata Gaffo,Direttore di Vitrum: “Siamosoddisfatti per il numero di visitatoriitaliani e stranieri cheh<strong>anno</strong> apprezzato questa edizionedi Vitrum, nonché per ilnumero degli espositori partecipanti.La situazione <strong>del</strong> mercatoè ancora incerta, i momenti diripresa si alternano a fasi di repentinacaduta <strong>del</strong>la domanda,ma ancora una volta i risultatidi Vitrum dimostrano la vivacità<strong>del</strong> settore.”Ha riscosso un notevole succes-40
dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>so la prima edizione di VitrumGourmet Festival, un vero eproprio Festival <strong>del</strong>l’alta cucinaitaliana, simbolo per eccellenza<strong>del</strong> Made in Italy nel mondo. Perla prima volta all’interno di unafiera di settore, 7 stelle Michelinh<strong>anno</strong> dato vita ad un eventoculinario di spicco: 4 Chef,che h<strong>anno</strong> ottenuto più volte perla loro abilità il più facoltoso eambito riconoscimento a livellointernazionale, sono stati i protagonistiindiscussi <strong>del</strong> nuovoappuntamento creato per i visitatoridi Vitrum <strong>2011</strong>. Ognigiorno, per l’intera durata <strong>del</strong>lafiera, uno degli chef protagonisti<strong>del</strong>l’evento ha dimostrato lapropria abilità preparando unparticolare e caratteristico menùscelto dal suo repertorio più personale.Vitrum ha voluto così riunire ilmeglio <strong>del</strong> Made in Italy e farloscoprire ad un pubblico di respirointernazionale.Fonte:www.vitrum-milano.itA conclusione dei piani socialiche h<strong>anno</strong> coinvolto Saint-Gobain a Pisa e nella provinciadi Cuneo, il gruppo francese haripercorso le vicende che h<strong>anno</strong>visto coinvolte Saint-GobainGlass, Sekurit ed Eurovederin una tavola rotonda intitolata“Crisi, relazioni industrialie futuro”, che si è tenuta il 28novembre <strong>2011</strong> presso il CentroCongressi <strong>del</strong>la provincia di Cuneo.Nel corso <strong>del</strong>l’incontro sonointervenuti Gianni Scotti, DelegatoGenerale Saint-GobainItalia, Ezio Borreani, DirettoreRisorse Umane Saint-GobainItalia, Gianna Gancia, PresidenteProvincia di Cuneo eRoberto Chinello, consulente,team coach ed esperto di “visionestrategica”, che ha approfonditol’argomento nel suo nuovolibro presentato in occasione<strong>del</strong>la tavola rotonda.Il libro, “Crisi, relazioni industrialie futuro”, edito da FrancoAngeli, racconta la rinascitaitaliana <strong>del</strong>le tre aziende <strong>del</strong>gruppo Saint-Gobain specializzatenel vetro piano che h<strong>anno</strong>saputo fronteggiare con coraggioe determinazione uno deipiù profondi periodi di crisieconomica degli ultimi decenni,preservando i loro importantistabilimenti produttivi rispettivamentea Pisa, Savigliano eCervasca, che - grazie all’uscitadalla loro crisi - d<strong>anno</strong> lavorooggi rispettivamente a 270, 140e 140 dipendenti, oltre ad unconsistente indotto. Una storianon a lieto fine per tutti i lavo-Un librosulla rinascitaitaliana <strong>del</strong> GruppoSaint-GobainLa storia <strong>del</strong>la crisi<strong>del</strong> 2008/2009 e <strong>del</strong>larinascita <strong>del</strong>le tre aziendeSaint-Gobain, specializzatenel vetro piano, raccontatanel corso <strong>del</strong>la tavolarotonda “Crisi, relazioniindustriali e futuro”41
6-<strong>2011</strong> dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>ratori, ma il problema occupazionaleprovocato dalla perditadei posti di lavoro è stato gestitocon ricorso esteso a tutti gli ammortizzatorisociali disponibili,concedendo il tempo necessarioper la ricollocazione in altre realtàaziendali.In occasione <strong>del</strong>la tavola rotonda,Gianni Scotti ha spiegato:“Volevamo che questa vicendavenisse ricordata, più in generaleconosciuta, in particolare inun momento in cui la crisi economicagenerale sta iniziando ascuotere nelle fondamenta la societàitaliana e le sue regole difunzionamento. Parliamo di unacrisi che inizialmente prevedevala chiusura di uno stabilimentoe la ristrutturazione di altri due,con la perdita di oltre 500 postidi lavoro, tra diretti e indotto.Ma parliamo anche di una crisiche si è oggi risolta con unaristrutturazione importante, mamantenendo aperti tutti e tregli stabilimenti, mantenendo ilsapere tecnologico, l’organizzazioneproduttiva, logistica ecommerciale che ruotava attornoagli stabilimenti”. ContinuaScotti: “In questa vicenda, tuttele parti coinvolte h<strong>anno</strong> giocato‘a carte scoperte’, e tutta questavicenda ha avuto un esitopositivo solo grazie alla grandepassione che tutti i protagonistih<strong>anno</strong> dimostrato. Tutti insieme,management, sindacato, maestranze,si sono messi in giocoper un obiettivo comune, solocon il cuore di chi non voleva vedermorire una parte <strong>del</strong>la storiaindustriale italiana. Il ruolo <strong>del</strong>management italiano di Saint-Gobain è stato cruciale perchécapace di visione oltre la crisi,‘rischiando di suo’ per compiereazioni al limite <strong>del</strong>l’accettabilitàdi una multinazionale regolatada linee comportamentalied economiche fi sse. I verticifrancesi h<strong>anno</strong> ascoltato le argomentazionieconomico-socialiavanzate dalla Delegazioneitaliana, accettando la soluzionealternativa alla chiusura: ilrilancio attraverso una strategiaindustriale nuova! Il managementitaliano in questo casoha messo in gioco tutta la suacredibilità, ma ciò era necessarioper poter rifondare la nostrapresenza industriale in Italia.Questa è una storia che ha uncarattere di unicità - concludeScotti - c’erano tutti i presuppostiperché si concludesse conun conflitto secco e senza uscita,come ne vediamo di questi tempipurtroppo, e invece, grazie allavoro sapiente di tutte le parti,siamo riusciti a costruire un futurodiverso. È una buona lezioneper tutti.”“Quel che più colpisce di questavicenda è la straordinariaconvergenza di tutte le forze incampo verso un unico obiettivo:non arrendersi alla crisi e trovareuna via d’uscita che potessepreparare un futuro di nuova ripresa.Tutti i protagonisti coinvolti,direzione aziendale, sindacati,maestranze, autorità localie nazionali, pur portatori diinteressi diversi, h<strong>anno</strong> saputoesercitare con estrema effi caciae tempismo pressoché perfetto illoro rispettivo ruolo, dando vitaad un concorso di azioni lucidee responsabili, che ha condottoin breve tempo alla soluzione<strong>del</strong> problema” ha sottolineatoEzio Borreani.42
dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Attraverso una dettagliata ricostruzione<strong>del</strong>le vicende e 35 approfonditeinterviste ai protagonistiaziendali, sindacali e istituzionali,si racconta come le treaziende Saint-Gobain abbianorischiato di “chiudere i battenti”e come siano riuscite a reinventarsicon grande responsabilità edeterminazione.Ed è attraverso ciò che Chinellochiama il “ricordamento” <strong>del</strong>lerisorse perdute e dimenticate,da lui considerata la più potentearma contro la crisi, che un’aziendapuò riscoprire le idee, laforza, la coesione sociale utili afronteggiare un evento traumaticocome una crisi. Nel caso specificodi Glass, Sekurit ed Euroveder,i protagonisti h<strong>anno</strong>avviato un processo di “ricordamento”<strong>del</strong>le proprie competenzee dei propri “saper fare”,reinventandosi con pazienza esenso di leadership.Il libro si rivolge a manager,imprenditori, direttori <strong>del</strong> personalee <strong>del</strong>le relazioni industriali,sindacalisti e amministratoripubblici e a tutti coloroche quotidianamente si trovanoa fronteggiare le difficoltà tipiche<strong>del</strong>l’operare nell’economiaglobale.Per ulteriori informazioni:www.saint-gobain.itwww.habitatsaint-gobain.itwww.saint-gobain.comUfficio stampa Ketchum PRNel libro si evidenzia inoltrecome, in questo contesto, il sistema<strong>del</strong>le relazioni sindacaliabbia avuto un ruolo importantenel facilitare l’avvio <strong>del</strong> processodi “ricordamento” primaancora che gli effetti <strong>del</strong>la crisipotessero prendere definitivamenteil sopravvento. La retedi relazioni industriali costruitanel tempo è diventata per le treaziende Saint-Gobain uno strumentodeterminante per la gestione<strong>del</strong>la crisi e per assicurarecontinuità operativa in terminidi sapere, competenze e qualità.43
6-<strong>2011</strong> dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong><strong>Vetro</strong>da imballaggiopiù leggeroe più resistenteLa Emhart Glass e la <strong>Vetro</strong>packh<strong>anno</strong> annunciato lo sviluppodi una nuova tecnologiaper la produzione di vetro dacontenitori che consente di migliorarecontemporaneamentela resistenza e il peso <strong>del</strong>le bottiglie.La produzione industrialenon avrà luogo prima <strong>del</strong>la fine<strong>del</strong> 2012.“Abbiamo investito molto tempoe molte risorse nel progetto disviluppo <strong>del</strong>le nuove tecnologierealizzato nell’impianto di produzionepresso l’Emhart GlassResearch Center negli StatiUniti, specializzato e dedicatoesclusivamente alle attività diricerca e sviluppo” affermanole due società. “La tecnologiain questione è in grado di ridurresignifi cativamente il peso deicontenitori senza comprometterela capacità di riempimento.A seguito di una serie di ‘droptest’ effettuati da un’altezza di1,5 metri su una superfi cie dura,solo una modesta parte di bottiglieriempite ha subito rotture.”L’innovativo processo di trattamento,protetto da brevetto, avvienedopo la formatura e consistein un riscaldamento uniforme<strong>del</strong> contenitore alla temperaturadi circa 700°C e prevede un dispositivodi raffreddamento rapidoe costante sia all’interno cheall’esterno <strong>del</strong>la bottiglia.La piena commercializzazione<strong>del</strong>la nuova tecnologia dipendedal successo <strong>del</strong>la fase di industrializzazione,che avverrà incollaborazione con <strong>Vetro</strong>packnell’impianto di produzione pilotaPöchlaru, in Austria.Fonte:Emballage Digeste FEVE NewsLe nuovelinee guida Diageosull’imbottigliamentosostenibileLa Diageo, primaria multinazionale<strong>del</strong>l’industria <strong>del</strong>le bevande,ha pubblicato le linee guidasull’imbottigliamento sostenibileche riflettono il concreto approccio<strong>del</strong>la società alla continuariduzione <strong>del</strong>l’impatto ambientalelungo l’intera catena di produzione,dalle materie prime aicontenitori, finalizzati ad unostile di vita più sostenibile, comerichiedono clienti e consumatori.Questo documento, scaricabiledal sito <strong>del</strong>la compagnia, èbasato sul principio “ridurre,riutilizzare, riciclare” e riportaesempi <strong>del</strong>le best practices e ilriconoscimento che collaborarecon i fornitori è la strada piùconcreta per raggiungere gliobiettivi fissati.L’impegno <strong>del</strong>la Diageo per unpackaging sostenibile prevede distudiare imballaggi a peso ridotto,di impiegare prodotti che utilizzinoquote sempre maggioridi materiale riciclato, e di usareimballaggi idonei al riutilizzo oal riciclo.Fonte:FEVE News44
dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Nel primo semestre <strong>del</strong> <strong>2011</strong>, ilvolume di produzione di vetroper contenitori in Europaè cresciuto <strong>del</strong> 4,7% secondoi dati pubblicati da FEVE, migliorandoi valori realizzati nel2010. Nei primi sei mesi <strong>del</strong>l’<strong>anno</strong>sono stati prodotti 10,6 milionidi tonnellate di vetro rispettoai 10,2 milioni <strong>del</strong>lo stesso periodo<strong>del</strong> 2010.I maggiori produttori sono statila Francia con un incremento<strong>del</strong> 7,2 dei volumi produttivi, laGermania e l’Italia con rispettivamenteun +7,1 e +6,4; la Turchiaha segnato il miglior risultatocon un incremento <strong>del</strong> 15%sul primo semestre 2010.“Questi segnali sono indicatividi una maggiore fi ducia deiclienti e consumatori - afferma ilPresidente FEVE Niall Wall - esignifi cano che il contenitore divetro rimane il materiale di riferimentoper garantire elevataqualità <strong>del</strong> cibo e <strong>del</strong>le bevandesia nel mercato interno chenell’export, perché il vetro conferisceelevato valore aggiuntomantenendo un prezzo competitivo;sono inoltre importantiindicatori che i consumatoricredono nel vetro per le sue caratteristicheigieniche, di salvaguardiaambientale e <strong>del</strong> gusto.”Tali dati di produzione confermanoi valori recentemente annunciatida Euromonitor Internationalche registrano unaumento dei beni per i quali siutilizzano imballaggi in vetro, icui volumi sono previsti in aumento<strong>del</strong> 2% nel <strong>2011</strong>.Fonte:FEVE NewsL’industria deicontenitori di vetroeuropea migliorai suoi datiIl TNO Glass Group si è trasformatoin CelSian Glass &Solar b.v. Il CdA ha <strong>del</strong>iberatola trasformazione <strong>del</strong>l’Istituto inuna società privata con decorrenzaal 1° gennaio 2012.La nuova società ha ribadito lasua mission legata ad attivitàdi ricerca e sviluppo dedicataall’industria <strong>del</strong> vetro, confermatoil suo staff e la dirigenza,e mantenuto la sede presso ilquartier generale <strong>del</strong> TNO adEindhoven, Olanda. I rapportidi collaborazione internazionaleproseguir<strong>anno</strong> con gli stessiobiettivi e il coordinamento <strong>del</strong>consorzio TREND non subiràripercussioni. Anche i rapporticon il TNO continuano con formedi collaborazione istituzionalee societaria di riferimento:la CelSian Glass & Solar b.v.continua infatti a far parte <strong>del</strong>gruppo pur con una autonomiache, secondo un comunicato <strong>del</strong>suo Managing Director, garantiràmaggiore indipendenza e flessibilità,ridurrà i costi generali eaccorcerà la catena decisionale.Piet van Santen è il DirettoreGenerale e Ruud Beerkens ilcoordinatore tecnico generale.Nuova vesteistituzionale per ilTNO45
6-<strong>2011</strong> dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>L’Alto Adige offrecondizioni ottimaliper interventi diefficienza energeticae sostenibilitàin ediliziaKlimahouse 2012a Bolzanodal 26 al 29 gennaioBusiness Location SüdtirolAlto Adige (BLS) - società provincialeper l’insediamento diimprese e la promozione territoriale<strong>del</strong>la Provincia Autonomadi Bolzano - aderisce a Klimahouse2012, fiera internazionalespecializzata nel settore <strong>del</strong>l’efficienzae <strong>del</strong>la sostenibilitànell’edilizia, in calendario dal 26al 29 gennaio.La manifestazione, che comeogni <strong>anno</strong> ha sede a Bolzano,dimostra la forte sensibilità<strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong>la collettivitàper un’economia nel rispetto<strong>del</strong>l’ambiente anche attraversola costruzione di immobili privati,pubblici e industriali ecocompatibili.Il concetto “Casa-Clima” - che è anche il nome<strong>del</strong>l’agenzia <strong>del</strong>la Provincia diBolzano incaricata di promuoverela certificazione energeticadegli edifici - è sinonimo di ediliziamoderna che unisce sostenibilità,drastica riduzione deicosti energetici e una climatizzazioneottimale <strong>del</strong>l’ambiente.“Anche nel corso <strong>del</strong>l’ultimo<strong>anno</strong> il comparto green nel nostroterritorio provinciale è cresciutoin maniera importante. Lerealtà imprenditoriali che giàoperano nell’area sono in pocotempo salite a 460, molte <strong>del</strong>lequali grazie al supporto di BLSche ha permesso la creazione dicondizioni economiche d’insiemevantaggiose. Siamo al serviziodi realtà interessate a farebusiness da noi. Il fare rete è poiun ulteriore elemento di valoreper queste imprese. Ci sono tuttele premesse: guardiamo al 2012con entusiasmo e fi ducia che lanostra provincia possa accoglie-re nuove ed interessanti attivitàeconomiche” commenta UlrichStofner, Direttore BLS.Il 26 gennaio, BLS organizzauna serata per promuovere l’attivitàdi networking con le aziendepartecipanti alla Fiera e operantinell’ambito <strong>del</strong>le risorserinnovabili già attive sul territorioo che desiderano avviare unnuovo insediamento: un’ottimaoccasione per conoscere da vicinoi numerosi vantaggi messi adisposizione dalla business locationAlto Adige.“Se la sostenibilità ambientalein Alto Adige è di casa, nel restod’Italia è in corso un programmadi forte sensibilizzazione checoinvolge tutti gli aspetti <strong>del</strong>lavita quotidiana, compresa lascelta <strong>del</strong>l’abitazione o <strong>del</strong>l’uffi -cio. Ad oggi, CasaClima ha certificato oltre 3500 edifi ci e sonoin fase progettuale 800 strutture.Lavoriamo e continueremo a lavorareper promuovere iniziativedi responsabilizzazione sui temi<strong>del</strong> risparmio energetico, sostenibilitàe mutamenti climatici,contenuti chiave per lo sviluppodi una corretta cultura ambientale”conclude Flavio Ruffini,presidente <strong>del</strong>l’Agenzia Casa-Clima.Fonte:Ufficio Stampa BLS - Ketchum46
dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>AGC Glass Europe e InterpaneGlas Industrie h<strong>anno</strong> annunciatooggi la firma di un accordoattraverso il quale AGC deterràil 51% di Interpane. Oltre ad essereentrambi produttori di vetrofl oat, i due partner sviluppanoattività di lavorazione complementari,dal punto di vista <strong>del</strong>lacopertura geografica e <strong>del</strong>le specialità<strong>del</strong> prodotto.Attraverso Interpane, AGC ottieneuna presenza industriale,principalmente sul mercato tedesco<strong>del</strong> vetro piano e prevededi estendere la gamma dei prodottirivestiti. “Con questa alleanzaAGC intende potenziare laleadership nel settore dei rivestimenti<strong>del</strong> vetro, offrendo nuovefunzioni nella costruzione,nelle applicazioni solari e autoper ampliare la sua improntaindustriale”, conferma Jean-François Heris, CEO di AGCGlass Europe. Alla ricerca dinuovi mercati, Interpane potràbeneficiare <strong>del</strong>l’estensione <strong>del</strong>larete e <strong>del</strong>la presenza industrialedi AGC in Europa. “L’ingressoin AGC garantisce l’ulterioresviluppo di Interpane attraversol’accesso ad un know-howpiù esteso e ai vari segmenti dimercato, migliorando la qualità<strong>del</strong>la nostra offerta”, commentaJörn Hesselbach, CEO di InterpaneGlas Industrie.La conclusione <strong>del</strong>l’operazioneè soggetta all’approvazione<strong>del</strong>la Commissione europeanell’ambito <strong>del</strong>le normative <strong>del</strong>controllo <strong>del</strong>le fusioni.Fonte:AGCAGC e Interpanecreano un’alleanzastrategica nel settore<strong>del</strong> vetro pianoQuesta nuova piattaforma consoliderài rapporti tra le associazioninazionali ed europee<strong>del</strong> settore, rendendo progressivamentedisponibili nel corso<strong>del</strong>l’<strong>anno</strong> mezzi per interventidi lobby, un network nazionale,lo scambio di informazionitra tutti i membri e una migliorvisibilità <strong>del</strong>la nuova Alliance.In occasione <strong>del</strong>l’AssembleaGenerale straordinaria <strong>del</strong> 29novembre <strong>2011</strong>, i membri <strong>del</strong>CPIV h<strong>anno</strong> eletto BertrandCazes Segretario Generale <strong>del</strong>laGlass Alliance Europe peril 2012. Egli succede nella caricaad A<strong>del</strong>ine Farrelly, il cuiimpegno nel rendere agevole ilpassaggio tra CPIV e GAE nel<strong>2011</strong> è stato molto apprezzatodagli associati.Bertrand Cazes è SegretarioGenerale di Glass for Europe,l’associazione europea <strong>del</strong>settore <strong>del</strong> vetro per l’edilizia,vetro per auto e pannelli solari.Fonte:CPIV - Glass Alliance EuropeNewsletter January 2012Glass AllianceEurope47
6-<strong>2011</strong> dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>La versatilità <strong>del</strong>vetro Pilkingtonnel Quid HotelVenice AirportSpirito metropolitano,design moderno e granderisparmio energeticoSituato nella nuova area businessAEV Terraglio di Mestre, a duepassi dall’autostrada e da Venezia,il nuovo Quid Hotel <strong>del</strong>lacatena alberghiera Best Westernè un edifico dinamico, flessibilee fortemente innovativo. Pensatoper chi si muove per lavoro, sorgein un’area in cui affari e culturasi incontrano, una zona chenegli anni è diventata un vero eproprio trend setter architettonico.Per questo motivo si è decisodi dare all’albergo un aspettoricercato e altamente innovativo,in cui geometrie essenziali, eleganzae tecnologia si fondonol’una con l’altra.La struttura <strong>del</strong>l’hotel si articolain due volumi principali connessitra loro: un corpo alto eslanciato, contenente l’albergodi nove piani con ben 128 camere,e una costruzione più bassa,dove trovano collocazione il ristorantee la sala conferenze con150 posti a sedere. L’involucroesterno <strong>del</strong>l’edificio abbina ilnero ad un brillante color argentoe fa risaltare l’intera strutturasu tutti gli elementi <strong>del</strong> paesaggiocircostante. Gli arredamentiinterni h<strong>anno</strong> un design minimalista,con una particolare attenzionealle necessità high-tech dichi si sposta per lavoro.Il forte spirito metropolitano<strong>del</strong>l’edificio è dovuto alla combinazionetra design moderno ebasso impatto ambientale: progettatacon le più severe normeeco-sostenibili, la struttura è infattidotata di vetri Pilkington,che con la loro innovativa tecnologiagarantiscono in ogni situazioneprestazioni particolarmenteelevate.Sostenibilità ambientale e risparmioenergetico sono ormaifattori chiave anche per il settorealberghiero. Dato che il consumoenergetico per presenza èquattro volte superiore ai consumigiornalieri per abitante <strong>del</strong>comparto civile, sta crescendo laricerca di soluzioni mirate ad unuso più razionale ed economicamentesostenibile <strong>del</strong>l’energia.La salvaguardia <strong>del</strong>l’ambientee la tutela <strong>del</strong>le risorse sonodiventate un elemento strategico<strong>del</strong> settore ricettivo non solodal punto di vista energetico, maanche dal punto di vista <strong>del</strong>l’im-48
dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>magine: in seguito alla diffusione<strong>del</strong> turismo eco-consapevole,sempre più turisti prestano attenzionealla sostenibilità ambientale<strong>del</strong>le strutture, premiandoquegli alberghi che si mobilitanoin prima persona per preservarele risorse ambientali.Pilkington, marchio a diffusionemondiale nel settore <strong>del</strong> vetro,grazie alla sua esperienza ealle sue tecnologie fortementeinnovative, offre molteplici soluzionisia nell’ambito <strong>del</strong> controllosolare che in quello <strong>del</strong>l’isolamentotermico e acustico,garantendo in ogni occasione lamassima efficienza energetica.Le vetrocamere <strong>del</strong> Quid Hotelmontano in faccia esterna ivetri a controllo solare PilkingtonSuncool Silver 50/30in versione stratificato di sicurezza,mentre in faccia internasono stati installati i vetri <strong>del</strong>lagamma Pilkington Optiphonper la sicurezza e l’isolamentoacustico. I vetri PilkingtonSuncool Silver 50/30 h<strong>anno</strong>un coating argentato ideale pertutte le facciate che richiedonoun’alta brillantezza e riflessione,come nel caso <strong>del</strong> Best WesternQuid Hotel. Queste particolarivetrate permettono di ottenereun’elevata riflessione luminosaesterna e un bassissimo fattoresolare, mentre la trasmissioneluminosa viene mantenuta neutra.L’isolamento termico che siottiene è eccellente e la resa <strong>del</strong>colore dall’interno rimane inalterata.Pilkington Optiphon è inveceun vetro stratificato di sicurezzaad alto isolamento acustico, cheoffre un’eccellente riduzione<strong>del</strong> rumore senza comprometterela trasmissione luminosa49
6-<strong>2011</strong> dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>o il comportamento all’urto. Acausa <strong>del</strong> continuo aumento <strong>del</strong>traffico stradale, ferroviario edaereo, l’isolamento acustico inedilizia è ormai un requisito indispensabileper ridurre i disturbilegati allo stress e al rumore.Pilkington Optiphon è quindiil prodotto ideale perché offre unelevato potere fonoassorbentelasciando comunque ai designerla totale libertà progettuale perla creazione di ambienti moderni,originali e di facile manutenzione.L’unione <strong>del</strong>le due tecnologiePilkington permette ad ognivetrata di raggiungere risultatistraordinari: un fattore solare <strong>del</strong>30%, un isolamento termico diUg = 1,0 W/m 2 K, una trasmissio-ne luminosa <strong>del</strong> 48%, una riflessioneluminosa esterna <strong>del</strong> 38%e un indice di abbattimento acusticostimato a Rw = 42 (-3; -7).A soli 400 m dall’uscita <strong>del</strong>latangenziale e a 8 km dall’aeroportoMarco Polo di Venezia, ilQuid Hotel consente di vivereun’esperienza metropolitananel pieno rispetto <strong>del</strong>le risorsenaturali, facendo <strong>del</strong> risparmioenergetico uno dei suoi punti dimaggiore forza.Fonte:www.edilportale.comCrediti foto:www.pilkington.comIl North AmericanInternational AutoShow 2012 vedeun incremento<strong>del</strong>l’utilizzo di vetrolaminato e per ilcontrollo solareavanzatoFonte:CPIV - Glass Alliance EuropeNewsletter January 2012I veicoli esposti al North AmericanInternational Auto Show2012 (NAIAS) h<strong>anno</strong> impiegatoin gran parte vetro laminatoe/o vetro per il controllo solareavanzato per tutte le applicazionidiverse dal parabrezza, come stabilitodalla Enhanced ProtectiveGlass Automotive Association(EPGAA). Queste tipologie divetro vengono ora utilizzate peri finestrini laterali <strong>del</strong> conducentee dei passeggeri, per i lunottiposteriori ed i tettucci in vetro.I nuovi utilizzi di vetro laminatodimostrano quanto importantisiano le innovazioni sul prodottoper i fabbricanti di automobili.Dal 2000, il vetro laminatogarantisce qualità accessibilea tutti, aumentando la sicurezza,riducendo l’esposizione airaggi UV, migliorando inoltrel’efficienza dei veicoli elettriciattraverso una ridotta richiestadi aria condizionata nei mo<strong>del</strong>liche prevedono il controllo solareavanzato.Il numero di mo<strong>del</strong>li dotati divetro laminato è aumentato <strong>del</strong>30% in soli tre anni. Il vetro laminato- e le tecnologie avanzatedi riduzione <strong>del</strong> calore solareche offre - influisce su aree moltosignificative, quali la qualità,la sicurezza, il comfort e la protezionedegli occupanti, l’economicità<strong>del</strong> carburante.L’EPGAA è stata creata dai fornitoridi laminato e vetro a scopoinformativo ed educativo suglisviluppi <strong>del</strong> vetro laminato finalizzatiad aumentare la sicurezza,il comfort e l’efficienza neiveicoli.50
dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong> 6-<strong>2011</strong>Sempre più famiglie decidono dipassare al solare per risparmiaresulla bolletta di luce e gas. Aconvincere i più reticenti ci pensanogli ecobonus statali destinatia chi investe nelle rinnovabili:i dettagli <strong>del</strong> nuovo ContoEnergia.Per la maggior parte degli italianiil solare è l’energia <strong>del</strong> futuro.A rivelarlo è il rapporto “Gliitaliani e il solare”, realizzatoda Ipr marketing e FondazioneUniverde (guidata dall’exMinistro <strong>del</strong>l’Ambiente AlfonsoPecoraro Scanio), secondo cuidal 2009 è aumentato il numero<strong>del</strong>le famiglie che decidonodi scommettere sul fotovoltaico.Tra i principali motivi alla basedi questa maggiore propensionenei confronti <strong>del</strong>l’energia solaree, in generale, <strong>del</strong>le fonti rinnovabilic’è la volontà di risparmiaresui costi energia elettricae gas, soprattutto in previsione<strong>del</strong>l’ennesimo rialzo annunciatodall’Aeeg. Inoltre, il Governomette a disposizione degli incentivispecifici per chi investe nelfotovoltaico.Secondo quanto affermato nelrapporto di Ipr marketing e Fon-dazione Univerde, da settembre2009 è aumentata la quota diitaliani che investe nel solare:il numero di persone che h<strong>anno</strong>dichiarato di aver preso inconsiderazione l’idea di sfruttareil solare è passato dal 54%all’80%. In crescita anche le percentualidi consumatori a favoredi eolico, idroelettrico, geotermicoe biomasse, a conferma di unrinnovato interesse nei confronti<strong>del</strong>le fonti di energia rinnovabili,che sono state largamente giudicatesicure ed eco-compatibili. Ainfluire su questi dati sono i continuiaumenti che si sono abbattutisui costi <strong>del</strong>l’energia. Anchese continua a persistere un 35%che considera il solare più costosorispetto alle fonti energetichetradizionali, il principale motivoalla base di questo trend è, infatti,la volontà di risparmiare sullabolletta <strong>del</strong>l’energia (45%); seguonoil rispetto per l’ambiente(31%) e la convinzione di averfatto una scelta giusta per il futuro(17%).Fonte:http://canali.kataweb.itCrediti foto:www.fotovoltaicosolare.orgFotovoltaico: per gliitaliani è l’energia<strong>del</strong> futuroE con il 2012, in arrivonuovi incentivi51
6-<strong>2011</strong> dal mondo <strong>del</strong> vetroRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>La Eckeltproduce il vetro perGround ZeroVerrà utilizzatoil "Diamond Glass"La Eckelt Glas GmbH, consede a Steyr, Austria, produrràcirca 4.000 metri quadri di vetroisolante - per un importo di circa1,6 milioni di euro - per la realizzazionedi una nuova stazioneferroviaria, nell’ambito <strong>del</strong>la ricostruzionedi Ground Zero aNew York.L’architetto spagnolo SantiagoCalatrava ha ideato il complesso<strong>del</strong> trasporto sotterraneo <strong>del</strong>World Trade Center che saràcompletato nel 2014, ed assomiglieràad un gigantesco uccello;la struttura vuole simboleggiareuna colomba che vola libera nelcielo.Il “Diamond Glass” <strong>del</strong>laEckelt, uno speciale vetro rivestitoper la protezione dai raggisolari, farà sì che l’entrata<strong>del</strong>l’edificio sia inondata di lucenaturale senza che l’ambiente risultitroppo caldo.Controllata dal gruppo franceseSaint-Gobain per più divent’anni - nel corso dei qualiil rapporto con la consociataSaint-Gobain Exprover NorthAmerica ha giocato un ruolo de-terminante -, la Eckelt ha moltorisentito <strong>del</strong>la crisi economica<strong>del</strong> 2009, perdendo un terzo <strong>del</strong>lesue vendite record di 64 milionidi euro. Tuttavia, grazie aquesto nuovo incarico e numerosiordini per il 2012, secondo ilsales manager Dieter Wachaeurquesta tendenza dovrebbe cambiare.I vetri isolanti <strong>del</strong>la Eckelt sonostati impiegati anche per il Museo<strong>del</strong>l’Acropoli di Atene, e peril BMW World di Monaco.Fonte:CPIV - Glass Alliance EuropeNewsletter January 2012Crediti foto:www.glassonline.com52
indiceRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>6-<strong>2011</strong>INDICE DEL VOLUME 41 - <strong>2011</strong>Pubblicazioni ScientificheAntonio Daneo, Roberto Falcone, GiuseppeSommariva, Marta Vallotto: I fi lm sottili (coating)su vetro: caratteristiche, materiali e metodologiedi analisi (1, p. 5)Ennio Mognato, Alessandra Barbieri, AndreaNembro, Marco Pace: Una semplice tecnologiaper proteggere il vetro durante l’attività di cantiere(1, p. 15)Sandro Hreglich, Roberto Falcone, AntonioTucci, Nicola Favaro, Paolo Bertuzzi, PieroErcole, Lodovico Ramon: Nuove soluzioni per lavalorizzazione di scorie e ceneri volanti prodottedagli inceneritori di rifi uti solidi urbani (2, p. 5)New solutions for the valorization of glassy residuesproduced by municipal waste incinerators(2, p. 13)Alessandro Mola, Paolo Bortoletto, GiampaoloBruno, Ernesto Cattaneo, Augusto Santero:Sistemi avanzati di recupero termico per forni davetro. Sistema ibrido rigenerativo-recuperativoCentauro (2, p. 18)Stefano Ceola, Stefano Maurina, RobertoDall’Igna: Cause <strong>del</strong>la formazione <strong>del</strong>le bollenel vetro dall’analisi <strong>del</strong>la loro composizione. I:analisi statistica multivariata (3, p. 5)Ennio Mognato, Alessandra Barbieri, MatteoSchiavonato, Marco Pace: Thermally toughtenedsafety glass: correlation between fl exuralstrength, fragmentation and surface compressivestress (3, p. 15)Rossella Corrao, Alessandra Garraffa, GiuseppeGiambanco, Giuseppe Trapani: Pannelli traslucidipreassemblati “a secco” e precompressi realizzaticon vetromattoni modifi cati (4, p. 6)Andrea Veronese, Manuele Dabalà: Stampi pervetro cavo: Studio <strong>del</strong>la temperatura di adesionevetro-metallo e caratterizzazione dei fenomeniinterfacciali (4, p. 20)Daniela Cappello, Marco Beccali, RossellaCorrao, Piera Mannino: Nuove confi gurazioni<strong>del</strong> vetromattone. Simulazioni dinamiche per lavalutazione <strong>del</strong>le prestazioni ottiche e termiche(5, p. 5)Elisabetta Tonella: Il vetro strutturale: rispostadi elementi stratifi cati infl essi e prove di indentazione(5, p. 15)Roberto Falcone, Sandro Hreglich, BrunoProfi lo: Sostituzione <strong>del</strong>l’arsenico nelle miscelevetrificabili per la produzione di vetro cristallo(6, p. 3 )Arte e storiaCesare Fiori: <strong>Vetro</strong> musivo <strong>del</strong> VI secolo dagliscavi <strong>del</strong>la Basilica di S. Severo a Classe(Ravenna) (1, p. 22)Paolo Zecchin: Il Capitolare degli Specchieri <strong>del</strong>1764 (2, p. 26)Paolo Zecchin: Il Capitolare dei Perleri <strong>del</strong> 1764(3, p. 23)Paolo Zecchin: Il Capitolare dei Margariteri <strong>del</strong>1764 (5, p. 25)Riccardo Cella: Storia di un marchio contraffattoa Venezia nel XVIII secolo (6, p. 19)53
6-<strong>2011</strong>indiceRivista <strong>del</strong>la <strong>Stazione</strong> <strong>Sperimentale</strong> <strong>del</strong> <strong>Vetro</strong>AttualitàAggiornamento normativo - Verifiche dei sistemidi monitoraggio in continuo <strong>del</strong>le emissionisecondo la UNI EN 14181:2005 ed il D.L. n°152/06 (1, p. 37)Borsa di Studio “Giuseppe Breviari”, edizione2010-<strong>2011</strong> (1, p. 35); (2, p. 38)Assegnazione <strong>del</strong> Premio “Giuseppe Breviari,edizione 2009-2010 (3, p. 47); (4, p. 4)Attività 2010 SSV (3, p. 34)Nuove dotazioni alla SSV (6, p. 35)Rubriche varieAgenda (1, p. 64); (2, p. 40); (3, p. 46); (4, p. 32);(5, p. 37); (6, p. 38)International Glass Commission (2, p. 41); (4,p. 53)Dal mondo <strong>del</strong> vetro (1, p. 44); (2, p. 43); (3, p.48); (4, p. 37); (5, p. 54); (6, p. 39)Metodologie di analisi (6, p. 31)Newsletter Progetto VALIRE(3, p. 40)(5, p. 38)Convegni e manifestazioni“<strong>Vetro</strong> che passione!” Un progetto per incrementarela quantità e migliorare la qualità <strong>del</strong> vetroraccolto (1, p. 40)GLASSTRESS <strong>2011</strong> (4, p. 33)MADE expo <strong>2011</strong> (5, p. 44)“Zero Energy Building: Situazione attuale e sviluppifuturi, Europa e Italia a confronto” (5, p.46)EDIZIONE <strong>2011</strong>: Premio “Sostenibilità ambientalee sociale per il comune. Efficienza energeticae innovazione nell’edilizia” (5, p. 48)Festerbau Frontale 2012 (5, p. 51)54