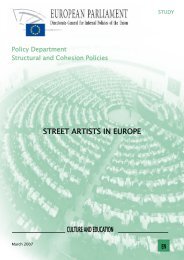Nuovi scenari e vecchie liturgie del consumo culturale. Cosa accade ...
Nuovi scenari e vecchie liturgie del consumo culturale. Cosa accade ...
Nuovi scenari e vecchie liturgie del consumo culturale. Cosa accade ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dall’effetto brand, in cui un numero esiguo di istituzioni di forte richiamo genera<br />
quote molto significative di domanda complessiva. Si creano di conseguenza forti<br />
inefficienze a livello complessivo perché a fronte di pochi musei sovraffollati e presi<br />
d’assalto dal turismo, si conta un numero elevato di musei di buona qualità con<br />
problemi di pubblico e di sottoutilizzazione <strong>del</strong>le risorse disponibili. Il discorso vale<br />
anche se lo si riporta alla scala <strong>del</strong>la città. Nelle città d’arte in particolare a fronte di<br />
alcuni fattori di attrattiva imperdibili (il museo rinomato, il duomo e la piazza<br />
centrale, il belvedere e lo scorcio fotogenico) si ritrovano decine di beni e<br />
monumenti di altrettanto valore totalmente trascurati dal turismo perché al di fuori<br />
dai percorsi canonici <strong>del</strong>la gita di giornata, non presenti nelle guide o<br />
nell’immaginario <strong>del</strong>le persone. Si tratta <strong>del</strong>la coda lunga potenziale <strong>del</strong> mercato dei<br />
monumenti e dei beni culturali. Come sappiamo, le condizioni per attivare una coda<br />
lunga sono la presenza di grande varietà nell’offerta, consumatori potenzialmente<br />
interessati a prodotti di nicchia e a soddisfare bisogni specifici, efficienza nei<br />
processi di distribuzione, collegamenti tra domanda e offerta. Si obietterà che in<br />
questo caso ci si trova nel mondo reale e i vincoli di spazio (non si possono<br />
smaterializzare i beni) e tempo (l’erogazione <strong>del</strong> servizio deve essere contestuale al<br />
suo utilizzo) nel processo distributivo sono difficilmente eludibili. Esistono comunque<br />
margini di crescita nella logica di una maggiore varietà e multidimensionalità <strong>del</strong><br />
<strong>consumo</strong> di beni culturali? La mia impressione è che il punto su cui si dovrà<br />
maggiormente lavorare riguarda l’individuazione di modalità nuove di<br />
infrastrutturare l’incontro tra la domanda e l’offerta. Si tratta di partire da quello che<br />
già si sta sperimentando in altri contesti più innovativi, senza dover inventare nulla<br />
di nuovo. Il dato eclatante di questa nuova economia <strong>del</strong>la coda lunga è la forza<br />
<strong>del</strong>le opinioni <strong>del</strong>le persone nel mediare domanda e offerta. Come si apprende dalle<br />
ricerche sul pubblico di musei e beni culturali il passaparola, già allo stato attuale, è<br />
il canale di comunicazione più efficiente nell’informare e convincere i visitatori. È<br />
però un processo comunicativo totalmente spontaneo, poco incentivato, che i musei<br />
e i territori non hanno ancora debitamente colto nella sua portata. Inserire musei e<br />
beni nei circuiti comunicativi di nicchie mirate, appoggiarsi alle reti già esistenti<br />
(blog, community, social networking, ecc.) per veicolare informazioni e contenuti,<br />
individuare modalità alternative per attrarre pubblici dispersi, difficilmente<br />
segmentabili ma uniti da interessi comuni, rappresentano alcune <strong>del</strong>le principali<br />
sfide, ma anche i passi obbligati, per chi dovrà occuparsi <strong>del</strong> marketing e <strong>del</strong>la<br />
valorizzazione <strong>culturale</strong>.<br />
Nuove e <strong>vecchie</strong> architetture di partecipazione: dai blog ai festival “culturali”<br />
Parto da una considerazione di Bernard Cova 3 in merito ad una tendenza attuale<br />
nelle modalità e nei riti di <strong>consumo</strong>: diminuiscono i prodotti e le esperienze che<br />
isolano e mettono a distanza e aumenta l’interesse per quelle che avvicinano a<br />
mettono in relazione. È un’affermazione la cui valenza assume un significato<br />
particolare quando la si riporta al campo <strong>del</strong>le esperienze culturali. In un periodo di<br />
retorica <strong>del</strong>l’individualità e <strong>del</strong>l’individualismo, si scopre che il legame conta spesso<br />
più <strong>del</strong>la merce, si riconosce cioè un’importanza addizionale a quei beni e a quelle<br />
pratiche che detengono un valore nella costruzione o nel potenziamento dei legami<br />
tra gli individui. Non è un caso, ad esempio, se nel settore dei videogiochi le<br />
principali innovazioni di prodotto non riguardano tanto un miglioramento <strong>del</strong>le<br />
prestazioni e <strong>del</strong>la qualità grafica (che comunque è avvenuto più per autoalimentare<br />
un meccanismo di “schiavitù tecnologica” <strong>del</strong> consumatore che per rispondere a sue<br />
l’8% dei musei più importanti produce due terzi <strong>del</strong>la domanda complessiva.<br />
3 Cfr. Bernard Cova, Il marketing tribale…<br />
7<br />
Testo tratto da L'arte <strong>del</strong>lo spettatore. Il pubblico <strong>del</strong>la cultura tra bisogni, consumi e tendenze, 2008 Franco Angeli