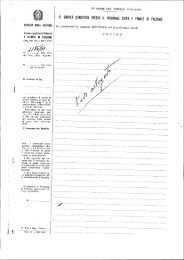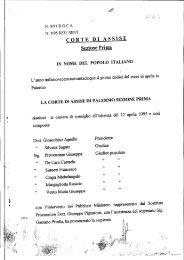LA MAFIA URBANA - Archivio digitale Pio La Torre - Camera dei ...
LA MAFIA URBANA - Archivio digitale Pio La Torre - Camera dei ...
LA MAFIA URBANA - Archivio digitale Pio La Torre - Camera dei ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Senato della Repubblica — 195 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTICAPITOLO TERZO<strong>LA</strong> <strong>MAFIA</strong> <strong>URBANA</strong>SEZIONE PRIMAL'INSERIMENTO DEL<strong>LA</strong> <strong>MAFIA</strong>NEL<strong>LA</strong> SOCIETÀ <strong>URBANA</strong>1. — <strong>La</strong> fase di transizione.Intorno agli anni 1954-1955 (che sul pianonazionale segnano l'avvio di una nuova fasedi espansione economica, culminata nel cosiddettomiiracdlo), si assiste in Sicilia aduna sensibile accentuazione dell trasferimentoverso le città {e soprattutto verso Palermo)<strong>dei</strong> principalli interessi mafiosi.In quegli anni, come prima si è detto, sida finalmente attuazione, sia pure in formalimitata, alla legge di riforma agraria, con laassegnazione ai contadini delle tenre scorporate.Ili vecchio blocco <strong>dei</strong> ceti dominantiriceve un duro colpo e di riflesso l'evoluzioneeconomica e sociale delle campagne sicilianespinge i mafiosi a sperimentare nuovee (diverse forme di potere, non più legate soltantoal mondo .rurale, ma proiettate, conuna 'decisione maggiore che nel passato, versoi grandi centri urbani.Con questo naturalmente non si vudl direche ned periodo accennato la mafia abbia cercatodi realizzare un disegno ordinato e prestabilito.Si è già più volte spiegato come nonsia accettabile una concezione schematicadella mafia, che individui nel fenomeno unapotente e compatta organizzazione unitaria,i cui affiliati partecipano, ciascuno nel settoredi propria competenza, all'attuazione difini predeterminati. Al contrario, la storiadella mafia è fatta di episodi specifici e spessodisarticolati, in sostanza delle 'vicende 'dicisingoli capi, del modo in cui ciascuno di loroha saputo mescolare, in un intricato tessutodi potere personale, attività delittuose e affarileciti, collegamenti con persone influentie pressioni di ogni tipo sull'ambiente esterno.Resta tuttavia il fatto che, nell'ultimo ventennio,il fenomeno mafioso esce in misuramassiccia dall'ambiente chiuso dell'agricoltura(latifondista, che ne aveva costituito l'idealeterreno di cultura, per trasferirsi in forzenel cuore stesso delle città siciliane. Il passaggio,però, non è affatto lineare, ma si sviluppaal contrario in una sorta di rapportocircolare, che finisce con l'incìdere profondamentesul modo di essere della « nuovamafia ». Certo i mafiosi, entrati in città, siimpadroniscono rapidamente delle tecnichee <strong>dei</strong> moduli operativi di una società assaipiù ©voluta di quella che ne vide le origini,tanto da riuscire a primeggiare nel sottoboscodelinquenziale <strong>dei</strong> grandi agglomerati urbanisiciliani (e non sol tanto siciliani); maal fondo le caratteristiche peculiari delle manifestazionimafiose rimangono quelle disempre, sia pure con le modifiche e con gliaggiornamenti necessari, continuano cioè adesprimere, anche nei nuovi contesti sociali,i tratti tipici di una subcultura di stampoprettamente agricolo. <strong>La</strong> stessa sopravvivenzadella mafia si ipuò dire in definitiva condizionataa questo trasferimento in un inondodiverso di una mentalità antica, caratterizzatada rapporti particolari con l'ambienteesterno, con coloro che sono costretti a subirela presenza mafiosa.<strong>La</strong> cronistoria degli avvenimenti, in cui siconcreta questa fase di transizione, chiarisce,con l'evidenza <strong>dei</strong> fatti, come la nuova mafianon sia altro che una diffusione di quella agricola,spesso anche per quanto riguarda laprovenienza degli uomini che la rappresenta-
Senato della Repubblica — 196 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIno e come la sua affermazione nel nuovo contestourbano sia diventata possibile, da unlato per la difettosa soluzione <strong>dei</strong> problemiconnessi ai rapporti tra città e campagne, edall'altro per il mancato sviluppo in Siciliadi una società moderna.Non è in primo (luogo senza significato chel'esplosione della mafia urbana coincida inpratica con la soppressione a Corleone di MicheleNavarca, il grande avversario di LucianoLeggio, crivellato di colpi di arma da fuoco,mentre tornava in paese insieme ad unignaro compagno di viaggio. <strong>La</strong> 'fine di Navarcasegna come uno spartiacque. In cittàdiventa sempre più prepotente e aggressivala voce della nuova mafia gangsteristica <strong>dei</strong>traffici illeciti. Il 7 settembre 1959, viene eliminatoFilippo Drago, il 9 maggio 1960 VincenzoManiscalco, il 2 ottobre 1960 GiulioPisciotta e Natale Carolilo. Sono tutti episodiche si ricollegano alle mosse di grandi associazionimafiose, i cui interessi non semprecollimano e nelle quali cominciano ad assumereprestigio, accanto ai capi già noti, comeLuciano Leggio, Tommaso Buscetta, RosarioMancino, Vincenzo e Filippo Rimi, nuovi espieiati personaggi che presto assurgerannoa notorietà nazionale, e che subito si schieranoin opposte fazioni, da una parte Angeloe Salvatore <strong>La</strong> Barbera, dall'altra Nicola,Paolo e Salvatore Greco. Questa nuova levadi capi irrompe sulla scena con violenza inusitata,adottando i metodi e ile tecniche delgangsterismo nordamericano. Palermo diventala città di incontro e di scontro delle vecchiee delle nuove attività della mafia. Unalotta sanguinosa si accende tra le varie coschemafiose, per la ripartizione delle zone diinfluenza e per Ha ricerca di nuove fonti diillecito guadagno.Le ostilità vennero aperte il 26 dicembre1962 con l'omicidio di Calcedonio Di Pisa,vice capo della gang <strong>dei</strong> Greco di Ciaculli,che venendo meno alle ferree leggi dalla mafiasi era appropriato del denaro ricavato daun'operazione di traffico di stupefacenti portataa termine insieme con un'altra gang.Il 17 gennaio 1963, fu ucciso Salvatore <strong>La</strong>Barbera. Il 19 aprile, in piena Palermo, dinanziall'affollatissima pescheria Impero,venne eseguito un attentato contro Angelo <strong>La</strong>Barbera, durante il quale rimasero feriti StefanoGiaconia, Salvatore Crivello e GioacchinoCusenza. Il 21 aprile, fu soppresso VincenzoD'Accardo, il 24 aprile fu ila volta diRosolino GuJizzi, il 26 aprile a Cinisi su unaautomobile « Giulietta » esplose un congegno,che provocò la morte di Cesare Manzellae Filippo Vitalle, il 23 maggio fu uccisoSalvatore Gambino, il 19 giugno venneroassassinati Pietro Garofalo e Girolamo Conigldaro,il 22 giugno Bernardo Diana, il 27giugno Emanuele Leonforte. Nella notte sul30 giugno 1963, a Villlabate, esplose un ordignosu un'automobile che era stata abbandonatadavanti all'autorimessa del mafiosoGiovanni Di Peri e nell'attentato morironoPietro Cannizzaro e Giuseppe Tesauro. Lostesso giorno, nella borgata Ciaculli di Palermo,l'esplosione di un altro ordigno postosu un'altra macchina abbandonata nel fondoSirena, provocò la morte <strong>dei</strong> militari che eranoaccorsi al primo allarme: il,tenente <strong>dei</strong>Carabinieri Mario Malausa, il maresciallo <strong>dei</strong>Carabinieri Calogero Vaccaro, il maresciallodi Pubblica sicurezza Silvio Corrao, i carabinieriMarino Faindella ed Eugenio Altomare,il maresciallo artificiere Pasquale Nuccio e ilsoldato Giorgio Ciacci.Fu il punto d'arrivo di una escalation criminosache aveva alle sue spalle la lenta operadi penetrazione nel tessuto sociale dellacittà. Per un'organizzazione, che provenivadalla campagna, la via, o quanto meno unadelle vie scelte per portare a termine questaopera, fu quella <strong>dei</strong> mercati all'ingrosso. Erain questo settore infatti che si incontravanocittà e campagna, ed era qui che l'intrinsecadebolezza del ceto produttivo più efficiente,affiorato dalla demolizione delle vecchiestrutture agrarie, consentiva ancora l'eserciziodi una lucrosa attività di intermediazione.2. — / mercati all'ingrosso. L'erogazione delcredito.Fu appunto per le ragioni ora accennate,che la Commissione ritenne subito necessarioportare il suo esame sull settore <strong>dei</strong> mercatiall'ingrosso; per tranne le opportune indicazionicirca i metodi operativi della mafia,
Senato della Repubblica — 197 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LOGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTInel momento dell'introduzione in città <strong>dei</strong>prodotti agricoli, occorrenti al vettovagliamentodella popolazione.In questa prospettiva la Commissione fermòinnanzitutto la propria attenzione sugliepisodi criminali verificatisi nell'ambito <strong>dei</strong>mercati e sui precedenti penali degli operatorieconomici del settore. Ne risultò (comepuò più specificamente desumersi dalla relazionesettoriale sui mercati già pubblicatadalla Commissione — Doc. XXIII n. 2/bis -V Legislatura) uri quadro eloquente, caratterizzatodalla forte incidenza di individuipregiudicati sull'insieme degli operatori, dallapresenza di cosche rivali, dalla conseguenteesplosione di determinati periodi disanguinosi episodi di delinquenza.Si accertò, poi, in riferimento ai singoli tipidi mercato, che all'epoca della indagine, ilmercato ortofrutticolo di Palermo non eraubicato (così come avviene tuttora) nel modomigliore possibile per un grande aggregatourbano come il capoluogo siciliano, che mancavaall'ingresso ogni forma di controllosulle persone e sulle merci, che all'interno<strong>dei</strong> mercati la vigilanza veniva effettuata daun numero insufficiente di agenti municipalie che l'area disponibile appariva piuttostoristretta per il numero degli stands e <strong>dei</strong>magazzini. Risultò pure che in occasione deltrasferimento del mercato dalla vecchia sedeal nuovo spazio approntato dal Comune, laassegnazione <strong>dei</strong> 42 stands, con le inevitabiliesclusioni e le constatate disparità di istallazione,era stata lasciata nelle mani <strong>dei</strong> commissionari,senza nessuna intromissione dell'entegestore, era stata cioè in pratica lasciatanelle mani del più forte, e quindi tendenzialmentenelle mani <strong>dei</strong> mafiosi.In questo modo il Comune aveva perdutoun'utile occasione per svolgere -un'adeguatocontrollo sul possesso da parte degli operatori<strong>dei</strong> prescritti requisiti di legge, in primoluogo di quello della buona condotta. Glistands invece erano sitati concessi anche apersone con precedenti penali e in seguitoalla scadenza delle (licenze non si era nemmenoprovveduto ad eliminare gli indiziatidi appartenenza alla mafia. Per la verità conla gestione Ganazzolo e Agnello erano statieffettuati allcuni tentativi di risanamento dell'ambiente,ma l'iniziativa era stata frustratadall'atteggiamento degli stessi rappresentanti<strong>dei</strong> commissionari, par respingere laproposta di considerare scadute le licenzeal termine di due anni. Inoltre, quando siera deciso di depennare dall'albo <strong>dei</strong> grossistii commercianti pregiudicati o che nonavessero il requisito della buona condotta, inun primo tempo vi erano state caviliose resistenzeda parte del sindaco al rilascio delrelativo certificato; e poi, allorché moltigrossisti erano stati effettivamente cancellatidall'albo, l'ente gestore del mercato avevaomesso idi estrometterli, per attendere la decisionesul ricorso presentato dagli interessati.Si accertò ancora che gli spazi riservatiai produttori e alle cooperative agricole eranostati anche essi assegnati ai' grossisti concessionaridelle licenze e che questi li avevanotrasferiti ai produttori, dietro compensodel dieci o dodici per cento sul prodottocommerciato. Infine, per i rilevamenti statisticie fiscali, il Comune si era sempre rimessoalle dichiarazioni degli interessati, con laconseguenza che ne erano derivate una totalefalsità della documentazione e una colossaletruffa nel pagamento delle imposte,specie dell'IGE., <strong>La</strong> Commissione portò, peraltro, il suoesame anche .sul più itipico <strong>dei</strong> mercati vicinia Palermo, quello di Villabate, e sui mercatiall'ingrosso della carne e del .pesce..Dalle indagini risultò che il mercato dellecarni era fortemente inquinato dalla presenzadi numerosi pregiudicati fra gli operatorie i macellai di Palermo e dagli evidentied accertati collegamenti con le cosche mafioseche ancora praticavano l'abigeato. Perdi più una serie di episodi confermavano laesistenza di un vero e proprio monopolio mafiososul mercato delle carni e sul controllo<strong>dei</strong> più grossi centri di utilizzazione <strong>dei</strong> prodotti,quali gli alberghi e in genere le comunitàdi ogni tipo.Anche nel mercato all'ingrosso del pescela presenza mafiosa era denunciata dal piùassoluto monopolio, che detenevano nel settorepochi concessionairi e da altre anomalieparimenti gravi, rappresentate dalla man-
Senato della Repubblica — 198 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIcata realizzazione degli impianti di conservazionee immagazzinamento del pesce e dallamancata caratterizzazione <strong>dei</strong> vari tipi dioperatori presenti sul mercato, non esistendouna netta distinzione fra grossisti e commissionaried essendovi altresì un'identitàpersonale fra i coneesskmairi e gli stessi produttori,cioè gli armatori di gran parte dellaflottiglia peschereccia di Mazara del Vallo.Gli accennati rilievi indussero la Commissionea formulare nella relazione, di cui si èprima parlato, le seguenti proposte, che almenoin parte sono tuttora valide, e in questamisura saranno perciò di nuovo sottoposteall'attenzione del Parlamento:« a) una riforma della legge sui mercatiall'ingrosso che dia strumenti legali per impedirel'inserimento di elementi adusati allasopraffazione ed al profitto parassitario eper eMminadi .dall'attività di operatori;b) un ampliamento del mercato ortofrutticolo,con trasferimento in area perifericao con esproprio di aree adiacenti, chedia la 'possibilità di istituire nuovi posteggie di riservare ai produttori, singoli o associati,spazi sufficienti e tali da assicurare equacompetitivita nei confronti <strong>dei</strong> commissionari;e) un provvedimento di carattere solo inparte straordinario, per cui, nell'imminentescadenza delle concessioni (o amene dopo),tutte le precedenti assegnazioni vengano dichiaratedi fatto prive di valore anche ai finidi titolo preferenziale precostituito.Nelle nuove assegnazioni, titolo preferenzialedovrebbe essere ritenuta solo l'assenzadi ogni precedente penale (anche se seguitoda riabilitazione) e di ogni precedente in materiadi prevenzione. <strong>La</strong> selezione delle domandedi concessione dovrebbe anche tenerconto, come elemento di carattere negativo,dell'appartenenza di due o più elementi allostesso nucleo familiare o alla stessa società(anche di fatto). <strong>La</strong> selezione dovrebbe peraltrooperare in profondità nell'accertamento<strong>dei</strong> passaggi di titolarità in qualsiasi formaconsacrati, al fine di eliminare qualsiasi formadi subconeessione;d) criteri di massimo rigore, dal puntodi vista <strong>dei</strong> precedenti penali, dovrebberoessere applicati anche nella ricostituzionedella Commissione di mercato, potendo peraltroagiire l'autorità prefettizia sulle ternedesignate dalla categoria e dallo stesso gestore;e) incoraggiamento alle forme associativedi produttori attraverso d'applicazionedi tutti i possibili incentivi e facilitazioni edaccertamento delle non rare forme di camuffamentodella speculazione intermediariasotto forma di pseudo
Senato della Repubblica — 199 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIchiarezza accertato durante le sue indagini,che cioè — come si legge nella relazione settoriale,già richiamata — « la carenza nell'eserciziodell'attività amministrativa e divigilanza da parte dell'ente gestore (Comunedi Palermo) aveva contribuito notevolmentea determinare un clima e un ambiente favorevolial prodursi di una situazione dove hadominato la legge del più forte, estrinsecandosiin atti di potere monopolistico, di intermediazioneparassitarla, di attività extralegali,di pressioni di ogni sorta, di indebitiprofitti, di delitti veri e propri. In una parola:della mafia <strong>dei</strong> mercati ».Di fronte ad una situazione del genere, laCommissione non può fare a meno di rilevareche anche in questo settore la presenzamanosa si affermò, secondo un dato ricorrentenella sua storia, per il contemporaneo concorsodi due fattori; da una parte l'intrinsecadebo'lezza (economica, politica e in generesociale) dell'ambiente considerato, dall'altrola mancanza di un'efficace resistenza dell'apparatopubblico alle pressioni e ai tentatividi infiltrazione mafiosa. <strong>La</strong> Pubblica amministrazionedenunciò rispetto alla gestione<strong>dei</strong> mercati carenze e cedimenti inspiegabilie i suoi interventi finirono così col favorirela mafia e col creare un inammissibileintreccio itra l'azione amministrativa e lasituazione di predominio mafioso che ha caratterizzato,nel corso di questi anni, il settorei<strong>dei</strong> commercio all'ingrosso della cittàdi Palermo e del suo retroterra.Le stesse note, gli identici caratteri, le medesimecondizioni di cultura si ritrovano, siapure in forme e con dimensioni diverse, intutti gli altri campi dell'attività economica,in cui la mafia urbana è riuscita, negli ultimilustri, a far sentire la propria presenza. Nell'accaparramentodelle aree fabbricabilicome nello sfruttamento <strong>dei</strong> suoli, nella ricercadi appalti e di concessioni vantaggiosee particolarmente lucrative, come nel collocamentodella marno d'opera, o nella sollecitazionedi crediti, la mafia è stata favoritaanche in città, come già era avvenuto nellecampagne dell'interno della Sicilia occidentale,dal lassismo, dall'inefficienza, se nondalla compiacente accondiscendenza <strong>dei</strong> pubblicipoteri, e sull'altro versante, dalla mancanzaidi un tessuto sociale, che fosse in grado,per forza propria, di opporle la necessariaresistenza e di non subirne le insidiosevessazioni.<strong>La</strong> Commissione ha seguito con attenzionein ognuno <strong>dei</strong> suddetti settori, i tentativicompiuti dalla mafia per imporre la sua legge,o almeno per conseguire o mantenere posizionidi favore; ma sarebbe ora difficile e indefinitiva superfluo esporre in tutti i parti^colari i risultati del lavoro compiuto, essendogià un dato di rilievo avere identificato(nei termini generali che si sono indicati) lecaratteristiche peculiari che ebbe, nei primianni della sua ascesa (e che sono in sostanzaquelle di sempre), la mafia urbana. Naturalmente,per dare di ciò una dimostrazioneconvincente, sarà necessario soffermarsi inun esame più approfondito di talune iniziativemafiose, specialmente nel campo dellaspeculazione edilizia e in genere dell'urbanistica.Così come è utile accennare brevementea quanto si è potuto accertare a propositodegli interventi della mafia in altri due <strong>dei</strong>settori prima menzionati: quello del collocamentodella 'mano d'opera e quello delcredito.Nel primo <strong>dei</strong> due settori, lo sviluppo industrialedella Sicilia ha in un certo sensofavorito i mafiosi, perché anche le grosse impreseindustriali del settore chimico e elettronico,calate nell'Isola nel dopoguerra, nonhanno esitato ad utilizzare i loro servizi. Gliepisodi della Montecatini nelle province diCaltanissetta e di Agrigento e quello dellaElettronica sicula a Palermo sono tropponoti perché sia necessario farne menzione.Non si può tuttavia fare a meno di ricordareil caso, veramente scandaloso, del Cantierenavale di Palermo, dove alcuni personaggimafiosi riuscirono ad ottenere il controllodelia mensa aziendale e del subappalto per ilavori nei bacini di carenaggio.Per quanto riguarda poi l'erogazione delcredito, la Commissione si è preoccupata diconfrontare le tendenze e le caratteristichedell'intero sistema bancario italiano conquelle specifiche del corrispondente settoresiciliano. In particolare, la Commissione haacquistato i dati completi sulla situazionedegli sportelli, <strong>dei</strong> depositi e degli impieghi.
Senafo della Repubblica — 200 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZrONf - DOCUMENTIPer un opportuno esame comparativo, i datisono 'Stati raccolti in modo da esprimere lasituazione dell'intero territorio nazionale epiù analiticamente quella della Sicilia occidentale,della Sicilia orientale e delle provincedi Palermo, Napoli, Firenze, Bologna, Genova,Tonino e Milano; inoltre sono stati reperitii dati riguardanti, non solo il complessodell'attività bancaria, ma anche quella diciascuni istituto di credito di diritto pubblico,delle banche di interesse nazionale,delle banche di credito ordinario, delle banchepopolari cooperative, delle casse di risparmioe <strong>dei</strong> monti di prima categoria, dellecasse rurali ed artigiane.<strong>La</strong> Commissione ha anche rivolto la suaattenzione all'attività di vigilanza esercitatadalla Banca d'Italia sul Banco .di Sicilia e ingenere su tutti gli istituti di credito siciliani;ciò al fine di accertare in che misura eper quali finalità la gestione bancaria in Siciliatenda a sottrarsi ad un effettivo controllodegli organi centrali. È stato peraltro curatol'invio di un questionario a tutti gli istitutibancari dell'Isola, alle Camere di com- ;mercio e alle organizzazioni di categoria, alloscopo di individuare le eventuali disfunzionidella gestione bancaria in Sicilia rispettoalle norme e alle prassi vigenti. Si è infineesaminata la struttura dell'organizzazionebancaria siciliana e si è potuto rilevare cheessa è .dominata da due grandi istituti, il Bancodi Sicilia e la Cassa di Risparmio « VittorioEmainuele » ed è caratterizzata da una vastadiffusione, in numero superiore alla medianazionale, delle casse irurali e artigiane.Purtroppo, lo svolgimento delle indaginiha incontrato molte difficoltà soprattutto inrelazione alla necessità di procurarsi dati edinformazioni su taluni aspetti dell'organizzazionee dell'attività creditizia che sono risultatidifesi da un particolare riserbo, spessogiustificato più che dal dovere professionale,dalla tendenziale reticenza degli ambientisiciliani. Un simile atteggiamento hareso difficile il lavoro della Commissione, cheprima di potere avere le informazioni richieste,ha dovuto spesso superane numerosiostacoli, non riuscendo talora a raggiungerelo scopo che si era prefisso.Così, per esempio, non è stato possibile conoscerequanti dirigenti e funzionari degliistituti bancari siciliani siano di estrazioneesclusivamente politica o siano utilizzati fuoridegli uffici, che provvedono a pagarne glistipendi, in quanto si è sostenuto, specie negliambienti più sospetti, che la richiesta comportavaun controllo inammissibile.<strong>La</strong> Commissione tuttavia ha avuto la possibilitàdi individuare una serie di disfunzionie di carenze relative alla gestione del creditoin Sicilia. Si è potuto tra l'altro accertareche gli organi di vigilanza non sempreesercitano col dovuto rigore e con la necessaria' costanza le loro funzioni di indirizzoe di assistenza; che il credito agrario è statodistribuito in taluni casi in difformità delledisposizioni legislative; che i fondi specialisono stati spesso utilizzati in settori diversida quelli nei quali sono stati creati; che piùdi una volta è stato concesso credito a gruppio società finanziarie che se ne sono avvalsiper effettuare prestiti usurari.Si è inoltre rilevato che esiste un enormedivario tra le richieste e le assegnazioni dicredito, con la conseguenza che in questospazio finiscono con l'operare amicizie, raccomandazioni,favoritismi e in definitiva interventidi natura mafiosa. Non sono infattimancati casi di concessione di credito su garanziegeneriche a persone notoriamente manose,come Mariano Licari. Più in generale,la gestione bancaria è sembrata svolgersi, inaltre occasioni, in contrasto con l'interessedegli istituti di credito ed in deroga alle disposizionivigenti, legittimando il sospettodi illeciti favoritismi nei confronti di notipersonaggi mafiosi, così come ad esempioè avvenuto riguardo a Francesco Vassallo, lacui fortuna cominciò proprio con la concessione,probabilmente irregolare, di una cospicuaapertura di credito.Ma al di là di singoli episodi, un costumetipicamente mafioso ha caratterizzato tuttoil sistema del credito. Sono stati frequenti icasi di finanziamenti concessi con la mediazionedi personaggi in qualche modo collegatial mondo della mafia, così come non sonomancate le ingenti fortune patrimonialicostruite sulla degenerazione e sui difetti delsistema bancario. Una legge bancaria, nata
Senato della Repubblica — 201 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIin un clima e in tempi diversi e diretta a sostenerecerti gruppi di pressione, si è rivelatainadeguata nel dopoguerra alle esigenzedel mercato creditizio e ha favorito la formazionein Sicilia di una costellazione inverosìmiledi istituti bancari, non dissimile,pur nella diversità delle dimensioni, da quellasulla quale, negli ultimi anni, ha costruitoil suo impero personale Michele Sindona.<strong>La</strong> Commissione ha anche accertato chei fondi versati annualmente dallo Stato allaRegione, a norma dell'articolo 38 dello Statuto,rimangono di solito inutilizzati per lunghiperiodi di tempo, mentre sarebbe augurabileche essi fossero subito destinati alloro naturale impiego nel 'settore <strong>dei</strong> lavoripubblici. Al riguardo nulla è emerso chepossa far pensare all'illecita presenza di interessimafiosi, ma non è dubbio che la ritardatautilizzazione <strong>dei</strong> fondi determina unaanomala giacenza di liquidità, pregiudica ilfunzionamento del sistema bancario, e compromettein definitiva lo sviluppo dell'economiasiciliana. Secondo dati attendibili le giacenzedi cassa per i fondi (previsti dall'articolo38 dello Statuto regionale ammontavano,alla fine del 1973, a circa 450 miliardi dilire. Si tratta, come si vede, di una sommaingente, che rimane a disposizione di istitutibancari, i quali pagano alla Regione il modestointeresse <strong>dei</strong> 4,25 per cento e ohe potrebbe,invece, qualora fosse opportunamentee tempestivamente impiegata, contribuire,in modo notevole, al successo di convenientiiniziative produttive.<strong>La</strong> lentezza della spesa è stata indubbiamenteuno <strong>dei</strong> fattori di compressione dell'economiaisolana; d'altra parte nel corsodelle indagini relative alla gestione del credito,è anche risultato che il sistema con ilquale si era tentato di promuovere un'attivitàindustriale è in pratica naufragato in unacongerie di imprese spesso affidate a personesprovviste di ogni qualificazione.L'uno e l'altro dato sembrano in superficienon avere nessuna attinenza, col problemadella mafia, ma a ben guardare è proprio•nelle accennate circostanze che si trova uno<strong>dei</strong> fattori, e non certo il meno importante,dell'espansione che ha avuto dal 1955 in poiil fenomeno mafioso urbano. Se è stata, comegià si è detto, l'in tiri nseca debolezza del tessutosociale a favorire o almeno a non impedire'l'infiltrazione manosa nelle città, èsegno evidentemente che una delle cause diquanto è accaduto va appunto ricercata nellamancata evoluzione, in senso moderno edeuropeo, della vita economica e della strutturasociale della popolazione della Siciliaoccidentale.3. — // processo di industrializzazione in Sicilia.Distorsioni e limiti.Nessuno può certo negare che nelle provincedella Sicilia occidentale si sia registrata,specie negli anni passati, una sensibilee positiva accelerazione del processo.diindustrializzazione; ma è anche innegabileche lo sviluppo industriale non è stato parialle speranze, e che in particolare non è statoin grado di far fronte al massiccio esodo dallecampagne e di costituire quindi per le nuoveleve della popolazione locale una fontesicura di occupazione e di lavoro. Infatti, peril periodo che va dal 1954 al 1971, in tutta laregione, il 43 per cento <strong>dei</strong> suoi 909,2 miliardidi capitale investito è stato destinatoalle attività petrolifere e petrolchimiche, conuna occupazione complessiva di 5.408 persone;mentre il 57 per cento residuo è sitatodestinato ad altare iniziative che comportanol'occupazione di 61.121 unità.Sono, come si vede, cifre altamente significative,anche se certo non basta aver messoin evidenza la modesta entità dello sviluppoindustriale siciliano, per dedurne che se maggiorie più incisive fossero state le iniziativeindustriali, sarebbe mancata alla mafia l'occasionefavorevole per la sua estensione, soprattuttoterritoriale. I fatti, per la verità,dimostrano con chiarezza (per dirla col sociologoFranco Ferrarotti), come « le attivitàindustriali, anziché modificare ài costume,possono essere inglobate in una rete divalori tradizionali e anacronistici » in quantoesiste « una maniera maliosa di dirigerele imprese economiche ».Non si può negare che uno sviluppo piùaccentuato delle attività industriali avrebbefavorito di riflesso una crescita economica
Senato della Repubblica — 202 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIe sociale della popolazione; mentre, per converso,i ritardi e le carenze del processo diindustrializzazione hanno ostacolato e frenatol'elevazione di vastissimi strati dellepopolazioni <strong>dei</strong> ceetri urbani della Sicilia,specie occidentale. Ed è proprio qui — lo siè visto prima — uno <strong>dei</strong> fattori più significatividelle infiltrazioni mafiose nelle città.Lo conferma un'analisi più approfonditadell'evoluzione ohe ha avuto in Sicilia, negliultimi anni, la struttura della 'popolazione. Aquesto proposito, il primo dato da tenere presenteè il dato relativo alla percentuale dellapopolazione attiva rispetto a quella residente.Secondo i risultati <strong>dei</strong> censimenti nazionalinel 1961, le province di Agrigento e diTrapani erano all'incirca attestate sui livelladi occupazione della Sicilia orientale, mentreal contrario Caltanissetta e ancora di piùPalermo denunciavano percentuali più basse.Nel corso degli anni e fino al 1971, l'accennatodivario rispetto alla Sicilia orientalee all'aggregato nazionale si è andato accentuando,tanto che nel 1971, Ja popolazioneattiva, che in Italia era del 34,9 per cento enella Sicilia orientale del 29 per cento diquella residente, arrivava ad Agrigento al27,4 per cento, a Palermo al 26,8 per cento ea Caltanissetta soltanto al. 25,16 (per cento.Al regresso degli indici della popolazioneattiva corrisponde peraltro un aumento notevoledelle percentuali relative alle liste <strong>dei</strong>disoccupati già occupati e <strong>dei</strong> disoccupati incerca di prima occupazione; ciò soprattuttoper quanto coneeime Palermo, che passa dal2,03 al 3,43 per cento del totale nazionale.Ancora più significative sono le cifre assolute.Da esse risulta che in provincia di Caltanissettala popolazione non attiva è passatada 210.831 unità nel 1971 a 208.773 nel1971, in provincia di Trapani da 291.477 a286.615, in quella di Agrigento da 317.604 a322.291, in provincia di Palermo da 794.306a 824.721.A Palermo inoltre si è andata concentrandouna parte notevole di tutti i disoccupatidella Sicilia, in quanto quelli delle classi,prima accennate, sono passati, nel decennio1961-1971, dal 19,02 al 26,01 <strong>dei</strong> totali regionali.D'altra parte in Sicilia, e specie a Caltanissetta,il rapporto tra coloro che sono addettialla Pubblica amministrazione e il complessodella popolazione attiva è stato sempremolto più alto che nel resto d'Italia,così come risulta dalla tabella che segue:Italia . . . .Sicilia . . .Sicilia orientaleCaltanissetta .Agrigento .Trapani . . .Palermo . . .196122,11 %27,10 %28,00 %30,73 %25,08 %26,02 %27,23 %197124,15 %35,04 %35,22 %39,3.1 %35.09 %32,03 %35.10 %A fronte di questi dati, si riscontra unadiminuizione relativa delle attrezzature civili.Così, il numero <strong>dei</strong> posti-letto negli istitutidi cura pubblici e privati di Palermo èpassato, dal 1959 al 1969, dal 2,09 all'1,52 percento del totale nazionale, e dal 35 al 30,06del totale regionale. Nel complesso della Siciliaoccidentale le cose non sono andatemeglio, tranne che per Agrigento (Trapani:dallo 0,44 allo 0,43 per cento del totale nazionalee dal 7,24 al 7,04 del totale regionale;Caltanissetta dallo 0,30 allo 0,24 per centodel totale nazionale e dal 5,01 al 4,09 per centodel totale regionale).Anche le abitazioni hanno subito lo stessoandamento: a Palermo, dal 2 all'I,17 per centodel totale inazionale e dal 21,12 al 23,06per cento del totale regionale; a Trapani, dallo0,81 allo 0,70 per cento del totale nazionalee dal 9,06 all'8,12 per cento del totale regionale;ad Agrigento, dallo 0,90 allo 0,80 percento del totale nazionale e dal 10,02 al 9,08per cento del totale regionale; a Caltanissetta,dallo 0,51 allo 0,50 per cento del totalenazionale e dal 6,02 al 6,01 del totale regionale.Parimenti, negli anni dal 1959 al 1970, nelleprovince della Sicilia occidentale, la cifradegli iscritti alla scuola d'obbligo e alla scuolamedia superiore ha registrato, in generale,una relativa caduta: a Palermo, mentrela percentuale relativa alla scuola d'obbligosi è stabilizzata negli anni considerati sul2,31 per cento del totale nazionale, si è pas-
Senato della Repubblica — 203 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIsali dal 25,1 al 25,2 per cento del totale regionale,e per la scuola media superiore dal2,27 al 2,52 per cento e dal 25 al 23,02 percento; a Trapani, dallo 0,83 allo 0,75 per centodel totale nazionale e dall'8,26 al 7,64 percento del totale regionale per la scuola d'obbligo,e dallo 0,81 allo 0,71 per cento del totalenazionale, e dall'8,37 all'8,05 per centodel totale regionale per la scuola media superiore;ad Agrigento, dall'I,01 allo 0,9 percento del totale nazionale e dal 10,09 al 9,23per cento del totale regionale per la scuolad'obbligo, e dallo 0,65 allo 0,01 per cento deltotale nazionale e dal 7,03 allo 8,4 del totaleregionale per la scuola superiore; a Caitanissetta(stabilizzato l'indice sullo 0,6 percento del totale nazionale) dal 6,5 al 7,06 percento del totale regionale per la scuola d'obbligo,e dallo 0,35 allo 0,41 per cento del totalenazionale e dal 3,59 al 5,02 per centodel totale regionale per la scuola media superiore.Il quadro che emerge da questa breve analisimostra una società urbana burocratica ecaratterizzata da attività terziarie e poco produttive,nella quale per di più la spesa pubblicaper le attrezzature civili è stata di granlunga inferiore ai bisogni. Le scarse possibilitàdi un lavoro sicuro, la difficoltà di inserirsiin un processo produttivo di tipomoderno e la conseguente, disperata ricercadi occupazioni burocratiche o comunque terziarie,la formazione che ne è derivata di unceto parassitario sempre più esteso e infinel'incapacità di spendere m impieghi produttivi'le risorse che provengono dai fondi nazionalie regionali sono stati tutti fattori chehanno dato nuova linfa a quel fenomeno diintermediazione, che è sempre stata la mafiae che le hanno consentito di impiantarsi,in modo più stabile che nel passato,nelle città della Sicilia occidentale. Traendoappunto alimento da queste condizioni isocioeconomiche,la mafia ha trovato in Sicilia•la forza di far sentire la sua presenza in moltisettori dell'attività sociale, perfino nellascuola, così come la Commissione ha messoin evidenza nella relazione dedicata a questoparticolare problema, specificamente rilevandoche « la mafia tende a radicarsi nellestesse strutture scolastiche, dalle cattedre aipatronati scolastici, ovunque cerca di incunearsi,valendosi del potere che già riescead esercitare ».4. — Gli Enti pubblici e le assunzioni di personale.Accanto a quelli indicati, gli altri elementiohe hanno contribuito, come prima si accennava,a rendere possibile l'espansione urbanadella mafia sono stati l'organizzazione e imodi di Intervento dell'apparato pubblico inSicilia.Una delle iniziative più rilevanti tra quelleprese dalla Regione 'siciliana fu indubbiamentel'istituzione di tulita una serie di Entipubblici economici, dotati in alcuni casi anchedi notevoli risorse, i quali avrebbero dovutoagire con prontezza ed efficacia nei varicampi della vita economica, finanziaria e socialedell'Isola per creare nuovi posti di lavoro,per aumentare il reddito individuale eglobale delle popolazioni siciliane, in una parolaper dare l'avvio alla rinascita della Sicilia.Non si può negare, a trenta anni di distanza,che il tentativo non ha avuto la sortesperata, ma sarebbe un grave errore attribuirel'insuccesso alla posizione costituzionaledi cui gode la Regione siciliana. Al contrario,l'autonomia regionale resta tuttoraun fattore potente di impulso per lo sviluppoe l'evoluzione civile dell'Isola, mentre sonoben altre — e spesso legate proprio ad alcuneinopportune limitazioni dell'autonomia— le cause che hanno inciso negativamentesu un'iniziativa, che tante speranze aveva suscitatoper un effettivo rinnovamento dellestrutture sociali ed economiche siciliane.Tra queste.cause, la prima e non certo lameno rilevante, è stata appunto l'eccessivaestensione <strong>dei</strong> controlli a cui sono soggettigli Enti pubblici economici in Sicilia. Questicontrolli, oltre a costituire una lesione delprincipio dell'autonomia regionale, finisconocon l'appesantire inutilmente le proceduree col rendere estremamente lento, come primasi è visto, l'impiego del pubblico denaronelle iniziative produttive. È fuori dubbiod'altra parte che la molteplicità <strong>dei</strong> campi di
Senato della Repubblica — 204 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIintervento in cui si esercita l'attività deglienti ha provocato difetti consistenti di indi-Tizzo e di coordinamento e che col tempogli enti creati dalla Regione sono diventatieccessivamente numerosi, jn pratica una verae propria selva.Su queste disfunzioni degli enti economiciha portato 'la propria attenzione anche laAssemblea regionale siciliana che nella secondametà del 1967 decise di nominare unaspeciale commissione, incaricata di « censirei predetti enti e di raccogliere dati sullastruttura, l'attività, gli organici e i bilancidi ciascuno di essi ». <strong>La</strong> Commissione regionalenon ha mai completato l'indagine, ancheperché molti enti, fra cui i più importanti,hanno frapposto rifiuti e ostacoli di ogni generealla richiesta di notizie. Si è accertatotuttavia che il numero degli enti era maggioredel previsto, ben novantacinque, di cuiventicinque consorzi di bonifica e quindiciconsorzi anticoccidici. Come si vede, unavera pletora, che ha comportato una moltiplicazioneingiustificata del personale, unimpegno ingente di denaro per le spese relative,e conseguentemente fenomeni di clientelismoe di trasformismo, che almeno inparte sono alla base della potenza mafiosa.Infatti, la creazione di un apparato burocraticocosì esteso, che si è andato ad aggiungerea quello degli altri Enti locali territoriali(Regione, Province, Comuni), ha determinatola necessità di un massiccio reclutamentodi dipendenti che, sia per quanto attiene aglienti economici e sia riguardo agli enti di altrotipo, non sempre si è svolto in modo daescludere irregolarità e illeciti connessi conil mondo della mafia.Più in generale, si può dire che la Commissioneha sempre considerato quello delle assunzionicome uno <strong>dei</strong> settori maggiormentecaratterizzato da interferenze estranee, dadisfunzioni, in una parola da illegalità di sospettostampo mafioso.Non a caso, quasi sempre alla radice dideliberazioni irregolari, altrimenti non spiegabili,si trovano questioni inerenti a personaleassunto .precariamente. Il fenomeno delleassunzioni in massa senza concorso pressola Regione, presso gli Enti regionali, pressole Province, presso i Comuni, presso gli entidipendenti dalle Province e dai Comuni, haraggiunto livelli incredibilmente alti, e nonha rappresentato soltanto un fatto di malcostume,ma una grave deformazione del tessutosociale.Così, in occasione delle inchieste e <strong>dei</strong> dibattitisulla frana di Agrigento si potetteaccertare che lo sviluppo urbanistico, tumultuosoe irregolare, della città trovava la suaradice nella richiesta di case avanzata da unostuolo di centinaia di nuovi immigrati, assuntipresso gli Enti locali e presso le lorofiliazioni o dipendenze.Gran parte <strong>dei</strong> bilanci della Regione, delleProvince e <strong>dei</strong> Comuni sono ipotecati per i'1pagamento degli stipendi di dipendenti assuntisenza riferimento non solo alle possibilitàeconomiohe degli enti, ma alle stesseesigenze del loro funzionamento. A tutto questosi aggiunge la scarsità, se non la mancanza,di personale qualificato ed efficiente a disposizionedegli Enti pubblici, e ciò segnatamentead Agrigento, dove numerosi dipendentidegli Enti locali esercitavano altre attivitàanche in settori direttamente connessicol loro ufficio, specialmente nel campodelle rappresentanze commerciali e delle attivitàcommerciali in genere. Centinaia dialtri impiegati e funzionar! sono distaccatia svolgere funzioni che nulla hanno a chevedere con il loro rapporto di impiego. Perdeterminati posti di notevole rilievo, i concorsisono stati spesso effettuati secondo normeche prestabilivano il vincitore e si sonoavuti casi di concorrenti unici per la assegnazionedi un determinato posto.L'impiego presso gli Enti locali è consideratocon tanto favore che perfino esponentiqualificati del mondo politico, nel corso delloro mandato parlamentare, sono risultativincitori di concorsi presso gli Enti locali peil'esercizio delle funzioni di consulente o persimili attività. Le relative delibere hanno subitovicissitudini non sempre rettilinee, attraversoi vari organismi di controllo, comenel caso delle assunzioni di consulenti legalida parte del Comune di Palermo e dell'aumentodel loro trattamento economico.<strong>La</strong> vita stessa dell'organizzazione sindacale<strong>dei</strong> dipendenti degli Enti locali è stata profondamenteinfluenzata dalle caratteristiche
Senato della Repubblica — 205 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIdel sistema di assunzione, di promozione e diutilizzazione <strong>dei</strong> dipendenti. Così come è avvenutoche uomini politici sono diventatifunzionati di Enti locala nel corso del loromandato, è pure accaduto che individui, entratisenza qualifica nelle amministrazionilocali, abbiano percorso rapidissime carriere,utilizzando poi le posizioni di potere raggiunte,fino ad inserirsi clamorosamente neicorpi elettivi della Regione, delle Province e<strong>dei</strong> Comuni. .Se questo che si è delineato è il quadrod'insieme di un fenomeno, che suscita gravipreoccupazioni per le sue possibili implicazionidi carattere mafioso, meritano una piùspecifica segnalazione gli episodi e le prassirelative all'assunzione di personale alle dipendenzedegli Enti pubblici economici e dellaRegione.Per quanto attiene ai primi, non è naturalmentepossibile una dettagliata elencazionedi tutte le anomalie riscontrate e delledisfunzioni accertate. Ma basta un saggioper campione delle suddette anomalie, riguardoa qualcuno degli enti in questione,per farsi una idea abbastanza precisa dellasituazione.A questo fine si possono citare i casi particolarmentesignificativi <strong>dei</strong> seguenti enti:Ente siciliano elettricità (ESE): oltre il 90per cento <strong>dei</strong> suoi dipendenti fu assunto senzaconcorso.Azienda siciliana trasporti (AST): tutti isuoi dipendenti furono assunti senza concorso.Tra gli altri, il suo direttore generale,che è fratello di un notissimo capomafia, fuassunto in modo piuttosto singolare, e cioèil giorno stesso della presentazione della domandadi impiego.Ente siciliano per le case ai lavoratori(ESCAL) : anche i suoi dipendenti ebbero tuttiil posto, senza partecipare a concorsi. Ildirettore generale e gli amministratori dell'Entesono stati sottoposti a procedimentopenale per peculato e per interesse privatoin atti di ufficio.Società finanziaria siciliana (So.Fi.S): II95 per cento <strong>dei</strong> suoi dipendenti fu sceltoal di fuori di ogni prova selettiva. Il direttoregenerale invece fu assunto per concorso,ma si trattava di un concorso che prevedeva,per parteciparvi, condizioni particolari.Azienda foreste demaniali della Regionesiciliana: oltre il 90 per cento <strong>dei</strong> suoi dipendentiebbe il posto senza concorso.Consorzio di bonifica alto e medio Belice:tutti i suoi funzionali di ogni grado e livellofurono assunti senza concorso.Ente riforma agraria siciliana (ERAS):uno soltanto <strong>dei</strong> suoi 1884 dipendenti fu assuntoper concorso.Gli esempi potrebbero continuare a lungo,ma quelli fatti appaiono sufficienti, se siconsidera che le irregolarità accennate sonoin 'molti casi ricorrenti e che è stato generale,per tutti gli enti considerati, il metodo dell'assunzionedel personale senza la prova diun concorso, per esami o per titoli.Quest'ultima anomalia è stata peraltro riscontrata,e in proporzioni altrettanto massicce,anche per quanto riguarda dipendentidella Regione.Si è detto in altra parte della relazione cheall'inizio la necessità di assumere il personaleper chiamata diretta fu determinatadall'ostinato e ingiustificato rifiuto delloStato di trasferire i suoi funzionari al serviziodella Regione.In seguito però questa pratica non ebbenessuna giustificazione. Eppure è continuatoad accadere che a ondate successive e frequenti,dipendenti della Regione sono statiassunti, nella grande maggioranza, per chiamatadiretta.Più specificamente, si è potuto accertareche nel periodo di tempo che va dal 1946 al1963, nello spazio cioè di diciassette anni,405 <strong>dei</strong> 431 dipendenti della Presidenza dellaRegione sono stati assunti senza concorso.Nello stesso tempo, su 2627 funzionari, impiegatie salariati dell'amministrazione centraledella Regione, ben 2138 hanno avuto ilposto senza dover partecipare a una provaselettiva. Infine, <strong>dei</strong> 6260 dipendenti delleamministrazioni regionali periferiche, 6100circa sono stati assunti per chiamata diretta.In conclusione, perciò, 8236 delle 8887 personeche sono entrate alle dipendenze dellaRegione nei diciassette anni che vanno dal1946 al 1963 (con una percentuale quindi di
Senato della Repubblica — 206 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIelitre il 90 per cento) sono state assunte senzaconcorso, e cioè, si deve ritenere, sullabase di segnalazioni e di rapporti di amiciziae di favore.È inoltre significativo rilevare che il 73,23per cento del suddetto personale provenivadalle province mafiose della Sicilia occidentale,mentre soltanto il 16,08 per cento provenivadalla Sicilia orientale, e il 10 per centocirca da regioni diverse dalla Sicilia; ciò,nonostante che le province occidentali eorientali dell'Isola abbiano una popolazionepraticamente eguale per numero. In particolarepoi è risultato che i dipendenti degli ufficiperiferici dell'Assessorato per l'agricolturaprovenivano per il 63,14 per cento dallaSicilia occidentale e per il 31,1 per cento daquella orientale, mentre, nell'ambito dell'amministrazionecentrale, il 54,05 per cento provenivadalla provincia di Palermo, malgradoche la sua popolazione rappresenti soltantoil 23 per cento dell'intera popolazione dellaSicilia.L'accennato metodo di assunzione ha consentitoche divenissero dipendenti della Regionepersone prive di ogni qualificazione esenza specifiche capacità, con la conseguenzache molte di esse sono state stipendiatesenza poter rendere un-adeguato servizio. Èaccaduto inoltre (ed è questo il fatto più graveai fini che qui interessano) che sono stateassunte persone condannate per reati di ognigenere, parenti di mafiosi, o addirittura individuisospettati di appartenere essi stessi allamafia.Si creò così, è innegabile, un nuovo e piùcospicuo spazio, non solo alla pratica dell'illegalità,ma in definitiva alla forza della penetrazionemafiosa e ciò anche attraversoil deprecabile sistema delle raccomandazioni,a cui è pure necessario porre fine una voltaper tutte, mediante gli opportuni rimedi.Quale che possa essere il giudizio da daresui singoli episodi che costituiscono il tessutodel fenomeno ora descritto, non sembradubbio tuttavia che il sistema dell'assunzioneper chiamata diretta, il rifiuto di criteriselettivi che non fossero l'amicizia e il favore,la provenienza infine della maggior partedegli assunti proprio dalle province tradizionalmentemafiose sono tutti elementi cheinducono a ritenere per fermo che questodelle assunzioni fu uno degli strumenti piùefficaci mediante i quali la mafia riuscì a infiltrarsinell'apparato pubblico e a consolidaredi riflesso la propria forza nelle cittàsiciliane. In questo modo, la Pubblica amministrazionedimostrò ancora una volta lasua incapacità di opporre un'adeguata resistenzaalla pressione mafiosa, soprattutto allasua pretesa di esercitare in forme mediatelo stesso legittimo potere dell'organizzazionestatale. Una situazione questa che si è ripetuta,in termini analoghi, in molti altri settoridell'attività della Regione. « Sono centinaiadi migliaia » dichiarò alla Commissioneun funzionario della Regione, Amindore Ambrosetti« i provvedimenti illegittimi dell'Amministrazioneregionale, e tutti questiprovvedimenti recano il timbro della Corte<strong>dei</strong> conti. Ci si chiede se quésto timbro nonfinisca con l'essere un passaporto per rendereformalmente legale ciò che sostanzialmenteè illegittimo ». E fece alcuni esempi scottanti,come quello dell'ordine di demolizionedi un attico costruito da Vassallo, ma chenon fu possibile eseguire, perché andaronodeserte tutte le gare indette per trovare unaditta disposta ad abbattere l'immobile; cosìancora quello del provvedimento votatodall'Assemblea regionale con cui si stabilivache non spettassero gettoni a funzionatimembri di Commissioni, ma che fu interpretatodalla Corte <strong>dei</strong> conti nel senso cheavrebbe avuto valore solo per coloro che sarebberostati nominati in futuro e non ancheper quelli già nominati; così infine quello<strong>dei</strong> danni arrecati alle Terme di Sciacca« con la connivenza di un presidente di sezionedella Corte <strong>dei</strong> conti, che era presidentedel collegio <strong>dei</strong> revisori ».5. — L'amministrazione regionale e gli interventinell'economia.Non si può concludere l'indagine sulle disfunzionie le carenze dell'amministrazioneregionale siciliana e sui fenomeni di parassitismoche ne hanno caratterizzato l'attività
Senato della Repubblica — 207 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIin tanti settori, senza accennare, sia puresommariamente, alle vicende connesse a taluni<strong>dei</strong> più significativi interventi svolti dallaRegione nella vita economica siciliana.Tra queste iniziative, assume primaria importanza,e non solo in ordine di tempo, lacostituzione della So.Fi.S. <strong>La</strong> So.Fi.S. (Societàfinanziaria siciliana) venne costituita dallaRegione nel 1958 ed ebbe lo scopo di promuoverelo sviluppo industriale della Siciliae più in particolare di agevolare le piccolee medie industrie, con opportune sovvenzioni.<strong>La</strong> Regione volle dare alla So.Fi.S.una struttura privatistica, per assicurarle unmaggior dinamismo imprenditoriale e contrattuale,ma la società si dimostrò una panaceadi affaristico ricovero d'imprese andatein coma, col solo risultato di riversare sullaRegione le perdite aziendali, salvando proprietaried amministratori.<strong>La</strong> nuova società, pur avendo carattere privatistico,si avvaleva di finanziamenti e dell'apportodella Regione, che provvide tral'altro a nominarne i dirigenti.Secondo le previsioni, il presidente dellanuova società sarebbe dovuto essere l'ingegnerDomenico <strong>La</strong> Caverà.A quel tempo <strong>La</strong> Caverà era un personaggiogià noto nella vita economica e politicasiciliana. Alle elezioni amministrative del1946, era stato eletto consigliere comunaledi Palermo nelle liste del Partito liberale edera stato quindi nominato Assessore ai lavoripubblici, conservando l'incarico fino al1949, per un periodo di tempo che fu di particolareimportanza per il futuro sviluppoedilizio di Palermo, perché fu allora che lacittà cominciò ad espandersi verso occidentee cioè verso la zona in cui si sarebbero verificatele sanguinose speculazioni edilizie deglianni sessanta.Fu inoltre in quel periodo che ebbe iniziola pratica, diventata poi abituale, di violarei vincoli dell'espansione urbanistica previstidal piano di ricostruzione della città.Tra l'altro, in molte zone periferiche sisviluppò l'edilizia sovvenzionata, mentre inaltre si ampliò l'area riservata agli insediamentiindustriali. L'ingegner <strong>La</strong> Caverà nonfu certo estraneo a queste vicende, che costituironoin un certo senso i prodromi dellaspeculazione edilizia palermitana.È un dato di fatto, ad esempio, che il « Cotonificiosiciliano », una società di cui <strong>La</strong> Caveràera amministratore, ebbe la possibilitàdi costruire un complesso industriale in unadelle zone, che inizialmente non erano riservatead insediamenti del genere; così come ècerto che durante il tempo in cui fu Assessoreai lavori pubblici vennero limitati i vincolia verde pubblico e privato lungo una stradadi nuova costruzione.È anche risultato che nella qualità di amministratoredella società AIR, costituitaper lo studio di problemi edilizi e la progettazioneed esecuzione di costruzioni, l'ingegner<strong>La</strong> Caverà effettuò diverse operazioniper l'acquisto di lotti di terreno in quelle chesarebbero state le zone del futuro sviluppoedilizio della città.Nel 1948, inoltre, l'AIR cedette al Comunedi Palermo un terreno, confinante con la proprietàdel padre di <strong>La</strong> Caverà, in permuta diun altro lotto di terreno.Cessato dalla carica di Assessore ai lavoripubblici, <strong>La</strong> Caverà si dedicò a un'intensaattività economica, impegnandosi in molteiniziative industriali e nell'amministrazionedi numerose società.L'ingegner <strong>La</strong> Caverà, inoltre, nel 1949,venne eletto presidente dell'Associazione industrialidella provincia di Palermo e in talequalità fu membro della Confindustria finoal 1959 e partecipò, come esperto, a vari incontriinternazionali, per la soluzione di problemieconomici.<strong>La</strong> Caverà tuttavia non riuscì a diventarepresidente della So.Fi.S., per l'opposizione diGiuseppe <strong>La</strong> Loggia, che allora era a capo delGoverno regionale; anzi fu probabilmente laopposizione di <strong>La</strong> Loggia che in seguitoavrebbe spinto <strong>La</strong> Caverà ad appoggiare ilGoverno regionale di Silvio Milazzo.Il compenso non si fece attendere. Sottola gestione di Milazzo, <strong>La</strong> Caverà fu nominatonel 1959 direttore generale della So.Fi.S. equindi venne assunto nel giugno successivocon un contratto della durata di sette annie con uno stipendio mensile di 703.151 lireper 17 mensilità.
Senato delta Repubblica — 208 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTICon il nuovo incarico <strong>La</strong> Caverà raggiunseuna posizione di vertice nell'intricato panoramadelle strutture industriali siciliane, diventando,tra l'altro, amministratore, per effettodella carica che gli era stata conferita,di altre società, oltre a quelle in cui era interessatoin proprio; coisì che, complessivamente,<strong>La</strong> Caverà risulta essere stato in epochediverse e per determinati periodi ditempo:1) socio fondatore della SES, « Societàeditrice siciliana »;2) socio fondatore e poi procuratore specialee consigliere delegato della « Societàcotonificio siciliano », costituita per la produzionee il commercio di articoli tessili;3) presidente, vicepresidente e amministratoredella società « Willeys mediterranea», costituita per il montaggio, la costruzionee la riparazione d'autoveicoli;4) amministratore della società ISPE, interessataalla produzione di elementi prefabbricatiper l'edilizia;5) socio fondatore e consigliere di amministrazionedella « Società mineraria siciliana», interessata alla ricerca, estrazione e lavorazioneminerali;6) consigliere di amministrazione dellasocietà CISAP, impegnata in iniziative direttealla formazione e all'addestramento e perfezionamentoprofessionali;7) socio fondatore e consigliere d'amministrazionedella società « Colli », costituitaper trasformare e collocare i prodotti delsottosuolo.<strong>La</strong> So.Fi.S. intanto aveva deciso di sostituireil sistema del finanziamento con quellodella partecipazione azionaria e di acquistarein conseguenza i pacchetti azionari di maggioranzadi numerose imprese, che non sempreversavano in floride condizioni economiche.Pertanto nel 1965 la Presidenza della Regionenominò una Commissione d'inchiesta,perché indagasse sull'attività della Società,ma l'iniziativa non ebbe fortuna perché larelazione conclusiva della Commissione nonvenne mai pubblicata e all'Assemblea regionalefu comunicato un insignificante documentodi poche pagine. Ciò tuttavia non haimpedito che venissero a galla i metodi incredibiliche hanno caratterizzato la gestioneSo.Fi.S. Per rappresentarli in tutta la loroevidenza basta leggere taluni documentiche il senatore Alessi cita nella sua relazionesugli Enti locali svolta nella seduta del 29febbraio 1968. Il primo è una lettera scrittada un membro del Comitato consultivo dellaSo.Fi.S. all'atto del suo inopinato licenziamento.« Dalla Gazzetta. Ufficiale della RegioneSiciliana del 1° aprile 1961 apprendo che, nonostantenon sia incorso il termine per ilquale io ero stato chiamato a far parte delComitato tecnico consultivo della So.Fi.S., siè provveduto alla nomina di un nuovo membroper i due esercizi ancora da cominciare ».« Questo decreto, bassamente politico edaltamente offensivo, emanato da una autoritàcarente di poteri, ha voluto innanzi tempopreordinare una successione per il timoreche la volontà del testatore, al momentodella scadenza del Comitato tecnico consultivo," potesse mutare "».« Da questo momento, naturalmente, nonposso più partecipare ai lavori del Comitato,sicuro di aver sempre operato nell'interessedella Società anche se, purtroppo, hodovuto sottolineare la signoria in seno allaSocietà stessa del Banco di Sicilia e dellaCassa di Risparmio che, presenti e dirigentinegli uffici, nel Comitato tecnico consultivo,nel Consiglio di amministrazione, spesso hannodovuto conciliare gli interessi <strong>dei</strong> loro enticon quelli della Società, con grave dannodi questa;iniziative il cui naturale sviluppo può impegnarel'intero capitale della Società ed avversareancora il desiderio di inserirsi nellegrandi iniziative, con la sola esperienza dellerelazioni degli esperti e degli studi e conla sola autorità del capitale sociale, massiccio,inoperoso e triste, come bue che si avviaal macello;l'arrendevolezza di tutti gli organi dellaSocietà alle pressioni politiche, la preoccupazionedi non dispiacere ai « grandi », e soprattuttoil desiderio di piacere agli stessi,hanno fatto sì che una teoria di aziende dissestatee spesso senza alcuna speranza di vitasono state rilevale, finanziate e comunque
Senato della Repubblica ~ 209 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIinserite nell'attività della Società con delleragioni tecniche che, talvolta, non mancanodi sapere ».« Mi auguro soprattutto che questa esperienzaserva a qualcosa, 'soprattutto consigli•a dire "no" alle note autorità che soillecìtanol'intervento della Società in uno zuccherificiodissestato ».« Consiglio infine una migliore formazione<strong>dei</strong> dirigenti onde neutralizzare i disegnidi infeudamento della So.Fi.S. da parte dellegrandi società private ».Il secondo documento è, poi, la seguenterelazione al bilancio della Società, che reca ladata del 31 dicembre 1961;« <strong>La</strong> relazione predisposta dagli uffici nonpuò essere sottoscritta; è mancato il materialeper un esame analitico e per la redazionedi una relazione che avrebbe dovuto esserel'esperienza di questo primo anno di esercizioe che avrebbe dovuto fornire agli amministratoridella Società osservazioni di rilievoche, a parer mio, dovrebbero consigliare:1). una revisione dello Statuto con particolaremodifica <strong>dei</strong> poteri;2) un esame delle incompatibilità;3) direttive per le imprese collegato ».« <strong>La</strong> So.Fi.S. ha ereditato le operazione delfondo; nessun confine tra quella amministrazionee la nostra Società, sicché non sarannomai precisati i promotori delle singole iniziative,tutto ciò non è sicuramente avvenuto"pour cause", ma naturalmente per il susseguirsidi avvenimenti politici, economici efinanziari.1) Sulla revisione dello statuto, con particolaremodifica <strong>dei</strong> poteri, gli amministratoridella società e gli autorevoli azionistiavranno sicuramente il loro schema; la vitasociale di questi due esercizi ha rilevato leremore allo sviluppo della società ed il pericolodi coltivare delle grosse iniziative chepotrebbero portare lontano. Tutto ciò fa partedell'oggetto sociale "industrializzazione"della Sicilia che, auspicato da tutti e nelcuore di tutti, nella realizzazione pratica nonha trovato uomini, ma "studi economici" •"piani" - "relazioni".2) L'esame delle incompatibilità è inderogabileed urgente: amministratori dellaSocietà non possono essere i rappresentantidel Banco di Sicilia e della Cassa di Risparmio;in due operazioni hanno dimostratouna fedeltà agli enti che rappresentano conevidente danno della nostra società, dannoche può essere tradotto in cifre.« <strong>La</strong> Cassa di Risparmio, creditrice dellaSIMENS, ha subordinato una soluzioneextra fallimentare, proposta dalla So.Fi.S.,solo se avesse ottenuto la maggior parte delsuo credilo traballante tramutato in nuoveazioni della nuova SIMENS; la So.Fi.S. (nelcui Consiglio siede il presidente della Cassadi Risparmio) ha aderito, ha aumentato ilcapitale sociale e si è così accollata l'oneredell'operazione.« II Banco di Sicilia, creditore della CISAS,società in situazione fallimentare, che pocoo niente prometteva ai creditori chirografari,ha preteso una sistemazione del suo creditoper aderire ad una sistemazione extra fallimentareproposta dalla So.Fi.S. Gli uffici nonhanno precisato ancora i termi di questasistemazione.« <strong>La</strong> So.Fi.S. (nel cui Consiglio siede ilPresidente del Banco di Sicilia) ha aderitoalla proposta.« Per i due grandi istituti di credito sicilianila So.Fi.S. rappresenta la più compiacenteassicurazione <strong>dei</strong> loro crediti.3) Le persone preposte alle imprese collegate,dal fondo prima e dalla So.Fi.S. dopo,nelle società in cui sono assegnate, finisconocon l'essere <strong>dei</strong> veri e propri funzionari; si èvisto ancora che ove si è trattato di liquidareo abbandonare queste imprese, preoccupazionecostante è stata quella di non mandareallo sbaraglio amministratori, che solo formalmentesono stati nominati dall'Assemblea».L'esposizione così efficace di simili sistemidi amministrazione non implica naturalmentenessun giudizio sulle personali responsabilitàdi <strong>La</strong> Caverà. Di lui si può solo aggiungereche nel 1966, alla scadenza del contratto,rifiutò di abbandonare la carica, eccependoche secondo la legge il rapporto di lavoro dovevaconsiderarsi a tempo indeterminato. Masubito dopo la sua fortuna cominciò a decli-14.
Senato della Repubblica — 210 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTInare, e il 21 novembre 1968, durante l'assembleadegli azionisti della So.Fi.S., che intantoera stata assorbita dall'« Ente siciliano dipromozione industriale », l'ingegnere UmbertoDi Cristina ne propone e ne ottenne il licenziamento.<strong>La</strong> Caverà .tentò ancora qualche resistenza,ma poi dovette rassegnarsi ad uscire di scena.Gli restavano una notevole liquidazione,superiore ai cento milioni, un patrimonio cospicuoe la soddisfazione di essere stato unprotagonista della vita pubblica siciliana, inpiù di un settore, da quello iniziale dell'ediliziaa quello della promozione industriale edello sfruttamento delle miniere siciliane.Come prima si è visto, infatti, <strong>La</strong> Caverà èstato anche amministratore di società interessatealla ricerca e all'estrazione di minerali,ed in particolare della « Società mineraria siciliana». Ed è significativo ricordare al riguardoche nel periodo del governo Milazzo,l'Assemblea regionale approvò una legge cheprevedeva un finanziamento di dodici miliardiagli industriali minerari.Ma questa provvidenza, più che un beneficioper <strong>La</strong> Caverà, rappresentò il risultatodelle iniziative prese dall'avvocato Vito Guarrasi,per trasformare le esauste miniere dizolfo della Sicilia in una fonte di guadagnoa carico dell'erario pubblico.Come quella di <strong>La</strong> Caverà, anche l'attivitàpublica di Guarrasi è stata caratterizzata darapidi successi e dalla ricerca costante di posizionidi potere.L'armistizio dell'8 settembre 1943 trovòGuarrasi, che era un semplice ufficiale dicomplemento del Servizio automobilistico,impegnato in una missione segreta ad Algericon la Commissione italiana presso il Comandoin capo delle forze alleate. Con moltaprobabilità, egli partecipò alle trattative, inquanto legato da profondi vincoli di amiciziacon il principe Galvano <strong>La</strong>nza Branciforti diIrabia, allora ufficiale di ordinanza del generaleCastellano.Anche dopo la fine della guerra, Guarrasimantenne i suoi rapporti con <strong>La</strong>nza, iniziandoquindi un'intensa attività imprenditorialee di consulenza economica, nei sattori più diversi.In particolare, secondo le infooimaziordraccolte, si è accertato che l'avvocato Guarrasiè stato in epoche varie e per determinatiperiodi di tempo:1. — consigliere di amministrazione dal 7luglio 1948 al 19 ottobre 1964 della società« Val Salso - società mineraria » costituitaper la coltivazione di miniere in Sicilia e perl'industria e il commercio di prodotti e sottoprodottidello zolfo;2. — consigliere di amministrazione dellasocietà per azioni « L'Ora », proprietaria dell'omonimogiornale di Palermo, e della societàimmobiliare « L'Ora » interessata alla costruzionee attivazione d'uno stabilimento tipografico;3. — azionista della società « A. Zagara »,costituita per promuovere ed incrementareil turismo in Sicilia;4 — socio fondatore e consigliere di amministrazionedella società « Palumberi e Scialabba», interessata al commercio di medicinalied affini;5. — azionista della società « Val Naro »,costituita per la coltivazione di nuove minieredi zolfo nell'amministrazione della Regionesiciliana;6. — socio fondatore e poi presidente delconsiglio di amministrazione della società« Megar », interessata ad operazioni di investimentoe di commercio mobiliare e immobiliare;7. — consigliere di amministrazione dellasocietà « Friigor-Sicuila », costituita per la costruzionee la gestione di uno stabilimentofrigorifero;8. — presidente del consiglio di amministrazionedella società « Capo Zafferano », perl'esercizio di attività turistiche e affini;9. — azionista della società « Adelkam »,costituita per l'impianto in Sicilia di uno stabilimentoper la produzione e la lavorazionenel campo della viticoltura;10 — consigliere di amministrazione dellasocietà « Copresa », interessata all'impiantoe all'esercizio di stabilimenti industriali perla produzione di manufatti, cementi ecc.;
Senato della Repubblica — 211 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTI11. — presidente del consiglio di amministrazionedella società « Butera », costituita perla costruzione di case;12. — consigliere di amministrazione dellasocietà « Astera », diretta a promuovere edincrementare il turismo in Sicilia;13. — consigliere di amministrazione dellasocietà « Anic-Gela », costituita per la (lavorazionein Sicilia degli idrocarburi e <strong>dei</strong> derivati;14. — presidente del consiglio di amministrazionedella società « SO.S.MI. » (Societàsiciliana mineraria), interessata alla costruzionee all'esercizio di impianti e stabilimentiper l'estrazione e la trasformazione di sostanzeminerali;15. — consigliere di amministrazione dellasocietà « RASPEME », costituita per l'assunzionedi rappresentanze per la vendita dimedicinali e affini;16. — azionista della società immobiliare« Adelkam »;17. — socio fondatore e poi presidente delconsiglio di amministrazione della società assicuratrice« Compagnia mediterranea di sicurtà»;18. — vicepresidente e membro del comitatoesecutivo della società « Immobiliaremediterranea » e vicepresidente della società« Garboli », anch'essa interessata a iniziativeedilizie;19. — consigliere di amministrazione dellasocietà « SOMIS », interessata alla ricerca eallo sfruttamento in Sicilia di giacimenti diidrocarburi liquidi e gassosi;20. — consigliere di amministrazione dellasocietà « SOIS », anch'essa costituita per laricerca e la coltivazione in Sicilia di giacimentidi idrocarburi liquidi e gassosi;21. — azionista e consigliere di amministrazionefino al 23 settembre 1952 della società« Palermo Calcio », messa in liquidazione nel1960;22. — socio fondatore della società « SO-CHIMISI », costituita per la riorganizzazionee la verticalizzazione dell'industria zolfiferasiciliana;23. — socio fondatore della società « Aeolica», costituita per promuovere e incrementareil turismo in Sicilia;24. — consigliere di amministrazione dellasocietà « SAGET », interessata alla gestionedi tonnare, all'esercizio della pesca e al commerciodel pesce;25. — consigliere di amministrazione dellasocietà « <strong>La</strong> Voce di Sicilia », diretta a promuoveree sostenere iniziative culturali e ricreative;26. — consigliere di amministrazione e vicepresidentedella società per l'acquisto e lavendita di terreni e fabbricati « Siviere diLentini »;27. — consigliere di amministrazione dellesocietà immobiliari « Leonforte », « Benso »e « Piraino ».Come si vede, non c'è stato settore di qualcheimportanza della vita economica sicilianache non ha visto impegnato in prima personal'avvocato Guarrasi. Tra le altre iniziative, sonodegne di menzione quelle edilizie, che sirealizzarono nella costruzione in Palermo digrossi fabbricati utilizzati anche come sededi pubblici uffici. Non sempre però questeiniziative andarono a buon fine. Così ad esempio,la Mediterranea immobiliare e la Compagniamediterranea assicurazioni, chiusero laloro attività col fallimento e l'avvocato Guarrasi,nella sua qualità di amministratore dellaCompagnia mediterranea assicurazioni, fusottoposto a procedimento penale per il delittodi bancarotta fraudolenta, ed assolto inappello per non aver commesso il fatto, dopoessere stato condannato in primo grado aquattro anni di reclusione.Ma fu indubbiamente nel settore'dell'industriamineraria che meglio si manifestarono,anche se non sempre a vantaggio del contribuentesiciliano, le qualità e Io spirito di iniziativadi Guarrasi. Impegnato com'era in alcuneimprese per lo sfruttamento delle risorseminerarie siciliane, Guarrasi si rese contodella necessità di risolvere, con interventi
Senato della Repubblica — 212 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIstraordinari, la gravissima crisi in cui si dibattevanole preistoriche miniere siciliane,che erano state fino allora dominio incontrastato<strong>dei</strong> baroni siciliani e <strong>dei</strong> capimafia.Sarebbe nato proprio da questa esigenzal'interesse dimostrato da Guarrasi per la formazionedel governo Mila/zo. Si è detto dapiù parti che egli avrebbe avuto una funzionedeterminante, anche se indiretta, nella crisiche portò alla costituzione della giurata presiedutada Silvio Milazzo. Certo è che Milazzolo nominò segretario generale del pianoquinquennale per la ricostruzione della Siciliae che nel periodo del suo governo Guarrasifu delegato ad occuparsi <strong>dei</strong> rapporti trala Presidenza della Regione e gli enti finanziarisiciliani. Inoltre, come prima si è accennato,fu sempre il governo Milazzo che feceapprovare la legge regionale 13 marzo 1959,n. 4, che istituì un fondo per le industrie delsettore minerario, con una dotazione inizialedi dodici miliardi di lire e che in pratica servìa trasferire sulla Regione tutti gli oneri chegravavano sulle miniere e sul Banco di Sicilia,per i crediti concessi alle imprese di gestione.Ma nel 1963 la Regione istituì l'Ente minerariosiciliano (EMS) allo scopo di promuoverela ricerca, la coltivazione, la trasformazioneed il collocamento commerciale dellerisorse minerarie esistenti nel territorio dellaregione siciliana, mediante società per azioninelle quali l'ente doveva riservarsi, a normadi legge, una quota di capitale non inferioreal 51 per cento.Senonchè, dopo poco tempo, l'EMS determinòe favorì la creazione di numerose societàcon scopi che esorbitavano dalle ragioniche ne avevano consigliato l'istituzione, determinandocosì una proliferazione di aziendeproiettate nei più vari settori economici.Anche in questo caso, peraltro, nella costituzionedegli organi societari si badò ad accontentarei vari gruppi politici e queste operazioni,talora particolarmente difficili, hannofatto passare in secondo piano la gestionestessa delle società. Nel corso degli anni, infatti,le varie aziende hanno in sostanza finitocol produrre stipendi per il personale, tantoche i bilanci di numerose collegate presentanoun forte deficit di fronte ad un attivoche spesso non consente nemmeno di farfronte alle spese correnti.Tra le società di questo tipo, ha avuto unaposizione di spicco la SOCHIMISI (Societàchimica mineraria siciliana) di cui, come siè visto, anche Guarrasi fu uno <strong>dei</strong> soci fondatori.Costituita per la gestione delle miniere dizolfo in Sicilia, la SOCHIMISI è talora venutaalla ribalta della cronaca, per episodi inqualche modo collegati alla mafia.Il caso più clamoroso è quello che riguardail noto mafioso Giuseppe Di Cristina, imputatonel processo contro la nuova mafia e comemandante dell'omicidio di Candido Ciuni.Nonostante i suoi precedenti e malgrado chefosse stato licenziato dalla Cassa di Risparmio,perché sottoposto a una misura di prevenzione,Di Cristina venne assunto alle dipendenzedella SOCHIMISI; così come fuassunto nello stesso periodo di tempo un altromafioso, tale Tano Lo Grasso.Si è accertato peraltro che molte operazionifinanziarie della SOCHIMISI furonoconcepite ed attuate proprio dall'avvocatoGuarrasi. Tra le più spregiudicate, meritadi essere segnalata quella che portò alla fusionecon la SOCHIMISI di una società, la« COZZO-DISI », titolare di una vecchia concessionemineraria,, con la conseguenza che laSOCHIMISI, 'Secondo calcoli approssimativa,si è dovuta accollare le sopravvenienze passivedell'altra società, ammontanti a qualchemiliardo di lire.Un'altra società, pur essa collegata all'EMS,la società SCAI, costituita per la verticalizzazionedello zolfo per l'agricoltura, acquistòun terreno da privati, al prezzo correntedi mercato, nonostante che il Comunedi Mazara del Vallo le avesse offerto gratuitamenteuna parte del terreno che le occorreva,così come aveva fatto con altri enti di sviluppoe di promozione industriale operanti inSicilia. <strong>La</strong> stessa società inoltre affidò i lavoriper la costruzione di uno stabilimentoad un'industria palermitana, la « SicilianaKeller », che non aveva nessuna esperienzanel settore e che pretese, a quanto sembra,un prezzo maggiore di quello richiesto daun'industria milanese, specializzata in impiantichimici, con la conseguenza che lo
Senato della Repubblica — 2Ì3 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIstabilimento non è mai entrato in funzioneproprio per deficienze tecnico-costruttive.Episodi come questi hanno messo in evidenzail sistema di parassitismo e di clientelismoche ha caratterizzato le vicende connessealla gestione delle miniere siciliane e hannoalla fine provocato lo scandalo, che hacoinvolto lo stesso Ente minerario e tuttala costellazione delle società collegate.L'Autorità giudiziaria si sta direttamenteoccupando di queste vicende e dell'amministrazione<strong>dei</strong> fondi dell'EMS, e al centrodelle indagini si trovano i dirigenti dell'Ente,in primo luogo il suo presidente GrazianoVerzotto, anche lui legato da vincoli di affarie di amicizia con l'avvocato Guarrasi, e poiil direttore generale Pietro Giordano.Graziano Verzotto, nato a Padova nel 1923,negli anni 1944-45 comandò la brigata partigiana« Damiano Chiesa » che operava nel padovano;dal 1945 al 1948 dimorò a Roma,esplicando le mansioni di funzionario pressola segreteria nazionale della Democrazia cristiana.Nel 1948 fu trasferito alla Federazioneprovinciale della Democrazia cristiana diCatania ove svolse attività organizzativa perle elezioni politiche, sostenendo con impegnola candidata Maria Nicotra Fiorini, che poisposò il 19 luglio 1949; nel 1950, a seguitodi interventi della moglie e con l'aiuto delpartito, fu assunto dall'AGIP; nel 1955 fu destinato,quale commissario straordinario, allaFederazione provinciale della Democraziacristiana di Siracusa, divenendone successivamentesegretario; nel 1958 si presentò candidatoalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, ma non venneeletto; nel 1960 fu nominato vice segretarioregionale del partito e fu durante questo periodoche fece da testimone alle nozze delmafioso Giuseppe Di Cristina; nel 1962 fueletto segretario, carica mantenuta fino al 30febbraio 1966, quando si dimise a seguito dicritiche della CISL che Io accusava di averedeterminato l'immobilismo del governo regionaledi centro-sinistra, per soddisfare ambizionied interessi clientelari nell'attribuzionedegli incarichi di « sottogoverno »; nel1961 fu nominato capo ufficio Pubbliche relazionidell'ENI in Sicilia, per l'interessamentodell'ingegner Enrico Mattei; nel 1967fu nominato presidente dell'EMS (Ente minerariosiciliano); nel 1968 fu eletto senatorenel collegio di Noto, ma si dimise per incompatibilitàcon la carica di presidentedell'EMS, che ha ricoperto ininterrottamentedal 1967 fino al 17 gennaio 1975, quando siè dimesso a seguito delle indagini giudiziarieiniziate a suo carico. Dai primi accertamenticompiuti dalla Magistratura palermitana eda quella milanese, è risultato che l'EMS, violandola norma statutaria che lo impegnavaa depositare il suo denaro presso il Bancodi Sicilia o presso banche comunque operantiin Sicilia, aveva depositato somme ingenti(sette miliardi) sulla Banca Privata Italianae sul Banco di Milano, operanti entrambenel capoluogo lombardo. È poi risultato chele due banche hanno pagato interessi-extrarispetto a quelli pattuiti e che tali interessivenivano versati non all'EMS, ma ad alcunisuoi dirigenti, tra cui il Giordano e il Verzotto.Si è inoltre appurato che i compensi aiconsiglieri di amministrazone del Banco diMilano venivano liquidati in percentuale sugliaffari compiuti. Pertanto, Graziano Verzotto,essendo consigliere di amministrazionedel Banco di Milano, è stato imputato deldelitto di interesse privato in atti di ufficio,nel presupposto che egli avesse versato il denarosulle due banche milanesi per fini propried in particolare per lucrare compensimaggiori, come amministratore della citatabanca.A seguito dell'istruzione, l'Autorità giudiziariadi Milano ha rinviato a giudizio Verzotto,Giordano ed altri dirigenti dell'EMSper tale reato e per il delitto di peculato, relativamenteall'illegittima appropriazione deldenaro pagato dalle banche milanesi comeinteresse extracartello.Le vicende e gli episodi ora narrati nonsembrano collegati col mondo della mafia,ma resta il fatto che è stato proprio nel parassitismoe nel clientelismo programmatico, inuna parola nel sistema di malgoverno, disprechi, di strumentalizzazione delle stesseistituzioni, e quindi in definitiva nel comportamentodi certe persone che hanno trovatoterreno favorevole e nuovo alimento il costumee la presenza mafiose.Se è vero che lo Stato accentratore e poliziescoha avuto la sua parte nelle origini della
Senato della Repubblica — 214 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTImafia, è altrettanto certo che uno Stato, chemostra talora di tollerare la dilapidazionedel patrimonio nazionale a favore di ceti privilegiati,e che si presenta a una popolazione,che vive ancora in pesanti ristrettezze economiche,con le ricchezze sfacciate e di incertaprovenienza di alcuni suoi rappresentanti,non è meno colpevole della sopravvivenzadella mafia, appunto perché, mentre favoriscepericolose collusioni e illecite connivenze,dissuade i cittadini da quell'attiva collaborazionecon l'apparato pubblico, che potrebbeessere un fattore decisivo per la liberazionee il riscatto del popolo siciliano.SEZIONE SECONDA<strong>LA</strong> <strong>MAFIA</strong> E IL POTERE PUBBLICO1. — <strong>La</strong> mafia e i Comuni dell'Isola. Gli abusiedilizi.Sempre nel settore <strong>dei</strong> rapporti tra mafiae pubblici poteri, la Commissione si è tral'altro occupata con particolare attenzionedel comportamento tenuto, tra gli anni cinquantae sessanta, dagli organi degli Entiterritoriali locali, soprattutto <strong>dei</strong> Comuni dellaSicilia occidentale. L'indagine ha avuto adoggetto gli interventi di questi Enti nei varicampi dell'attività sociale, e per ciò che riguardai Comuni, specialmente quelli svoltinel settore edilizio. Si è cercato, in questomodo, di accertare gli eventuali rapporti tragli organi della Pubblica amministrazione ela mafia, di analizzare il funzionamento degliorgani amministrativi per porre in risalto laloro possibile permeabilità ad azioni di mafia,di valutare infine l'opera ed il comportamentodegli amministratori per stabilire,indipendentemente dai legami con la mafiaorganizzata, se essi rientrassero nel quadrodel costume mafioso.A conclusione dell'indagine e in via generalesi può dire senz'altro che le ricerchecompiute hanno messo in luce molteplici anomaliedi funzionamento <strong>dei</strong> vari organi dellaPubblica amministrazione, che hanno causatoalla comunità gravi pregiudizi di ordinesociale, igienico, urbanistico ed economico,sotto le frequenti spinte di forze extra-legali,che indubbiamente portano un'impronta dinatura mafiosa. Si è trattato ovviamente dianomalie che hanno avuto, nei diversi casi,una diversa intensità ed estensione. Ma laCommissione, più ohe limitarsi ad un'analisicomparativa <strong>dei</strong> risultati conseguiti in relazioneall'attività <strong>dei</strong> singoli Enti considerati,reputa opportuno esporre nel modo più precisopossibile gli elementi di giudizio acquisitiin uno <strong>dei</strong> settori più scottanti, e quindipiù significativi, della indagine, quello degliinterventi comunali in materie di alto interessesociale, in primo luogo in ordine allo sviluppoedilizio ed urbanistico delle città e <strong>dei</strong>centri più importanti della Sicilia occidentale.Gli accertamenti compiuti infatti non sonostati limitati ai quattro capoluoghi delleProvince occidentali, ma sono stati estesi aiComuni minori, anche se per questi casi, sisono esauriti nell'esame della documentazioneraccolta dagli ispettori regionali, in occasione<strong>dei</strong> controlli eseguiti, per conto dell'Assessoratoagli Enti locali, sulla gestione dellevarie amministrazioni comunali.Si è trattato comunque di un materiale diestremo interesse, sintetizzato nelle relazioniconclusive delle ispezioni, che hanno permessoalla Commissione di avere a disposizioneun quadro globale e sufficientemente anticolatodell'attività svolta in Sicilia dalle amministrazione<strong>dei</strong> Comuni minori durante glianni sessanta.Ovviamente il giudizio che se ne trae nonpuò essere generalizzato, in quanto gli esempidi Comuni caraitterizzati dalla regolaritàed efficienza dell'amministrazione si alternanoa quelli <strong>dei</strong> Comuni nei quali invece l'inosservanzadella legge è stata la norma. AllaCommissione, però, non interessano i paragoni,e nemmeno il quadro di insieme. Importasoltanto sottolineare come in moltissimi casi,e si tratta della maggioranza <strong>dei</strong> casi, lagestione <strong>dei</strong> Comuni di qualche importanzadella Sicilia occidentale è stata connotatada una serie frequente, anzi continua, di irregolaritàamministrative di ogni genere. Sonostate tutte irregolarità che, per la natura,
Senato della Repubblica — 215 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIpiù che per la quantità, e soprattutto per ilcontesto in cui si sono verificate, denuncianochiaramente, se non un'origine maliosa, certamenteil pericolo di un cedimento della |Pubblica amministrazione alle insidie, alle lusinghe,in una parola alla capacità di infiltrazionee di ricatto del potere mafioso, in queglianni presente, in tutta la sua forza, neicentri urbani presi in esame. Per renderseneconto, bastano le citazioni di alcuni giudiziespressi nelle relazioni ispettive (prima menzionate)sul comportamento degli organi amministratividi questi Comuni.« Non vi è dubbio » si legge ad esempio inuna di queste relazioni « che esista nei confrontidegli amministratori passati e recentiuna responsabilità civile e anche penale ».Così -ancora, per un altro Comune, la relazioneconclude « che le numerose irregolaritàe manchevolezze amministrative e finanziarieemerse nel corso dell'ispezione, oltre a costituiregravi infrazioni alle norme che regolanol'amministrazione della cosa pubblica, importanoin alcuni casi la responsabilità degliamministratori che hanno trascurato di curareed assicurare il buon andamento <strong>dei</strong> piùimportanti servizi, specie quelli che hannoattinenza alla finanza comunale ».Parimenti duro è il giudizio espresso inuna terza relazione nella quale si afferma, aproposito di uno <strong>dei</strong> campi tradizionali dellaspeculazione mafiosa, quello delle aree fabbricabili,che « le concessioni del suolo comunalenon solo non hanno seguito l'iter proceduralenormale, ma sono state elargite aprezzi molto bassi, che potevano essere triplicati...Il funzionamento della Commissioneedilizia fu viziato in continuità dalla suainiziale composizioTie, anche perché di essafacevano parte due fratelli, che spesso nonottemperavano alle norme vigenti in occasionedella presentazione <strong>dei</strong> progetti da loroelaborati ».Per un quarto Comune infine « devesi concludere» dice la relazione ispettiva « chel'attività dell'amministrazione sia consapevolmenteorientata nel senso di continuare,anche per l'avvenire, ad espletare in manierairregolare il servizio di nettezza urbana. L'appaltatoreviolerebbe il capitolato, riguardoal numero degli operai, riguardo alle attrezzaturenecessarie, riguardo al rispetto <strong>dei</strong>contratti di lavoro e riguardo alla continuitàdel servizio ».Sono, come si vede, irregolarità di variogenere, ma che hanno tutte il comune denominatoredi mettere a nudo una cronica debolezzadegli organi amministrativi di frontealle pressioni esterne e quindi una disponibilitàal comportamento illegale, che è caratteristicadel costume mafioso.Non si sottraggono peraltro a questo stessotipo di giudizio i moduli operativi <strong>dei</strong> Comunicapoluoghi di provincia, della Sicilia occidentale,Trapani, Caltanissetta, Agrigentoe Palermo.Per quanto riguarda Trapani, la Commissioneha avuto modo di accertare che nelperiodo compreso tra gli ultimi anni cinquantae i primi anni sessanta furono commessedagli organi comunali molte e varieirregolarità, relative al rilascio di licenze edilizie,alla concessione di appalti, al rilasciodi licenze di commercio.In particolare, è risultato che almeno trentalicenze edilizie furono concesse dal Sindacodi Trapani, in deroga alle norme di legge,tanto che in sede amministrativa vennerotutte considerate illegittime, « essendosi concretatein provvedimenti di favore ». Allostesso modo, in materia di appalti, nell'arcodi tempo 1958-1963, furono commesse decinedi irregolarità e non mancarono casi di appaltiin opere e di forniture concessi a personecondannate per reati anche gravi, tra l'altropeculato, sfruttamento di prostitute e furtoaggravato. Al riguardo, l'amministrazione comunaledi Trapani rispose ai rilievi che leerano stati mossi in sede ispettiva che « nonriusciva ad individuare per quali motivi esotto quali profili tali condanne potessero inficiarela legittimità » degli appalti; ma la risposta,risolvendosi in una considerazione diordine formale, anziché rappresentare unavalida giustificazione, meglio sottolinea comel'assuefazione a un costume possa far perderedi vista la linea di demarcazione tra lecito eillecito e possa quindi favorire pericolosi cedimentidella pubblica autorità.Anche per ciò che attiene al rilascio dellelicenze di commercio, furono riscontrate numeroseirregolarità e gravi responsabilità do-
Senato della Repubblica — 216 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIvute a negligenza, impreparazione ed incapacitàdel personale, tanto che tra l'altro 311licenze risultarono concesse senza che fosserostati acquisiti dal Comune i documenti indispensabilial loro rilascio.Analoghe anomalie, anche se forse menogravi e frequenti, furono accertate relativamentealla gestione del Comune di Caltanissetta,specie con riguardo alla concessione dilicenze edilizie.Ad Agrigento invece, l'esame di 986 praticheper il rilascio di licenze di costruzionemise in evidenza come ben più rilevanti fosserostate le irregolarità commesse in questamateria nel periodo che va fino ai primi mesidel 1964. In proposito, si legge tra l'altro,nella relazione conclusiva di un'ispezione amministrativa,ohe « nel complesso, l'esecuzionedi costruzioni abusive in Agrigento ha assuntoun aspetto veramente eccezionale, perchéogni persona a qualsiasi categoria socialeappartenga, insofferente a qualsiasi tipodi .disciplina, si è sentita autorizzata a costruirela sua casa ».In particolare, furono costruiti, in quel periodo,moltissimi edifici senza licenza, oppurein difformità delle prescrizioni, oppure aldi là <strong>dei</strong> limiti e <strong>dei</strong> criteri fissati dalla Sovrintendenzaai monumenti e dalla Sovxintendenzaalle antichità. Di fronte a questoscempio urbanistico, di proporzioni insolite,e che sarebbe stato all'origine della frana del1966, l'opera del Comune fu per più versa criticabile.In molti casi gli organi comunaliesorbitarono dalla sfera delle loro attribuzionie non mancò nemmeno il sospetto che il rilasciodelle licenze, specie di quelle relativea'ila zona archeologica, fosse « il frutto di favoritismi». In altri casi, invece, l'amministrazionecomunale si rivelò incapace di pretendereil rispetto della legge, inadeguata in sostanzaal compito che l'ordinamento le assegnava:il Sindaco, infatti, anche se emise inpiù di una occasione provvedimenti di sospensionee atti di diffida, trovò remore maggiori,e quasi sempre insuperabili, di frontealla necessità di giungere alla demolizione,e quella sola volta che gli riuscì di dare esecuzioneall'ordine di demolire una costruzioneabusiva fu costretto a dimettersi insiemealla Giunta comunale, appena tre giorniidopo.<strong>La</strong> conseguenza (obiettiva) di questa politicadissennata fu la frana che il 19 luglio1966 colpì tragicamente la città di Agrigento.A seguito del disastro, il Ministero <strong>dei</strong> lavoripubblici nominò una Commissione d'inchiesta,presieduta dal dottor Michele Martuscelli,direttore generale dell'urbanistica, alloscopo di indagare in merito alla situazioneedilizia della città, mentre a sua volta la Regioneincaricò una propria Commissione disvolgere gli opportuni accertamenti sull'operatodegli amministratori di Agrigento.I risultati delle inchieste autorizzarono ungiudizio nettamente negativo. « Gli uominidi Agrigento » scrissero i componenti dellaCommissione ministeriale « hanno erratofortemente e pervicacemente, sotto il profilodella condotta amministrativa e delle prestazionitecniche, nella veste di responsabilidella cosa pubblica e come privati operatori.Il danno di questa condotta, interamente ecoscientemente voluta, di atti di prevaricazionecompiuti o subiti, di arrogante eserciziodel potere discrezionale, di spregio della condottademocratica, è incalcolabile per la cittàdi Agrigento ».Era un'accusa che non ammetteva attenuantie che avrebbe avuto un seguito in Tribunale.Infatti i tre sindaci di Agrigento,succedutisi in carica tra il 1956 e il 1966, AntoninoDi Giovanna, Vincenzo Poti e AntoninoGinex, furono condannati, in primo gradoe in appello, per il delitto di interesse privatoin atti di ufficio, in relazione alla condottada loro tenuta in merito allo sviluppourbanistico ed edilizio della città.Si trattò, dunque, di tutta una serie di irregolarità,di favoritismi, di abusi, di veri epropri illeciti penali che, se pure non furonotali di rivelare una vera e propria collusionetra mafiosi e Pubblica amministrazione, ebberotuttavia tale estensione e furono di cosìelevata virulenza, da mettere almeno in lucecome fosse sempre ampia la zona di permeabilità<strong>dei</strong> pubblici poteri alle azioni e ai tentatividi infiltrazione della mafia.Non si può infatti dimenticare che nel periodoconsiderato i tre capoluoghi della Siciliaoccidentale, al pari degli altri Comuni primaesaminati, erano zeppi di mafiosi, tantoè vero che tra il 1957 e il 1968 furono adottati
Senato della Repubblica — 217 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputaliLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI D[ LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTI4188 provvedimenti di diffida nella provinciadi Trapani, 1623 in quella di Agnigento,1359 in quella di Caltanissetta. Molti di questimafiosi non vivevano ai margini della vitasociale, ma parecchi di loro si erano impegnatiin prima persona nelle attività economicheallora più redditizie, e in primo luogoin quella della speculazione edile.Per di più la Commissione ha potuto accertare,non solo attraverso le informazioni degliorgani di pubblica sicurezza, ma altresìmediante indagini documentali, che figli enipoti e in genere parenti di noti personaggimafiosi si erano via via inseriti a vari livellinelle amministrazioni locali e negli Enti dipubblico interesse. Così, in particolare, l'amministrazionecomunale di Trapani contava15 parenti di mafiosi, quella di Caltanissetta16, quella di Agrigento 20.Non ci vuole di più, per dedurne, nei terminidi un giudizio politico, che non ha bisognoper essere espresso della puntualità e dellaprecisione delle prove che sono richiestein sede giudiziaria, che tutto quello che avvenne,negli anni presi in considerazione, aTrapani, a Caltanissetta e ad Agrigento nonpuò essere spiegato, se non ammettendo chesul comportamento degli organi pubblici, abbiain qualche modo esercitato la sua influenzail potere della mafia.Ma fu in particolare a Palermo che l'accennatofenomeno assunse dimensioni percosì dire visive, di tale evidenza cioè da nonlasciare dubbi sull'insidiosa penetrazionemafiosa all'interno dell'apparato pubblico.<strong>La</strong> gestione amministrativa del Comune diPalermo raggiunse, negli anni intorno al1960, vertici sconosciuti nell'inosservanzaspregiudicata della legge, lasciandosi dietroirregolarità di ogni genere che il Consiglio digiustizia amministrativa, nella seduta del 25giugno 1964, così tentava di riassumere: « laesistenza di costruzioni sprovviste di licenzao abusive, la precipitosa approvazione di progettie il rilascio altrettanto precipitoso dilicenze edilizie nel periodo di carenza dellasalvaguardia e, soprattutto, la distorsione eJa falsa applicazione di' vecchie norme regolamentari(del 1889) richiedenti l'interventonelle licenze edilizie e nelle conseguenti costruzioni" di un capotmastro od impresariocapace ed abile ". Si è preteso di dare applicazionea tali norme (i cui fini originari eranoormai esauriti e superati dalla normazionesulle professioni di ingegnere, geometra edanaloghe, in relazione alla compilazione diprogetti e alla direzione di lavori edili), attraversol'istituzione ed il mantenimento di unalbo di costruttori " per canto terzi " nelquale, per disposizione dell'Assessore, sonostate iscritte persone delle quali non risultanochiari i 'titoli e Je benemerenze professionalie che, negli ultimi anni, hanno monopolizzatoquasi per intero il settore delle licenzeedilizie, fungendo evidentemente da prestanomedegli effettivi costruttori rimastinell'ombra ».Sarebbe naturalmente impossibile e ai finidella Commissione in pratica inutile esaminareparatamente i singoli abusi, a cuidiede luogo la gestione del Comune di Palermoe che formarono oggetto tra l'altro dellaindagine della cosiddetta Commissione Bevivino,incaricata dalla Regióne di svolgere inproposito un'ispezione straordinaria. Non èperò possibile non fare menzione, fra quellericordate nella relazione Bevivino, delle seguentivicende che appaiono tra le più significative,nell'ambito di un'inchiesta sulla mafia:a) « Convenzione tra il Comune e i signoriTerrasi e Consorti per l'approvazione diun piano di zona di iniziativa privata riguardantel'appezzamento di terreno in localitàGirato delle Rose.Con delibera n. 133 del 12 ottobre 1955,il commissario del Comune di Palermo approvòun compromesso .tra il Comune e i signoriTerrasi e Consorti, stipulato tra l'aliorasindaco Scaduto e i predetti.<strong>La</strong> Giunta provinciale amministrativa, nellaseduta del 9 dicembre dello stesso anno,rinviò la delibera commissariale in considerazionedell'eccessiva ed ingiustificata onerositàdel compromesso nei confronti dell'amministrazionecomunale.li Comune in data 29 febbraio 1956, controdedussee la Giunta provinciale amministrativaaccogliendo le osservazioni approvòla delibera nella seduta del 23 marzo 1956(n. 24975 Div. 4).
Senato della Repubblica — 218 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTITuttavia, nell'agosto del 1957, l'ufficio comunale<strong>dei</strong> lavori pubblici propose la revocadi tale delibera, ritenendola superata dal pianoregolatore generale del 1956; la Giuntamunicipale, in accoglimento di tale proposta,con sua delibera n. 4983 del 14 novembre1957, revocò la delibera commissariale numero.133. <strong>La</strong> Commissione provinciale dicontrollo non riscontrò in tale provvedimentovizi di legittimità.Il provvedimento di revoca adottato, comesopra detto, dalla Giunta municipale fu ratificatodal Consiglio comunale oon deliberan. 486 del 23 novembre 1959. Il provvedimentodi revoca era ispirato alla necessità di salvaguardareil piano regolatore generale.Ma nel 1962, e precisamente il 30 aprile, ilConsiglio comunale, con delibera n. 290, deciseinopinatamente di approvare la convenzioneTerrasi.<strong>La</strong> Commissione provinciale di controllo,peraltro, in data 25 luglio 1962 pronunciòl'annullamento della delibera ed il segretario.generale del Comune, con sua lettera del22 aprile 1963 diretta all'Assessore ai lavoripubblici, comunicò che Io schema di convenzioneTerrasi, dopo l'annullamento da partedella Commissione provinciale di controllo,doveva essere riproposto ex nova.Ciò non pertanto, il piano regolatore generaledel 1959, come risulta dall'elaborato al1:2000, foglio 19, riporta una zona convenzionatasui terreni di Terrasi e Consorti.Non risulta, a tutt'oggi, stipulata, con attopubblico, alcuna regolare convenzione. Infattila nuova convenzione non è stata ancoraapprovata dal Consiglio comunale ».b) « Vassallo Francesco - Edificio in viaQuarto <strong>dei</strong> Mille, n. 9.jL'impresa Francesco Vassallo, il giorno 18aprile 1961, presentò un progetto per la costruzionedi un edificio in via. Quarto <strong>dei</strong>Mille, comprendente uno scantinato, un pianoterra, sei piani elevati ed un piano attico.L'edificio ricadeva in zona a densità fondiariain 14 metri cubi/metri quadrati dellaclasse F3, secondo il piano regolatore generaledel 1959. <strong>La</strong> costruzione doveva sorgerein zona già edificata.<strong>La</strong> sezione III-B dell'ufficio tecnico espresseil parere che il progetto doveva essereesaminato secondo le norme del regolamentoedilizio ordinario; secondo tali norme il progettorisultava regolare.In data 16 maggio 1961, la Commissioneedilizia espresse parere favorevole, e vennerilasciata la licenza di costruzione n. 856per un piano scantinato, un piano terra, seipiani elevati ed un piano attico.<strong>La</strong> ditta Vassallo ripresentò, peraltro, unnuovo progetto il 4 febbraio 1963, con unavariante consistente nella aggiunta di un superatticoed in modifiche planimetriche alpiano terreno e al primo piano. Con questavariante, inoltre, venivamo ridotti i cortiliin corrispondenza del piano terreno e delprimo piano e ciò allo scopo di poter ampliarel'edificio.<strong>La</strong> Commissione edilizia, in data 12 febbraio1963, espresse parere favorevole allavariante.<strong>La</strong> Commissione ispettiva ha ritenuto di disporreun sopralluogo, dal quale è risultatoche la costruzione eseguita è difforme dalprogetto approvato. E precisamente:a) il piano superattico non è arretratonel retroprospetto, come era previsto nelprogetto di variante;b) sono stati eseguiti nel retroprospettopiccoli corpi aggiunti lungo i corpi di fabbricafino al confine e per l'altezza del solo primopiano.I rapporti per 'l'abitabilità ed il certificatodi fine lavori compilati dall'ufficio tecnicorispettivamente il 3 ottobre 1962 ed il 1° dicembre1962 dichiarano invece che la costruzioneè conforme al progetto approvato.Su quest'ultima circostanza, il capo dell'ufficiotecnico — a richiesta della Commissioneispettiva — ha fornito alcuni chiarimenti, secondoi quali i corpi abusivi risultano tecnicamentecostruiti dopo il rilascio del certificato,che non è " coperto " da licenza e percui non è stato rilasciato il rapporto di abitabilità»;e) « Natoli Anna in Cataliotti - Costruzionein corso Calatafimi angolo via Marinuzzi.
Senato della Repubblica — 219 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIII progetto di costruzione venne presentatoil 2 febbraio 1960. Secondo quanto osservatonella sezione V dell'ufficio tecnico, l'edificioricadeva in zona di espansione a densità 3,5metri cubi/metri quadrati - classe RIO, secondoil piano regolatore generale del 1959.<strong>La</strong> sezione III-B, per quanto di sua competenza,osservò che l'edificio aveva una cubaturain 16.734 metri cubi, mentre la cubaturacalcolata secondo le norme dello stesso pianoregolatore generale era di 5.000 metri cubi.Esaminato con il regolamento edilizio, ilprogetto sarebbe risultato conforme; mentre,come si è detto, per il piano regolatore generalela cubatura risultava molto superiore aquella consentita.<strong>La</strong> Commissione edilizia diede parere favorevoleil 22 febbraio stesso anno senza porrealcuna condizione, per un piano terra, settepiani ed un piano attico.Si osserva che la Commissione edilizia nonritenne di doversi adeguare ai rilievi dellasezione III-B dell'ufficio tecnico e non ritennedi applicare le norme del piano regolatoregenerale che, nel periodo in esame, eranosalvaguardate.Inoltre, in data 24 ottobre 1960, venne presentato,questa volta a nome di VassalloFrancesco, un progetto .di variante per la costruzionedi un ottavo piano sul corso Calatafimi.<strong>La</strong> sezione III-B e lo stesso dirigente dell'ufficiotecnico confermarono che tanto ilprogetto quanto la variante non rispettavano,per cubatura ed altezza, le norme del pianoregolatore generale.<strong>La</strong> Commissione edilizia, tuttavia, non tenendoconto, ancora una volta, del parere degliuffici tecnici, espresse il voto favorevolealla variante.In sostanza, la Commissione edilizia e, successivamente,gli amministratori non hannoritenuto, per il progetto in esame e per glialtri casi analoghi, di avvalersi delle normedi salvaguardia, perché — a loro avviso —le soluzioni <strong>dei</strong> progetti in esame non " sconvolgevano" il piano regolatore generale.Al contrario, secondo questa Commissioneispettiva, una notevole diversa densità fondiariain un dato lotto turba gravementel'equilibrio urbanistico della zona.Nel caso in esame, il volume è stato più chetriplicato (16.734 metri cubi), oltre l'ottavopiano della variante, in confronto ai 5.000metri cubi previsti e concessi dal piano regodalore generale.Mentre, sia nel certificato di fine lavori sianel rapporto di abitabilità viene affermatoche la costruzione è conforme ai progetti approvati,da un sopralluogo disposto da questaCommissione ispettiva è risultato che l'impresa:a) ha unificato gli ingressi;b) ha costruito <strong>dei</strong> corpi bassi;e) ha aumentato lo spessore <strong>dei</strong> corpidi fabbrica;d) ha ridotto la terrazza del piano attico;tutto ciò senza che, dal fascicolo, risultialcuna approvazione da parte degli organicomunali.Il capo dell'ufficio tecnico, a richiesta dellaCommissione ispettiva, ha fornito in meritoalcuni chiarimenti, dai quali risulterebbeche i coi pi abusivi sarebbero stati costruitiin epoca posteriore agli accertamenti degliuffici ;>.d) « Moncada Girolarrio e Messina Eugenio- Costruzione di due fabbricati in via NinoBixio.Il progetto venne presentato il 14 ottobre1959.<strong>La</strong> costruzione, secondo il parere espressodalla sezione V dell'ufficio tecnico, rientravain zona di espansione a densità edilizia urbana'fino a 2,5 metri cubi/metri quadrati, secondoil piano regolatore del 1956.<strong>La</strong> sezione III-B, osservato che l'edificiorientrava nella lottizzazione D'Arpa e fratelli,approvata dalla Commissione edilizia nellaseduta del 1° dicembre 1958, rilevava che ilprogetto non si uniformava a detto piano dilottizzazione per la maggiore lunghezza previstanegli edifici: tre metri per l'edificio B edue metri per l'edificio C, con conseguenteaumento di 1.000 metri cubi di volume. Nonsi uniformava inoltre allo stesso piano di lottizzazioneper il minore distacco dagli edificistessi in corrispondenza del collegamento aterrazza (metri 4,70 anziché metri 6).
Senato della Repubblica — 220 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIII progetto prevedeva, inoltre, un pianorientrante che non risultava arretrato in manieraregolamentare. Entrambi i piani atticirisultavano arretrati, su tre fronti, di metri2 anziché di metri 3,40; in corrispondenza delquarto fronte erano a filo del fabbricato.<strong>La</strong> Commissione edilizia, il 9 novembre1959, espresse parere favorevole alla unicacondizione che venisse eliminato il piano attico.Successivamente, in data 23 marzo 1960, ilsignor Moncada presentò un progetto di variante.<strong>La</strong> sezione III-B, esaminato il progetto divariante, osservò che la planimetria non corrispondevaalle previsioni del progetto e cheera prevista una maggiore altezza di quellaindicata nel piano di lottizzazione D'Arpa efratelli (metri 25,40 anziché metri 21).<strong>La</strong> Commissione edilizia, il 31 gennaio1961, espresse parere favorevole, a condizioneche il piano attico venisse arretrato su tutti ifronti in misura regolamentare e che fosserorispettati i distacchi e gli arretramenti previstinel piano di lottizzazione.Venne ancora presentata altra variante, indata 1° luglio 1961, consistente nella costruzionedi un piano attico nei due edifici e diulteriori ambienti sopra il piano attico (giàescluso, come si è detto sopra, dalla Commissioneedilizia).<strong>La</strong> sezione III-B osservò che la variantenon era regolamentare, perché non solo nonvenivano arretrate le fabbriche, come avevaprescritto la Commissione edilizia, ma ancheperché venivano ulteriormente ridotti gli arretramentie l'interpiano (ridotto a metri2,90).<strong>La</strong> Commissione edilizia espresse, peraltro,parere favorevole alla variante il 4 luglio1961, senza porre alcuna condizione.<strong>La</strong> licenza di costruzione (n. 1006) venneconcessa il 25 luglio 1961 ».e) « Vassallo Francesco - Edifici A, B, Ce D in via <strong>La</strong>zio.Il progetto di costruzione degli edifici sopraindicati fu presentato all'ufficio tecnicoil 27 gennaio 1961. Faceva parte di un pianodi lottizzazione a nome Lipari e Citarda, approvatodalla Commissione edilizia il 13 giugno1960. Comprendeva uno scantinato, unpiano terra, un ammezzato, sei piani elevatied un attico. Rientrava, secondo la relazionedella competente sezione V, in zona ediliziaa densità fondiaria di 9 metri-cubi/metriquadrati della classe E7, secondo il piano regolatoregenerale del 1959.Secondo le osservazioni della sezione III-B,la superficie coperta con corpi bassi superavaquella ammessa dalle norme di attuazione dimetri quadrati 1,50, su metri quadrati 680.<strong>La</strong> Commissione edilizia, nella seduta de]30 stesso mese (tre giorni dopo la presentazionedel progetto), si espresse favorevolmentesenza porre alcuna condizione.Il 3 giugno 1962, l'impresa presentò una varianterelativa a tutti e quattro gli edifici,consistente nella creazione di uno scantinato,di un seminterrato e di un piano rialzatofacente parte <strong>dei</strong> corpi accessori.Con tale variante, si superava di circa metriquadrati 200 la superficie, e di centimetri80 l'altezza ammissibile.<strong>La</strong> Commissione edilizia il giorno 5 successivo(due giorni dopo la presentazione dellavariante) diede parere favorevole senza porrealcuna condizione.Si osserva che l'impresa, con i corpi bassidi metri 4,80 di altezza, anziché di metri 4,ha potuto realizzare due elevazioni (piani) alposto di una.In data 17 novembre 1962 l'impresa presentòun'altra variante per gli edifici B e C, consistentein una diversa distribuzione interna;la Commissione edilizia espresse parere favorevoleil 20 stesso mese.Si rileva che l'amministrazione comunaleha concesso la licenza al progetto originarioe alle successive varianti nelle more dellastipulazione delle convenzioni.Questa procedura è stata seguita dall'amministrazionenella maggior parte <strong>dei</strong> casiesaminati dalla Commissione ispettiva.Per quanto riguarda il progetto delle costruzioniin esame, si osserva che esso prevedevaun fronte di metri 115. Tale fronteera regolarmentare nel momento della presentazionedel progetto (gennaio 1961). Ma,nelle more del rilascio della licenza, era statoapprovato dal Presidente della Regione il
Senato della Repubblica — 221 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTInuovo piano regolatore generale, nel qualeveniva tra l'altro determinato in non più di100 metri (articolo 72 delle noume di attuazione)il ironie degli edifici del tipo di quelloin esame.Da ciò, la perplessità, che si evince dallalettura degli atti del fascicolo, delle sezionitecniche competenti, circa il rilascio dellalicenza con la detta norma della lunghezzainfinita e con quella successiva, che limitavaa 100 metri la lunghezza infinita (115 metri).In questo modo, è stato possibile all'impresaedificare con una volumetria superiorea quella stabilita dal decreto presidenziale».Tutti quelli riassunti sono episodi particolari,ma non per questo meno illuminanti,non solo per il tipo neon-ente degli abusi edelle irregolarità riscontrate, che chiaramentedenunciano un cedimento, se non una connivenzadegli organi pubblici con gli ambientimafiosi, quanto per i nomi che si ritrovanonelle vicende narrate e quindi per le deduzioniche se ne possono ricavare. In primoluogo, la certezza, desunta anche da altrielementi di giudizio, che in quegli anni, inconnessione con lo sviluppo dell'attività edilizia,emersero a Palermo personaggi di discutibileprovenienza, che si arricchirono rapidamentein modo perlomeno sospetto, provache molte irregolarità, soprattutto nelcampo delle licenze edilizie, furono commessea beneficio di persone già allora indicatecome mafiose o che tali si sarebbero rivelatenel corso di avvenimenti successivi.Ma accanto a questi episodi specifici, siaccertò anche che nello stesso periodo ditempo furono iscritti nell'albo <strong>dei</strong> costruttorie ottennero numerose licenze personesprovviste di mezzi finanziari e di ogni capacitàimprenditoriale, tra i quali SalvatoreMilazzo, Michele Caggegi e Lorenzo Ferrante.Secondo la Prefettura di Palermo, il Milazzo,padre di quattro figli, di cui uno sposato,« esercitava il mestiere di muratore giornaliero», non aveva mai svolto attività di. costruttoreedile, non aveva beni immobili;anche il Caggegi era un muratore, pensionatodella previdenza sociale, non aveva beni disorta e non esercitava neppure l'attività dimuratore, perché di salute malferma.Di fronte a fatti del genere, non si puòpensare che alla mafia, una mafia che si eraimpadronita, con i suoi tentacoli, del settoredella speculazione edilizia e che non eradisposta a indietreggiare dalle posizioni conquistate,anche a costo, come in effetti avvenne,di ricorrere alla violenza più spietata. Leaccennate irregolarità amministrative offrironoun terreno propizio al successo dellamafia e alla forza che essa esercitava, attraversogruppi di pressione organizzati, per ottenereogni forma di favoritismi e per lucrarei vantaggi dell'intermediazione parassitaria,connessa all'attività edilizia e all'acquistodelle aree fabbricabili. D'altra parte, laparticolare intensità che ebbe in quegli anniil fenomeno della delinquenza nella cittàdi Palermo fu certamente l'effetto delle lotteche si scatenarono tra le cosche mafiose perassicurarsi il predominio nelle varie zone dellacittà, ma nemmeno può essere senza significatoil parallelismo che si venne obiettivamentea creare tra la sequela delle manifestazionidelittuose e le ricorrenti anomaliee carenze della gestione amministrativa delComune di Palermo.Ma tutti questi fatti, pur così significativi,perderebbero parte del loro rilievo, se nonfossero valutati nel quadro delle vicende personalidi colui che, se non fu l'unico responsabiledella situazione determinatasi in queglianni a Palermo, ne fu certo uno <strong>dei</strong> protagonisti:Vito Ciancimino.2. — Vito Ciancimino.A) Notizie sulla vita. — Vito Cianciminoè nato il 2 aprile 1924 a Corleone, dove trascorsegli anni dell'adolescenza. Iniziò glistudi a Corleone e frequentò presso quel liceostatale il 2° liceo classico; conseguì poila maturità nella sessione estiva del 1941presso il liceo « Meli » di Palermo.Nell'anno accademico 1942-1943 si iscrissealla facoltà di ingegneria dell'Università diPalermo, proseguendo gli studi sino al 1946e sostenendo 19 esami. Nell'anno accademico
Senato della Repubblica — 222 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTI1953-1954 cambiò facoltà ed ottenne l'iscrizioneal secondo anno di giurisprudenza senza,però, conseguire la laurea.Il padre di Ciancimino, Giovanni, ultimodi sette figli, nato a Corleone il 1° agosto1894 e deceduto a Palermo il 12 luglio 1968,emigrò a New York nel settembre del 1910.Ritornato a Corleone, aprì un negozio di barbieredove — come ricordano diversi corleonesi— il giovane Vito si recava ad aiutarlo.<strong>La</strong> madre, Pietra Mantovana, è nata a Corleonenel 1905, è pensionata e risiede a-Palermoin via Rudinì 42. L'unica sorella di Ciancimino,Maria Concetta, è nata anch'essa a Corleonenel 1928 e non svolge nessuna attivitàlavorativa. È coniugata con il dottor FilippoRubino, insegnante di scienze dell'alimentazionepresso l'Università di Palermo, elettonel 1963 presidente dell'ordine <strong>dei</strong> medici delcapoluogo siciliano. Il Rubino è stato ancheesponente e consigliere provinciale della Democraziacristiana e nel 1967 venne elettoassessore ai lavori pubblici della Provinciadi Palermo. I coniugi Rubino abitano a Palermoin un appartamento di loro proprietàin via Scaduto, 10.Tra gli altri congiunti di Ciancimino meritanodi essere menzionati:a) la zia paterna, Marianna Ciancimino,nata a Corleone nel 1881 ed ivi deceduta,coniugata con Vincenzo Zanchi, coltivatorediretto, residente a Corleone e membro delConsiglio di amministrazione dell'ospedalecivile di quel paese.Una figlia degli Zanchi, cugina pertanto diVito Ciancimino, sposò Ciro Maiuri, fratellodi Giovanna ed Antonino Maiuri già legati aMichele Navarra. A seguito delle lotte trale cosche di Navarra e di Leggio in data 6settembre 1958, rimase ucciso un figlio diCiro Maiuri, di venti anni, e il delitto venneimputato ai leggiani che lo avrebbero compiutoper vendetta.Un'altra figlia degli Zanchi andò sposa adAntonino Lisotta, nato a Corleone nel 1892ed ivi residente, e che ha un figlio, Giuseppe,nato nel 1935 a Corleone e dal 1962 residentea Palermo;fc) lo zio materno, Carmelo Martorana,nato a Corleone nel 1912, celibe, titolare dal1964 di un negozio per la vendita di armi emunizioni;e) un altro zio materno, Leoluca Martorana,è nato a Corleone nel 1926; da qualcheanno è di fatto emigrato per Vercelli;d) lo zio materno acquisito, Paolo Jannazzo,nato a Corleone nel 1913, è stato collocatorecomunale e consigliere della Pia unionebraccianti dal 1961 al 1963.Tutta la famiglia di origine di Cianciminoha sempre vissuto in modeste condizioni economiche.Entrambi i genitori erano nullatenenti.Durante la sua permanenza a Corleone,Vito Ciancimino ebbe la possibilità difrequentare parenti ed amici, che avrebberitrovato in seguito a Palermo e. con i qualiavrebbe avuto rapporti di vario genere.Uno di essi è Giuseppe Lisotta di Antonino,già ricordato, cugino di secondo grado diCiancimino, essendo sua nonna sorella delpadre di Vito. È laureato in medicina e nellaconsultazione elettorale del 1964 fu elettoconsigliere al Comune di Corleone nella listadella Democrazia cristiana. Già sanitariopresso la clinica medica dell'Università diPalermo, è stato assistente presso l'Assessoratoprovinciale alla sanità. Tale incarico,che si fa datare dal 1963-1964, sembra sia dovutoall'interessamento del Ciancimino.Un altro degli amici di Corleone è SalvatoreCastro fu Antonino e di Giovanna DiGregorio, nato a Corleone il 10 dicembre1929, residente a Palermo in via Principe diPaterno, 102, coniugato, impiegato d'ordinedella Cassa di Risparmio V.E. di Palermo.Proviene dall'Azione cattolica di Corleone eda sempre ha militato in quella sezione DC.Nel 1956 entrò, quale vice presidente, nel direttivodella Pia unione braccianti agricoli diCorleone, conservando poi l'incarico sino al1961. Sempre nel 1956 risultò tra i primi elettinella lista DC per il Comune di Corleonee nel 1960 divenne segretario di quella sezionedel Partito democristiano, mantenendo lacarica sino al 6 giugno 1970. Già assessoreprovinciale al personale (1964-1967) e all'assistenzapsichiatrica (1967-1969), il 7 giugno1970 fu eletto consigliere per la DC al Comunedi Palermo.
Senato della Repubblica — 223 <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIIn Corleone ha retto, a fasi alterne, le filadell'amministrazione comunale, anche valendosidel prestigio che gli veniva dall'esserecognato di Matteo Vintaloro, fratello delnoto mafioso Angelo Vintaloro, già luogotenentedel capo mafia Michele Navarra.Ma la permanenza di Ciancimino a Corleonenon fu molto lunga. Negli anni dell'immediatodopoguerra, egli e i genitori si allontanaronodal paese di ergine e si trasferironoa Palermo. Tuttavia Ciancimino trasferìla propria residenza anagrafica nel capoluogosiciliano solo il 2 novembre 1953; anzil'anno dopo, per ragioni non accertate,tornò ad iscriversi nell'anagrafe di Corleone,per registrarsi definitivamente a Palermosoltanto il 22 novembre 1963.È certo, comunque, che di fatto Cianciminoabitava da vari anni a Palermo, in corso<strong>dei</strong> Mille, 276, quando, il 21 marzo 1955, contrassematrimonio in Pompei con EpifaniaScardino, insegnante elementare, figlia di AttilioScardino, maresciallo dell'esercito inpensione.<strong>La</strong> famiglia originaria della Scardino eracomposta dal padre, Attilio, nato a Messinanel 1901, dalla madre, Adele <strong>La</strong> Mantia, nataa Palermo pure nel 1901, casalinga, e dalfratello Salvatore, nato a Palermo nel 1936,praticante procuratore legale.Lo Scardino era nullatenente, mentre Adele<strong>La</strong> Mantia possedeva, per eredità, due appczzamentidi terreno ed un villino nel suburbiodella città.Subito dopo il matrimonio, i coniugi Ciancimino(che hanno avuto cinque figli) andaronoad abitare in una casa di via CarmeloTrasselli, 32, e alcuni anni dopo si trasferironoin un appartamento di via Sciuti, 85-R.In questo stesso stabile abitano anche i suoceridi Ciancimino.Per quanto riguarda l'attività professionaledi Vito Ciancimino, non si hanno molte notizieper i primi anni della sua permanenzaa Palermo. Si sa solo che in quegli anni fusocio dell'impresa edile di Rosario Maniglia.Ma Ciancimino trovò la sua sistemazioneeconomica soltanto quando riuscì ad entrarein rapporti con le ferrovie dello Stato, grazieai buoni uffici dell'onorevole Bernardo Mattarella,allora Sottosegretario di Stato alMinistero <strong>dei</strong> trasporti. In proposito, i fattisi svolsero nel modo che segue.B) L'attività professionale. — In data 24aprile 1950, Vito Ciancimino presentò allaSezione commerciale e del traffico delle Ferroviestatali di Palermo un'istanza volta adottenere la concessione del trasporto di carriferroviari a mezzo di carrelli stradali nellacittà di Palermo. <strong>La</strong> Sezione commerciale edel traffico assunse informazioni e la Questuradi Palermo, con nota del 12 giugno 1950,n. 37469-24, rispose che Vito Ciancimino erapersona di buona condotta morale, civile epolitica, senza precedenti o pendenze penali,che era laureato in ingegneria, che era sociodell'impresa di Rosario Maniglia e che lesue condizioni economiche e finanziarie erano« ottime ».Pertanto, con nota del 20 giugno 1950, laSezione commerciale e del traffico di Palermocomunicò al Ministero <strong>dei</strong> trasporti (Serviziocommerciale e ''del traffico) che VitoCiancimino aveva presentato istanza per laconcessione del trasporto di carri ferroviari,che dalle informazioni assunte era risultatotrattarsi di una « ditta seria e di ottime condizionifinanziarie » e che non vi erano difficoltàdi affidare il servizio di trasporti aprivati.Successivamente, sul foglio disposizionin. 118 del 31 luglio 1950 del Compartimentodelle Ferrovie dello Stato di Palermo, fu pubblicatoun bando per « l'appalto a licitazioneprivata del servizio di trasporto a domicilio<strong>dei</strong> carri ferroviari a mezzo carrelli stradalinella stazione di Trapani e nelle stazionidi Palermo Centrale, Lolli-Marittimae S. Erasmo ». Nel bando si stabiliva,tra l'altro, che sarebbero stati ammessia partecipare alla gara « soltanto quegliaspiratiti che l'amministrazione delle Ferroviedello Stato — a suo giudizio esclusivoe insindacabile — avrebbe giudicato opportunoammettere, tenuto anche conto dell'attrezzaturaper la manutenzione e riparazionedelle trattrici e <strong>dei</strong> carrelli di cui possonodisporre gli aspiranti, nonché delle capacitàfinanziarie e personali ad esercitare ilservizio ». Si stabiliva inoltre nel bando che
Senato della Repubblica — 224 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIl'Amministrazione delle Ferrovie si riservavala facoltà di « procedere in modo diverso all'assegnazionedella concessione, senza chegli aspiranti potessero accampare diritti disorta o pretendere rimborsi di spese di qualsiasigenere ».In data 29 agosto 1950, Vito Cianciminopresentò alla Sezione commerciale e del trafficodi Palermo un'istanza con cui chiedevadi essere ammesso alla gara per la concessionedel servizio negli scali ferroviari di Palermo.Con successiva domanda del 12 settembre1950, Ciancimino chiede alla Amministrazionedelle Ferrovie il noleggio di tre carrelli,per il caso che gli venisse accordata la concessione.Intanto, la Questura di Palermo,con nota del 4 settembre 1950, aveva comunicatoalla Sezione commerciale e del trafficodi Palermo che Ciancimino era « in condizionifinanziarie tali da garantire l'acquisto didue trattrici e tre carrelli stradali, per il valoredi lire 16 milioni » e che quindi era idoneo« ad assumere la gestione del servizio ».Al termine delle operazioni di verifica <strong>dei</strong>requisiti finanziari e tecnici delle ditte aspiranti,la Sezione commerciale e del trafficodi Palermo, con nota del 14 settembre 1950,comunicò al Ministero <strong>dei</strong> trasporti che avevanochiesto di partecipare alla gara di licitazionele ditte di Vito Ciancimino, AntonioTrio,. Enrico Silvestri e Giuseppe Monti. Mentrela pratica era in corso di svolgimento, VitoCiancimino fece pervenire alla Direzionegenerale delle Ferrovie — a mezzo del Sottosegretariodell'epoca, onorevole BernandoMattarella — un esposto col quale rivendicavail diritto ad ottenere la concessione, peressere stato il primo a presentare la relativadomanda e per avere nel frattempo procedutoall'acquisto di due trattrici, sostenendocosì una spesa non indifferente.Il Ministero, con nota del 31 ottobre 1950,inviò l'esposto alla Sezione commerciale edel traffico di Palermo, invitandola a considerarese la ditta Ciancimino possedesse « effettivamente<strong>dei</strong> requisiti tali (migliore attrezzatura,capacità tecnica e finanziaria,possibilità di maggior sviluppo del servizio,eccetera) » da renderla preferibile rispettoagli altri aspiranti alla concessione.« In tal caso — concludeva la lettera ministeriale— potrebbe essere esaminata la possibilitàdi affidare il servizio, a trattativaprivata, alla predetta ditta Ciancimino ».<strong>La</strong> Sezione commerciale e del traffico diPalermo rispose al Ministero con lettera del7 novembre 1950, facendo presente che leinformazioni di polizia erano state favorevoliper tutte e quattro le ditte che avevanochiesto di partecipare alla gara, ma aggiungendoche la ditta Ciancimino aveva « unaconsistenza finanziaria maggiore delle altreditte » e che perciò tale elemento poteva costituire« ragione di preferenza ».Successivamente, in data 29 novembre1950, l'ingegnere Giuseppe Criscione dellaSezione trazione, in concorso col signor PaoloPalmigiano della Sezione commerciale edel traffico, eseguì una visita nell'officina« Lo Porto », al fine di accertare la consistenzadelle attrezzature meccaniche della dittaCiancimino. Il risultato della visita fu cosìattestato nel relativo verbale:« 1) L'officina è idonea alla manutenzionedi autoveicoli, in particolare di trattrici,essendo dotata della normale attrezzaturautensile;2) il gerente l'officina è elemento capacea dirigere i lavori di manutenzione ed eventualmentepiccole riparazioni;3) si è notata la presenza di un trattore" Pavesi " a benzina con motore della potenzadi HP.60, che potrebbe essere adibito alservizio <strong>dei</strong> carrelli stradali se munito digancio di trazione, di verricello e di ruotecon semipneumatici. L'esistenza di un trattoresimilare in contrada Baucina (prov. Palermo)è stata, altresì, fatta presente dalCiancimino e dal Lo Porto;4) fatta notare al Ciancimino l'inesistenzadi carrelli stradali e l'insufficienza numerica<strong>dei</strong> due « Pavesi », il Ciancimino ha fattoconoscere di essere già in trattative con laSocietà Panini — impresa trasporti con se<strong>dei</strong>n Verona — per l'acquisto di n. 2 trattrici adoppio differenziale per trazione su quattroruote, portanti motori Diesel tipo <strong>La</strong>ncia3.RO (a nafta), con consegna a trenta giornidalla commissione.
Senato della Repubblica — 225 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VIDISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTITali trattori soddisferebbero, a giudizio delsottoscritto, alle condizioni necessarie perl'espletamento del servizio <strong>dei</strong> carrelli stradali.In quanto ai carrelli stradali il Cianciminosi è dichiarato pronto a fornirsene di due, edentro sei mesi, ordinandoli alla ditta " Moncenisio" o facendoli costruire presso qualcheditta locale ».In data 7 dicembre 1950, la Sezione commercialee del traffico di Palermo trasmiseal Ministero copia del suddetto verbale, restandoin attesa di disposizioni. Con nota del24 dicembre 1950, n. 123/806.19 il Ministero(Servizio commerciale e traffico) rispose nelmodo che segue:« Visti gli atti e le informazioni fornitecon le note suddistinte, si ritiene che dallagara di appalto per il servizio <strong>dei</strong> carrelli aPalermo, debbano essere escluse le ditte:Trio — in quanto la domanda avanzata,in proprio nome, dalla filiale di Palermo nonpuò impiegare la Casa-madre di Roma, laquale non ha svolto nessuna pratica per ottenereil servizio. <strong>La</strong> ditta stessa, per il modocon cui svolge il lavoro di delegazione INTnon offre garanzie di ben condurre il servizio<strong>dei</strong> carrelli stradali;Silvestri — trattandosi di una società aresponsabilità limitata, senza alcuna attrezzaturadi mezzi;Monti — in quanto non è chiaro se l'impegnodovrebbe essere assunto dal solo Montio dalla Società Monti e Compagni. Si ritieneinoltre che la ditta Monti, distratta daaltre occupazioni non aventi alcuna attinenzacol traffico ferroviario, non sia la piùindicata ad assumere il servizio ».« Per i motivi suddetti si può ritenere chela sola ditta Vito Ciancimino abbia tutti inecessari requisiti ed offra le dovute garanzieper un buon incremento del delicato lavorodi acquisizione del traffico strettamenteconnesso al servizio <strong>dei</strong> carrelli stradali.Valendosi quindi delle facoltà di giudizioesclusivo ed insindancabile richiamate nelbando di gara, si prega invitare la sola dittaCiancimino a presentare una offerta definitivaper il lavoro in oggetto.ISi restituiscono i documenti trasmessi conle note " a riferimento "».A seguito della suddetta nota, con un'istanzadel 15 febbraio 1951, Vito Ciancimino, in-| vitato alla trattativa privala, concretò la propriaofferta in un ribasso del 2, 50 per centosulle tariffe di trasporto stradale. <strong>La</strong> Sezionecommerciale e del traffico di Palermo comunicòl'offerta a Roma, facendo altresì presenteche Ciancimino aveva chiesto di noleggiareprovvisoriamente, a determinatecondizioni, tre carrelli stradali. Con nota delmarzo 1951, il Ministero comunicò il propriobenestare per l'affidamento alla ditta Cianciminodel servizio di trasporto e per il noleggiodi tre carrelli, alle condizioni propostedall'offerente.In data 31 agosto 1951, quindi, Vito Cianciminostipulò con l'Amministrazione delleFerrovie una convenzione con la quale venivaautorizzato ad effettuare i trasporti di carriferroviari, per conto terzi, per un periodo dianni cinque, a partire dal 21 aprile 1951, econ la clausola che in mancanza di disdettala concessione sarebbe stata rinnovata tacitamente,per un'eguale durata. Contemporaneamentele Ferrovie noleggiarono a Cianciminodue trattori e cinque carrelli stradalia sedici ruote. Il contratto venne quindi modificatocon due appendici del 31 agosto 1951e del 14 aprile 1954, con le quali Cianciminofu autorizzato ad effettuare il trasporto dicarri ferroviari, anche per conto dell'Amministrazionedelle Ferrovie, in base ai normaliprezzi di tariffa, ridotti prima del 20per cento e poi del 17 per cento. In data 11ottobre 1954, l'iniziale convenzione venne sostituitacon un nuovo contratto, valido dal1° settembre 1954 al 20 aprile 1956 e tacitamenteprorogabile di anno in anno fino al20 aprile 1961.Col nuovo contratto la ditta Cianciminovenne autorizzata ad effettuare il trasportodi carri ferroviari, per conto terzi, a condizionianaloghe a quelle previste in precedenza.Si stabilì, invece, che i trasporti per contodell'Amministrazione ferroviaria, nella cittàdi Palermo, sarebbero stati « di volta in voltaregolarizzati con atti separati ».15.
Senato della Repubblica — 226 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIDopo l'aprile 1956, il contratto fu tacitamenteprorogato di anno in anno, fino al22 dicembre 1960, quando venne stipulatoun altro contratto valido per cinque anni etacitamente prorogabile fino al 20 aprile1970. Col nuovo contratto il concessionariosi impegnò ad effettuare i trasporti ai prezzie alle condizioni fissate dalle Ferrovie, senzaalcun ribasso sulle voci di tariffa. Dopo lascadenza del termine fissato nel contratto, laconcessione fu tacitamente rinnovata fino al1970.Nel 1-970, con nota del 18 febbraio, la Sezionecommerciale e del traffico di Palermocomunicò al Ministero che l'Antimafia si interessavadella questione relativa a VitoCiancimino e che la Questura di Palermo, richiestadi dare le informazioni di rito sulconto del concessionario, aveva fatto intenderedi non poter fornire nessun elementodato che erano in corso le indagini dellaCommissione di inchiesta parlamentare. Pertanto,l'ufficio sezionale di Palermo proponevadi confermare la concessione per un soloanno, tacitamente prorogabile per un altroanno. Il Ministero, con nota del 9 marzo1970, autorizzò il rinnovo del contratto,ma intanto il Commissariato compartimentaledi Pubblica sicurezza, con rapporto del 3marzo 1970, aveva comunicato che Vito Cianciminoera imputato di interesse privato inatti di ufficio, che era anche sospettato dicollusioni con elementi mafiosi, e che si eraarricchito con molta rapidità, traendo presumibilmentevantaggio dai suoi rapporti conla mafia. Di conseguenza, con lettera del 25marzo 1970, il Ministero comunicò alla Sezionedi Palermo che non era il caso di rinnovarela concessione alla ditta Ciancimino eche occorreva ricercare un nuovo concessionarioidoneo. <strong>La</strong> Sezione commerciale e deltraffico di Palermo si adeguò alle disposizioniministeriali, ma poiché non fu possibiletrovare subito un'altra ditta, la concessionea favore di Ciancimino venne prorogata perdue volte, tre mesi alla volta, fino al 21 ottobre1970.Prima di questa scadenza, in data 29 settembre,la ditta Carmelo <strong>La</strong> Barba presentòistanza per la concessione del servizio; gli organicompetenti si accingevano ad aggiudicarela concessione all'aspirante, quandol'Antimafia comunicò al Ministero che il <strong>La</strong>Barba, pur non essendo mai nominato negliatti di concessione, era socio di fatto di VitoCiancimino e che di conseguenza affidargliil servizio significava lasciare sostanzialmenteimmutata la situazione.Pertanto, l'Amministrazione ferroviariastipulò con Carmelo <strong>La</strong> Barba un contrattodi concessione limitato al periodo dal 21 ottobreal 31 dicembre 1970. Il contratto, tuttavia,fu provvisoriamente prorogato, finquando il servizio fu attribuito alla ditta CiroButitta, con convenzione del 1° giugno1971.Risulta già da quanto si è detto che negliatti relativi alla concessione del servizio ditrasporto <strong>dei</strong> carri ferroviari per la città diPalermo, non figura mai il nome di Carmelo<strong>La</strong> Barba. È certo tuttavia, per sua stessaammissione, che <strong>La</strong> Barba lavorò in societàdi fatto con Ciancimino fin dall'aprile 1951,e cioè fin dall'inizio della gestione del serviziodi trasporto <strong>dei</strong> carri ferroviari. Tuttaviala società tra Ciancimino e <strong>La</strong> Barba fuiscritta presso la <strong>Camera</strong> di commercio diPalermo al n/4922n/3346n del registro delleditte, con la ragione sociale « Autotrasportidi merci per conto terzi » soltanto in data29 gennaio 1965, a seguito di una denunziadi esistenza presentata il 27 ottobre 1964. Inprecedenza, alla <strong>Camera</strong> di commercio figuravanoiscritte solamente le ditte individualiVito Ciancimino e Carmelo <strong>La</strong> Barba, la primadal 3 aprile 1951 (pochi giorni prima dellastipula della convenzione con le Ferrovie)e la seconda dal 25 febbraio 1964.Si è peraltro accertato che Carmelo <strong>La</strong>Barba, proprietario di un appartamento inPaterno, di una casa di abitazione e di alcuniappezzamenti di terreno in Corleone, èfratello del mafioso Giovanni <strong>La</strong> Barba, condannatoalla misura della sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno per la duratadi tre anni.Risulta inoltre da quanto si è detto cheinizialmente Ciancimino non possedeva nessunaattrezzatura e non doveva nemmenoavere grandi disponibilità economiche, se
Senato della Repubblica 227 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIfu costretto a prendere in noleggio dall'Amministrazioneferroviaria due trattori e cinquecarrelli. Alla fine del rapporto però lasocietà era proprietaria di sei trattrici e didodici carrelli, sette <strong>dei</strong> quali furono acquistatitra il 1953 ed il 1957 dall'Amministrazioneferroviaria con pagamento dilazionato,in media, in trentasei rate. Per acquistarequeste macchine, Ciancimino si servì di dueprestiti concessigli dal Banco di Sicilia, il primoper 7.200.000 lire il 28 gennaio 1953 e ilsecondo per otto milioni di lire il 7 luglio1959. Si è peraltro accertato che in base allefatture emesse nel periodo dal 1961 al1970, la società incassò complessivamente lire306.125.415. <strong>La</strong> ditta, inoltre, nel periodosuddetto, eseguì anche <strong>dei</strong> trasporti, per iquali non rilasciò fatture. Sulla scorta <strong>dei</strong>dati forniti dall'Amministrazione ferroviaria,si è calcolato in via presuntiva che per questitrasporti la società avrebbe riscosso altre209.376.426 lire. In altri termini, gli incassieffettuati dalla società negli anni dal1961 al 1970 sarebbero stati in tutto di515.501.841 lire, di cui 53.567.682 lire nel 1968,51.304.205 lire nel 1969 e 51.413.751 lire nel1970.Di conseguenza, tenuto conto <strong>dei</strong> costi e<strong>dei</strong> ricavi, negli ultimi tre anni la società,a giudizio della Guardia di finanza, avrebbeconseguito utili di 18.801.307 lire nel 1968,di 19.243.524 lire nel 1969 e di 13.840.718lire nel 1970. Gli organi di polizia tributariacomunicarono agli uffici finanziari le cifresuddette, ai fini della determinazione dell'imponibiledella società e <strong>dei</strong> due soci, che erastato concordato per il 1967 (come poi sidirà) in misura molto inferiore.Si è anche accertato che la società nel periododal 1961 al 1970 omise di corrisponderel'IGE su una parte <strong>dei</strong> trasporti effettuatie non presentò nei termini la prescritta dichiarazionedegli incassi conseguiti; inoltredal ]° marzo 1966 al 31 dicembre 1970 corrisposeirregolarmente una parte del tributodovuto; infine, omise, in relazione ad atti divario genere, il pagamento dell'imposta dibollo.Si desume da tutto ciò che i guadagni diCiancimino furono fin dall'inizio abbastanzarilevanti. Assicuratasi così la tranquillità economica,Ciancimino potette dedicarsi conmaggiore impegno all'attività politica e raggiungereil successo anche in questo settore,nel corso degli anni '50.C) <strong>La</strong> carriera politica. Le origini, — VitoCiancimino si iscrisse fin da giovane nellefile della Democrazia cristiana e dopo un breveperiodo trascorso a Roma (ove pare abbialavorato nella segreteria dell'onorevole BernardoMattarella) si dedicò — appena stabilitosia Palermo — a un'intensa attività dipartito.Forte, quindi, di una reale o millantata vicinanzaalla sfera politica di un parlamentaremembro del Governo, Ciancimino ebbe unesordio politico abbastanza rapido. Anzi, ilsuo temperamento vivace ed intraprendentelo portò ben presto a fianco della correnteche in opposizione ai notabili nazionali e regionaliavrebbe portato uomini nuovi allaribalta della PC palermitana. Ciancimino dimostròcosì notevole abilità nella scelta degliuomini e un sicuro acume nello sfruttare situazionifavorevoli, perché, offrendo il proprioappoggio elettorale ai nuovi dirigenti,finì per divenire, egli stesso, una figurapolitica di un certo rilievo, tanto da ottenereuna prima personale affermazione politica,con la nomina a commissario comunale perla Democrazia cristiana di Palermo (caricache mantenne per sedici anni).Inoltre, per l'attività svolta, fu eletto consiglierecomunale e quando venne eletto sindacodi Palermo Salvatore Lima, Ciaciminogli subentrò nella carica di assessore ai lavoripubblici, che mantenne dal luglio 1959al giugno 1964.In conclusione, la prima parte della carrierapolitica di Vito Ciancimino può esserecosì riassunta:fu nominato commissario comunale dellaDemocrazia cristiana di Palermo nel 1954e mantenne questa carica fino al 1970;fu consigliere comunale per lo stessopartito dal 1956 in poi;fu assessore comunale all'Azienda municipalizzatadal giugno 1956 al luglio 1959;fu nominato assessore comunale ai lavoripubblici nel luglio 1959, in sostituzione
Senato della Repubblica — 228 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIdi Lima, eletto sindaco, e mantenne l'incaricofino al luglio 1964.Si può anche aggiungere che in questo periodoCiancimino, pur non avendo tenutocomizi riè in Palermo, né in provincia, riportò,nelle consultazioni amministrative 685voti di preferenza nel 1956, 11088 nel 1957,9305 nel 1964.Evidentemente, Ciancimino, se non si presentòpubblicamente all'elettorato come normalmenteusavano fare gli altri canditati,dovette avere la possibilità di condurre altrimentila propria campagna elettorale. È comunquecerto che egli partecipò a numeroseriunioni indette dalle sezioni rionali dellaDemocrazia cristiana, alcune delle quali gliassicurarono numerosi suffragi. Una dellesezioni più attive si dimostrò (in questo periodoe anche successivamente) quella diPalermo « Greto », della quale fu segretariasin dal 1958 la sorella di Ciancimino, MariaConcetta, sezione che di norma rimanevaaperta solamente durante le campagne elettorali,politiche ed amministrative, e che annoveravatra gli iscritti gli elettori più fedelia Vito Ciancimino e alla sua politica.Nel periodo preso in esame, e cioè dal1956 (anno della prima elezione del Ciancimino)al 1964, l'amministrazione comunale diPalermo fu formata dalla DC e da altripartiti. Più precisamente dal 27 maggio 1956al 6 novembre 1960, la Giunta fu costituitadalla DC, dal PLI, dal PSDI, dal PNM e dalPMP e fu presieduta dai sindaci LucianoMaugeri (deceduto il 23 maggio 1958), e SalvatoreLima.Dal 6 novembre 1960 al 30 aprile 1964, invece,parteciparono alla Giunta la DC, ilPSDI, il PDIUM, e indipendenti; furono sindaciLima e Francesco Saverio Di Liberto,pure democristiano. Nel 1964, fu eletto sindacoPaolo Bevilacqua e Ciancimino non entrònella Giunta.D) Vito Ciancimino e il Comune di Palermo.— Durante i cinque anni (1959-1964) incui Vito Ciancimino fu assessore ai lavoripubblici, la speculazione edilizia a Palermoraggiunse punte particolarmente elevate, comerisulta da quanto prima si è detto. Perrendersene conto, basta ricordare che delle4.000 licenze edilizie rilasciate nel suddettoperiodo, 1.600 figurano intestate a SalvatoreMilazzo, 700 a Michele Caggegi e 200 a LorenzoFerrante, e cioè (come già si è accennato)a tre pensionati, di modeste condizionieconomiche, che non avevano nulla a che farecon l'edilizia e che, evidentemente, eranoi prestanomi di costruttori edili.Gli organi comunali inoltre (come pure siè detto) presero anche <strong>dei</strong> provvedimenti afavore di iniziative urbanistiche (non semprelecite) di personaggi mafiosi o comunque legatialla mafia. Tali provvedimenti furonopresi per decisione o con la partecipazionedi Vito Ciancimino: così come risulta dallastoria di alcuni episodi (di cui si parleràqui di seguito) e così come si desume anchedalle deposizioni di alcune persone, che dichiararonoalla Commissione che Cianciminoera stato il principale responsabile delcaos edilizio palermitano e che egli svolseuna parte predominante in seno alla Commissioneedilizia.1) II primo degli accennati episodi riguardaNicolo Di Trapani, capo delle famiglie DiTrapani e Citarda, pregiudicato per associazionea delinquere, legato da stretti vincolidi amicizia con i mafiosi Vincenzo Di Mariae Gerardo Namio, esponente di prestigiodella borgata Malaspina, sottoposto alla sorveglianzadi pubblica sicurezza.Il 2 febbraio 1960, Nicolo Di Trapani presentòal Comune una richiesta di variante alpiano regolatore, relativamente a un terrenodi proprietà della sua famiglia, sito nellaborgata Malaspina tra le vie Ciléa, Tramontanae Malaspina. Con delibera dell'I 1 luglio1960, n. 270 alla quale partecipò Ciancimino,il Consiglio comunale approvò in parte la richiestavariante, consentendo, tra l'altro, chela zona di proprietà <strong>dei</strong> Di Trapani fossequasi per intero destinata ad edilizia privata,anziché a verde pubblico, così come era stabilitonel piano regolatore. In questo modo,i Di Trapani potettero vendere alla societàimmobiliare « <strong>La</strong> Favorita » un'area edificabilcal prezzo di 324 milioni di lire. I progettidi costruzione <strong>dei</strong> fabbricati furono pre-
Senato della Repubblica — 229 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputaliLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIsentati al Comune il 7 marzo 1962 e approvatidalla Commissione edilizia il 25 maggio1962, in periodo di vacanza delle norme disalvaguardia. I titolari dell'impresa che costruìi fabbricati erano Giuseppe e BernardoCampione, legati ai Di Trapani.Per quanto riguarda i suoi rapporti colDi Trapani, Vito Ciancimino, nel corso di unprocedimento penale a suo carico, non hapotuto negare di conoscerlo e di averlo vistoqualche volta nel proprio ufficio. È risultatoinoltre che l'automobile 1100/E targataPA 24029, intestata al socio di Ciancimino,Carmelo <strong>La</strong> Barba, e in uso alla società, futrasferita a Di Trapani nel 1955.2) L'impresa di costruzioni « GirolamoMoncada », di cui era titolare il noto mafiosoGirolamo Moncada, implicato nei fatti divia <strong>La</strong>zio, costruì (tra gli altri) nel periodoconsiderato un edificio a via <strong>La</strong>zio e due edificia via Cilea. Per il primo di questi fabbricati,che sorge su un'area della lottizzazioneLipari-Taormina, il progetto venne presentatoil 1.2 giugno 1961 e approvato con qualchemodifica il 20 giugno 1961, e cioè solootto giorni dopo. L'edificio per di più vennecostruito in difformità della licenza. Per idue fabbricati di via Cilea, che sorgono suun'area della lottizzazione di via Sperlinga,il progetto presentato il 5 ottobre 1959 erain contrasto con il piano di lottizzazione, mal'irregolarità fu sanata con la delibera giàcitata dell'I 1 luglio 1960, n. 270. A seguitodi che, Moncada potette presentare, in data1° luglio 1961, una richiesta di variante perla costruzione di altri vani, ottenendo la relativalicenza solo tre giorni dopo, il 4 luglio1961.3) L'impresa edile « Matranga Domenico »,costituita il 17 febbraio 1963 con la partecipazionedi Domenico, Salvatore e Pietro Matranga,nel settembre 1963, ottenne dalla societàimmobiliare SACI l'appalto della costruzionedi un fabbricato in piazza Politeama.Il progetto di costruzione del suddettofabbricato fu inizialmente presentato il 15giugno 1957 da Italo Bazan, ma fu accantonatoperché in contrasto con il vigente pianoregolatore. Successivamente, in data 4 ottobre1960, lo stesso progetto fu nuovamentepresentato al Comune e fu approvato il giornodopo, 5 ottobre 1960, dalla Commissione,di cui facevano parte Lima e Ciancimino.In seguito, nel 1961, fu costituita la SACI,rappresentata dall'ing. Bazan e quindi, nelsettembre 1963, i lavori di costruzione furonodati in appalto alla « Matranga ». In precedenzal'Assessore regionale <strong>dei</strong> lavori pubbliciaveva ordinato la sospensione della demolizionedegli immobili, che dovevano esseresostituiti dai nuovi fabbricati, ma l'interventorisultò inutile; tuttavia, con una decisionedel 4 marzo 1963, il Consiglio di giustiziaamministrativa riconobbe la palese violazionedel piano regolatore.L'appartamento che i Ciancimino andaronoad abitare nel 1955 a via Trasselli 32, eradi proprietà di Pietro Matranga. Costui e ilfratello Domenico non risultano sottopostia provvedimenti di polizia e non sono statimai imputati in procedimenti con implicazionimafiose.4) Sempre nel periodo che interessa, moltecostruzioni furono realizzate dalla societàSICIL-CASA (già ITAL-CASA), costituita l'ilfebbraio 1961, da Paolo Zanelli, BaldassarreMeola, Giuseppa Terranova, Pietro Genovese,Vittorio Matranga e Nicolo Cacace. Di questepersone, Pietro Genovese è l'unico ad esserestato diffidato, ai sensi della legge del 1956,perché soleva associarsi con pregiudicati emanosi. È stato anche coimputato con NicoloDi Trapani in un procedimento con implicazionimafiose, ma è stato prosciolto per nonaver commesso il fatto. È sposato con AntoninaMatranga, sorella di Pietro e SalvatoreMatranga. Anche Paolo Zanelli e Nicolo Cacacesono cognati <strong>dei</strong> Matranga, il secondoper averne sposato la sorella Vittoria. GiuseppaTerranova è la moglie di Pietro Matranga.A sua volta Baldassarre Meola è generodi Paolo Zanelli e fu lui che insieme conCacace e Genovese costituì la ITAL-CASA dacui poi ebbe origine la SICIL-CASA.Tra il 1960 ed il 1962, in epoca non esattamenteprecisata, la SICIL-CASA acquistò dall'Istitutoreligioso delle Sorelle di Carità delPrincipe di Palagonia, rappresentato da suor
Senato della Repubblica — 230 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIBeatrice Catti, una parte del fondo Palagonia.Altre zone dolio stesso fondo furono vendute,più o meno nello stesso periodo, a GiuseppaTerranova, moglie di Pietro Matranga,a Nunzia Crescimanno Aiello (moglie del capodivisione regionale all'assessorato Entilocali), a P'ierina <strong>La</strong> Rosa Martorana (mogliedell'assessore al traffico e membro dellaCommissione edilizia), all'impresa edile Aversae all'impresa Seidita.<strong>La</strong> zona venduta alla SiICIL-CASA confinavacon due aree, di proprietà l'una i<strong>dei</strong>la famigliaDi Trapani, l'altra della famiglia D'Arpa.Si è detto prima ohe i Di Trapani chieserouna variante al piano regolatore, per quantoriguardava la zona di loro proprietà; lo stessofecero i D'Arpa e l'Istituto religioso rappresentatoda suor Beatrice Catti. Tutte levarianti, compresa quella proposta dall'Istitutoreligioso, vennero approvate, con vantaggio-per tutta i richiedenti, e quindi ancheper la SICIL-CASA che, come si è detto, 'divenneproprietaria della zona appartenenteall'Istituto religioso. Successivamente, il 3,4 e 7 agosto 1961, la SICIL-CASA presentòquattro, istanze volte ad ottenere altrettantelicenze per la costruzione di fabbricati nellazona acquistata dall'Istituto religioso. 'Le licenzevennero rilasciate pochi giorni dopo,il 12 e 18 agosto 1961, dall'ufficio (tecnico municipale,i cui poteri deliberativi erano mmano dell'assessore Cianciamolo e del direttoretecnico dell'ufficio, ingegner Giuseppe Drago.Autorizzata da queste licenze, la SiICIL-CASA costruì quattro fabbricati a via Giordano116 e 152 e a via Cilea 43 e 45.Alle vicende ohe portarono ala costruzione<strong>dei</strong> suddetti fabbricati, risultano collegativari episodi di stampo mafioso a cui figuraassociato il nome <strong>dei</strong> Di Trapani. In particolareNicolo Di Trapani fu imputato (e poiassolto) del delitto di violenza privata peraver costretto i coloni che occupavano ilfondo comprato dalla SICIL-CASA a lasciarela terra. Quest'azione <strong>dei</strong> Di Trapani di appoggioalla SICIL-CASA fu ostacolata da unaltro mafioso, Agostino Caviglia, e dai suoiaccoliti. Lo scontro culminò in una sparatorianella quale trovò la morte Agostino Cavigliae rimase ferito il mafioso Vincenzo DiMaria, amico del Di Trapani. A seguito dellamorte del Caviglia, i fratelli Salvatore, Alfonsoe Giuseppe D'Arpa, anche essi mafiosi, intimamentelegati ai Di Trapani, subirono diversiattentati, in quanto sospettati dell'omicidio.Subito dopo furono uccisi Luigi e FrancescoGucciardi, cognati di Caviglia, e dellaloro uccisione 'furono sospettati anche i fratelliD'Arpa, senza che però venissero' raggiuntial riguardo da sufficienti indizi.5) Negli anni dal 1959 al 1965 l'impresa dicostruzione di Gaetano e Vincenzo Randazzocostruì vari uffici e tra .gli altri tre fabbricatisulle aree acquistate dai Di Trapani. Progettista<strong>dei</strong> lavori di costruzione di questi treedifici fu l'ingegner Franco Mastrorilli, amicodi Ciancimino, autore <strong>dei</strong> piani di lottizzazione« Guglielmo Inglese » e « Lipari-Taormina», nell'ambito <strong>dei</strong> quali furono costruititutti i fabbricati che si sono fin qui menzionati.Sempre nella stessa epoca, come già si èvisto, Francesco Vassallo costruì, in contrastocon il piano regolatore e valendosi delleautorizzazioni accordategli dal Comune, unfabbricato a via Sardegna, quattro fabbricatia via <strong>La</strong>zio e uno a corso Calataiìmi'.Infine, il 28 novembre 1959 il proprietariodi Villa Deliella, già vincolata per il suopanticolare interesse artistico, presentò al Comuneun'istanza di autorizzazione alla demolizione.Il permesso gli 'fu accordato lo stessogiorno, e la villa fu demolita .tra da sera del28 novembre e il giorno dopo.E) <strong>La</strong> vicenda della SICIL-CASA. Duranteil periodo in cui si svolsero le vicende oranarrate, Ciancimino entrò 'in rapporti di variogenere con alcune società, tutte interessateall'edilizia.Con atto di compravendita del 9 dicembre1961, acquistò dalla SICIL-CASA, per il prezzodi quattordici milioni di lire, due appartamentia via Scruti 85/R, composti uno .di unsalone, tre stanze ed accessori e l'altro diquattro stanze ed accessori. Il prezzo, pagatonon sembrò adeguato al valore degli immobili.D'altra parte a vendere gli appartamentiera stata quella stessa società SICIL-CASA,che nel 1963 avrebbe ottenuto alcune (licenzein contrasto col piano regolatore. <strong>La</strong> cosasuscitò qualche sospetto e il 15 agosto 1963
Senato della Repubblica — 231 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIl'avvocalo Lorenzo Pecoraro, nella sua qualitàdi amministratore della società edileAversa, presentò una denuncia al Procuratoredella Repubblica contro Ciancimino e controM direttore dell'ufficio urbanistico comunaleGiuseppe Drago.Secondo la denunzia, Cianeimino e Dragosi erano resi .responsabili di una iserie di illecitipenalmente rilevanti. In particolare Ciancimino:a) aveva fatto deliberare due variantial piano regolatore di Palermo, ali'ionicoscopo di favorire la società SICIL-CASA;b) aveva concesso più licenze alla suddettasocietà per la costruzione di alcuni fabbricatisull'area acquistata dall'Istituto religioso, disuor Beatrice Catti, mentre aveva accantonatouna richiesta di licenza presentata dallasocietà Aversa e relativa alla stessa zona; e)dopo vari mesi aveva alla fine concesso talelicenza, ma lo aveva fatto soltanto a seguitodi un intervento del mafioso Nicolo Di Trapani;d) per uno sciopero del personale, la licenzanon era stata ritirata a tempo ed eraquindi divenuta inutilizzabile, dato che ilPresidente della Regione siciliana non avevaapprovato le varianti al piano (regolatore,inerenti alla zona interessata. Questa (decisioneaveva danneggiato sia pure manginalmenteanche la SICIL-CASA e pertanto Cianciminoaveva subordinato il rilascio di unanuova licenza a favore della società Aversa alristoro <strong>dei</strong> danni che erano derivati alla SI-CIL-CASA dall'accennato provvedimento delPresidente della Regione; è) la richiesta erastata respinta e Ciancimino allora avevaemesso un'ordinanza di demolizione delleopere nel frattempo eseguite dalla societàAversa; successivamente, nonostante un interventodel Consiglio di giustizia amministirativa,Ciancimino si -era rifiutato idi provvederesull'istanza di rilascio della licenza.A seguito di sommarie indagini, il Giudiceistnittorc di Palermo, con provvedimento del31 ottobre 1963, dispose l'archiviazione degliatti.Successivamente, l'avvocato Pecoraro, conuna lettera del 4 giugno 1964, 'ritrattò tuttele sue accuse, attestando ila conrettezza delcomportamento tenuto da 'Ciancimino. Macionostante nel giugno 1965 l'istruzione furiaperta e si procedette col rito formiate controCiancimino e Drago. Al termine dell'istruzione,con sentenza del 21 maggio 1966, ilGiudice istnittorc prosciolse i due imputaticon formula ampia. Contro questa decisionepropose appello il Procuratore generale dellaRepubblica, e la Sezione istruttoria, con sentenzadel 4 aprile 1969, irinviò a giudizio VitoCiancimino per rispondere del delitto continuatodi interesse privato in atti di ufficio.•Nel corso dell'istruzione si accertò in modonon dubbio che la SICIL-CASA in data 3,4, e 7 agosto 1961 aveva chiesto quattro licenzeedilizie e le aveva ottenute alcuni giorni dopo,il 12 e il 13 agosto 1961; invece la societàAversa, proprietaria di un altro terreno dellastessa zona e che pure si trovava media medesimaposizione giuridica della SICIL-CASA,aveva chiesto una licenza, in data 28 novembre1961, ma non l'aveva ottenuta se non l'8giugno 1962, dopo che in un primo tempol'ingegnere Drago aveva dispoto il temporaneoaccantonamento della richiesta. Inoltre,sempre durante l'istruzione, l'avvocato Pecoraroaffermò di aver ritrattato le sue accuse| iniziali, perché era questa la condizione impostagliper un benevolo riesame della richiestadi licenza; licenza che effettivamentegli venne concessa il 26 maggio 1964.Le accennate circostanze tuttavia non sembraronosufficienti per una condanna di Ciiancimino.I giudici esclusero ogni intento difavoritismo, in quanto ritennero che Cianciminonon fosse a conoscenza della domandapresentata dalla società Aversa e perciò10 assolsero con una sentenza divenuta definitiva,perché confermata in appello e inCassazione.F) Le iniziative economiche di Vito Ciancimino.Nel 1963, la moglie di Vito Ciancimino,Epifania Silvia Scardino', divenne sociadalla società per azioni ISEP (Istituto sovvenzionie prestiti), che nel 1968 assunse ladenominazione di COFISI (Compagnia finanziariasiciliana).<strong>La</strong> ISEP venne costituita a Roma, comesocietà a responsabilità limitata, 41 24 gennaio1951, da David Boselli, Giovanni Bosel-11 e Salvatore Cappadonna. Nel 1953 entraronoa far parte della società Angelo Di Carloe Antonino Sorci e poi anche le loro mogli
Senato della Repubblica — 232 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTILuisa Castro e Susanna Di Bella. Nel dicembre1961, il capitale sociale venne portatoda 300.000 lire a un milione e la I SEP i£u .trasformatain società per azioni. Quindi fu elettoun nuovo consiglio di amministrazione,nelle persone di Gaetano Garofalo, VincenzoFerrino, Salvatore Satta, Susanoa Di Bella(moglie di Sorci) e Antonia Passalacqua. Ilnuovo consiglio, in data 14 luglio 1962, dopocirca un mese dall'approvazione da parte delPresidente della Regione del nuovo piano regolatoredella città di Palermo, deliberò diaumentare il capitale sociale da uno a 200 milioni.Fu in questa occasione che entrò a farparte della società per ama partecipazione di11.538.000 lire, la moglie di Ciancimino, EpifaniaScardino. Divennero inoltre soci AngelaRiaria Guceiardi, moglie di Vincenzo Penino,Gioacchino Nuccio, Mairianna Giallombardo,Salvatore Levantino e Eduardo De Filippis;invece Angelo Di Carlo e la moglie Luisa Castrocedettero iturtte le loro azioni alla mogliedi Sorci, Susanna Di Bella.Successivamente, nel 1965, Gaetano Garofalosi dimise da presidente del consiglio diamministrazione e fu sostituito dall'avvocatoFilippo Seminara. Il consiglio fu rinnovatoanche in altri suoi componenti, tanto che nel1966 ne divenne membro Filippo Moncada, figliodi Salvatore Moncada. Nel biennio seguente(1967-68) gli amiminis,traitori (tentaronoiuna politica di risanamento della societàe favorirono perciò la cessione di una partedelle azioni a favore di Salvatore Moncada,di Antonina Di Gregorio (moglie di FrancescoSorci), e degli eredi di Mariano Capizzi.Ma poiché le cose non cambiarono, ili data30 maggio 1968, l'assemblea <strong>dei</strong> soci ridusseil capitale (che era allora di lire 131.821.000)a lire 98.693.000, mutò in COFISI la denominazionedella società e elesse un nuovo consigliodi amministrazione nelle persone diFilippo Seminara, Andrea Romeo, MatildeRestivo, Antonio Collura, Marianna Giallonbardo,Salvatore Levantino, Filippo Moncada.Quindi, in data 7 giugno 1969, il capitalefu nuovamente aumentato a 150 milioni dilire. In seguito, oltre a Epifania Scandirlo,che vi partecipò con azioni per 5 milioni dilire, divennero soci della COFISI AntoninaDi Gregorio, Angela Maria Gucciardii, GiovannaVelia, Flavia Conti, Provvidenza Pasta,Tommaso Granozzi, Maria Pace, CarmelaCottone, Olimpia, Anna Maria, Filippo,Giuseppe Salvatore Moncada, Matilde, Mariae Andrea Restivo, e Andrea Romeo.Due persone, che hanno fatto parte dellasocietà, sono ben note al mondo mafioso: AngeloDi Carlo (morto il 12 novembre 1967),che è stato uno <strong>dei</strong> più autorevoli 'mafiosi diCorleone pregiudicato e diffidato dalla Polizia,e Antonino Sorci, che fa parte della mafiadi Palermo, è pregiudicato ed è stato diffidatodalla Polizia. D'altra parte, VincenzoPerrino è 'nipote di Angelo Da Carlo, ©d è inrelazione di affari con i noti mafiosi Giovannie Francesco Sorci e Antonino Collura; iMoncada sono tutti parenti di Girolamo Moncada,titolare dell'ufficio in cui avvenne lasparatoria di viale <strong>La</strong>zio; Antonina Di Gregorioè moglie di Francesco Sorci, appartenentea famiglia mafiosa; Antonino Collura ècontitolare di una società imprenditorialeche viene considerata di estrazione mafiosa.<strong>La</strong> moglie di Ciancimino si è dunque trovatanella stessa società insieme con personenon proprio raccomandabili. Solo i coniugiDi Carlo cessarono di far parte dell'ISEP, nellostesso momento in cui la Scardino ne divennesocia. Non risulta, peraltro, in che modoe per quali ragioni la Scardino sia divenutasocia dell'ISEP; né risulta che la Scardinoabbia preso parte attiva alla vita della società.Si è solo accertato che nell'assemblea del13 dicembre 1963 la Scardino dìu rappresentatadalla socia Angela Gucciardi, moglie diVincenzo Perrino: ciò si spiega col fatto chei coniugi Perrino sono amici <strong>dei</strong> Ciancimino.In ordine alle operazioni compiute dallasocietà è risultato quanto segue:a) in data precedente al 1961, l'ISBP ricevetteuna somma di denaro da FrancescoGarofalo, cittadino statunitense, noto esponentedel'la malavita 'internazionale, montonel 1969;b) la società inoltre durante gli anni dellasua vita concesse vari finanziamenti, versando:1) quindici milioni di lire a GiuseppeSpina; 2) dieci milioni di lire a tale EduardoDe Filippo, verosimilmente identificabile nel
Senato della Repubblica — 233 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIsocio Eduardo De Filippis; 3) trenta milionidi lire alla società cooperativa ;S. Quikino,fondata tra gli altri dai mafiosi Antonino Sorcie Angelo di Carlo, dalla moglie di Sorci,Susanna Di Bella e dal nipote di Di Cado, VicenzoFerrino; 4) venticinque milioni di lirealla S.r.l. ISAR (Immobiliare S. Rosalia), costituitaTU luglio 1965 da Antonio Sorci natonel 1904, Antonio Sorci nato nel 1924 e GiuseppeSpina, con lo scopo della « progettazione,esecuzione e manutenzione di lavoristradali, edili, marittimi e ferroviari ». Il finanziamentofu concesso alla ISAR il 6 novembre1963, quando la società era igià in liquidazionedal 2 gennaio 1963. In precedenza,nel 1960, era stato nominato amxninisrtjratoiredella società Vincenzo Ferrino.Amici e parenti di Ciancimino fecero parteanche di un'altra società, la SIR (Societàimmobiliare regionale).<strong>La</strong> 'società fu costituita in Palermo l'il ottobre1962, all'indomani dell'approvazionedel piano regolatore, con .finalità imprenditorialinel 'settore edilizio, da Giuseppe Lisotta,Salvatore Mazzara e Marcellb Dominoci.Giuseppe Lisotta è la persona idi cui si èparlato in precedenza ed è parente ,di 'sospettimafiosi.Salvatore Mazzara, nato a Palermo il 18maggio 1929, è impiegato presso l'Aziendamunicipalizzata dell'acquedotto «di Palermo.Tuttavia fin dal 1962 è stato .distaccato perlunghi periodi di tempo presso l'Assessoratoai lavori pubblici idi Palermo, ohe, come siè detto, fu tenuto fino al 1964 da iCianciminoe successivamente dal fratello del Mazzara,Francesco Paolo, eletto consigliere comunalenelle liste democristiane. Il Mazzara ha unasolida posizione patrimoniale.Marcelle Dominici, nato a Palermo
Senato delta Repubblica — 234 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIazione irevocatoria e di simulazione nei confrontidella SIR; nel 'relativo giudizio, paureche sarebbero stati esibiti dalla SIR i tronconidi alcuni assegni versati alla « Stassi eAlbeggiani » in corrispettivo <strong>dei</strong> 14 appartamenti.Nelle pagine precedenti si sono fatti i nomidi alcuni mafiosi (tra gli alitai .di Nicolo DiTrapani) con i quali Qancimino ha avutorapporti diretti e indiretti,. Alla lista va aggiuntoGiuseppe Marsala, capomafia 'di Vicari,sottoposto al soggiorno obbligato perquattro anni. Giuseppe Marsala è assegnatariodi un quartino dell'Istituto autonomocase popolari, ottenuto su segnalazione diCiancimino. D'altra parte il figlio di Marsala,Salvatore, è dipendente comunale, è stato autistadi Cianeimino ed è anche lui assegnatariodi un appartamento delle Case popolari.A sua volta, il genero di Marsala, iCarìo Farina,è impiegato all'Azienda municipalizzatadell'acquedotto e vi fu assunto per chiamatadiretta. Ciancimino, nel corso di un procedimento.penale, non negò 'di conoscereMarsala e non negò che costui si fosse occupatodelle sue elezioni.G) // patrimonio di Vita Ciancimino. Nel1970, i Ciamcimino erano proprietari <strong>dei</strong> seguentibeni:a) due appartamenti a via Scinti, 85/iR,di cui Ciancimino è usufruttuario e la moglieEpifania Scardino nuda proprietaria;b) un appartamento in nuda proprietà,intestato alla Scardino e sito a 'Palermo a viaAntonio di Rudinì. Usufruttuario è il padredi Ciancimino, Giovanni;e) azioni per cinque milioni di ilare intestatealla Scardino nella società COFISI;d) due automobili (una <strong>La</strong>ncia Fulvia euna Fiat 124);e) tre trattrici e sei canrelli .stradali, insocietà con Carmelo <strong>La</strong> Barba.Secondo la Guardia di finanza, Cianciminocon la sua attività imprenditoriale e coni proventi che gli derivavano dalla carica dipubblico amministratore, conseguì nel 1968 e1969 utili netti di circa otto milioni di lire, enel 1970 di circa sei milioni di ilare, più o menoipari a quelli ottenuti negli' anni precedenti.Ciononostante, Ciancimino per gli anni1968 Q 1969 figurava iscritto mei .ruoli dell'impostadi famiglia per un imponibile di1.360.000 lire e, nel 1967, fu dichiarato nontassabile ai fini dell'imposta complementare,avendo famiglia numerosa e un reddito nonsuperiore a 2.500.000 di lire. D'altra parte,nel 1967, Ciancimino e <strong>La</strong> Barba, ai fini dellaricchezza mobile relativa alla gestione delservizio di trasporto <strong>dei</strong> carri ferroviari,concordarono un reddito netto imponibiledi 3 milioni e 400.00 lire.H) Le ultime vicende. Dopo l'uscita dallaGiunta municipale, Ciancimino rimase consiglierecomunale. Nel 1966 fu nominato capogruppodella Democrazia cristiana nelConsiglio comunale di Palermo e tenne questoincarico fino al 1970. Nel frattempo, nel1969 era stato addetto all'ufficio Enti localidella sezione provinciale della Democraziacristiana.Nel 1970, fu rieletto consigliere comunalecon 11.193 preferenze. Anche questa volta,come già nel 1964, ottenne il maggior numerodi preferenze (4.000 su 9.305 nel 1964 e oltre5.000 su 11.193 nel 1970) nei sei mandamenti(su 22') 'corrispondenti ala zona (compresafra corso Calatafimi, i Torrazzi, viale dellaRegione siciliana, Cruillas, viale <strong>La</strong>zio) dominatadalle famiglie mafiose Di Trapani, Citardae D'Arpa.Dopo le elezioni, nell'ottobre 1970, fu elettosindaco di Palermo, ma nel dicembresuccessivo, la Giunta da lui presieduta fucostretta a dimettersi. Tuttavia, il nuovosindaco fu eletto solo il 6 aprile 1971 nellapersona di Giacomo Manchiello e Cianciminorimase in carica fino al 24 aprile, quandoavvenne lo scambio di consegne. In quest'ulltimoperiodo Ciancimino firmò, in data14 aprile 1971, due mandati di pagamentoper complessive lire 3.433.762.645 a favoredella ditta Cassina, per maggiori oneri relativialla manutenzione del sistema di fognaturedella città di Palermo. I due mandaticostituivano l'attuazione di una delibera,per più versi discutibile sia nella sostanzache nella forma, che era stata adottatadalla Giunta municipale il 30 dicembre 1970,quando l'amministrazione Ciancimino era
Senato della Repubblica — 235 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputaliLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIgià dimissionaria per motivi di necessità ecioè per evitare che il Comune non potesseutilizzare il finanziamento avuto per farfronte all'onere assunto nei confronti delladitta Cassina.Attualmente Ciancimino non fa nemmenoparte del consiglio comunale di Palermo. Asuo carico sono stati iniziati tre procedimentipenali. Nel primo procedimento a caricodi Ciancimino e di altre 22 persone (tracui Francesco Vassalllo) che riguarda unaserie di irregolarità commesse nel rilasciodi licenze edilìzie a favore del Vassallo, ilGiudice istruttore ha emesso mandato dicoirijparizioiie per interesse privato in attidi ufficio e altri- reati. L'istruttoria peraltroè tuttora in corso, come quella del secondoprocedimento, pendente a carico di Cianciminoe di altre 33 persone e riguardante irregolaritàedilizie verificatesi nella lottizzazionedel fondo « Inglese »; infine, il terzoprocedimento riguarda le irregolari assunzionialle dipendenze del Comune di congiuntidi membri della Commissione provincialedi controllo, ed attualmente è pendentepresso la II Sezione penale del Tribunale diPalermo.I fatti narrati non hanno bisogno di interpretazioni.Basta commentarli con le osservazioniche il Tribunale di Genova ha dedicatoa Ciancimino, nel definire, con sentenzadel 15 giugno 1974, il procedimento penaleper diffamazione intentato dall'ex sindacodi Palermo ai giornalisti siciliani Bru :no Caruso e Etrio Fidora.« L'articolo e la vignetta del Caruso, unitariamenteconsiderati, contengono infattinumerosi apprezzamenti ed accostamenti checostituiscono non sollo acerba critica delmodo nel quale la città di Palermo ebbe recentementea svilupparsi dal punto di vistaedilizio, ma anche amara constatazione degliingenti arricchimenti che il potere mafiososeppe trame, ricorrendo a sanguinarieviolenze e mettendo a profitto una serie dicompiacenze, di tolleranze e di illeciti amministrativi.« Posto che il Ciancimino ebbe a ricoprireininterrottamente o quasi, la carica di assessoreall'urbanistica e di capogruppo consiliaredel maggior partito nel periodo di tempodurante il quale ebbe luogo lale sviluppo,è chiaro che il Caruso praticameli le additail querelante alla pubblica disistima, integrandocosì tulli gli estremi del delillo alui contestalo.« A riguardo, è sufficiente riportare testualmentealcuni brani dell'articolo incriminato:"Ha prosperato solo l'edilizia abbattendotutto quello ohe c'era di gentile e piacevolenella città, comprese le ville di Basileed altri monumenti, per edificare una speciedi Caracas zeppa di lugubri casermoni, secondoun piano regolatore a base di clienteleche ha prodotto una disfunzione urbanaestesa non proprio, come si suoi dire, amacchia d'olio, ma a macchia di sangue, perchéil tributo <strong>dei</strong> sacrifici umani a questoaltare del denaro e della speculazione è statoaltissimo".« E poi: "<strong>La</strong> speculazione edilizia gestitadalla mafia è stata l'unica cosa che è realmentecresciuta a dismisura secondo un pianorapido ed efficiente".« L'accusa al pubblico amministratoreCiancimino di aver colluso con il poteremafioso è quindi, pur se indiretta, di manifestaevidenza e nella vignetta trova ulterioreconferma mediante la collocazionedella figura di costui affiancata a quella delnoto — e molto discusso — costruttoreVassallo.« <strong>La</strong> sussistenza dell'antigiuridicità del fattoè però esclusa dall'esistenza di causedi giustificazione, prima tra le quali èquella rappresentata dall'esercizio di un dirittoo dall'adempimento di un dovere (articolo51 C.P.). Invero Ja legge 3 febbraio1973, n. 69, in adempimento del dettato costituzionale,all'articolo 2 attribuisce al giornalista— qual è il Caruso — il diritto insopprimibile,nel rispetto delle norme direttealla tutela della personalità altrui, allalibertà d'informazione e di critica, osservatala verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti.« Nella stpecie, la dignità del Cianoiminoè stata lesa negli stretti limiti necessari perla pura espressione della critica, mentre laverità sostanziale <strong>dei</strong> fatti è indiscutibile nelsenso: 1) che il Ciancimino è stato, per unamplissimo lasso di tempo, il dominus dellosviluppo edilizio palermitano, sia quale
Senato della Repubblica — 236 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIcapogruppo <strong>dei</strong> consiglieri comunali iscrittial partito della D.C., sia qualle assessore adl'urbanistica;2) che lo sviluppo edilizio diPalermo ha portato ingentissimi arricchimentidi persone molto discusse ed ha datoluogo ad una infinita serie di sanguinosiscontri tra cosche mafiose rivali; tra gli altriquello determinante la strage di eiaculili,avvenuta nel 1963, e la sparatoria di viale<strong>La</strong>zio, verificatasi nel dicembre 1969.« II .Collegio ritiene ohe in una situazionedel genere — e, cioè, quando una lunga seriedi enormi speculazioni edilizie, consentitae' favorita da innumerevoli irregolaritàamministrative, si sia svolta tra fiumi di sangueversati da partecipi di opposte coschemafiose e da appartenenti a forze dell'ordine,degne di ogni elogio e malauguratamentetrovatesi tra i due fuochi (vedasi l'omicidiodel tenente Malausa a Ciaculli) — siadovere civico e professionale di ogni giornalistaadditare alla pubblica opinione, qualemanifesto connivente del potere mafioso,il pubblico ammini'stratore che, nella cittàinteressata da tali fenomeni delinquenziali,abbia avuto, per il periodo in questione, lasostanziale veste di assoluto dominus in materiaurbanistica ed edilizia e sia quindi responsabileo corresponsabile delle irregolaritàe <strong>dei</strong> favoritismi persistentemente verificatisi;sicché, per essere del tutto chiari,si possa concludere che, mentre le diversecosche mafiose afflavano le armi, l'assessoreCiancimino predisponeva, a vantaggio di unao dell'altra parte, ma sempre in completooblio del pubblico interesse, varianti al pianoregolatore o licenze edilizie in deroga.« II Tribunale non ritiene certamente cheil Ciancimino sia stato l'unico responsabiledella caotica situazione urbanistica di Palermo,datila quale il potere manoso seppeabilmente trarre profitto; ritiene però ohenel suddetto caos, derivato da atti illegittimi,viziati da favoritismi e risultisi a favoredel potere mafioso, l'odierno querelantesia stato, non per semplice insipienza maper voluta adesione, uno <strong>dei</strong> maggiori artefici.« E del fatto ohe il Ciancimino sia personaadusa, non già per sprowedutezza, ma, adir poco, per inveterato abito mentale, atrarre personali profitti dall'attività politicasvolta, il Collegio ha avuto esauriente provaper bocca del Ciancimino stesso.« Questi, nel corso del proprio interrogatorio,ha dimostrato infatti di ritenere cosadel tutto lecita e normale quella di intavolareprivate trattative con la P.A. (nella speciecon l'azienda delle FF.SS.) senza neppurelontanamente disporre <strong>dei</strong> mezzi necessariper l'esecuzione dell'agognato appalto,quella di reclamare contro la decisione dellaP.A. di procedere invece ad una pubblicagara, e di fare poi presentare direttamenteagli organi periferici dell'Amministrazioneil reclamo — ovviamente accolto — da partedi un compagno di fede politica che sitrovava ad essere investito di funzioni alivello ministeriale (on. Mattarella) proprioal vertice dell'Amministrazione interessata.E tutto ciò il Ciancimino ha fatto ed ha serenamenteammesso.« II Collegio ritiene che la natura <strong>dei</strong> fattiavvenuti in Palermo in correlazione conlo «viluppo urbanistico, unita al comportamentoed alla mentalità del Ciancimino, autorizzanopienamente il Caruso a ritenere— ed a criticare — il querelante quale concorrentedel saccheggio edilizio avvenuto inPalermo, in violazione delle leggi ed a precipuovantaggio del potere mafioso ».In appello, la sentenza del Tribunale cheaveva assolto i due giornalisti per insussistenzadi reato, è stata riformata e i dueimputati sono stati assolti per insufficienzadi prove sul dolo, ma nemmeno questo documentogiudiziario libera completamenteCiancimino dalle accuse ohe gli sono staterivolte durante gli anni del suo potere.« II Ciancimino » si legge infatti nellasentenza della Corte di Appello di Genovadel 1° luglio 1975 « eletto consigliere comunaledi Palermo per il Partito democraticocristiano il 27 maggio 1956, fu dal 28giugno 1956 al 18 luglio 1959 assessore alleaziende municipalizzate e poi dal 19 luglio1959 al 12 luglio 1964 assessore ai lavoripubblici, venendo quindi eletto sindaco delcapoluogo siciliano. Orbene, lo stesso Ciancimino,che aveva dato luogo a varie critichedurante il lungo periodo in cui era statoamministratore del Comune di Palermo, edin particolare assessore ai lavori pubblici,
Senato della Repubblica — 237 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIè stalo oggetto di rilievi per irregolarità relativeprqprio al caotico sviluppo urbanisticodella città ed in specie all'irregolarerilascio di licenze edilizie destinate ad elementiindicati come mafiosi dai rapportidella Polizia, rilievi contenuti nella relazioneredatta dal dottor Bevivino ed in quelladelllla Commissione parlamentare d'inchiesta,che ha considerato la elezione del Cianciminoa sindaco come "significativo episodioche sarebbe stato anche possibile interpretarecome una sorta di sfida nei confrontidell'opinione pubblica e <strong>dei</strong> poteri dello Stato,e ciò per la esistenza di .specifici precedentiohe si sapeva già da tempo essereall'esame della stessa Commissione antimafia" (v. pag. 91 relazione Commissioneantimafia).« Inoltre il Ciancimino, che dal 1951 al 1970aveva ottenuto dailila Direzione delle Ferroviedello Stato la concessione del servizio<strong>dei</strong> carrelli stradali, come si evince dallarelazione della Direzione generale di dettoEnte fu segnalato dal Commissariato compartimentaledi P.S. di Palermo quale imputatodi vari reati ai danni del Comune epersona modto discussa, tanto da essere sospettatodi collusione con elementi mafiosied arricchitosi rapidamente in seguito aisuoi rapporti con la mafia, ragione per cuigli fu revocata ila concessione.« Vi è poi da aggiungere che lo stesso Cianciminofu effettivamente più volte denunciato,proprio nella sua qualità di pubblicoamministratore, alla Procura della Repubblicadi Palermo per interesse privato inatti di ufficio, fallso ideologico ed altri reatiin concorso con numerose person'e, tra cuiil noto e malto discusso costruttore Vassallo.« In tale situazione, pertanto, a parere dellaCorte, il Caruso ed il Fiderà nel pubblicarela più volte richiamata vignetta, in cui èeffigiato anche il Ciancimino affiancato alLeggio, al Vassallo ed al Buttafuoco, nonchél'articolo dal titolo "questa mia città", incui il Caruso attribuisce evidentemente alCiancimino "la speculazione edilizia gestitadalla mafia" che "è l'unica cosa che è realmentecresciuta a dismisura" e lo scempiodella città, riferendosi poi alla "classe dirigentemafiosa e corrotta" potevano all'epocapossibilmente ritenere, anche in pendenzadelle numerose procedure giudiziariea carico dell'ex sindaco, seppure ancora inistruttoria e tuttora pendenti, che il Cianciminomedesimo fosse effettivamente responsabiledelle irregolarità nel settore urbanisticoverificatesi in Palermo durantela sua gestione, e colludesse con il poteremafioso. Apparendo, quindi, e per le ragionianzidette, incerto l'elemento psicologicodel delitto di diffamazione, la Corte ritienedi assolvere il Caruso ed il Fidora da talereato in danno dal Cianchnino per insufficienzadi prove sul dolo ».Il caso Ciancimino è stato l'espressioneemblematica di un più vasto fenomeno cheinquinò negli anni sessanta la vita politicae amministrativa siciliana, per effetto delleinteressate confluenze e aggregazioni dellecosche maliose e <strong>dei</strong> tentativi di recupero,ai fini elettorali o per giochi interni di partito,delle vecchie forze del blocco agrarioo d'uomini politici logorati dalla consuetudinecol mondo mafioso; il successo di Cianciminoperciò non si spiega coirne un fattocasuale, indipendente dalle circostanze ambientalie dalle forze politiche che gli avevanoassicurato il loro sostegno, ma si comprendesolo se visto nel quadro d'una situazioneampiamente compromessa da pericolosecollusioni o da cedimenti non semprecomprensibili. Niente meglio di ciò che è accadutonegli anni di Ciancimino rivela inoltrecome la mafia sia 'stata favorita dall'incapacitàdi partiti politici di liberarsi intempo di uomini discussi nella speranza dimantenere o di accrescere la propria sferadi influenza o magari col solo effetto di rafforzareil peso elettorale delle varie correntiinterne.Un fenomeno analogo si è manifestato peraltro nella subordinazione a interessi o aalleanze contingenti della superiore necessitàdi denunciare, con coerenza e senza improvvisie inopinati ripensamenti, ogni sospettacollusione, con la conseguenza chespesso 'sono mutati, nel corso degli anni, igiudizi circa le persone accusate di connivenzemaliose; ciò che ha fatalmente affievolitola lotta contro la mafia.
Senato della Repubblica — 238 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTISEZIONE TERZA<strong>LA</strong> QUARTA ONDATA MAFIOSA1. <strong>La</strong> strage di viale <strong>La</strong>zio. Il rapimento diMauro De Mauro. L'omicidio di PietroScaglione.L'elezione di Vito Ciancimino a sindacodi Palermo fu interpretata in moliti ambienticome una sorta di sfida nei confronti dell'opinionepubblica e <strong>dei</strong> poteri dello Stato;ma nel volgere di pochi mesi Cianciminofu costretto a dimettersi, e così l'inizio deglianni sessanta vedeva il tramonto definitivodi un uomo che precedentemente avevadominato la scena del caos edilizio edurbanistico di Palermo.Più o meno nello stesso periodo esplodeva,con la strage di viale <strong>La</strong>zio, la quartaondata mafiosa.Dai tempi della carneficina di eiaculili, erala prima volta che un grave fatto di sangueriproponeva all'attenzione dell'opinione pubblical'estrema pericolosità della delinquenzamafiosa.Nei primi anni di vita della Commissione,dal 1963 ali 1968, le organizzazioni mafiosefurono scardinate e disperse per effetto diuna energica azione condotta sia dalla Poliziae sia dalla Magistratura, che preserospunto dalla cruenta lotta scatenatasi tradue opposte cosche mafiose, culminata appuntonella strage di Ciaoulli del 30 giugno1963. Fu un periodo emblematico, perchéfu proprio allora che cominciò a verificarsdun deciso mutamento dell'opinione pubblicaverso la mafia e in cui crollarono certimiti collegati al fenomeno mafioso, comequello dell'impunità. Fu il periodo in cui aPalazzo <strong>dei</strong> Normanni si discusse dell'opportunitàdi sciogliere il Consiglio comunaledi Palermo, proprio in relazione allevicende della speculazione edilizia ed allepesanti infiltrazioni mafiose in quella vicenda.Fu il periodo in cui la tranquillità e l'ordinepubblico sembrarono nuovamente ristabiliti,in cui i reati di tipo mafioso subirono.una contrazione mai prima registrata,in cui in paesi come Corleone la gente ripresel'abitudine, quasi dimenticata, di uscirela sera per le strade.Questa azione fu certo agevolata ed incoraggiatadal semplice fatto ohe esistevauna Commissione parlamentare d'inchiestache rappresentava il simbolo autorevole dellavolontà politica di perseguire e stroncareil fenomeno mafioso. Senonchè, anche inquesta occasione, come in tante altre, venneroa mancare quegli Interventi idonei asradicare il 'malcostume .mafioso, che sarebberostati necessari, mentre le deludenti etalora sorprendenti conclusioni di gravi processicontro i boss di potenti organizzazionimafiose annullarono praticamente gli sforzie 1 sacrifici degli anni precedenti, o diederoagli imputati rimessi in libertà un prestigioaccresciuto dall'ennesima vittoria controlo Stato.Il delitto di viale <strong>La</strong>zio trovava la suapremessa nella sentenza pronunciata il 28dicembre 1968 dalla Corte di Assise di Catamzaro.Quel giorno, i giudici calabresi avevanogiudicato i presunti maggiori responsabilidell'organizzazione criminale, arrestatio denunciati dopo i fatti di Ciaoulli; male loro conclusioni non avevano rispostoalle espettative; alcune condanne per associazioneper delinquere, poche condanne peromicidio e per sequestro di persona, unasfilza di assoluzioni per insufficienza diprove.Tra gli altri, era stato giudicato MicheleCavata] o.Da modesto autista di piazza, in pochianni Cavatajo era riuscito ad accumulareun considerevole patrimonio immobiliare,ed insieme, come agni mafioso che isi rispetti,una serie di assoluzioni. Denunciatouna prima volta per omicidio nel 1964, edassolto per insufficienza di prove, era statoancora assolto con formula dubitativa daun'imputazione di rapina aggravata, dal delittodi associazione per delinquere, dal tentatoomicidio di Salvatore Carello, dagliomicidi di Carmine Calatolo, Giuseppe DiGirolamo e Roberto Di Girolamo. I giudicidi Catanzaro invece lo avevano, condannatoper il solo delitto di associazione a delin-
Senato della Repubblica — 239 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIquere a quattro anni di reclusione, ritenendoohe egli avesse partecipato, come luogotenentedi Pietro <strong>Torre</strong>tta, alla lunga e sanguinosalotta della mafia dell'edilizia e dellearee fabbricabili. <strong>La</strong> Corte d'Assise, peraltro,gli aveva condonato due anni di pena e neaveva disposto la scarcerazione per decorrenza<strong>dei</strong> termini di custodia. Subito dopo,Cavataj o si era ufficialmente stabilito a Roma,ma soltanto a distanza di nove mesi gliorgani di polizia avevano proposto l'applicazionea suo carico di una misura di prevenzione,richiedendone anche la custodiaprecauzionale, « ridila certezza che, avutosentore del procedimento in corso, egli (potesse)rendersi irreperibile •». <strong>La</strong> propostaperò non era stata accolta dall'Autorità giudiziariapalermitana, sul presupposto appuntoche Cavatajo aveva altrove la sua residenzaufficiale.Il Cavatajo, pertanto, era tonnato a Palermoper riprendere il posto di colui cheera stato il suo capo; e così, i killers mandatiad ucciderlo ebbero modo di trovarlonegli uffici della ditta Moncada, a viale<strong>La</strong>zio, la sera del 10 dicembre 1969.Alile 19 circa di quella sera, un'automobileblu si fermò vicino agli uffici delladitta, nei quali si trovavano in quel momentoMichele Cavatajo, Salvatore Bevilacqua,Francesco luminello e i-due figli di GirolamoMoncada, Filippo e Angelo. Dalla macchinadiscesero 5 individui, vestiti uno indivisa di capitano di Pubblica sicurezza, glialtri in divisa di agenti di polizia. Entratinegli uffici, con i mitra in mano, i 5 killersaprirono il fuoco, uccidendo Cavatajo, Tuminelloe Bevilacqua e ferendo i due Moncada.Ma, prima di cadere, Cavatajo e glialtri fecero fuoco a loro volta, ferendo amorte uno degli aggressori. Ma i banditiriuscirono ugualmente a dileguarsi portandocon loro il compagno ferito e fuggendouccisero anche un ignaro guardiano <strong>dei</strong>Moncada, Giovanni Donè, accorso ad fragoi-edegli spari.Ili processo, cominciato dopo i fatti, a caricodi Gerlando Alberti e di altri mafiosi,è stato definito in primo grado con l'assoluzionedi tutti gli imputati; ma al di là dellaconclusione giudiziaria, la strage di viale<strong>La</strong>zio serve a ribadire con la sua classicaevidenza come almeno in quel periodo neigrandi centri urbani della Sicilia occidentaleil settore dell'edilizia e delle relativespeculazioni fosse certamente tra i più contaminatidalla attività manosa; e ciò soprattuttoperché la mafia poteva giovarsi,in questo settore, come condizione determinanteed operativa, dell'appoggio o del lassismocompiacente di alcuni rappresentanti<strong>dei</strong> pubblici poteri.Risultava d'altra parte confermato che,nonostante i periodi di quiescenza ancheprolungati della delinquenza maliosa, la pericolositàddlla mafia non conosce soste edè comunque tale da poter dar luogo a manifestazioniimprovvise e gravi di violenza, almenofino a quando non siano individuati espezzati i suoi legami con alcuni ambientipubblici che, soprattutto a livello di amministrazionelocale, non ponendo in attoi necessari controlli, finiscono con il consentiread esponenti mafiosi di continuarenella loro attività parassitarla in importanticampi della vita economica e sociale.•<strong>La</strong> strage di viale <strong>La</strong>zio mette inoltre benein evidenza i limiti e le carenze del sistemadelle misure di prevenzione: da unlato infatti la normativa in vigore deve considerarsilacunosa e mal congegnata, se nel1968 aveva consentito, in coincidenza conil processo di Catanzaro, 'la scadenza contemporaneadi numerosi provvedimenti presinegli anni precedenti, e se aveva impeditol'immediata applicazione di una misuraa carico di un pericoloso personaggio comeCavatajo; dall'altra, è significativa e insiemepreoccupante la scarsa sorveglianzache l'autorità di Polizia era riuscita ad attuare,al di fuori di ogni provvedimento formale,sugli esponenti particolarmente qualificatidel mondo mafioso. L'azione criminosa,che portò al delitto di viale <strong>La</strong>zio,covava da tempo e da lunga data erano notii contrasti tra le cosche che facevano capoai protagonisti della vicenda; eppure le forzedell'ordine non avevano preso nessunainiziativa che evitasse uno scontro armatoe una nuova esplosione delle antiche lottetra le opposte fazioni, ma sembrarono anzi
Senato della Repubblica — 240 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIcome colte di sorpresa dalla sanguinosa aggressionedel Gommando di viale <strong>La</strong>zio.D'alltra parte, come spesso è avvenuto nelpassato, le successive indagini giudiziarienon hanno portato, nemmeno questa volta,alla punizione <strong>dei</strong> responsabili; e pertanto,malgrado l'impegno e la tenacia dimostratinegli anni più recenti dalla Magistratura, èrimasta confermata l'impressione che i piùtemibili esponenti della mafia riescono adusufruire spesso di una vera e propria impunità,attraverso un diabolico meccanismoche sfugge al controllo della legge, del Parlamentoe di tutti gli organi e poteri delloStato.Un'impressione questa ohe ha trovato ulteriorealimento nelle vicende giudiziarieriguardanti gli episodi delittuosi, o alcunidegli episodi delittuosi, òhe hanno seguitola strage di viale <strong>La</strong>zio. Specialmente nel1970 e nel 1971, ma, come si vedrà, anchepiù recentemente, si sono susseguiti in Sicilia,soprattutto nelle città, una serie diclamorosi delitti, che hanno determinatovivo allarme nell'opinione pubblica e tra iquali spiccano, per il significato quasi emblematicoohe hanno, il rapimento del giornalistaMauro De Mauro e l'omicidio delProcuratore della Repubblica di Palermo,Pietro Scaglione.Alle 20,30 circa del 16 settembre 1970,Mauro De Mauro lasciava la sede del giornaleL'Ora e alla guida della sua macchinaraggiungeva il bar Spatola, locale ohe abitualmentefrequentava prima di recarsi acasa. Dopo aver consumato una bibita eacquistato caffè, vino e sigarette, arrivavaa viale delle Magnolie, dove abitava, e lasciaval'automobile parcheggiata vicino a'1marciapiede di fronte all'ingresso della propriaabitazione. In quello stesso momento,la figlia di De Mauro, Franca, e il suo fidanzato,Salvo Mirto, stavano tornando a casae avevano così modo di notare una personaclaudicante (probabilmente lo stesso DeMauro) sedersi al posto di guida della
Senato della Repubblica — 241 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIdi ricerca, controllo e battute in città e nellaprovincia.Le pronte indagini iniziate dai Carabinierie dalla Pubblica sicurezza venivano ben prestoorientate su piste e canali diversi; e anchese tutti pensavano che De Mauro dovevaessere stato vittima di un sequestro, lerispettive indagini si sviluppavano e proseguivanoautonomamente, tanto che ciascunaforza di Polizia inoltrava propri rapporti all'Autoritàgiudiziaria, la quale a sua voltane trasmetteva copia alla Commissione.Secondo i Carabinieri, le ipotesi più probabilicirca la scomparsa di De Mauro eranoin pratica due: la prima muoveva dallapremessa che De Mauro potesse essere venutoa conoscenza di notizie sul traffico deglistupefacenti tra la Sicilia e gli StatiUniti, notizie tali da costringere i capi delcontrabbando a modificare i sistemi usatifino allora per ricevere e smistare la mercé,e quindi a subire ingenti danni economici.Si sarebbe così reso necessario prendereDe Mauro vivo, per sapere coinè fosse venutoin possesso delle informazioni, a chi. leavesse comunicate, quali potevano ©ssere leprove di cui disponeva. Era ovvio naturalmenteche il giornalista, una volta ohe avesseconfessato, sarebbe stato ucciso^ Secondol'altra ipotesi, invece, De Mauro poteva esserevenuto a conoscenza di notizie relativea qualche grave delitto, colsi da indurre gliinteressati a sequestrarlo, per le stesse ragioniprima indicate.Luna e l'altra ipotesi, ma specialmentela prima, erano fondate sulle seguenti considerazioni.Già da qualche mese prima della sua scomparsa.De Mauro doveva essere in possessodi notizie che lo avevano indotto a interessarsinella zona di Terrasini, e <strong>dei</strong> possibilisbarchi su quella costa di mercé dicontrabbando; ciò è tanto vero che, essendosirecato in quella località, per fare unservizio su un complesso alberghiero sortoda poco, aveva dato al fotografo che lo accompagnavauna serie di fotografie (in negativo)ohe riproducevano vari punti dellacosta che nulla avevano a che fare con l'oggettodel servizio tgiornalistico. Inoltre, nell'agostodel 1970, De Mauro era andato aRaguisa, Gela e Vittoria e al ritorno da quelviaggio aveva detto al collega Enzo Perroneche aveva in mano il filo del traffico deglistupefacenti che si svolge tra la Sicilia, Marsigliae il Canada, che la zona di sbarcodella droga si trovava tra Punta Raisi e Villagraziadi Carini, che nel traffico erano implicatialcuni grossi personaggi e che chiedevala sua collaborazione per pubblicareuna serie di articoli sull'argomento. Nei giorniprecedenti alla scomparsa, De Mauro avevaaccennato di nuovo con amici e familiaria'1 « colipo grosso » che stava per fare, conchiaro riferimento a un episodio connessoal commercio degli stupefacenti.Senonchè il giornalista, sempre a parere<strong>dei</strong> Carabinieri, doveva essersi tradito banalmente,o mettendosi troppo in mostranelle indagini personalmente condotte, oppurechiedendo notizie proprio a qualcheaffiliato dell'organizzazione criminosa. Sarebbenata di qui l'idea del sequestro e icriminali avevano potuto attuare con facilitàil piano, in quanto De Mauro conoscevapersonalmente qualcuno di loro e aveva pertantoaderito, senza difficoltà, all'invito diseguirli.Sulla base di questi e altri elementi diprova, i Carabinieri denunciarono trentunopersone, come responsabili del sequestro edell'omicidio del giornalista.<strong>La</strong> Pubblica sicurezza, invece, seguiva nelfrattempo una pista del tutto diversa, cercandodi collegare la scomparsa del giornalistaad altri moventi, in qualche modoconnessi con la sua vita privata e il suo lavoro.In particolare, a un certo punto dell'inchiesta,l'attenzione della Polizia si concentròsul commercialista Antonino Buttafuoco.Risultò al riguardo che, dopo il sequestro,il Buttafuoco aveva avuto frequentiabboccamenti con i familiari di De Mauroe che nel corso degli incontri aveva cercatodi avere notizie sullo stato, sullo sviluppoe sull'indirizzo delle indagini, e aveva inoltrescandagliato la moglie e la figlia del giornalistacirca ciò che sapevano in merito allascomparsa del loro congiunto: il Buttafuoco,quindi, dopo aver promesso il propriointeressamento alle ricerche del giornalista,aveva all'improvviso interrotto i suoi rap-16.
Senato della Repubblica — 242 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIporti con la moglie e la figlia di De Mauro,suscitando così il sospetto di essere in qualchemodo implicato nella vicenda.<strong>La</strong> Polizia perciò lo denunziò in stato diarresto come responsabile insieAie con altridel sequestro di De Mauro, e nei giorniimmediatamente successivi un magistratodella Procura della Repubblica di Palermodichiarò ai giornalisti: « Nel sequestro diDe Mauro il Buttafuoco ci si è infilato finoal collo. Manca però la causale. Non sappiamoperché De Mauro è stato preso. Ripetoche non ci sono dubbi che l'arrestatoc'entri ».Senonchè, dopo breve tempo, a Buttafuocofu concessa la libertà provvisoria e ilprocessò per il rapimento di De Mauro ètuttora in corso di istruzione, senza che leindagini abbiano fatto sostanziali passi avanti.Non ha avuto risultati concreti neppurel'inchiesta relativa all'omicidio del Procuratoredella Repubblica di Palermo.<strong>La</strong> mattina del 5 maggio 1971, Pietro Scaglione,dopo essersi recato ai cimitero <strong>dei</strong>Cappuccini, a Palermo, si dirigeva verso ilPalazzo di giustizia a bordo dell'automobiledi servizio, guidata dall'agente di custodiaAntonino Lo Russo, quando in via<strong>dei</strong> Cipressi era stato bloccato da un'altramacchina; da essa erano uscite due o trepersone, che con repentina prontezza avevanofatto fuoco, freddando all'istante Scaglionee il suo autista.Le indagini per il grave delitto sono attualmentedirette dal Giudice istruttore diGenova, a cui la Corte di Cassazione ha rimessoil iprocedimento, ma malgrado l'impegnodella Magistratura e degli organi dipolizia, jnon è stato finora possibile identificaregli autori del duplice omicidio. Ancheper quanto riguarda il movente del delitto,gli inquirenti si muovono in più direzioni,secondo un quadruplice orientamento oheprevede: a) una causale di carattere privato;b) una causale inerente alla legittimaattività funzionale dell'alto magistrato palermitano;e) una causale inerente ad abusio deviazioni dall'attività funzionale, e infined) una causale fondata sull'erronea supposizione('da parte degli autori del delitto)di abusi o deviazioni nell'attività funzionale.ISembra comunque fuori discussione, aldi là di queste ipotesi e nei limiti in cui ilsegreto istnittorio permette di conoscerelo stato delle indagini, che il delitto abbiaavuto una matrice mafiosa, così come è dimostratonon solo dalle tipiche modalitàdell'attentato, ma anche dalle diverse pisteche nel corso degli anni si sono presentatealla sagacia degli inquirenti.Allo stesso modo, è certo che i delitti DeMauro e Scaglione richiamano l'attenzioneuna volta di più sulla difficoltà (e quasi sidirebbe l'impossibilità) di individuare gli autori<strong>dei</strong> più gravi delitti di mafia. Le causedel fenomeno (di cui si è già ampiamentetrattato in altra parte di questa relazione)sono varie e molteplici e con ogni verosimiglianzanon sono gran che diverse da quelleche rendono difficile anche in altri settorid'opera della giustizia; ma tuttavia non sipuò fare a meno di rilevare, a proposito deldelitto De Mauro, come il deprecabile contrastodegli organi di polizia in ordine allosvolgimento delle indagini e il ritardo concui la Magistratura diede credito, nello sviluppodell'istruttoria, a una delle (possibili)spiegazioni del delitto non abbiano certofavorito una positiva conclusione dell'inchiesta.Così come sembra innegabile ohe riguardoall'omicidio Scaglione hanno avutopeso negativo -il silenzio e la reticenza di coloroche pure dovettero assistere all'efferatoomicidio, nella popolosa via <strong>dei</strong> Cipressi.Ma è un'altra circostanza quella che davverocaratterizza i delitti De Mauro e Scaglionerispetto ai soliti crimini di stampomafioso. Ammesso infatti che i due delittiabbiano avuto una matrice mafiosa e che•nessun lecito rapporto sia mai esistito trale vittime e i loro assassini, i casi De Mauroe Scaglione rappresentano una novità, prò-,prio perché a subire l'aggressione della mafiasono stati questa volta un giornalista e•un magistrato. In precedenza, ad eccezionedell'omicidio di Petrosino, la mafia non avevamai osato colpire in simili direzioni; siera anzi sempre ritenuto che i mafiosi avesserouna particolare considerazione per imagistrati, per i poliziotti, appunto perchéigli stessi sono obbligati, ciascuno nella sferadelle proprie competenze, a svolgere le
Senato delta Repubblica — 243 <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIloro funzioni. I delitti De Mauro e Scaglionesegnano una svolta e concorrono a sottolinearecome, nel periodo della sua evoluzioneurbana, .la delinquenza mafiosa abbiamano a mano perduto o abbia visto almenoattenuarsi i caratteri specifici chel'hanno connotata nel contesto della societàagricola. Certo, non è dubbio ohe la violenzacostituisca ancora la nota dominantedella delinquenza mafiosa, è dubbio inveceche le sue manifestazioni continuino a presentare,almeno nella normalità <strong>dei</strong> casi,quei requisiti tipici che l'hanno sempre contraddistintain passato e che valevano a separarlada altre forme di delinquenza.In realtà, dopo essersi insediata nella societàurbana e industriale, la mafia ha semprepiù indirizzato la sua attività delittuosaverso scopi diversi da quelli di una volta,alla ricerca non più di posizioni di prestigioo di potere, ma di un diretto e gangsteristicosfruttamento di illecite fonti di guadagno.In questo senso, assume particolaresignificato la circostanza che proprio nel periododella sua urbanizzazione si è andatoprogressivamente accentuando — come risultada quanto ora si dirà — l'interesse dellamafia ,per il contrabbando <strong>dei</strong> tabacchi eil traffico degli stupefacenti.2. — <strong>La</strong> mafia, il contrabbando e il trafficodi stupefaccenti.Particolare impegno ha dedicato la Commissioneall'indagine sui rapporti tra mafia,contrabbando di tabacchi (soprattutto esteri)e traffico di stupefacenti, ciò sul presuppostoche questi illeciti commerci fosserodivenuti, còl passare degli anni e specie negliultimi tempi, uno <strong>dei</strong> settori più importantie redditizi dell'attività mafiosa. Piùspecificamente, la Commissione ha svoltosull'argomento un'autonoma ricerca che,sulla base degli elementi di giudizio ad essaforniti dalle forze di Polizia o da essa direttamenteacquisiti, servisse a dare una rispostaagli interrogativi più attuali, così daoffrire alla vallutazione del Parlamento, deglialtri poteri dello Stato e della stessa opinionepubblica gli strumenti necessari, nonsolo e non tanto per un approfondimentoulteriore del problema, quanto per l'adozionedelle opportune misure di salvaguardiada parte degli organi competenti.A questo fine, si è provveduto anzituttoad acquisire tutta la documentazione necessaria,per puntualizzare (anche alla luce <strong>dei</strong>fatti successivi) alcuni degli episodi più significatividelle infiltrazioni mafiose nei settoridel contrabbando e nel traffico delladroga; si è cercato inoltre di dedicare particolareattenzione ad alcuni personaggimafiosi, che avevano già operato nei suddettisettori e che, nonostante le apparenze,si pensava che potessero continuare nell'attivitàillecita; è stata svolta infine una specificaindagine per verificare l'eventualeestrazione mafiosa di quanti erano stati condannatio denunciati negli ultimi anni percontrabbando di tabacchi e per traffico didroga e per individuare i legami esistentitra le principali cosche mafiose e le organizzazionidelittuose operanti nei due settoriin Sicilia e nel resto d'Italia.<strong>La</strong> Commissione ha tenuto altresì fruttuosirapporti con tutti gli organi di polizia (inparicolare con la Guardia di finanza), impegnatinei settori della droga e del contrabbandodi tabacchi. Sono stati in questomodo acquisiti tutti i dati relativi alle proporzionie all'estensione territoriale che hanno,assunto i suddetti fenomeni negli annipiù recenti; mentre si è cercato di approfondirecon ogni mezzo gli spinosi, spesso indecifrabiliproblemi del finanziamento <strong>dei</strong>traffici illeciti, della provenienza <strong>dei</strong> mezzi,tailora apparentemente leciti, attraverso iquali si provvede al pagamento delle partitedi droga e di tabacchi, e della distribuzionedegli utili ricavati dal relativo commercio.Le pagine che seguono si limiteranno comunquead illustrare a grandi linee i risultatidelle indagini compiute dalla Commissione,in quanto una approfondita analisi euna dettagliata descrizione dello specificofenomeno riguardante il ruolo e le dimensionidella presenza mafiosa nel contrabbando<strong>dei</strong> tabacchi e nel traffico degli stupefacenti,' formano oggetto della relazionesettoriale, redatta dal senatore Michele Zuccaia,e a cui si rinvia.
Senato della Repubblica — 244 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTI3. — <strong>La</strong> mafia e il contrabbando di tabacchi.I dati statistici (1) comunicati alla Commissionedal Comando generale della Guardiadi finanza dimostrano che nell'ultimoventennio il fenomeno del contrabbandoha assunto in tutto il Paese proporzioni notevolied è stato caratterizzato, specie dal1955 in poi, dall'aumento quasi costante delnumero delle denunzie, dall'entità crescentedi sequestri di tabacchi esteri, dall'imponenza<strong>dei</strong> tributi evasi.Risulta in particolare da una recente valutazione,sufficientemente attendibile, degliorgani tecnici della Guardia di finanza, chesu 80 miliardi circa di sigarette (pari a 80mila tonnellate) consumate annualmente inaItalia, circa 10 miliardi di sigarette (jpari10 mila tonnellate) possono essere consideratedi contrabbando, ciò che ha provocatoall'Erario, per l'evasione <strong>dei</strong> tributi, unaperdita ragguardevole, calcolabile, tenutoconto <strong>dei</strong> prezzi del tabacco estero sul mercatonazionale, nella somma di circa 250miliardi di lire.Lo Stato, peraltro, oltre a subire un dannoconseguente alla frode tributaria, ha dovutosopportare e tuttora sopporta una spesa notevoleper mantenere e potenziare di continuole costose attrezzature ed i mezzi dicontrasto aerei, navali e terrestri òhe impiegala Guardia di finanza nella lotta alcontrabbando nelle acque doganali, lungo lecoste e nell'interno defl territorio nazionale.Le cause del fenomeno, ohe è sempre stato,dal dopoguerra ad oggi, di notevoli dimensioni,.sono individuabili in fatti di variogenere, ma è indubbio ohe almeno tre elementiconcorrono a favorirne l'estensione;in primo luogo gli ingenti profitti che leorganizzazioni contrabbandiere ricavano da 1 !-l'attività illecita, poi l'elevata entità dell'onerefiscale, pari mediamente all'80 per centodel costo totale del prodotto, che se da unlato assicura all'Erario un gettito di impostacostituente una delle più cospicue fonti d'enfi)I dati statìstici relativi al traffico di stupefacentie al contrabbando di tabacchi sono ampiamenteriportati nella relazione settoriale dal senatoreZuccaia (v. ali. 4).trata, determina, in contrapposto, una notevolespinta all'incremento della multiformeattività contrabbandiera nel settore; infine,la posizione geografica della Penisola che haun territorio caratterizzato da uno sviluppocostiero pari a chilometri 6.621 di litorale,e quindi senza riscontro in Europa, da unaestensione del mare territoriale e della zonacontigua pari a 43.498 miglia quadrate, in ultimodall'andamento del confine terrestre,pari a chilometri 1.871, con i profondi salientisvizzeri che si incuneano nel cuore delleregioni lombarda e piemontese.Un'attività illecita di queste caratteristichee dimensioni non poteva non incontrarsi conla mafia. Ed infatti, il contrabbando ha offertoalla mafia non solo una allettante fonte dilucro ma anche la disponibilità di mezzi cospicui,collaudate strutture di comando esoprattutto sperimentate possibilità di mimetismo,mentre a sua volta il contrabbandoha trovato nella mafia i necessari finanziamentie una valida protezione.<strong>La</strong> mafia, in particolare, pretende che leoperazioni di contrabbando eseguite in Siciliasi svolgano, al pari di altre attività delittuose,sotto il suo controllo diretto; ciòper evitare di rimanere coinvolta nell'azionedi 'repressione degli organi di vigilanza. Perciò,i contrabbandieri che sbarcano in Siciliadebbono ottenere l'autorizzazione preventiva<strong>dei</strong> capomafia presenti nelle zoneprescelte; ma una volta dato il proprio consenso,i mafiosi si prodigano nell'aiuto aicontrabbandieri, mettendo in moto tutta lafitta rete di amicizie e di aderenze di cuidispongono, segnalando le zone più adatte,i depositi più sicuri, le persone più fidate,affiraohè le operazioni siano portate a sicurosuccesso.Gli organizzatori del contrabbando sannod'altra parte di poter contare sull'omertàe sull'appoggio della mafia, per poterreagire alle eventuali reazioni <strong>dei</strong> gruppi rivali,ma sanno anche che, se non si procurasserola protezione <strong>dei</strong> mafiosi, si esporrebberoal rischio di pericolose rappresaglie.Si ricostruisce, così, in tutta la nettezza<strong>dei</strong> suoi contorni il quadro <strong>dei</strong> rapporti tramafia e contrabbandieri, che trova peraltroriscontro in una serie di fatti specifici;, inparticolare i rapporti fra potenti capi di
Senato della Repubblica — 245 <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIorganizzazioni contrabbandiere (quali Forni,Falciai, Scarabelli e Molinelli da una parte,e i Mancino, i Davi, i Greco dall'altra), mostranocome la mafia, dall'immediato dopoguerra,abbia trovato nel contrabbandouna Eonte di guadagni particolarmente elevati.È vero che nel 1959 si verificò una notevoleflessione del volume del contrabbandoin conseguenza del mutamento del regimepolitico nella città di Tangeri, base importantissimadel contrabbando internazionale,passata nel 1957 sotto la sovranità del Marocco,ma è altrettanto certo che ben prestosi ebbe una ripresa su vasta scala del contrabbandocontrollato dalla mafia nel territorionazionale.Taluni episodi mostrano infatti come all'iniziodegli anni sessanta la mafia penetrinel mercato napoletano, si associ strettamenteai bigs del contrabbando della Lombardiae della Liguria fino ad estendere intutto il Paese l'attività contrabbandiera inserendosinelle fila <strong>dei</strong> massimi esponenti dell'illecitotraffico. A questa conclusione laGuardia di finanza pervenne attraverso laraccolta di un copioso materiale informativocoordinato in un rapporto del 5 dicembre1963, trasmesso all'Autorità giudiziariadi Palermo nel quadro degli accertamentiistruttori allora in atto sugli omicidi, ferimentied attentati dinamitardi verificatisiin Sicilia ed a Milano ad opera di mafiosi.Dal 1964 inoltre anche le coste della Siciliaorientale divennero teatro di semprepiù frequenti attività di contrabbando che,in Sicilia, vive e prospera necessariamente,come si è rilevato, all'ombra della mafia.Per la verità, secondo le più recenti statistiche,tra i 1.050 individui denunziati inSicilia per contrabbando negli anni dal 1968al 1972 soltanto 37, e cioè il 3,53 per cento,sarebbero mafiosi, mentre ancora più bassaè la percentuale di presunti mafiosi (319 pariallo 0,30 per cento) sul numero complessivodelle denunziie (108.019) presentate all'Autoritàgiudiziaria nel restante territorionazionale, ma si cadrebbe certo in errore sesi assegnasse all'influenza mafiosa nel settoredel contrabbando un peso corrispondentea quello delle insignificanti percentualiora riportate.Le cifre indicate riguardano le personedenunziate alla Magistratura, ma è fuoridiscussione che sono soltanto i contrabbandieridi rango inferiore a cadere almeno disolito nella rete della Polizia. I mafiosi, invece,hanno nella gerarchla del contrabbandoun ruolo e una posizione molto più elevata,sì che è ben più difficile che essi venganoindividuati come i sicuri autori di singoliepisodi del traffico illecito. Ciò che importa, ,per percepire le dimensioni della presenzamafiosa, è che in tutte le principalioperazioni di contrabbando ricorrano confrequenza, e talora costantemente, i nomidi noti mafio'si siciliani, Salvatore Greco comeRosario Mancino, Vincenzo e TommasoSpadaro, Pietro Davi, Tommaso Buseetta,Antonio Camporeale, Vincenzo Buccafusca,Salvatore Adelifio, Gerlando Alberti. SalvatoreGreco, anzi, può essere davvero considerato,tante sono le imprese che si debbonoalla sua iniziativa, come una speciedi padrino del contrabbando siciliano, mentreanche gli altri personaggi ora nominatihanno tutti avuto, ciascuno nel proprio tempoe secondo le fortune del momento, unaparte di primo piano nella organizzazione,direzione e finanziamento del traffico illecito<strong>dei</strong> tabacchi esteri.Naturalmente, anche in questo settore,come in tutti quelli che la interessano, lamafia ha importato i suoi metodi tradizionali,esasperando le divisioni e i contrastitra le cosche rivali, ricorrendo spesso a interventipunitivi, strumentalizzando infine,a scopi ulteriori, le posizioni di prestigioe di forza raggiunte nell'ambiente <strong>dei</strong> contrabbandieri.Tra l'altro, la mafia si è servita <strong>dei</strong> rapportistabiliti con i trafficanti di tabacco(e più ancora di stupefacenti) per estendereall'estero la propria influenza, per prenderecontatti con la malavita internazionale eper continuare a dirigere, da posizioni direlativa sicurezza, i traffici illeciti all'internodel nostro Paese. Per di più, la mafiaha trovato nel contrabbando l'occasione propiziaper agganciarsi ad altri ambienti dellamalavita nazionale e soprattutto per trasferirsi,con vere e proprie squadre, in altre
Senato della Repubblica — 246 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIregioni d'Italia, e soprattutto in quelle meridionali.Risulta da taluni degli episodi documentatidagli atti in .possesso della Commissioneche fin dal 1967 gli organizzatori del contrabbandosiciliano pensarono di spostarele zone di sbarco del tabacco sulle coste dellaCalabria e della Campania.Da allora divennero sempre più frequentile operazioni di contrabbando organizzateda siciliani che ebbero come punto di approdole coste calabre e campane. Una seriedi fattori spiega questa evoluzione delfenomeno: anzitutto l'intensificazione in Siciliadell'attività di repressione, poi lo sviluppostesso del traffico illecito, che ha resonecessario, nel corso del tempo, un piùstretto collegamento tra le varie organizzazioniregionali e, infine, cause minori manon insignificanti, come i buoni fondali dellecoste calabresi e napoletane, spesso accessibilianche a natanti di una certa stazza,la relativa vicinanza <strong>dei</strong> centri di più vastoconsumo, come Napoli e Roma, le numeroserotabili che dalle strade litoranee si irradianoverso .l'interno delle due regioni.In Calabria, peraltro, i gruppi sicilianinon sono riusciti a costituire stabili rapporticon le cosche locali, che hanno preferitomantenere inalterate le proprie posizionidi influenza, limitandosi a svolgerefunzioni di protezione e quindi a pretendereche i contrabbandieri versassero tangentispesso onerose per ogni quantità idi tatacchisbarcata con successo.Invece a Napoli e più in generale in Campaniasi è potuto assistere negli ultimi anni(come lo speciale Comitato della Commissioneha potuto accertare mediante indaginicondotte sul posto) a un vero e proprio innestodella mafia (o idi alcuni suoi settori)nella delinquenza locale, una volta organizzatacome camorra e in atto non più esistentecome fenomeno associativo, ma al piùcome un fatto di clan. Le cause che hannofavorito questo innesto trovano le loro originilontane nei soliti agganci esistenti trala malavita napoletana e quella siciliana inrelazione allo smercio di prodotti ortofrutticolipresso i mercati di Napoli e <strong>dei</strong> centripiù importanti della provincia, e sono poi individuabiliin altri fattori più immediati, trai quaii i più incisivi sono stati da una partei collegamenti che tanto i 'siciliani quantoi napoletani avevano con i contrabbandierifrancesi e, dall'altra, la lunga permanenzanel Napoletano di personaggi di primo pianodella mafia. Negli ultimi anni, infatti, moltimafiosi sono stati inviati al soggiorno obbligatoproprio nei grossi centri del Napoletano,mentre altri siciliani si sono anche essitrasferiti in Campania, per sfuggire a indaginidi polizia o a provvedimenti restrittividella libertà personale. Nel 1971, inoltre,Gerlando Alberti, dopo una intensa attivitàsvolta in Lombardia, decise di trasferirsia Napoli e nei paesi vicini, infiltrandosiimmediatamente nel mondo del contrabbandoe continuando contemporaneamentea mantenere i suoi rapporti con altriesponenti della mafia in Lombardia e inSicilia. Si spiega perciò come questa concentrazionedi mafiosi in Campania non soloabbia aperto la strada ai contrabbandierisiciliani (arruolati o protetti! dalla mafia),ma abbia anche favorito o addirittura provocatoquella sorta di immedesimazione, dicui prima si parlava, tra mafia e malavitalocale.Correlativamente, però, si sono moltiplicatein Campania le organizzazioni contrabbandiere,con la conseguenza che ne sono derivatelotte di potere, spesso sanguinose, perl'accaparramento <strong>dei</strong> punti di sbarco e ilcontrollo <strong>dei</strong> depositi di tabacco.L'infiltrazione della mafia in Campania hainoltre provocato la penetrazione <strong>dei</strong> •metodimafiosi nelle fila stesse della delinquenzalocale, che oggi infatti non esita a ricorrere,nell'esecuzione delle operazioni di contrabbando,all'impiego di strumenti e di modalitàdi azioni che una volta sembravanopropri soltanto della mafia.Nella misura in cui organizza o dirige ilcontrabbando di tabacchi esteri, la delinquenzamanosa non presenta, salvo per quantoriguarda i sistemi operativi, differenze significativerispetto alla delinquenza comune.<strong>La</strong> mafia si inserisce nel settore del contrabbandocome una delle tante organizzazioni.che finanziano, preparano ed eseguono, a livellointernazionale e nazionale, il traffico
Senato della Repubblica — 24? — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIillecito <strong>dei</strong> tabacchi esteri. Ciò non toglietuttavia che anche in questo settore sia opportunarispetto alle iniziative mafiose unaparticolare vigilanza dell'apparato statale esoprattutto degli organi di Polizia e giudiziariaddetti alila repressione del fenomeno,in quanto maggiori e più insidiose sono lecapacità di azione della mafia e talora imprevedibilirisultano ila rapidità e l'efficaciacon cui essa riesce a sfruttare a fini ulteriorii successi conseguiti e le posizioni diprestigio dovunque raggiunte. Perciò, peirendere possibile l'adesione di opportuni rimedi,conviene procedere ad una sommariaricognizione delle deficienze applicative oheha avuto la normativa vigente fino al 31 dicembre1975, che possono lasciare aperto unvarco all'estensione della penetrazione mafiosanel settore specifico del contrabbando.In proposito, la Commissione ha potutorilevare che il contrabbando di tabacchi nonsempre è stato perseguito con da severità chele leggi consentivano e ciò per la diffusa opinioneche si trattasse di un fenomeno chenon meritasse la stessa decisa reazione che laopinione pubblica esige contro fatti delittuosid'altro tipo. Eppure è innegabile cheil contrabbando presenta oggi, con frequenzanotevole e certamente nei casi in cui èriconducibile alle iniziative della mafia,aspetti estremamente pericolosi, non diversida quelli propri della criminalità organizzata,sì che sarebbe auspicabile l'impegnodi un rigore più deciso nella repressionedelle sue manifestazioni più allarmanti.<strong>La</strong> Commissione invece ha potuto rilevare.che Je persone arrestate per contrabbandovenivano di solito rimesse in libertà dopobrevi periodi di detenzione e che anchei cittadini stranieri venivano sollecitamenteliberati previo pagamento di cauzioni irrisorie,nemmeno pari alla millesima partedella multa irrogabile, con la conseguenzache in questa ipotesi lo straniero una voltascarcerato si rende irreperibile e può quindifacilmente sottrarsi alla giustizia."A loro volta i natanti contrabbandieri vengonofrequentemente dissequestrati, previopagamento di esigue cauzioni, e questo perchénon sempre si riesce a provare che i loroproprietari sono anche essi coinvolti nel contrabbandoe in casi del genere la legge nonconsente la confisca del mezzo di trasporto.4. — <strong>La</strong> mafia e il traffico degli stupefacenti.Le indagini relative a questo settore hannoavuto come punto di partenza una ricognizionedel fenomeno che servisse ad illustrare,sia pure sommariamente, da un latol'evoluzione che ha avuto nel nostro Paeseil traffico degli stupefacenti e, dall'altro, lemodalità esecutive che ora lo caratterizzanoin relazione ai singoli tipi di droga. Inquesta prospettiva, si è avuta anzitutto laconferma che l'Italia è interessata al trafficodi sostanze stupefacenti sia come Paesedi transito, sia, in misura .minore, come mercatodi assorbimento.Per la sua posizione geografica, che la collocaquasi a mezza via tra i paesi dell'OrienteMediterraneo ed il Nord-Europa, l'Italiarappresenta la naturale zona di transito lungogli itinerari che la droga segue nel trasferimentodai luoghi di produzione a quelli'di trasformazione e di consumo.Alimentano precipuamente questa (massicciacorrente l'oppio e la morfina base chedalla Turchia (Istanbul, Izmir, Ankara), dalLibano (Beirouth) e dall'Afganistan (Kabul)vengono trasferiti, per la trasformazionein eroina, ai laboratori clandestini europei(fin qui localizzati nelle regioni meridionalifrancesi), seguendo itinerari marittimi,che toccano i porti italiani dell'Adriatico, oterrestri, con punti di accesso lungo il confineorientale del Paese.L'eroina prodotta raggiunge poi i mercatidi consumo statunitensi attraverso itinerariche, ancora una volta, investono il territorionazionale tanto nell'arco occidentale terrestre,per l'entrata dalla Francia, quanto, perl'uscita dallo Stato, nel confine marittimo,con particolare riguardo ai porti di Genova,Napoli e Palermo dai quali muovono i natantidiretti nel Nord-America.In questa fase di « transito » e per questotipo di droga l'Italia è dunque percorsada due distinte correnti, una ascendente, alimentatada materiale grezzo e semilavorato
Senato della Repubblica — 248 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTI(oppio, morfina base), l'altra discendente costituitada prodotto finito (eroina).Sono del pari consistenti le partite di canapaindiana, marijuana e hashish che, provenendodalle regioni del Medio Oriente edal Nord-Africa, affluiscono, attraverso ilterritorio nazionale, verso i mercati di assorbimentonord-europei.In questa fase sono .più da vicino interessatii porti di Bari, Brindisi, Venezia e Triesteper l'entrata ed in generale tutto l'arcodel confine alpestre per l'uscita del Paese.<strong>La</strong> frontiera terrestre, peraltro, segnatamentenella sua fascia occidentale, è attraversatada quel filone <strong>dei</strong> traffici che, dalle giàindicate zone di produzione della droga, risalela penisola balcanica per raggiungerei mercati di consumo attraverso itinerariterrestri.Assume invece .dimensioni notevolmentepiù ridotte il transito di cocaina .che, dallezone di produzione (Bolivia, Cile, Perù), pervienedirettamente ai diversi centri europeidi assorbimento, generalmente per mezzodi corrieri che viaggiano con gli aerei.L'altro aspetto del fenomeno, quello inerenteal consumo in Italia, da luogo a correntisicuramente meno imponenti che, intailuni casi, costituiscono una derivazione delflusso principale in transito ma che, piùspesso, hanno un significato e un meccanismoautonomi rispetto al primo.Il filone è alimentato per la maggior partedagli stupefacenti cosiddetti « teneri »(canapa indiana, marjiuana, hashish, reperibilicon irelativa facilità ed a buon prezzo)ed in minore misura della cocaina.Ancora più limitato è il consumo di LSD25 e >di altri allucinogeni, mentre recentiepisodi indicano un incremento dell'uso dianfetaminici ed un nascente problema di tossicomaniada eroina.Più specificamente, con riferimento allacocaina, si è accertato che il traffico di questadroga, che costituisce certamente l'attivitàmaggiormente remunerativa, fa capo,in misura preponderante, a cittadini sudamericani,soprattutto cileni, che curano sial'incetta dello stupefacente prodotto in Bolivia,Cile e Perù (in questi paesi sono statiscoperti, nel giro di un anno, 21 Jaboratoriclandestini), .sia il suo linoltro verso i mercatidi consumo nord-americani ed europei.Per quanto riguarda quest'ultimo punto, siè registrato negli ultimi tempi un aumentodella domanda di cocaina nel mercato clandestinonord-americano, mentre è diminuitoin quelle nazioni (Stati Uniti e Canada)il consumo di oppiacei, aio in conseguenzadella severa azione di controllo che i Paesiproduttori esercitano in .materia sulla basedi accordi internazionali. Nel mercato europeo,peraltro, il traffico della droga è praticamentemonopolizzato da organizzazionifrancesi, formate .speciaihnente da corsi eda marsigliesi.Per quanto poi attiene al nostro Paese, leinformazioni raccdke dalla 'Commissione, odirettamente o tramite 'gli organi di polizia,permettono di ritenere che gli insediamentipiù consìstenti di trafficanti si trovanoa .Milano, Roma, Genova e Napoli giacchétali città, oltre a costituire centri di assorbimentodella -droga, consentono, per la presenzadi scali, aeroportuali intemazionali,rapidi collegamenti con i Paesi produttoried offrono ai trafficanti — quasi sempre dotartidi più documenti falsi di identificazione— la possibilità di eludere e rendere diffiicoltoseile indagini di polizia.Tuttavia, nonostante queste obiettive difficoltà,gli accertamenti compiuti dai variorganismi di polizia hanno permesso di individuaree di scompaginare alcune organizzazioniintemazionali che agivano per ladistribuzione della cocaina in collegamentocon cittadini italiani. Si è avuto modo inqueste occasioni di notare che i trafficantisud-americani che operano nel settore dellacocaina risultano interessati non soltanto aquesta particolare forma di delinquenza maanche ad altre iniziative delittuose, quali ilfavoreggiamento della prostituzione, il taccheggio,eccetera.Per rendersi canto i<strong>dei</strong> truolo che ha svoltoe che svolge la mafia nel settore del trafficodegli -stupefacenti, ile cui dimensioni suscala nazionale sono illustrate dalle tavolestatistiche pubblicate in allegato alla relazionesettoriale del senatore Zuccaia, bisognamuovere anche qui dalla premessa,come già si è fatto a proposito del con-
Senato della Repubblica — 249 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIGabbando, che una così vasta irete di traffici,destinata a rifornire con assiduita i mercaticlandestini mondiali ed a soddisfareuna folla di acquirenti dalle tendenze e daigusta più disparati e, soprattutto, in vertiginosoaumento 'numerico, 'presuppone l'esistenzadi organizzazioni ben strutturate edeconomicamente dotate, capaci di alimentarel'intero circuito illecito della droga: dall'incettadelle materie prime alla preparazione'di prodotti finiti, al collocamento di questiattraverso fasi di commercio all'ingrossoed al dettaglio.È chiaro peraltro che un 'Siffatto schemaoperativo si attaglia precipuamente se nonesclusivamente a quei traffici che hanno peroggetto sostanze .stupefacenti, quali gli oppiaceie la cocaina, che consentono, per lapiù larga diffusione e per l'elevato costo finale,sensibili margini di utili nei diversimomenti e giustificano, quindi, organizzazionicomplesse ed onerose. Invece nel commercioclandestino di altri tipi di droga lestrutture .innanzi indicate non sono riscontrabili,se no» in presenza delle poche operazioniche possono comportare on rilevanteimpegno economico, ciò perché in questioasi la relativa facilità di reperimento <strong>dei</strong>prodotti ed il loro minore costo danno luogoad iniziative singole, propiziando il frazionamentodel traffico in una serie di epi Lsodi di modesto significato singolo.Risulta perciò evidente come sia possibilerinvenire la presenza della mafia, almenocome fatto associativo, soltanto nel trafficodella cocaina, dell'oppio e <strong>dei</strong> suoi derivati(morfina e soprattutto eroina). Anchein questi settori, naturalmente, è particolarmentedifficile documentare le infiltrazionimafiose, e ciò non soltanto per quanto si èdetto, a proposito del contrabbando, circala posizione e il (ruolo che assume la mafiain operazioni del genere, ma anche perchéle indagini di polizia in .materia di stupefacentitrovano un ostacolo naturale e taiorainsuperabile nella stessa facilità con cui ilprodotto può essere .nascosto e taiora trasportatoanche da corrieri ignari. Non è dubbiotuttavia che la mafia abbia certamenteavuto nel passato ed abbia tuttora una partedi primo piano nel traffico degli stupefacenti,in primo luogo se non esclusivamentedall'eroina e della cocaina.In effetti, nel 1956-57 d'inasprimento negliStati Uniti dolile sanzioni contro i trafficantidi droga e la crisi politica di Cuba, cheaveva costituito fino allora un importantecentro di raccolta <strong>dei</strong> narcotici destinati alNord-America, indussero i capimafia statunitensia valorizzare ancora di più la Siciliacome canale del passaggio della droga,e ciò non tanto per la favorevole posizionegeografica dell'Isola e per la presenza nelsuo territorio di contrabbandieri di tabaccosiculo-francesi, tra i quali Pascal Molinelli,Pietro Davi, Rosario Mancino, eccetera, capacidi assicurare collegamenti clandestini,quanto proprio per la possibilità di contaresull'appoggio e sull'aiuto incondizionatidella mafia siciliana, alla quale la mafiaamericana era stata collegata per unrapporto di filiazione diretta.Pertanto i mafiosi siciliani e i gangstersitalo-americani originari delila provincia diTrapani 'assunsero il compito di /risolvere iproblemi che assillavano allora i grandi organizzatoridel traffico idi stupefacenti, quellodi approntare una rete efficiente di collegamentiper assicurare il trasporto delladroga dal Medio Oriente ai mercati degliStati Uniti e del Canada e quello di difendersidalla Polizia e dai terzi aggressori contutti gli espedienti possibili.Puntualmente, infatti, nel luglio 1957, siistabilì in Sicilia Frank Garofalo, noto elementodella malavita statunitense legato davincoli di antica amicizia ai capi della mafia.di Castellammare del Golfo, Gaspare Maggadinoe Diego Plaja, e a distanza di qualchemese giunsero nella stessa zona anchei notissimi Joe Banamas, CamiMo Galante,Giovanni Bionventre e Santo Sorge. Tutti,quindi, nell'ottobre del 1957, si riunirononell'albergo delle Palme di Pallermo con GiuseppeGenco Russo, allora leader riconosciutodella mafia siciliana ed amico di Sorge,e con altri gangsters americani, che da tempo.sii erano stabiliti in Sicilia, come LuckyLuciano, Jon Di Bella e Vito Vitale, quest'ultimoamico e compare di Frank Coppola,un boss mafioso che la Commissione ha
Senato della Repubblica — 250 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIincontrato più volte nei lunghi anni dellasua attività. Una riunione questa che dovevaprecedere di poco il più celebre convegnoi<strong>dei</strong>la malavita americana tenutosi suimonta di Apalachin nello Stato di New York,nella villa del gangster Joseph Barbara pereleggere il successore di Albert Anastasia,assassinato alcuni giorni prima, .nominare icapi famìglia e ratificarle le decisioni presedai singoli gruppi della delinquenza associataal di là e al di qua dell'Oceano; ma unariunione altrettanto importante, perché conogni verosimiglianza fu durante l'incontrodi Palermo che si diede vita in Sicilia ad unnuovo sodalizio criminoso di carattere internazionale,invisibile, eppure temibilmentevivo e presente diretto proprio da questiboss siciliani e americani, nati a Castellammaredel Golfo, Alcamo e Salerai, i tre paesiche hanno visto nascere i maggiori trafficanti'di droga di fama mondiale.•Certo è comunque che d'incontro dell'albergodelle Palme diede luogo a complesseindagini giudiziarie, che sfociarono in unprocesso contro numerosi capomafia, tuttichiamati a rispondere di associazione perdelinquere per essersi associati al fine diesercitare il traffico degli stupefacenti, mapoi assolti dal Tribunale, sia pure per insufficienzadi prove.Ebbero invece maggiore .successo le operazionicompiute dalla Guardia di finanzanel 1960-1961, tra ile quali ila più importantee significativa fu quella conosciuta comeoperazione Caneba (dal nome <strong>dei</strong> due fratellipalermitani, Ugo e Salvatore, riconosciuticome i principali responsabili di ingentitraffici di eroina). In quegli anni, la Guardiadi finanza, agendo di concerto con l'Ufficionarcotici americano, riuscì a dare unduro colpo a due potenti organizzazioni internazionali,composte di .siciliani, americani,canadesi e francesi, e che avevano inItalia ila loro base proprio nella zona di Salemi,dove operavano noti mafiosi come SalvatoreZizzo, Giuseppe Palmari, Vito Agueci,Alberto Agueci (collegati in Canada), BenedettoZizzo, fratello di Salvatore, ed aifratelli Cutrone, noti esponenti della malavitaitalo-canadese.Le indagini della Guardia di finanza permiseroai giudici di infliggere agli imputatisevere condanne, e consentirono inoltre didimostrare i saldi legami esistenti tra mafiaamericana e 'mafia siciliana e di ricosttruireil mosaico dell'illegale commercio di eroina,tra Francia, Italia e Stati Uniti, per tuttigli anni cinquanta, fino al 1961.Si accertò così che i trafficanti francesivendevano gran parte dell'eroina prodottanei laboratori clandestini ad elementi mafiosisiciliani, trasportandola neH'Isola amezzo di autovetture munite di doppi fondi.Dopo laboriose trattative, condotte secondo.precise modalità, la mercé veniva scambiatacol denaro, ed ogni cosa veniva improntataalla massima cautela e prudenza,poiché entrambe le parti contraenti si premuravanodi non suscitare i sospetti dellaPolizia, né di favorire truffe sulla bontà dellamercé o sulla sicurezza <strong>dei</strong> pagamenti.Successivamente l'eroina veniva trasportatanel Nord-America talora in bauli affidatiad ignari emigranti che partivano, pergli Stati Uniti e il Canada, dai porti di Palermoe di Napoli.Spedizioni e amivi erano esattamente concordati;negli aeroporti o mei porti degliStati Uniti o dal Canada i fiduciari provvedevanoal ritiro della mercé ed al suo recapitoin sicuri posti di deposito. I bosserano tenuti costantemente informati sull'andamento<strong>dei</strong> trasporti e delle spedizioni,pronti ad impartire ondimi ed istruzioniper superare difficoltà, contrattempi e perdirimere, talvolta, contrasti o dissensi. Nelqual caso essi stessi, all'oocorrenza, si muovevanoda un continente all'altro, e, se chiamatia giustificare questi viaggi in sede diinvestigazioni, adducevano motivi familiario turistici apparentemente verosimili. <strong>La</strong> regoladell'omertà, infine, disciplinava ogniazione, qualsiasi atteggiamento di ogni membromafioso, dai capi all'ultimo gregario.Per finanziare tutte queste operazioni, occorrevanonaturalmente ingenti capitali, mala mafia riuscì sempre a procurarseli, riversandoin questa attività .gli utili che traevada altre imprese, e ricorrendo, tatara anchein Sicilia, allo strumento delle società finanziarie,per sostenetne, sotto l'apparenza
Senato della Repubblica -25Ì- <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIdi falsi scopi, gli impegni pecuniali connessiall'illecito traffico di 'Stupefacenti. I mafiosisiciliani del .resto traevano dal loro ruolodi intermedi ari fra francesi e mafia americananotevoli profitti, se si pensa che ilprezzo di rivendita all'ingrosso dell'eroinasupera di norma di cinque o sei volte quellodi acquisto e che perciò ogni chilo dieroina acquistato dai francesi, per due milionie mezzo di lire veniva iriivenduto al grossistaamericano per 12-15 milioni di lire.Le accennate conclusioni sulla via seguitadall'eroina per giungere negli Stati Uniti ein Canada trovarono sostanziale confermanelle indagini condotte dalla Sottocommissionedi inchiesta sull'organizzazione criminalee sul traffico illecito di stupefacenti nominataquailche anno dopo dal Governo degliStati Uniti d'America e presieduta dal senatoreMcClellan. « <strong>La</strong>' Sottocoonmissioneritiene » scrisse infatti McClellan nel suorapporto reso pubblico il 4 marzo 1965« che i gangsters corsi, dopo aver prodottol'eroina, la vendono ai tossicomani degli StatiUniti attraverso due vie. <strong>La</strong> principale rottadel traffico ha luogo attraverso le venditeeffettuate agli elementi della mafia inItalia e in Sicilia che hanno accordi di collaborazionecon i gruppi di Cosa Nostra negliStati Uniti, che si occupano della spedizionee dal contrabbando attraverso il portodi New York o per gli itkierari del Canadae del Massico. Il secondo canale di questotraffico, sviluppatosi di recente, consistenella vendita diretta di eroina da parte<strong>dei</strong> .ricettatori corsi ai colleghi di linguafrancese; questi a loro volta spacciano l'eroinaai gangsters della mafia delle zone metropolitanedegli Stati Uniti, perché questi sonoi centri dove abbondano gli individui deditial vizio degli stupefacenti ».Negli anni seguenti, però, il rapporto esistente.tra le due vie della 'droga si è percosì dire rovesciato, in quanto recenti osservazionieseguite suMa base <strong>dei</strong> sequestrioperati in Nord-America e in Francia autorizzanol'ipotesi secondo cui gran parte dell'eroinadestinata al mercato statunitensenon viene più inoltrata, come per il passato,attraverso l'Italia, ma proviene direttamentedal! territorio francese; ciò che confermerebbeun lento mutamento inedia fisionomia<strong>dei</strong> traffici degli oppiacei e starebbe a significareun progressivo inserimento di elementimarsigliesi nella fase commerciale immediatamentesuccessiva alila produzionedella droga.Queste circostanze però non escludonoche le organizzazioni mafiose abbiano continuatoad 'interessarsi del traffico degli stupefacenti,anche se forse hanno dovuto circoscriverela propria attività al controlloi<strong>dei</strong> canali di rifornimento e di distribuzionedella mercé nel continente nord-americano.Non sono tuttavia mancati specifici episodi,che documentano, in modo non equivoco,come siano tuttora massicoe le infiltrazionidella mafia nel settore del traffico deglistupefacenti, sia per quanto riguarda illoro trasporto nel Nord-America, sia per ciòche attiene agli spostamenti della droga tral'Italia e la Francia.In primo (luogo, si è calcolato che nel periodo1966-1972, su 43 persone che i Carabinierihanno denunciato iin Sicilia per trafficodi stupefacenti, 34 (e cioè il 79 per cento)erano presunti mafiosi; e che nel medesimoperiodo, su 20 denunzie presentate inSicilia dalla Guardia di finanza, 3 (pari al 15per cento) riguardavano mafiosi. Inoltre neglistessi anni su 581 persone denunzìate daiCarabinieri nel resto del territorio nazionale,111 (e cioè il 19;1 per cento) erano mafiose.Si tratta, come si vede, di 'dati statisticiche non sembrano di per sé indicativi diuna massiccia presenza mafiosa, ma che hannoin realtà un significato che va moltoal di Jà di valori numerici, posto che se giàè difficile, per .quanto prima si è detto, mettereile mani sulla droga che viaggia da uncontinente all'altro, è ancora più difficile (esi deve certe volte al caso) l'individuazione,quali responsabili dell'illecito traffico, di coloroche coinè mafiosi ne itiirano ile fila e neorganizzano le modalità di preparazione edi esecuzione.D'altra parte, alcune delle vicende più significative,tra quelle accadute negli ultimitempi, documentano, senza ombra di equivoci,come il ruolo e la posizione della mafiasia rimasta anche negli anni più recenti benpiù importante ed incisiva di quella che
Senato della Repubblica — 252 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIsembra apparire dalle cifre delle 'Statistiche.L'unico mutamento di qualche (rilievo verifiicatosinegli ultimi anni sui rapporti esistentitra la mafia e il 'traffico degli stupefacenti.riguarda .gli aspetti operativi. Oggicioè, mentre la zona di reclutamento <strong>dei</strong> corrieriinternazionali della droga da parte dellamafia italo-americana resta la Sicilia, icentri di organizzazione del traffico, per laparte che interessa l'Italia, ,non sono più soltantonell'Isola, ma si sono spostati almenoin prevalenza .in Campania e -soprattutto aNapoli.Al riguardo, lo speciale Comitato dellaCommissione ha potuto accertare, medianteindagini condotte direttamente sul luogo,che a Napoli si va configurando l'esistenzadi una associazione che si serve dielementi partenopei e siciliani e che mantienecostanti stretti contatti con Milano,soprattutto per dirottare la droga verso l'Europacentrale (oltre che verso l'America).Per avere .inoltre un quadro chiaro, anchese sommario, defila situazione, occorre tenerpresente che alcuni di coloro che sono indiziaticome tra i più grossi esponenti dellasuddetta organizzazione hanno stabile dimoraa Napoli dove svolgono la propina attivitàe che dalla fine del 1972 hanno avutoinizio, a Napoli e 'provincia, rapine a manoarmata per rilevanti importi, di diverse centinaiadi milioni; che nella totalità 'di talispecifici episodi criminosi sono state usatearmi particolari (lupara e pistola a tamburo);che le testimoniainze raccolte nelle diverseoccupazioni riferiscono di [rapinatoricon accento « siciliano o calabrese » e che,dalla fine del 1972, è stata segnalata, a Napoli,a Marano e Giugliano, la presenza delnoto mafioso Stefano Giaconia.È risultato pure che nella prima metà del1973 si trasferì a Sa'lemo tale Carlo Zippo,noto corriere della droga (eroina) -tra il Messicoe gli Stati Uniti. Era espatriato perchécolpito da mandato di cattura dall'Autoritàgiudiziaria nord-americana e si stabilì a Salerno,dove aprì conti bancari per circa duecentomilioni; ma prima di proseguire perSafarno aveva fatto sosta a Napoli, doveaveva .soggiornato, nello stesso periodo, VitoAdamo, successivamente ucciso a Napoli.Per quanto poi concerne i sistemi di pagamentode/lle partite di stupefacenti, si puòsenz'altro affermare che esse continuano adessere pagate in contanti e normalmente invaluta estera. Non è peraltro raro il casoche le stesse persone, specie ìgli organizzatori,risultino contemporaneamente interessate(basta pensare al caso di 'Salvatore .Greco)al traffico degli stupefacenti ed al contrabbandodel tabacco. Ma le modalità esecutivedelle due forme di contrabbando sonorimaste sostanzialmente diverse: mai sonostati rinvenuti colli' contenenti stupefacentifra le casse di .sigarette sbarcate clandestinamentein Sicilia o nelle coste dellaPenisola; mai si è rilevato che i camionistio altri elementi (reclutati per lo smistamentoa terra <strong>dei</strong> tabacchi esteri fossero ancheconrieri della droga. L'elevato valore e il limitatoingombro di questa mercé induce glioperatori ad occultarla in doppi fondi dibagagli al seguito di viaggiatori, in nascondigliricavati malie carrozzerie delle autovettureo in tasche appositamente confezionatenelle fodere di capì vestiario. Più raro appareil sistema, attuato solo per quantitativiingenti, di introdurla dn manufatti industrialio artigianali per poi affidarli a ditte ditrasporto internazionali, ignare del loro contenuto.Le stesse considerazioni che si sono fattea proposito del contrabbando di tabacchivalgono in sostanza anche per il trafficodegli stupefacenti. Anche in questo settorela delinquenza mafiosa non presentanote specifiche rispetto a quella comune.<strong>La</strong> lotta alle sue iniziative ideve essere perciò.inserita nel quadro più generale degliinterventi statali di repressione delle varieforme di delinquenza associata, sia pure congli opportuni accorgimenti, che sono consigliati'dalle particolari insidie connesse allapresenza mafiosa.Tn questa prospettiva, bisogna muovereda ailcune premesse.<strong>La</strong> prima è che la lotta al traffico internazionaledi stupefacenti è, tra le attivitàdi polizia, la .più difficile. L'efficienza <strong>dei</strong>trafficanti e delle loro organizzazioni, le regoleferree di fedeltà ed omertà che ne di-
Senato della Repubblica — 253 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIsciplinano l'azione, la rapidità e d'intensitàdai colilegaraeniti e degli' spostamenti a grandidistanze, favorite dal progresso <strong>dei</strong> mezzidi comunicazione, la prudenza costanteseguita nel mimetizzare movimenti ed incontri,l'abilitò di occultamento della mercé,l'impenetrabilità di ambiente frappongononotevoli difficoltà aill'aziane [repressiva.A queste difficoltà si aggiungono poi laparticolare solidità ed efficienza delle organizzazionimafiose e <strong>dei</strong> loro metodi, talida [richiedere 'interventi diretti più che a colpirei singoli a smantellare la stessa associazionedelittuosa.<strong>La</strong> lotta al contrabbando degli stupefacentirichiede inoltre una stabile cooperazionecon ile polizie degli altri Paesi che sia improntataalla massima tempestività, al pari<strong>dei</strong> perfetti collegamenti che esistono tra itrafficanti da una nazione all'altra, da uncontinente all'altro.<strong>La</strong> recente legge 22 dicembre 1975, ai. 685,sulla disciplina degli stupefacenti e sostanzepsicotrope dovrebbe -rappresentare nelsettore un efficace strumento a disposizionedelle autorità statali.È in particolare degno di nota che la leggeabbia previsto la costituzione alle dipendenzedel Ministero 'dell'interno di un ufficiodi direzione e coordinamento dell'attivitàdi polizia, che dovrebbe ovviare agli inconvenientifinora verificatisi per la contemporaneaazione delle due forze di Polizia digoverno nel Paese.5. — Gli ultimi avvenimenti.I fatti, le cifre, gli episodi esposti nellepagine precedenti e le considerazioni svoltesembrano dimostrare come quello della drogae del contrabbando sia diventato negliultimi tempi uno <strong>dei</strong> settori in cui è più intensala presenza dell'attività delittuosa dellamafia.Questo (naturalmente non significa che nonvi siano state manifestazioni criminali dialtro 'tipo. Al contrario, specie negli anni piùrecenti, le città siciliane, e soprattutto Palermo,sono state teatro di un'insolita, preoccupanteesplosione di criminalità. Una partedi questi delitti, come i danneggiamentie le estorsioni, appartengono alila casisticadella delinquenza mafiosa tradizionale; altriinvece, co-me i sequestri di persona, rinnovanouna tendenza che la mafia aveva datempo abbandonato e che si inserisce nelquadro di un fenomeno, esteso attualmentea (tutto il territorio nazionale e non semprericonducibile ad iniziative mafiose. In 'tuttii casi, comunque, nelle città siciliane, e comesi vedrà anche nel resto del Paese, sembraprocedere sempre più nettamente secondomoduli gangsteristici, attraverso un ricorsoindiscriminato alla violenza ed unasfida aperta ai poteri dello Stato.Tra te forme di delinquenza, il iricaitto restala più frequente; esercitato con mezzidiversi, e spesso mediante attentati dinamitardi,viene messo in atto per piegare la resistenzadel proprietario dell'area edificabilcche ne rifiuti la vendita, deH'dmprenditoreedile, costretto ad accettare la guardianiadi persone gradite all'organizzazione, infine,del commerciante, e in genere del piccolooperatore economico, piagato all'obbligodi pagare anche periodiicamente una determinata'tangente. Sono tutti risultala, chesi conseguono ancora con relativa facilità,ma che non sempre si 1 ottengono, come unavolta, con la semplice presenza, o soltantocon ilo sguardo; risulta invece dalle deposizioniche la Commissione ha raccolto in Siciliadurante l'ultimo suo sopralluogo nell'Isolache è diventata più frequente la necessitàdi fare ricorso aille minacce esplicite,o addirittura .alla violenza, per piegarealila propria l'altrui, volontà: segno non dubbiodi una maggiore resistenza dell'ambientealla prevaricazione mafiosa e .insieme dell'accennatocambiamento di rotta della mafiaverso forme di delinquenza di tipo gangsteristico.Si inseriscono in questo quadro anzituttoi quattro .sequestri di persona eseguiti inSicilia negli ultimi anni iin pregiudizio diAntonino Caruso, Luciano Cassina, GiuseppeVassallo e Francesco 'Madonia. Tutti isequestri sono stati commessi a scopo di ricattoe per \i primi due è stato anche possibilepervenire all'identificazione degli autorie all'accertamento <strong>dei</strong> collegamenti esi-
Senato della Repubblica — 254 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIstenti tra alcuni di loro, in particolare il sacerdoteAgostino Coppola, ed altre organizzazionicriminali operanti in parti diversedel territorio nazionale.Nello stesiso periodo di tempo, e cioè dadprimi mesi del 1970 alla fine del 1974, sonostati commessi melle città siciliane, a Trapanima soprattutto a Palermo, numerossimiomicìdi e tentati omicidi di stampo mafioso.In particolare a Palermo, negli ultimi tempi,sono stati commessi i seguenti gravi delittidi sangue:1) omicidio in persona di Giovanni Galilina,avvenuto il 26 maggio 1974 in Villagrazìadi Carini ad opera 'di ignoti, a mezzo diarmi ;da fuoco; si tratta di un delitto chesembra collegabile con l'altro in pregiudiziodel fratello Vito Gallina, consumato in Fabrianoil 5 febbraio 1974. Entrambi i delittisi inquadrano nell'attività di Agostino Coppolaed altri e cioè della cosiddetta « AnonimaSequestri »;2) omicidio volontario in pregiudizio daDomenico Bruno, sorvegliato .speciale diP.S., avvenuto in Palermo in data 4 giugno1974, mediante sei colpi di arnia da fuocoesplosi al suo indirizzo da persona rimastasconosciuta;3) omicidio in persona di Vittorio Manne,pregiudicato, gestore .di una officina, uccisoil 10 settembre 1974, con vari colpi diarma da fuoco corta, in via della Regionesiciliana. Per questo delitto si procede allostato contro G. Battista D'Agostino ed altriin atto ignoti;4) omicidio in persona di Angelo Sgoroi,pregiudicato e sorvegliato speciale di P.S.che esercitava l'attività di camionista, uccisoil 10 settembre 1974, con vari colpi diarma da fuoco, ad opera 'di ignoti in località« Ballavilla » del territorio di Partinico;5) duplice tentato omicidio, commessoin Palermo, in località Pallavicimo, il 15 settembre1974 ad opera di due sconosciuti armatidi pistola, in persona di Vincenzo Niooletti,nato a Palermo il 7 febbraio 1904, giàsottoposto a misura di prevenzione perchéImafioso e di Vincenzo Messina, nato a Palermoil 18 ottobre 1943;6) omicidio volontario, avvenuto in Palermoil 20 settembre 1974, in pregiudizio diSpiridione Candiotta, ad opera di tre personerimaste sconosciute mediante esplosionedi numerosi colpi di lupara e rivoltella;7) omicidio volontario, avvenuto in Palermoil 7 ottobre 1974, in pregiudizio di GiuseppeNaimo, guardiano in un cantiere edile,ad opera di ignoti che gli esplodevano contronumerosi colpi di arma da fuoco;8) omicidio in persona di Angelo' Minafò,commesso iin località Borgonuovo di Palermoil 21 novembre 1974, ad opera di ignoti,mediante vari colpi di arma da fuococorta. Il Minafò, pregiudicato e già sottopostoa misura di prevenzione, era imputatodi favoreggiamento nel procedimentopenale contro Giovanni Pitarresi, presuntoresponsabile degli omicidi idi Cesare RomanoMonaohelli e Pietro Ciresi. Le indaginidi polizia giudiziaria in corso tendonoad accertare se l'uccisione del Minafò siada ricondursi ad altri possibili aspetti dellamultiforme attività criminosa dell'ucciso;9) omicidio commesso di 7 dicembre1974 ad opera di ignota, mediante vari colpidi arma da fuoco corta, in persona delmafioso Antonino Taormina, già sottopostoa soggiorno obbligato che aveva terminatodi scontare nello scorso settembre. Il Taorminaera cognato 'del noto mafioso MicheleCavatajo, ucciso nella strage di viale <strong>La</strong>zio.L'omicidio è accaduto in pieno giornonel popolare rione dell'Acquasanta, verosimilmentein presenzia di numerosi testimoni;10) omicidio avvenuto fin Palermo il 19dicembre 1974 in pregiudizio di FilippoCioè Imperiale, ucciso da quattro sconosciuti;11) tentato omicidio, commesso in Palermoil 18 marzo 1975, in pregiudizio di SimonieMansueto mediante colpi di pistola e dilupara, ad opera di sconosciuti;12) omicidio in pregiudizio idi GiuseppeMessina, avvenuto in Palermo il 28 marzo1975, mediante colpi di lupara esplosi al suoindirizzo da quattro sconosciuti;
Senato della Repubblica — 255 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTI13) omicidio in persona idi Pasquale Marino,ucciso in Palermo il 10 maggio 1975,mediante colpii di airma da fuoco corta. Perquesto delitto è in corso una perizia balisticacomparativa con colpi esplosi da rivoltella,sequestrata in Napoli, 'all'indiziato mafioso-Stefano Giaconia;14) omicidio volontario in pregiudiziodi Cosimo Filippone, ucciso in Palermo il12 maggio 1975 mediante colpi di fucile. Gliautori del delitto sono stati identificati dagliorgani di polizìa;15) omicidio in persona di bazzone Filippo,ucciso din Palermo il 25 maggio 1975da sconosciuti, mediante colpi di rivoltella.11 Nucleo investigativo <strong>dei</strong> Carabinieri di Palermoha presentato rapporto giudiziario cheè al vaglio della locale Procura. Ili delittosi .ritiene connesso con il rinvenimento aPalermo del cadavere carbonizzato di unapersona probabilmente identificata con DomenicoMancini;16) omicidio avvenuto in iRoccamena il18 giugno 1975 in pregiudizio di CalogeroMorreale, ucciso da sconosciuti mediantecolpi idi 'rivoltella e lupara;17) omicidio in persona della guardiadi Pubblica sicurezza Gaetano Cappiello etentato omicidio in pregiudizio di AngeloRandazzo, commessi im Palermo il 2 luglio1975, mediante colpi di lupara, da personeidentificate, nel corso di un tentativo diestorsione;18) omicidio commesso in Palermo il7 luglio 1975, in pregiudizio di Antonino Pedone,ucciso mediante colpi di lupara da personeidentificate;19) omicidio in persona di Giuseppe Castellammare,ucciso in Palermo il 5 settembre1975, da sconosciuti, mediante colpi diarma corta da fuoco;20) omicidio, commesso ita Palermo il16 settembre 1975, in pregiudizio di DomenicoMontalto, ucciso da tre 'sconosciuti, mediantecolpi di rivoltella e di lupara;21) omicidio in pregiudizio idi GiacomoCosta, ucciso in Palermo il 23 ottobre 1975da due sconosciuti armati di lupara.<strong>La</strong> maggior parte delle volte si è trattatodi delitti commessi da killers, sempre sconosciutialla vittima e diretti per lo più a garantireall'organizzazione criminale il controllototale su ogni impresa, su ogni iniziativa,per la creazione di nuovi equilibri ein vista di una pacificazione tra i vecchiboss e le nuove leve.Il luogo elenco <strong>dei</strong> delitti commessi a Palermorivela per altro come parecchie voltele indagini non abbiano portato all'identificazionedegli assassini. Si ripete anche neitempi più ireceoti quella che può ben dirsiuna costante della delinquenza mafiosa. Ma'anche a voler sostenere che per il passatole cause del fenomeno siano state in qualchemisura connesse al tipo di criminalitàespresso dalla mafia, è senz'altro da escludereche oggi avvenga qualcosa del genere.<strong>La</strong> Commissione ha potuto direttamenteconstatare, nel suo ultimo viaggio in Sicilia,che la Magistratura e le forze dell'ordine inSicilia sono impegnate, con tutto il loro vigoreed al massimo delle proprie possibilità,.in una dotta decisa e senza quartiere adogni forma della delinquenza mafiosa. <strong>La</strong>Commissione anzi 'ha avuto modo di notarecome questo sforzo sia reso più alacre e piùcombattivo dalla raggiunta consapevolezzache per vincere occorre unità di intenti e diazione fra gli organi di polizia e tra la Poliziae la Magistratura, e che la mafia, avendoradici sociali, richiede, per essere efficacementecombattuta, l'impiego di strumentientro certi limiti diversi' e più modernidi quelli adottati nelle comuni operazionidi repressione poliziesca. Sta di fatto inoltreche sull'altro versante tende ad attenuarsi,almeno nelle sue motivazioni, il fenomenodell'omertà. Soprattutto in città, èdiventato più intenso e si va estendendo atutti gli strati della popolazione un nettoatteggiamento di rifiuto della prevaricazionemafiosa e perciò i testimoni, se non parlano,lo fanno non tanto per la rassegnataacquiescenza o per una generica solidarietàai criminali, ma o per paura di vendette edi rappresaglie o per ragioni non diverseda quelle che possono consigliare ai silen-
Senato della Repubblica — 256 — <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> DeputatiLEGIS<strong>LA</strong>TURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RE<strong>LA</strong>ZIONI - DOCUMENTIzio anche -in relazione ad inchieste che anulilahanno a ohe fare con da mafia.D'altra parte, come già si è accennato, lastessa delinquenza mafiosa tende a trasformarsilentamente, -ma in modo mano a manopiù accentuato, in una comune forma didelinquenza organizzata, non più connotatada requisiti tipici, pur .priva di propriecaratterizzazioni, ma .improntata soltanto ametodi di spietata violenza e di spregiudicatadecisione.Correlativamente, gli insuccessi della giustizianei confronti della delinquenza rnafiosanon sono più in nessun modo riconducibiili,se pure Io furono nel passato, a causeparticolari o comunque ad anomalie chetrovìimo nella mafia la loro 'Spiegazione, madebbano al contrario inserirsi nel quadrodella più generale incapacità, che il sistemasta in questi ultimi tempi dimostrando,di dare un'adeguata, efficace risposta allasfida di una nuova e più agguerrita criminalità.Di fronte ailia mafia, in alitane parole, lagiustizia fallisce per cause analoghe a quelleohe ne determinano l'ikisuccesso riguardoad altri settori della delinquenza ed è.perciò in questa prospettiva che vanno cercatiopportuni rimedi 1 alile attuali disfunzioni.Allo stesso modo, l'inserimento della mafianella società urbana e industria/le, la maggioree più incisiva compressione che questasocietà necessariamente esercita sullepossibilità di aggregazione di un potere informale,infine la conseguente, lenta trasformazionedelia mafia verso forme vere eproprie di gangsterismo, hanno prodotto (ostanno producendo) una sensibile modificazione<strong>dei</strong> suoi rapporti con i poteri pubblici.Si è più voke ribadito in questa relazioneche la mafia è nata ed ha avuto successo,in campagna come àn città, occupandolo spazio lasciato vuoto dal potere costituitoe intrecciando col potere, nei settori seditiper la propria attività, un viluppo di interessie di connivenze inconfessabili. Ma seoggi la mafia tende ad abbandonare i settoritradizionali della sua presenza, o se continuaad esservi presente, con metodi e formenuove rispetto al passato, riconducibiliunicamente all'imposizione esplicita dellapropria forza, tende per converso ad allentarsi(se non a scomparire) la presa che pertanto tempo la mafia ha avuto sull'apparatodel potere formale.Non è senza significato che gii 'ultimi anni,a 'differenza di quelli fino 'al 1970, nonabbiano fatto registrare, nelle città siciliane,nessuno scandalo di qualche dimensione,che coinvolgesse insieme mafia e pubblicipoteri. È un segno in più di un'evoluzionenel senso indicato del fenomeno mafioso. Lecaratteristiche che esso ha assunto nelle altreparti d'Italia, in cui è stato importato,ne rappresentano una prova 'ulteriore.