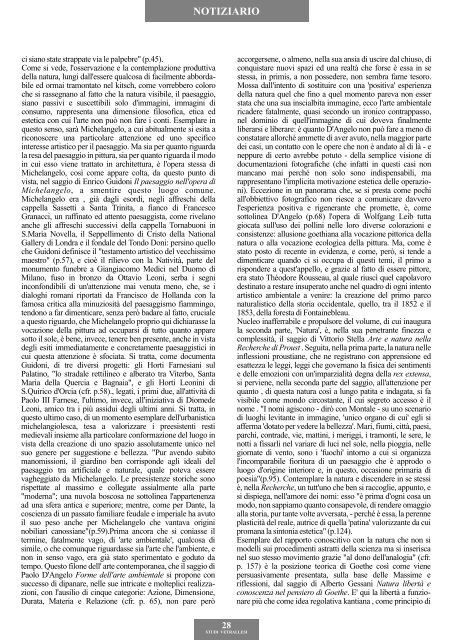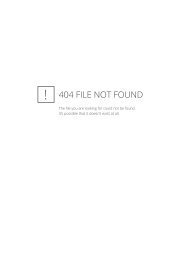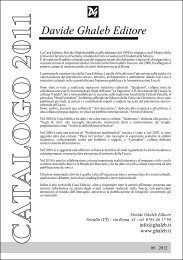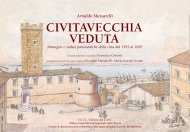Studi vetrallesi 07 - Davide Ghaleb Editore
Studi vetrallesi 07 - Davide Ghaleb Editore
Studi vetrallesi 07 - Davide Ghaleb Editore
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NOTIZIARIOci siano state strappate via le palpebre" (p.45).Come si vede, l'osservazione e la contemplazione produttivadella natura, lungi dall'essere qualcosa di facilmente abbordabileed ormai tramontato nel kitsch, come vorrebbero coloroche si rassegnano al fatto che la natura visibile, il paesaggio,siano passivi e suscettibili solo d'immagini, immagini diconsumo, rappresenta una dimensione filosofica, etica edestetica con cui l'arte non può non fare i conti. Esemplare inquesto senso, sarà Michelangelo, a cui abitualmente si esita ariconoscere una particolare attenzione ed uno specificointeresse artistico per il paesaggio. Ma sia per quanto riguardala resa del paesaggio in pittura, sia per quanto riguarda il modoin cui esso viene trattato in architettura, è l'opera stessa diMichelangelo, così come appare colta, da questo punto divista, nel saggio di Enrico Guidoni Il paesaggio nell'opera diMichelangelo, a smentire questo luogo comune.Michelangelo era , già dagli esordi, negli affreschi dellacappella Sassetti a Santa Trinita, a fianco di FrancescoGranacci, un raffinato ed attento paesaggista, come rivelanoanche gli affreschi successivi della cappella Tornabuoni inS.Maria Novella, il Seppellimento di Cristo della NationalGallery di Londra e il fondale del Tondo Doni: persino quelloche Guidoni definisce il "testamento artistico del vecchissimomaestro" (p.57), e cioè il rilievo con la Natività, parte delmonumento funebre a Giangiacomo Medici nel Duomo diMilano, fuso in bronzo da Ottavio Leoni, serba i segniinconfondibili di un'attenzione mai venuta meno, che, se idialoghi romani riportati da Francisco de Hollanda con lafamosa critica alla minuziosità del paesaggismo fiammingo,tendono a far dimenticare, senza però badare al fatto, crucialea questo riguardo, che Michelangelo proprio qui dichiarasse lavocazione della pittura ad occuparsi di tutto quanto apparesotto il sole, è bene, invece, tenere ben presente, anche in vistadegli esiti immediatamente e concretamente paesaggistici incui questa attenzione è sfociata. Si tratta, come documentaGuidoni, di tre diversi progetti: gli Horti Farnesiani sulPalatino, "lo stradale rettilineo e alberato tra Viterbo, SantaMaria della Quercia e Bagnaia", e gli Horti Leonini diS.Quirico d'Orcia (cfr. p.58)., legati, i primi due, all'attività diPaolo III Farnese, l'ultimo, invece, all'iniziativa di DiomedeLeoni, amico tra i più assidui degli ultimi anni. Si tratta, inquesto ultimo caso, di un momento esemplare dell'urbanisticamichelangiolesca, tesa a valorizzare i preesistenti restimedievali insieme alla particolare conformazione del luogo invista della creazione di uno spazio assolutamente unico nelsuo genere per suggestione e bellezza. "Pur avendo subitomanomissioni, il giardino ben corrisponde agli ideali delpaesaggio tra artificiale e naturale, quale poteva esserevagheggiato da Michelangelo. Le preesistenze storiche sonorispettate al massimo e collegate assialmente alla parte"moderna"; una nuvola boscosa ne sottolinea l'appartenenzaad una sfera antica e superiore; mentre, come per Dante, lacoscienza di un passato familiare feudale e imperiale ha avutoil suo peso anche per Michelangelo che vantava origininobiliari canossiane"(p.59).Prima ancora che si coniasse iltermine, fatalmente vago, di 'arte ambientale', qualcosa disimile, o che comunque riguardasse sia l'arte che l'ambiente, enon in senso vago, era già stato sperimentato e goduto datempo. Questo filone dell' arte contemporanea, che il saggio diPaolo D'Angelo Forme dell'arte ambientale si propone consuccesso di dipanare, nelle sue intricate e molteplici realizzazioni,con l'ausilio di cinque categorie: Azione, Dimensione,Durata, Materia e Relazione (cfr. p. 65), non pare peròaccorgersene, o almeno, nella sua ansia di uscire dal chiuso, diconquistare nuovi spazi ed una realtà che forse è essa in sestessa, in primis, a non possedere, non sembra farne tesoro.Mossa dall'intento di sostituire con una 'positiva' esperienzadella natura quel che fino a quel momento pareva non esserstata che una sua inscialbita immagine, ecco l'arte ambientalericadere fatalmente, quasi secondo un ironico contrappasso,nel dominio di quell'immagine di cui doveva finalmenteliberarsi e liberare: è quanto D'Angelo non può fare a meno diconstatare allorchè ammette di aver avuto, nella maggior partedei casi, un contatto con le opere che non è andato al di là - eneppure di certo avrebbe potuto - della semplice visione didocumentazioni fotografiche (che infatti in questi casi nonmancano mai perché non solo sono indispensabili, marappresentano l'implicita motivazione estetica delle operazioni).Eccezione in un panorama che, se si presta come pochiall'obbiettivo fotografico non riesce a comunicare davverol'esperienza positiva e rigenerante che promette, è, comesottolinea D'Angelo (p.68) l'opera di Wolfgang Leib tuttagiocata sull'uso dei pollini nelle loro diverse colorazioni econsistenze: allusione goethiana alla vocazione pittorica dellanatura o alla vocazione ecologica della pittura. Ma, come èstato posto di recente in evidenza, e come, però, si tende adimenticare quando ci si occupa di questi temi, il primo arispondere a quest'appello, e grazie al fatto di essere pittore,era stato Théodore Rousseau, al quale riuscì quel capolavorodestinato a restare insuperato anche nel quadro di ogni intentoartistico ambientale a venire: la creazione del primo parconaturalistico della storia occidentale, quello, tra il 1852 e il1853, della foresta di Fontainebleau.Nucleo inafferrabile e propulsore del volume, di cui inaugurala seconda parte, 'Natura', è, nella sua penetrante finezza ecomplessità, il saggio di Vittorio Stella Arte e natura nellaRecherche di Proust . Seguita, nella prima parte, la natura nelleinflessioni proustiane, che ne registrano con apprensione edesattezza le leggi, leggi che governano la fisica dei sentimentie delle emozioni con un'imparzialità degna della rex extensa,si perviene, nella seconda parte del saggio, all'attenzione perquanto , di questa natura così a lungo patita e indagata, si favisibile come mondo circostante, il cui segreto accesso è ilnome . "I nomi agiscono - dirò con Montale - su uno scenariodi luoghi levitante in immagine, 'unico organo di cui' egli siafferma 'dotato per vedere la bellezza'. Mari, fiumi, città, paesi,parchi, contrade, vie, mattini, i meriggi, i tramonti, le sere, lenotti a fissarli nel variare di luci nel sole, nella pioggia, nellegiornate di vento, sono i 'fuochi' intorno a cui si organizzal'incomparabile fioritura di un paesaggio che è approdo oluogo d'origine interiore e, in questo, occasione primaria dipoesia"(p.95). Contemplare la natura e discendere in se stessiè, nella Recherche, un tutt'uno che ben si raccoglie, appunto, esi dispiega, nell'amore dei nomi: esso "è prima d'ogni cosa unmodo, non sappiamo quanto consapevole, di rendere omaggioalla storia, pur tante volte avversata, - perché è essa, la perenneplasticità del reale, autrice di quella 'patina' valorizzante da cuipromana la sintonia estetica" (p.124).Esemplare del rapporto conoscitivo con la natura che non simodelli sui procedimenti astratti della scienza ma si inseriscanel suo stesso movimento grazie "al dono dell'analogia" (cfr.p. 157) è la posizione teorica di Goethe così come vienepersuasivamente presentata, sulla base delle Massime eriflessioni, dal saggio di Alberto Gessani Natura libertà econoscenza nel pensiero di Goethe. E' qui la libertà a funzionarepiù che come idea regolativa kantiana , come principio di28STUDI VETRALLESI