il rischio contrattuale in diritto romano: in particolare il periculum ...
il rischio contrattuale in diritto romano: in particolare il periculum ...
il rischio contrattuale in diritto romano: in particolare il periculum ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ufficiale; di <strong>periculum</strong> emptoris parlano chiaramente le Istituzioni giust<strong>in</strong>ianee, ma la realtà era oramaimutata e la compravendita gradatamente si avviava ad essere, come nei codici moderni, un contrattotraslativo 25 .3. Per quanto riguarda l’<strong>in</strong>cidenza del <strong>periculum</strong> nella locatio-conductio, poiché i Romani nonavevano un concetto unitario di questo contratto, <strong>il</strong> discorso va differenziato a secondo che si trattassedi locatio rei (locazione di cose), locatio operis (contratto d’opera, compreso l’odierno appalto) o locatiooperarum (contratto di lavoro subord<strong>in</strong>ato) 26 .Nella locazione di cose, <strong>il</strong> criterio prevalente era quello del <strong>periculum</strong> locatoris nel senso che <strong>il</strong>venir meno della disponib<strong>il</strong>ità della cosa senza colpa del locatore esonerava <strong>il</strong> conduttore dallacorresponsione del canone di affitto 27 . In <strong>particolare</strong>, nell’affitto dei fondi i rischi dipendenti da eventistraord<strong>in</strong>ari e imprevedib<strong>il</strong>i ricadevano sul locatore <strong>in</strong> quanto la sua obbligazione consisteva <strong>in</strong> un fru<strong>il</strong>icere praestare 28 , nel senso che su di lui gravava l’onere non solo di assicurare la disponib<strong>il</strong>ità del campo aif<strong>in</strong>i della coltivazione, ma anche quella di garantire alla controparte <strong>il</strong> “godimento della capacitàproduttiva del fondo, cioè dei frutti, i quali sono dati dalla s<strong>in</strong>ergia di attività umane e di fattor<strong>in</strong>aturali” 29 .Nella locatio operarum <strong>il</strong> momento della traslazione del <strong>rischio</strong> co<strong>in</strong>cideva con quello <strong>in</strong> cui <strong>il</strong>prestatore poneva le sue operae (<strong>il</strong>liberales 30 ) a disposizione del conductor <strong>il</strong> quale era tenuto al pagamentodel compenso pattuito anche se, per qualsiasi ragione, non le avesse ut<strong>il</strong>izzate 31 .Per quanto riguarda la locatio operis, le soluzioni prospettate dai prudentes <strong>in</strong> materia di <strong>periculum</strong>appaiono più articolate. Volendo tentare una schematizzazione, possiamo dire che i giuristi più antichisembrano propensi a far ricadere <strong>il</strong> “<strong>rischio</strong>” sul conductor operis f<strong>in</strong>o al momento dell’adprobatio oadsignatio, dopodiché esso grava sul committente. Ma già a partire dal I sec. d. C. com<strong>in</strong>cia a del<strong>in</strong>earsi ladifferenza tra eventi attribuib<strong>il</strong>i a vis naturalis o a vitium soli ed eventi dipendenti da vitium operis conconseguente accollo dei primi al committente e dei secondi al realizzatore dell’opus 32 . Emblematico <strong>in</strong> talsenso è <strong>il</strong> caso prospettato <strong>in</strong> D. 19.2.60 (59) (Iavol. 5 Lab. post.) 33 : Flacco ha commissionato a Marco lacostruzione di una casa. Dopo che già era stata costruita una parte dell’opera, sopraggiunge unterremoto che distrugge l’edificio. Secondo Sab<strong>in</strong>o “Flacci esse <strong>periculum</strong>”, <strong>in</strong> quanto <strong>il</strong> crollo della domus èdipeso da una vis naturalis 34 . In un altro frammento del Digesto tratto dalla nota di Paolo ai Pithana di25 Inst. 3.23.3. Per M. Talamanca, Considerazioni sul “<strong>periculum</strong> rei venditae” cit., pp. 294 ss., nelle Intitutiones <strong>il</strong> pr<strong>in</strong>cipio del<strong>periculum</strong> emptoris è ufficialmente accolto e ricondotto ad unità di sistema con la problematica del commodum e dell’<strong>in</strong>commodume ciò può agevolmente comprendersi se si considera che <strong>il</strong> <strong>periculum</strong> <strong>in</strong> senso tecnico è <strong>il</strong> limite massimo dell’<strong>in</strong>commodum.26 Gaio, <strong>in</strong> realtà, dist<strong>in</strong>gue solo tra locatio rei e locatio operis (Gai. 3.142-147), mentre di locatio operarum, oltre che <strong>in</strong> alcuniframmenti del Digesto [ad es. D.19.2.38 pr. (Paul. lib. s<strong>in</strong>g. regul.)], si parla nelle Pauli Sententiae (PS. 2.18.1).27 D. 19.2.15.2 (Ulp. 32 ad ed.); D. 19.2.19.6 (Ulp. 32 ad ed.).28 Ovviamente, i rischi rientranti nell’alea normale del contratto restavano a carico del conduttore.29 Così R. Card<strong>il</strong>li, L’obbligazione di “praestare” cit., pp. 235 ss.. In altri term<strong>in</strong>i, secondo lo studioso, la prestazione del locator(dom<strong>in</strong>us) del fondo aveva ad oggetto non solo la garanzia del libero godimento del bene, ma anche quella “delle condizioniesterne” e “questa obbligazione di garanzia, se trovava certo un limite nel cattivo risultato agricolo dovuto all’<strong>in</strong>capacità delcolono, sembrava non impedire un suo riconoscimento nel caso <strong>in</strong> cui una vis avesse <strong>in</strong>terrotto <strong>il</strong> perfezionarsi del cicloproduttivo” (op. cit. p. 241).30 Le prestazioni relative alle cc.dd. artes liberales (es. avvocatura, medic<strong>in</strong>a etc.) erano fuori del rapporto di locazione;l’honorarium del professionista, <strong>in</strong>fatti, era considerato – almeno f<strong>in</strong>o alla cognitio extra ord<strong>in</strong>em – solo un donativo socialmentedovuto.31 D. 19.2.19.9 (Ulp. 32 ad edict.): Cum quidam exceptor operas suas locasset, de<strong>in</strong>de is qui eas conduxerat decessisset, imperator Anton<strong>in</strong>uscum divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris <strong>in</strong> haec verba: “Cum per te non stetisse proponas, quo m<strong>in</strong>us locatas operas Antonio Aqu<strong>il</strong>aesolveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri aequum est”. Il <strong>diritto</strong> del prestatore d’opera alla mercedeveniva meno nell’ipotesi <strong>in</strong> cui questi, recedendo dal rapporto, avesse messo le sue capacità lavorative a disposizione di altri.Sul punto v. E. Betti, Periculum cit., p. 194.32 Così M. Sargenti, Rischio <strong>contrattuale</strong>, cit., p. 1128.33 Marcius domum faciendam a Flacco conduxerat: de<strong>in</strong>de operis parte effecta terrae motu concussum erat aedificium. Massurius Sab<strong>in</strong>us, si v<strong>in</strong>aturali, veluti terrae motu hoc acciderit, Flacci esse <strong>periculum</strong>.34 Il passo pone non pochi problemi <strong>in</strong>terpretativi soprattutto perché, pur essendo tratto dai posteriores di Labeone, nonriporta <strong>il</strong> parere del giurista augusteo. Tale circostanza, secondo parte della dottr<strong>in</strong>a, é da ascrivere ai comp<strong>il</strong>atori giust<strong>in</strong>ianeiche avrebbero soppresso l’op<strong>in</strong>ione di Labeone <strong>in</strong> quanto contrastante con l’orientamento <strong>in</strong> quell’epoca prevalente;secondo altri autori, <strong>in</strong>vece, l’omissione sarebbe dipesa dal fatto che i due giuristi avevano sul punto posizioni analoghe. Noi4







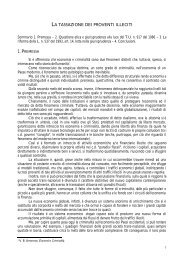








![POLITICA ED ECONOMIA [1970] - Rivista S.S.E.F.](https://img.yumpu.com/46476498/1/184x260/politica-ed-economia-1970-rivista-ssef.jpg?quality=85)