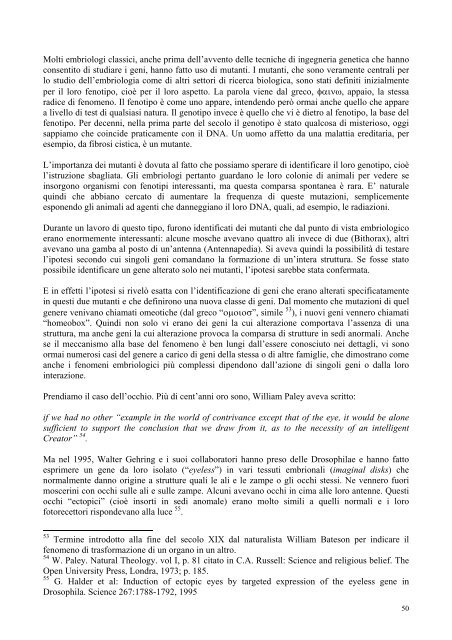Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Molti embriologi classici, anche prima dell’avvento delle tecniche di ingegneria genetica che hanno<br />
consentito di studiare i geni, hanno fatto uso di mutanti. I mutanti, che sono veramente centrali per<br />
lo studio dell’embriologia come di altri settori di ricerca biologica, sono stati definiti inizialmente<br />
per il loro fenotipo, cioè per il loro aspetto. La parola viene dal greco, φαινω, appaio, la stessa<br />
radice di fenomeno. Il fenotipo è come uno appare, intendendo però ormai anche quello che appare<br />
a livello di test di qualsiasi natura. Il genotipo invece è quello che vi è dietro al fenotipo, la base del<br />
fenotipo. Per decenni, nella prima parte del secolo il genotipo è stato qualcosa di misterioso, oggi<br />
sappiamo che coincide praticamente con il DNA. Un uomo affetto da una malattia ereditaria, per<br />
esempio, da fibrosi cistica, è un mutante.<br />
L’importanza dei mutanti è dovuta al fatto che possiamo sperare di identificare il loro genotipo, cioè<br />
l’istruzione sbagliata. Gli embriologi pertanto guardano le loro colonie di animali per vedere se<br />
insorgono organismi con fenotipi interessanti, ma questa comparsa spontanea è rara. E’ naturale<br />
quindi che abbiano cercato di aumentare la frequenza di queste mutazioni, semplicemente<br />
esponendo gli animali ad agenti che danneggiano il loro DNA, quali, ad esempio, le radiazioni.<br />
Durante un lavoro di questo tipo, furono identificati dei mutanti che dal punto di vista embriologico<br />
erano enormemente interessanti: alcune mosche avevano quattro ali invece di due (Bithorax), altri<br />
avevano una gamba al posto di un’antenna (Antennapedia). Si aveva quindi la possibilità di testare<br />
l’ipotesi secondo cui singoli geni comandano la formazione di un’intera struttura. Se fosse stato<br />
possibile identificare un gene alterato solo nei mutanti, l’ipotesi sarebbe stata confermata.<br />
E in effetti l’ipotesi si rivelò esatta con l’identificazione di geni che erano alterati specificatamente<br />
in questi due mutanti e che definirono una nuova classe di geni. Dal momento che mutazioni di quel<br />
genere venivano chiamati omeotiche (dal greco “ομοιοσ”, simile 53 ), i nuovi geni vennero chiamati<br />
“homeobox”. Quindi non solo vi erano dei geni la cui alterazione comportava l’assenza di una<br />
struttura, ma anche geni la cui alterazione provoca la comparsa di strutture in sedi anormali. Anche<br />
se il meccanismo alla base del fenomeno è ben lungi dall’essere conosciuto nei dettagli, vi sono<br />
ormai numerosi casi del genere a carico di geni della stessa o di altre famiglie, che dimostrano come<br />
anche i fenomeni embriologici più complessi dipendono dall’azione di singoli geni o dalla loro<br />
interazione.<br />
Prendiamo il caso dell’occhio. Più di cent’anni oro sono, William Paley aveva scritto:<br />
if we had no other “example in the world of contrivance except that of the eye, it would be alone<br />
sufficient to support the conclusion that we draw from it, as to the necessity of an intelligent<br />
Creator” 54 .<br />
Ma nel 1995, Walter Gehring e i suoi collaboratori hanno preso delle Drosophilae e hanno fatto<br />
esprimere un gene da loro isolato (“eyeless”) in vari tessuti embrionali (imaginal disks) che<br />
normalmente danno origine a strutture quali le ali e le zampe o gli occhi stessi. Ne vennero fuori<br />
moscerini con occhi sulle ali e sulle zampe. Alcuni avevano occhi in cima alle loro antenne. Questi<br />
occhi “ectopici” (cioè insorti in sedi anomale) erano molto simili a quelli normali e i loro<br />
fotorecettori rispondevano alla luce 55 .<br />
53 Termine introdotto alla fine del secolo XIX dal naturalista William Bateson per indicare il<br />
fenomeno di trasformazione di un organo in un altro.<br />
54 W. Paley. Natural Theology. vol I, p. 81 citato in C.A. Russell: Science and religious belief. The<br />
Open University Press, Londra, 1973; p. 185.<br />
55 G. Halder et al: Induction of ectopic eyes by targeted expression of the eyeless gene in<br />
Drosophila. Science 267:1788-1792, 1995<br />
50