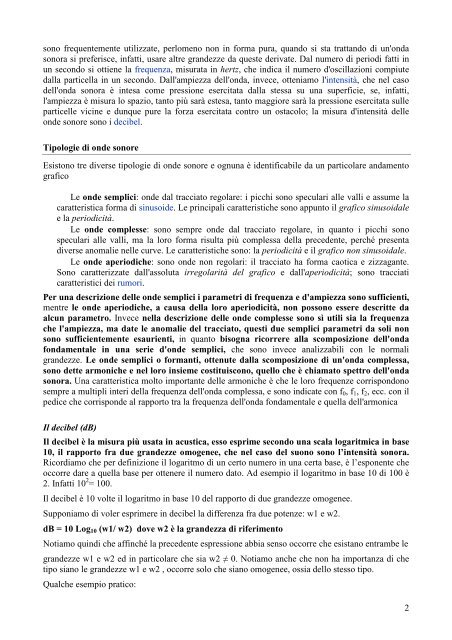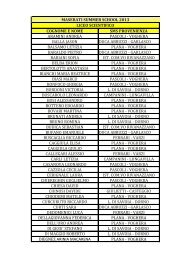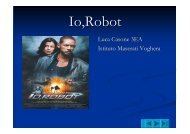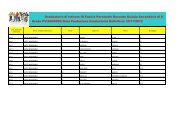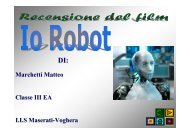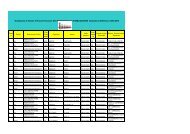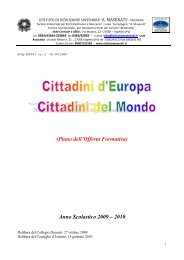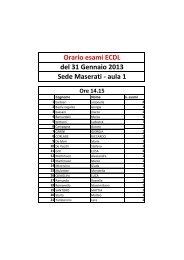Il suono : generalità - Istituto Istruzione Superiore Maserati
Il suono : generalità - Istituto Istruzione Superiore Maserati
Il suono : generalità - Istituto Istruzione Superiore Maserati
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sono frequentemente utilizzate, perlomeno non in forma pura, quando si sta trattando di un'onda<br />
sonora si preferisce, infatti, usare altre grandezze da queste derivate. Dal numero di periodi fatti in<br />
un secondo si ottiene la frequenza, misurata in hertz, che indica il numero d'oscillazioni compiute<br />
dalla particella in un secondo. Dall'ampiezza dell'onda, invece, otteniamo l'intensità, che nel caso<br />
dell'onda sonora è intesa come pressione esercitata dalla stessa su una superficie, se, infatti,<br />
l'ampiezza è misura lo spazio, tanto più sarà estesa, tanto maggiore sarà la pressione esercitata sulle<br />
particelle vicine e dunque pure la forza esercitata contro un ostacolo; la misura d'intensità delle<br />
onde sonore sono i decibel.<br />
Tipologie di onde sonore<br />
Esistono tre diverse tipologie di onde sonore e ognuna è identificabile da un particolare andamento<br />
grafico<br />
Le onde semplici: onde dal tracciato regolare: i picchi sono speculari alle valli e assume la<br />
caratteristica forma di sinusoide. Le principali caratteristiche sono appunto il grafico sinusoidale<br />
e la periodicità.<br />
Le onde complesse: sono sempre onde dal tracciato regolare, in quanto i picchi sono<br />
speculari alle valli, ma la loro forma risulta più complessa della precedente, perché presenta<br />
diverse anomalie nelle curve. Le caratteristiche sono: la periodicità e il grafico non sinusoidale.<br />
Le onde aperiodiche: sono onde non regolari: il tracciato ha forma caotica e zizzagante.<br />
Sono caratterizzate dall'assoluta irregolarità del grafico e dall'aperiodicità; sono tracciati<br />
caratteristici dei rumori.<br />
Per una descrizione delle onde semplici i parametri di frequenza e d'ampiezza sono sufficienti,<br />
mentre le onde aperiodiche, a causa della loro aperiodicità, non possono essere descritte da<br />
alcun parametro. Invece nella descrizione delle onde complesse sono sì utili sia la frequenza<br />
che l'ampiezza, ma date le anomalie del tracciato, questi due semplici parametri da soli non<br />
sono sufficientemente esaurienti, in quanto bisogna ricorrere alla scomposizione dell'onda<br />
fondamentale in una serie d'onde semplici, che sono invece analizzabili con le normali<br />
grandezze. Le onde semplici o formanti, ottenute dalla scomposizione di un'onda complessa,<br />
sono dette armoniche e nel loro insieme costituiscono, quello che è chiamato spettro dell'onda<br />
sonora. Una caratteristica molto importante delle armoniche è che le loro frequenze corrispondono<br />
sempre a multipli interi della frequenza dell'onda complessa, e sono indicate con f0, f1, f2, ecc. con il<br />
pedice che corrisponde al rapporto tra la frequenza dell'onda fondamentale e quella dell'armonica<br />
<strong>Il</strong> decibel (dB)<br />
<strong>Il</strong> decibel è la misura più usata in acustica, esso esprime secondo una scala logaritmica in base<br />
10, il rapporto fra due grandezze omogenee, che nel caso del <strong>suono</strong> sono l’intensità sonora.<br />
Ricordiamo che per definizione il logaritmo di un certo numero in una certa base, è l’esponente che<br />
occorre dare a quella base per ottenere il numero dato. Ad esempio il logaritmo in base 10 di 100 è<br />
2. Infatti 10 2 = 100.<br />
<strong>Il</strong> decibel è 10 volte il logaritmo in base 10 del rapporto di due grandezze omogenee.<br />
Supponiamo di voler esprimere in decibel la differenza fra due potenze: w1 e w2.<br />
dB = 10 Log10 (w1/ w2) dove w2 è la grandezza di riferimento<br />
Notiamo quindi che affinché la precedente espressione abbia senso occorre che esistano entrambe le<br />
grandezze w1 e w2 ed in particolare che sia w2 ≠ 0. Notiamo anche che non ha importanza di che<br />
tipo siano le grandezze w1 e w2 , occorre solo che siano omogenee, ossia dello stesso tipo.<br />
Qualche esempio pratico:<br />
2