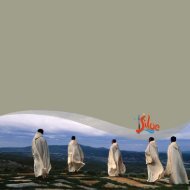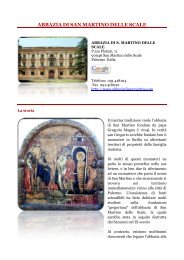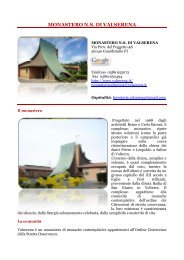ABBAZIA DI VALLOMBROSA - Prodotti monastici
ABBAZIA DI VALLOMBROSA - Prodotti monastici
ABBAZIA DI VALLOMBROSA - Prodotti monastici
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La storia della comunità<br />
<strong>ABBAZIA</strong> <strong>DI</strong> <strong>VALLOMBROSA</strong><br />
<strong>ABBAZIA</strong> <strong>DI</strong> <strong>VALLOMBROSA</strong><br />
Via San Benedetto, 2<br />
50066 <strong>VALLOMBROSA</strong> FIRENZE<br />
Telefono (39) 055.86.22.51<br />
Fax (39) 055.86.20.36<br />
http://www.monaci.org/<br />
info@evallombrosa.it<br />
Ospitalità: contattare<br />
La storia della comunità benedettina che è vissuta e continua a vivere in questo monastero<br />
dal 1036 ad oggi può essere suddivisa in 4 grandi periodi:<br />
dalla fondazione (1036) al 1300 circa<br />
dal 1300 al 1500 circa<br />
dal 1500 al 1800<br />
dal 1800 al 1960<br />
Dalla fondazione (1036) al 1300 circa<br />
È l’epoca del fervore degli inizi e dell’impulso dato dal fondatore. L’"unione fraterna" nelle<br />
singole comunità e fra i monasteri - il cosidetto vinculum caritatis et consuetudinis - sotto<br />
la guida dell’abate maggiore trovò espressione soprattutto nell’annuale raduno a<br />
Vallombrosa dei superiori, nello scambio di persone e cose favorendo consuetudini comuni<br />
come segno di affinità e collaborazione. È l’epoca d’oro della storia di Vallombrosa e<br />
dell’espansione della congregazione sia nel centro e nord Italia che in Sardegna. Sappiamo<br />
che nel 1160 i monaci di Vallombrosa erano presenti in 57 monasteri con le loro<br />
dipendenze.<br />
Dal 1300 al 1500 circa<br />
È l’epoca della "commenda", che consisteva nel conferimento del titolo di abate (superiore)<br />
di un monastero ad un estraneo da parte della Sede apostolica. L’abate commendatario<br />
solitamente lontano era comunque interessato non alla vita interna della comunità, ma
all’amministrazione dei suoi beni temporali di cui beneficiava in gran parte. Fu senza<br />
dubbio un periodo di decadenza sia per le comunità che per la congregazione, benchè il<br />
monastero di Vallombrosa non sia stato mai concesso in commenda.<br />
Dal 1500 al 1800<br />
È un periodo meno uniforme, inizialmente si assiste<br />
ad una ripresa spirituale, dovuta all’influsso esercitato<br />
dal Concilio di Trento (1545-1563), Vallombrosa torna<br />
ad essere un centro di spiritualità e di cultura, come<br />
attesta fra gli altri, s. Carlo Borromeo che vi giunse nel<br />
1575. Vi fu pure un grande sviluppo economico che ha<br />
lasciato la sua traccia profonda nella grandiosità<br />
dell’attuale complesso abbaziale.<br />
Con l’illuminismo fu accentuato l’inserimento dei<br />
monaci nelle attività culturali e scientifiche. Fa parte<br />
della tradizione monastica che i monaci non siano<br />
estranei al sociale; così i monaci vallombrosani si<br />
dedicarono ad attività varie a beneficio della società:<br />
agricoltura in pianura, selvicoltura in montagna,<br />
costruzione e gestione di ospedali e di luoghi di<br />
accoglienza per i pellegrini.<br />
Già dal 1300 l’abate Michele Flammini aveva dettato<br />
alcune norme per una selvicoltura razionale. Dalla<br />
metà del secolo XVII fino agli inizi del XIX si andrà<br />
formando una scuola di scienze botaniche e forestali.<br />
Ricordiamo almeno i più noti botanici e selvicoltori:<br />
V. Fallugi (+ 1707), B. Biagi (+1735), B. Tozzi (+ 1743), G.F. Maratti (+1777), F. Vittman<br />
(+1806).<br />
Allo sviluppo culturale della comunità contribuì lo scriptorium dell’abbazia, dove fin dal<br />
secolo XI venivano trascritti i libri liturgici, testi patristici, agiografici e classici. Questo<br />
patrimonio è oggi custodito in varie biblioteche italiane e straniere. Nella seconda metà del<br />
1700 fu pure aperto a Vallombrosa un collegio per l’educazione dei giovani.<br />
Particolare menzione va fatta pure per l’Eremo delle Celle, meglio conosciuto come<br />
"Paradisino", che domina l’abbazia, dove hanno condotto vita eremitica alcuni monaci fino<br />
alla metà del secolo scorso. In quest’eremo, dal 1743 al 1771, portò alla perfezione l’arte<br />
della scagliola il monaco Enrico Hugford, che lasciò un pregevole patrimonio artistico,<br />
iniziando una scuola che ha nel fiorentino Lamberto Gori il più valido rappresentante.<br />
Dal 1800 al 1960<br />
È l’epoca delle soppressioni attuate dalle autorità statali.<br />
Il 10 ottobre 1810 per la prima volta i monaci furono costretti ad abbandonare l’abbazia. Vi<br />
rientrarono il 16 gennaio 1818 con 15 sacerdoti e 16 fratelli.<br />
Nel 1866, anno dell’applicazione in Toscana delle leggi italiane riguardanti la soppressione
degli istituti religiosi, ai monaci fu tolta nuovamente l’abbazia che il 15 agosto 1869<br />
divenne sede del primo Istituto Forestale d’Italia, al quale veniva affidata la prosecuzione<br />
di un lavoro svolto da più secoli dai monaci.<br />
L a comunità monastica tuttavia non si estinse, ma continuò a vivere a Pescia (Pistoia) fino<br />
al suo ritorno a Vallombrosa, avvenuto nel 1949 e reso possibile dalla cessione di una parte<br />
del monastero. Era rimasto comunque in sede un esiguo numero di monaci per il servizio<br />
liturgico della chiesa abbaziale, che il 29 agosto 1906 venne eretta a parrocchia da mons.<br />
David Camilli, vescovo di Fiesole. L’intero edificio dell’abbazia è stato poi concesso in<br />
affitto ai monaci dal marzo 1961.<br />
Nel 1957, ad opera delle autorità competenti ha avuto inizio la complessa opera di restauro<br />
dell’abbazia, dichiarata monumento nazionale nel 1951.<br />
Visita virtuale del Monastero<br />
La chiesa<br />
- Le opere d'arte nella chiesa<br />
- La cappella di s. Paolo<br />
- La cappella Mater Amabilis<br />
- La cappella di s. Giovanni Gualberto<br />
- Il coro<br />
Per brevità e chiarezza distinguiamo quattro periodi della storia di questo edificio: la prima<br />
costruzione risale ai tempi della fondazione.<br />
Si trattava allora di un modesto oratorio in legno con il solo altare in pietra, consacrato nel<br />
1038.<br />
La costruzione in pietra si protrasse per 20 anni, dal 1038 al 9 luglio 1058, data della<br />
consacrazione.<br />
Dato lo sviluppo numerico della comunità, tra il 1224 e il 1230, si procedette ad una nuova<br />
costruzione.<br />
La chiesa, come si presenta oggi, è fondamentalmente quella del 1230. È caratterizzata da<br />
una navata unica molto allungata (m. 47 x 8.60).<br />
La copertura della chiesa romanica fu nascosta da tre volte padiglionate, rette da archi<br />
ribassati, decorate nel 1750 da Giuseppe Fabbrini.<br />
Al centro, la scena biblica del re Assuero e della regina Ester.<br />
Nella navata della chiesa furono collocati, negli anni 1730-1732, due altari in pietra. Quello<br />
di destra è dedicato a s. Atto, vescovo di Pistoia (morto nel 1153), già abate di Vallombrosa;<br />
la tela ivi collocata è di Agostino Veracini e rappresenta s. Atto che riceve le reliquie di s.<br />
Giacomo Apostolo.<br />
L'altare di sinistra è invece dedicato a s. Pietro Igneo, monaco vallombrosano, cardinale<br />
vescovo di Albano (morto nel 1089).<br />
La tela è di Antonio Puglieschi e rappresenta Gregorio VII che gli impone la berretta<br />
cardinalizia.<br />
Ai lati dei due altari, in alto, sono collocate quattro grandi tele: nella parete di destra, la<br />
prima rappresenta il martirio del b. Tesauro Beccaria, abate di Vallombrosa, di Niccolò<br />
Lapi; la seconda, opera di Niccolò Mannelli, raffigura l'incontro tra Enrico IV e Gregorio
VII a Canossa.<br />
Nella parete di sinistra, la prima tela raffigura s. Pietro Igneo nell'atto di scomunicare i<br />
canonici della cattedrale di Lucca, opera di Ignazio Hugford; mentre la seconda ricorda<br />
l'episodio della prova del fuoco sostenuta da s. Pietro Igneo, anch'essa opera del Veracini.<br />
L'elegante cornicione in pietra arenaria (1487) attualmente posto sotto la cantoria<br />
dell'organo, sostenuto da quattro lesene con capitello, ornato nel fregio da serafini e altri<br />
motivi, era collocato originariamente al centro della navata e serviva a separare il coro dei<br />
monaci dal resto dellla chiesa.<br />
Al lato dell'ingresso un'acquasantiera in marmo bianco (1487) reca lo stemma dell'abate<br />
Biagio Milanesi.<br />
L'organo sovrastante è la sintesi di due epoche: la cassa centrale contiene il prezioso<br />
strumento costruito da Benedetto Tronci di Pistoia nel 1819, mentre i due corpi laterali<br />
sono della ditta Tamburini di Crema che nel 1956 elettrificò anche l'antico organo.<br />
Cappella di s. Giovanni Gualberto<br />
Ornata di marmi e stucchi e decorata da Carlo Marcellini, costruita tra il 1695 e il 1707. Il<br />
quadro dietro l'altare raffigura San Giovanni Gualberto in preghiera, opera di Antonio<br />
Franchi.<br />
L'affresco della volta, opera di Alessandro Gherardini, rappresenta La Madonna con s.<br />
Giovanni Gualberto.<br />
Cappella del SS.mo Sacramento o dei Dieci Beati costruita sul sepolcreto dei primi monaci,<br />
la cappella fu iniziata nel 1755. l'altare, consacrato due anni dopo, è in marmo policromo,<br />
ma le colonne, i capitelli corinzi, il fastigio e altre parti sono in scagliola, opera di Enrico<br />
Hugford.<br />
La pala d'altare è opera di R. Soldaini, monaco camaldolense (1846).<br />
La volta a calotta è opera del pittore G. Giani (1819).<br />
Il pavimento presenta una divisione ottagonale a spicchi, ognuno dei quali ha una ricca<br />
decorazione a intarsi marmorei policromi. Dietro l'altare, il coro in noce è opera del<br />
monaco Gregorio Pantraccoli che lo eseguì negli anni 1755-57.<br />
Uscendo dalla cappella, a sinistra, una tela di Lorenzo Lippi: La Trinità e due angeli del<br />
1665. Al lato sinistro dell'altare è posto il monumentale leggìo, in noce intagliato, opera del<br />
1592 di Domenico Atticciati, e che si trovava anticamente nel coro della chiesa.<br />
Sacrestia<br />
La pala d'altare è di Luigi Sabatelli e raffigura s. Bernardo degli Uberti (morto nel 1133),<br />
cardinale e vescovo di Parma, già abate di Vallombrosa, mentre, nell'atto di celebrare la<br />
Messa, viene aggredito da alcuni eretici.<br />
Gli armadi degli arredi sacri vennero fabbricati dal monaco Mauro Boninsegni (1805).<br />
Alle pareti, S.Giovanni Gualberto e i santi Giovanni Battista, Maria Maddalena e Bernardo<br />
degli Uberti, Caterina d'Alessandria, tavola dipinta nel 1508 da Raffaellino del Garbo<br />
(morto nel 1525), discepolo del Ghirlandaio; terracotta di Luca della Robbia (morto nel<br />
1482), ai lati della Vergine, S. Giovanni Gualberto e S. Umiltà (morto nel 1310), in basso,<br />
Biagio Milanesi, abate di Vallombrosa, che commissionò l'opera e suo fratello Riccardo.
Usciti dalla sacrestia, sulla sinistra, l'altare di s. Sebastiano con una tela raffigurante il suo<br />
martirio opera di Alessandro Rosi.<br />
L'Aula Capitolare<br />
L'Aula capitolare è un'ambiente caratteristico del monastero, dove la comunità si radunava<br />
per la lettura della Parola di Dio, per l'accusa delle proprie colpe, per le conferenze<br />
spirituali, per trattare argomenti riguardanti la vita materiale della comunità, per ricordare<br />
i confratelli defunti ivi sepolti.<br />
Oggi è adibita a sala di conferenze per incontri e convegni.<br />
Alle pareti 12 tele di Venturino Venturi raffiguranti episodi della vita di S. Benedetto<br />
(1998).<br />
Sulla porta è da notare un'affresco raffigurante s. Benedetto ritratto con i tradizionali<br />
attributi iconografici: la Regola e un fascio di verghe.<br />
Il Chiostro principale<br />
Dalla porta di fronte alla sacrestia si accede al chiostro principale, detto anche della<br />
Meridiana. Sulla destra è visibile il muro perimetrale della costruzione romanica della<br />
chiesa, messo in luce nel corso degli ultimi restauri. La costruzione del chiostro risale agli<br />
anni 1470 - 1480; l'aspetto attuale è il risultato di posteriori rifacimenti. Nel 1753 vennero<br />
ampliate le finestre e le quattro grandi porte. Il chiostro è coperto da volte a crociera su<br />
peducci variamente decorati fra i quali spiccano quelli recanti figurazioni umane, santi o<br />
monaci, opera di discepoli di Benedetto da Rovezzano.<br />
Refettorio<br />
Si presenta nella trasformazione barocca realizzata negli anni 1740-1745. Sono di questa<br />
epoca i tavoli e gli schienali. Alle pareti quattordici tele di Ignazio Hugford, raffiguranti la<br />
Cena di Emmaus, s. Benedetto, s. Giovanni Gualberto e altri santi e beati vissuti a<br />
Vallombrosa; sulla volta l'Assunzione, sempre di Hugford.<br />
Sulla destra, il pulpito, perché secondo la Regola, a tavola non deve mai mancare la lettura.<br />
Antirefettorio<br />
Il refettorio è collegato alla cucina tramite un vestibolo<br />
ove si osserva il lavabo in pietra (1606) e una robbiana,<br />
opera di Benedetto Buglioni, che rappresenta la<br />
Madonna tra s. Giacomo maggiore e s. Giovanni<br />
Gualberto.<br />
La cucina<br />
Sull'architrave della porta è incisa la frase di S. Paolo:<br />
Regnum Dei non esta esca et potus
(Il Regno di Dio non è questione di cibo e di bevande).<br />
La cucina è uno degli ambienti più caratteristici dell'abbazia, ariosa ed armonica nelle<br />
proporzioni. Il caratteristico<br />
focolare con cappa<br />
esagonale, sorretta da<br />
pilastri, separa la parte<br />
quattrocentesca da quella<br />
seicentesca, restaurato una<br />
prima volta nel 1789.<br />
Accanto al camino, un forno<br />
per il pane e l'acquaio. Sui<br />
tavoli in pietra sono<br />
collocati utensili<br />
appartenenti alla cucina e<br />
all'antica spezieria del<br />
monastero.<br />
L'antica farmacia<br />
Uscendo dal portone<br />
centrale dell'Abbazia, sulla<br />
destra si accede alla farmacia. Vi si possono acquistare prodotti dell'Abbazia.<br />
La Comunità dei Monaci Vallombrosani...<br />
formano un ramo dell'ordine benedettino; il loro nome deriva da Vallombrosa, luogo<br />
montano ad una trentina di chilometri da Firenze, dove il fondatore, san Giovanni<br />
Gualberto, si ritirò intorno al 1036 con alcuni compagni<br />
per vivere con rinnovato ardore l'originario spirito della regola di san Benedetto,<br />
dedicandosi alla preghiera, al lavoro, all'accoglienza dei pellegrini. Alla scelta di un'austera<br />
vita monastica, Giovanni Gualberto fu indotto da un evento miracoloso: raccolto in<br />
preghiera nella chiesa di San Miniato al Monte dinanzi al Crocifisso, dopo che aveva<br />
coraggiosamente perdonato l'uccisore del fratello, egli vide il Cristo piegare la testa in<br />
segno di approvazione.<br />
Presto alla riforma monastica di Vallombrosa si unirono altri monasteri in Toscana e fuori,<br />
sotto la guida carismatica del Gualberto formando la Congregazione Vallombrosana<br />
riconosciuta ufficialmente dal Papa Urbano II nel 1090.<br />
Santa Trinita<br />
Alla Congregazione Vallombrosana, che ebbe subito notevole diffusione in Toscana, si unì<br />
presto il Monastero di Santa Trinita forse già nel corso dell’XI secolo. Qui, appena fuori<br />
dell’antica cerchia muraria, sul sito di un oratorio noto fin dai tempi di Carlo Magno, i<br />
vallombrosani eressero una prima chiesa - in stile romanico - dedicata alla Ss. Trinità. Con<br />
l’espansione della città e la costruzione della seconda cerchia muraria (1172-1173) questa<br />
chiesa risultò inglobata nel tessuto abitativo acquistando l'importanza dei grandi<br />
monasteri urbani, quale la Badia Fiorentina, e ricevette quindi il titolo abbaziale. La
comunità svolge un ruolo di grande importanza nella storia della città e della<br />
Congregazione.<br />
Così, nel clima di un rinnovamento architettonico della Firenze due-trecentesca (che vide<br />
sorgere Palazzo Vecchio, le grandi basiliche degli ordini mendicanti e il nuovo duomo),<br />
anche Santa Trinita fu ampliata con la sovrapposizione - proprio sulle mura della<br />
precedente - di una chiesa più alta e più lunga, in stile gotico. La sua pianta a croce egizia<br />
riprende quella delle chiese degli ordini mendicanti , ma presenta anche - per la prima<br />
volta nel gotico toscano - vere e proprie cappelle lungo le navate laterali. L'interno, a tre<br />
navate con volte a crociera, fu affrescato da famosi artisti del Tre-Quattrocento; nei secoli<br />
seguenti, quando la chiesa fu adattata allo spirito della Controriforma e al gusto della<br />
Firenze granducale, questa decorazione venne quasi totalmente coperta. Solo alla fine<br />
dell'Ottocento si procedette a un ripristino del suo carattere medievale, con interventi<br />
anche di ripittura e integrazioni, che furono poi rimosse nei più recenti restauri degli anni<br />
Sessanta di questo secolo.<br />
Nell'interno sono presenti opere del Vasari, Giovanni della Robbia, Benedetto da<br />
Rovezzano ed opere della scuola dell'Orcagna.<br />
Nella chiesa sono conservati le scaglie di pietra del Santo Sepolcro con le quali si accende il<br />
Fuoco della Pasqua, e il Porta fuoco con il quale viene trasportato alla Cattedrale.<br />
Dopo le soppressioni, Napoleonica prima e dello stato Italiano dopo, il monastero fu<br />
convertito in una scuola pubblica ed oggi vi è una sezione dell'Università di Firenze, più<br />
precisamente la facoltà del Magistero. Ai pochi monaci superstiti è rimasta solo una<br />
minima parte come residenza per esercitare il ministero parrocchiale.<br />
Badia a Passignano<br />
Il monastero di Badia a Passignano già esistente alla fine del secolo X, nel 1050 fu affidato<br />
a S. Giovanni Gualberto (+ 1073) perché vi ripristinasse la vita monastica secondo la<br />
Regola di San Benedetto, sintetizzata nel motto "Ora et labora": preghiera e lavoro.<br />
Parte del complesso monumentale è stato costruito nel secolo XIII in stile romanico:<br />
facciata della Chiesa, Cripta, Campanile; gran parte del monastero, invece, fu ristrutturato<br />
in stile rinascimentale nel secolo XV.<br />
Molto importante e significativo è l’affresco nel Refettorio Monastico che rappresenta<br />
l’Ultima Cena di Domenico Ghirlandaio che realizzò nel 1476, il Chiostro interno nel 1455:<br />
questo è stato il periodo più fulgido del monastero sotto la guida dell’Abate Francesco<br />
Altoviti e Isidoro del Sera.<br />
Per le vicende a tutti note, i monaci furono espulsi dal monastero il 10 ottobre 1810 con la<br />
prima soppressione napoleonica, che però riacquistarono nel 1818, insediandovi una<br />
piccola Comunità.<br />
A pochi anni di distanza, nel 1866, vi fu la soppressione voluta dal Governo Italiano e la<br />
Badia fu venduta all’asta.<br />
Anche in questo periodo di allontanamento dei monaci dal monastero, 2 o 3 monaci sono<br />
rimasti sempre a custodire le spoglie mortali del loro fondatore S. Giovanni Gualberto.<br />
Solo nel 1986, il 10 ottobre, i monaci sono potuti rientrare nel monastero e ripristinare la<br />
vita monastica con una piccola comunità.<br />
In questi ultimi anni, sono stati fatti vari interventi nelle opere murarie: revisione di gran
parte di tetti, risistemazione dell’ex-infermeria, nei locali dell’ex-fattoria è stata aperta una<br />
piccola foresteria, che si spera di ampliare. www.passignano.org<br />
Santuario di Montenero<br />
I monaci Vallombrosani dell'Ordine di San Benedetto, custodi del Santuario, centro di<br />
questo meraviglioso paesello, che gelosamente custodisce la Venerata Immagine della<br />
Madonna di Montenero, datano la loro presenza nel 1790.<br />
Notizie storiche parlano di un eremita vallombrosano della Sambuca già custode<br />
dell'Immagine nel 1400. Tuttavia dal loro ingresso i monaci si sono sempre prodigati per<br />
l'ampliamento e l'abbellimento del Santuario nonché la divulgazione della devozione verso<br />
la Madre di Dio.<br />
Il Santuario di Montenero è sorto nel XIV secolo, con "l' apparizione dell'immagine della<br />
Madonna" (15 maggio 1345) a un pastore, nei pressi dell' Ardenza, dove ora sorge, a<br />
ricordo, la suggestiva Cappella dell'Apparizione.<br />
L'attuale costruzione del Santuario è stata realizzata in periodi diversi: alcune parti sono<br />
del 1500, altre del 1700.<br />
Possiede pregevoli opere d'arte: il dossale fiammingo del sec. XV, la Crocifissione; l'antico<br />
altare di marmo; innumerevoli quadri ex-voto che rivestono le pareti e le Gallerie, tra cui<br />
l'ex-voto di Giovanni Fattori e quello di Renato Natali; il prezioso soffitto d'oro del 1600; il<br />
parato artistico in laminato d'oro; etc. www.santuariomontenero.org<br />
Parrocchia delle Grazie<br />
Nel 1966 viene affidato il Santuario della B.V. delle Grazie alla cura dei Monaci Benedettini<br />
di Vallombrosa.<br />
L’anno 1624, come si legge nelle Aggiunte alla Cronaca di Sebastiano Mantica, apparve la<br />
Madonna delle Grazie che stava dipinta sopra un capitello lungo la via che da Pordenone<br />
correva a San Gregorio. Il fatto miracoloso richiamò i Pordenonesi a visitare l’Immagine<br />
della Beata Vergine e a fare copiose offerte così che si potè pensare alla erezione di una<br />
Chiesa (1626). Da quel dì crebbe sempre più la venerazione per la taumaturga Immagine.<br />
All’interno della chiesa è conservata la tela della Madonna, dipinta da P. Varottari detto il<br />
Padovanino.<br />
Il Tempio conserva la sua classica imponenza. La facciata, sormontata da un armonioso<br />
rosone, si apre solenne sul piazzale antistante; mentre l’interno, a tre navate con transetto,<br />
è particolarmente raccolto e suggestivo. L’attenzione è rivolta all’immagine della Vergine,<br />
al di sopra dell’altare maggiore, maternamente protesa verso i suoi figli.<br />
Pitture e arredi subirono gravi danni per l’inondazione del Noncello del 1966. Negli anni<br />
successivi i Monaci Benedettini di Vallombrosa provvidero al restauro ed alla<br />
ristrutturazione. L’organo, inaugurato nel 1975 con un applauditissimo concerto, era stato<br />
ideato dai Religiosi come omaggio finale al loro fondatore San Giovanni Gualberto, nel IX<br />
Centenario della sua morte.<br />
A lato dell’altare delle celebrazioni si erge maestoso un grande Crocifisso in bronzo, opera<br />
della scultrice fiorentina Amalia Ciardi-Duprè.<br />
Delle antiche tavolette votive ne rimangono una decina, sufficientemente significative per<br />
testimoniare nel tempo la pietà dei fedeli.
La Vergine delle Barche del primitivo Capitello e dell’antica chiesa e quella attuale delle<br />
Grazie, rimane per eccellenza la "Madonna dei pordenonesi", la loro venerata e celeste<br />
Patrona; mentre il Santuario continua ad essere un segno visibile della presenza di Dio, un<br />
luogo privilegiato della sua misericordia.<br />
Orari delle Sante Messe<br />
Estivo (luglio e agosto):<br />
Nei giorni feriali:<br />
07:00 ; 10:00 ; 18:00<br />
Nei giorni festivi:<br />
09:30 ; 11:00 ; 17:00 ; 18:00<br />
Invernale (da settembre a giugno):<br />
Nei giorni feriali:<br />
07:00<br />
Domenica e Festivi<br />
ore 11.oo; 17.oo