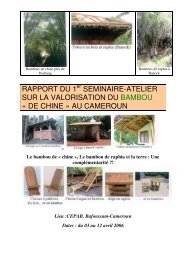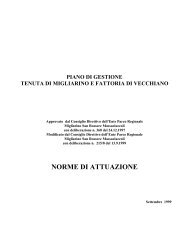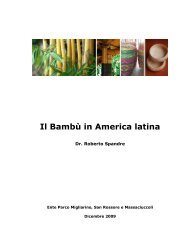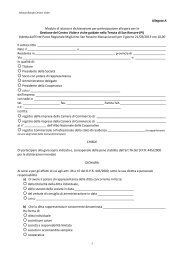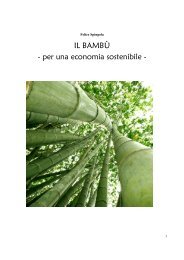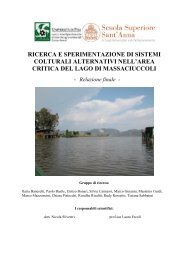Scarica il libro - Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Scarica il libro - Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Scarica il libro - Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
eNte PARco NAtuRAle MigliARiNo SAN RoSSoRe MASSAciuccoli<br />
<strong>Parco</strong> Naturale <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong><br />
Guida Natura<br />
ViAggio AllA ScoPeRtA del PARco<br />
Ambiente<br />
Flora<br />
Fauna
ENTE PARCO NATURALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI<br />
<strong>Parco</strong> Naturale <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong><br />
GUIDA NATURA<br />
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL PARCO<br />
Ambiente<br />
Flora<br />
Fauna
Testi Francesca Logli (botanica, selvicoltura e ecologia)<br />
Luca Gorreri (agricoltura)<br />
Antonio Perfetti (ecologia, conservazione della natura e zoologia)<br />
Illustrazioni Ombretta <strong>San</strong>ti (acquarelli e particolari grafici)<br />
Progetto grafico Ombretta <strong>San</strong>ti<br />
Coordinamento editoriale Sergio Paglialunga<br />
Susanna Paoli<br />
Si ringraziano le Prof.sse Benedetta Battisti e Lucia Stelli per la gent<strong>il</strong>e collaborazione ai contributi forniti<br />
Il presente volume è stato realizzato con <strong>il</strong> finanziamento del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca<br />
(ex art. 4 Legge 6/2000 per la diffusione della cultura scientifica)<br />
© 2006 Ente <strong>Parco</strong> Regionale <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong> - Pacini Editore SpA<br />
ISBN 88-7781-770-4<br />
Realizzazione editoriale<br />
Via A. Gherardesca<br />
56121 Ospedaletto (Pisa)<br />
Fotolito e Stampa<br />
Industrie Grafiche Pacini<br />
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso<br />
previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 apr<strong>il</strong>e 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO,<br />
CONFESERCENTI <strong>il</strong> 18 dicembre 2000.<br />
Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione r<strong>il</strong>asciata dall’Editore.
Prefazione<br />
Il presente volume nasce dalla volontà di offrire uno strumento di lavoro e un sussidio didattico agli insegnanti e agli studenti della Scuola Media<br />
Inferiore. La motivazione che ha condotto l’Ente <strong>Parco</strong> ad affrontare un tale lavoro è stata la necessità di riaffermare <strong>il</strong> proprio ruolo come<br />
educatore di tutta la cittadinanza e delle nuove generazioni in particolare.<br />
Del resto, tra gli elementi che caratterizzano la cultura della nostra società negli ultimi decenni, emerge la progressiva diminuzione nel sapere<br />
collettivo, della conoscenza del territorio e delle caratteristiche dell’ambiente, inteso come complessità di fattori.<br />
Il passare ad una economia industriale prima e post-industriale poi, ha reso meno dipendenti i nostri “lavori” dalle condizioni ambientali e dagli<br />
elementi naturali.<br />
Per l’agricoltore era fondamentale conoscere non solo l’evoluzione delle stagioni, ma anche l’assetto idraulico e la struttura dei terreni, le<br />
operazioni necessarie per <strong>il</strong> mantenimento di un bosco; da queste conoscenze dipendeva la sua capacità di sostenere la propria famiglia.<br />
I processi di urbanizzazione, <strong>il</strong> superamento della famiglia patriarcale, i miti di una presupposta modernità, hanno interrotto quel flusso costante<br />
di trasmissione della cultura materiale e della conoscenza del territorio, della fauna, della flora e del loro reciproco equ<strong>il</strong>ibrio.<br />
Queste conoscenze rappresentavano <strong>il</strong> presupposto del rispetto e della stessa cautela nell’ut<strong>il</strong>izzo produttivo del territorio.<br />
Le profonde trasformazioni sociali ed economiche della nostra società, se da una parte hanno consentito un notevole e positivo miglioramento<br />
delle condizioni di vita, hanno, per altro, prodotto un distacco tra uomo e natura.<br />
Il contributo che un parco naturale o un’area protetta in generale può dare alla collettività non si limita solo all’attuazione di azioni tese alla<br />
salvaguardia di ambienti naturali, ma deve prevalentemente indirizzarsi verso lo sv<strong>il</strong>uppo della conoscenza dell’ambiente, la diffusione di una<br />
migliore educazione ambientale, attraverso fattive collaborazioni con le scuole, gli enti locali, <strong>il</strong> mondo della cultura e delle scienze.<br />
Questa pubblicazione rappresenta un proficuo esempio per mezzo del quale si è prodotto un concreto e sicuramente duraturo strumento di<br />
conoscenza del nostro territorio, affrontando in modo approfondito i diversi aspetti che costituiscono la storia e la cultura di questo territorio.<br />
Il Presidente<br />
Giancarlo Lunardi<br />
3
TITOLO CAPITOLO
...<strong>il</strong> nostro parco<br />
Lo scopo principale di un Ente <strong>Parco</strong> è la tutela del territorio. Il modo con cui questa si attua è molteplice. Siamo convinti che per tutelare la<br />
natura presente sul nostro territorio, una delle condizioni fondamentali è innanzitutto farla conoscere ed apprezzare, in modo guidato ed intelligente,<br />
sv<strong>il</strong>uppando nel visitatore, piccolo o adulto, turisti o scuole, un senso educato di rispetto e di affetto. Stare in un <strong>Parco</strong>, educare all’ambiente,<br />
conoscere “sul campo” i suoi delicati equ<strong>il</strong>ibri anche con i suoi problemi, i suoi paesaggi ed i suoi numerosi abitanti, i suoi prodotti sono<br />
per noi le migliori azioni per comprendere e rispettare <strong>il</strong> valore ed <strong>il</strong> significato della gestione attiva della natura. Allo stesso tempo oggi, le aree<br />
protette sono in grado di proporsi come veri e propri laboratori territoriali dove “tutela e valorizzazione” dell’ambiente vanno d’accordo.<br />
Ma, già dai primi anni dall’istituzione, l’Ente <strong>Parco</strong> ha attuato anche un’azione di educazione naturalistica ed ambientale, perché la conoscenza<br />
è la premessa all’affezione, dalla quale nasce un rispetto profondo per l’ambiente ed un ulteriore stimolo per <strong>il</strong> sapere, contribuendo<br />
a creare nel giovane la coscienza di diventare un cittadino attivo e partecipe alla vita della terra e del pianeta in cui vive. A metà degli anni<br />
ottanta, Pierluigi Cervellati, redattore del Piano del <strong>Parco</strong>, scriveva che questo territorio “stupisce ed istruisce”, mettendo in evidenza come lo<br />
stupore suscitato dalla visita del parco faccia nascere <strong>il</strong> desiderio di conoscere più profondamente la realtà che lo costituisce, le dinamiche<br />
che lo rendono vivo, l’origine dei suoni e dei colori che lo animano.<br />
I Programmi di educazione ambientale che presentiamo vogliono offrire un complesso panorama di arte, storia e natura davvero speciale.<br />
Da noi vi aspettano antiche dune, lame, <strong>il</strong> lago di <strong>Massaciuccoli</strong>, pinete, boschi, paduli, uccelli, flora e fauna di rara bellezza. Tutti elementi<br />
questi che si fondono armoniosamente con affascinanti viali, edifici e manufatti, vissuti da una storia che ha garantito un alto grado di bio-diversità<br />
e di civ<strong>il</strong>tà. L’offerta presentata è molteplice, per rispondere alle esigenze e curiosità che caratterizzano l’età giovan<strong>il</strong>e, e ai programmi<br />
educativi attuati dalle varie scuole. Ma i nostri programmi sono rivolti anche ad un pubblico adulto, che, nell’ottica del concetto della life<br />
long learning, cioè nell’ottica dell’apprendimento durante tutto l’arco della vita, può trovare o approfondire nuove realtà, trattate da guide<br />
esperte ed appassionate.<br />
L’elemento centrale di queste nostre proposte è la visita e la conoscenza diretta del territorio del parco. Riteniamo infatti, che in una società<br />
come la nostra, in cui sempre più spesso la realtà virtuale sostituisce l’esperienza diretta, <strong>il</strong> contatto personale e fisico sia essenziale per apprezzare<br />
gli ambienti del parco. Il visitatore giovane o adulto viene dunque completamente coinvolto, tutti i suoi sensi devono poter essere sollecitati.<br />
Tutti gli strumenti messi poi a disposizione dalla tecnologia aiuteranno nell’approfondimento e nella conoscenza senza mai sostituire l’incontro<br />
personale e fisico con gli ambienti per favorire un’esperienza di coinvolgimento totale in questa “aula verde” a cielo aperto. È in questa ottica<br />
che l’Ente <strong>Parco</strong> ha iniziato a realizzare percorsi e strumenti anche per coloro che hanno difficoltà motorie, sensitive, psicologiche, ecc. Infatti,<br />
a tutti deve essere permesso un contatto diretto con la natura, perché è da questo che nasce lo stupore che attiva la curiosità del ragazzo e<br />
dell’adulto, così che la conoscenza non sia solo un dovere o un passatempo, ma la risposta ad una domanda e ad un desiderio, che arricchirà<br />
nel ragazzo l’approccio alla vita e nell’adulto, apporterà nuova consapevolezza e forse, un nuovo modo più maturo e corretto di relazionarsi<br />
con l’ambiente naturale.<br />
Pisa marzo 2006<br />
Il Consigliere all’Educazione Ambientale<br />
Paolo Cassola
TITOLO CAPITOLO
INDICE<br />
- Introduzione pag. 11<br />
- Sezione 1 - INQUADRAMENTO AMBIENTALE<br />
Il paesaggio tra ecologia, geografia e storia pag. 13<br />
Lo studio dell’ecologia e del paesaggio pag. 13<br />
Un parco tra terra e acqua, dove <strong>il</strong> mondo è in continuo cambiamento pag. 15<br />
Le caratteristiche naturali del territorio pag. 16<br />
La gestione dell’ambiente pag. 18<br />
Le risorse economiche di un territorio pag. 21<br />
La ricchezza ecologica di un territorio pag. 26<br />
Minacce per l’ambiente pag. 28<br />
Alla scoperta degli ambienti del <strong>Parco</strong> - SCHEDE DI LAVORO pag. 31<br />
Il paesaggio ed i suoi componenti pag. 31<br />
L’osservazione sul campo del paesaggio pag. 32<br />
Sintetizza le informazioni dei vari gruppi pag. 33<br />
Analizza le osservazioni raccolte pag. 34<br />
Rappresenta <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o del paesaggio che hai attraversato pag. 35<br />
Impara ad ut<strong>il</strong>izzare una carta pag. 36<br />
Le differenti unità di paesaggio della pianura costiera pag. 37<br />
Descrivi le diverse morfologie, origine e funzione degli elementi di paesaggio osservati pag. 38<br />
Dove e perché nelle diverse aree del parco ci sono problemi ambientali pag. 39<br />
Il ciclo dell’acqua sulla costa pag. 40<br />
Compara tre ambienti rispettivamente di foresta umida, arida e agricolo di bonifica pag. 41<br />
Sintesi dei dati raccolti comparando gli ambienti pag. 41<br />
Analisi delle informazioni raccolte pag. 42<br />
7
8<br />
- Sezione 2 - LO STUDIO DELLA FLORA<br />
Lo Studio della Vegetazione pag. 43<br />
I boschi pag. 44<br />
Le pinete pag. 47<br />
I boschi misti di caducifoglie pag. 51<br />
I boschi allagati (ontanete e frassinete) pag. 54<br />
Le rampicanti e le liane pag. 59<br />
Le specie acquatiche delle zone umide pag. 62<br />
Le piante delle sabbie ovvero una vita al limite pag. 68<br />
L’albero: un monumento della natura pag. 70<br />
Alla scoperta della vegetazione del <strong>Parco</strong> - SCHEDE DI LAVORO pag. 72<br />
Costruisci un erbario pag. 72<br />
Trova la chiave di accesso nel labirinto della conoscenza delle piante pag. 73<br />
Gli alberi danno i numeri pag. 74<br />
Tanti alberi formano… pag. 75<br />
... <strong>il</strong> bosco pag. 76<br />
Scova gli alieni! pag. 77<br />
Missione di ricerca pag. 78<br />
- Sezione 3 - LO STUDIO DELLA FAUNA<br />
Lo studio della fauna: gli uccelli pag. 79<br />
Gli ambienti degli uccelli pag. 80<br />
Gli adattamenti degli uccelli pag. 81<br />
Una rondine non fa primavera… ma un rondone si!! - Le migrazioni degli uccelli pag. 83<br />
La determinazione delle specie d’uccelli pag. 86<br />
Alla scoperta della fauna del <strong>Parco</strong> - SCHEDE DI LAVORO pag. 104<br />
A ciascuno <strong>il</strong> suo… ali, s<strong>il</strong>houette, becchi, e zampe, una questione di st<strong>il</strong>i di vita pag. 104<br />
Forma, comportamento e strategie d’alimentazione pag. 105<br />
Osservare gli uccelli pag. 106<br />
Analisi delle osservazioni ornitologiche fatte pag. 107<br />
Le osservazioni ornitologiche nel tempo pag. 108
Analisi delle osservazioni ornitologiche effettuate pag. 109<br />
Trova la rotta: ricostruzione dei viaggi degli uccelli osservati pag. 110<br />
Lo studio della fauna: gli invertrebati pag. 111<br />
I gruppi principali di invertebrati pag. 111<br />
Gli adattamenti all’ambiente degli invertebrati pag. 114<br />
Alla scoperta della fauna del <strong>Parco</strong> - SCHEDE DI LAVORO pag. 115<br />
Descrizione dell’habitat, prelievo e studio degli invertebrati pag. 115<br />
Determinazione delle specie o dei gruppi di invertebrati pag. 116<br />
Incontro di generazioni: cerca quello giusto per ogni specie pag. 117<br />
Sintesi delle osservazioni degli invertebrati pag. 118<br />
Lo studio della fauna: i mammiferi pag. 119<br />
Sulle tracce dei mammiferi pag. 119<br />
Cos’è un mammifero? pag. 119<br />
Come vivono i mammiferi? pag. 119<br />
Come si osservano i mammiferi pag. 120<br />
Il Daino pag. 121<br />
Il Cinghiale pag. 122<br />
Il Tasso pag. 123<br />
L’istrice pag. 124<br />
Lo Scoiattolo pag. 125<br />
Il Coniglio selvatico pag. 126<br />
Il Riccio pag. 127<br />
Alla scoperta della fauna del <strong>Parco</strong> - SCHEDE DI LAVORO pag. 128<br />
Occhio alle tracce dei mammiferi pag. 128<br />
Analisi degli indizi trovati sui mammiferi pag. 129<br />
Sintesi delle osservazioni sui mammiferi pag. 130<br />
- Norme di comportamento per <strong>il</strong> naturalista curioso pag. 131<br />
- Per saperne di più pag. 132<br />
- I luoghi pag. 133<br />
9
“Il vero viaggio di scoperta non consiste<br />
nel cercare nuove terre,<br />
ma nell’avere nuovi occhi.”<br />
Marcel Proust
Introduzione<br />
Il <strong>Parco</strong> Regionale <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong>, istituito nel 1979, da molti anni persegue le finalità di<br />
ricerca scientifica e divulgazione naturalistica che sono due delle principali funzioni legate alla conservazione della<br />
natura. Essa avviene infatti in concreto, attraverso azioni dirette e la pianificazione di uno sv<strong>il</strong>uppo sostenib<strong>il</strong>e.<br />
La conoscenza dell’ambiente naturale è necessaria per stupirci e meravigliarci di cose reali, che vivono accanto<br />
a noi, accrescendo così una sensib<strong>il</strong>ità e un rispetto profondo verso la natura.<br />
Oggi questo aspetto risulta di particolare importanza, in un mondo globalizzato, dove la tecnologia permette di<br />
“conoscere <strong>il</strong> mondo” e di muoversi ad un ritmo senza precedenti, ma allo stesso tempo riduce la percezione diretta<br />
dell’ambiente. Causa di ciò sono in particolare, la frammentazione della conoscenza, legata allo sv<strong>il</strong>uppo delle<br />
varie specializzazioni, e dall’altro lato poi, per i ragazzi che vivono nelle città, risulta quasi assente un’esperienza<br />
naturalistica diretta per la netta divisione che si è venuta a creare tra mondo urbano e mondo naturale. Infatti<br />
spesso l’unico veicolo di esplorazione è costituito da internet e dalla televisione, necessariamente superficiali<br />
perché legati all’immagine e ai tempi veloci della comunicazione dei mass media. Al contrario le esperienze<br />
naturalistiche, che sono <strong>il</strong> vero veicolo di conoscenza, non possono essere legate a scorciatoie tecnologiche ma<br />
ai tempi della natura (giorni, stagioni, anni ecc.).<br />
Progetto MIUR del <strong>Parco</strong><br />
Questo lavoro è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per la divulgazione della cultura scientifica Italiana. Il <strong>Parco</strong><br />
Naturale <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong> vi ha aderito volendo proporre un’opera che non è un classico testo naturalistico su un parco nè una guida al<br />
riconoscimento delle specie animali e vegetali. Esso è piuttosto uno strumento in mano a studenti ed insegnanti delle Scuole secondarie di primo grado, da<br />
usare per mettere a fuoco i concetti base dell’Ecologia, di come sono fatti cioè gli ecosistemi e di come funzionano, per poi provare, toccare con mano,<br />
quello di cui si parla sia attraverso verifiche in classe sia soprattutto con esperienze sul campo.<br />
Struttura del <strong>libro</strong><br />
Il <strong>libro</strong> ha una struttura gerarchica:<br />
• È costituito principalmente da tre sezioni : la prima è relativa al paesaggio, alla sua storia, all’ecologia e agli habitat naturali e seminaturali. La seconda è<br />
relativa alla flora, mentre la terza descrive <strong>il</strong> mondo animale del <strong>Parco</strong> Naturale di <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong>.<br />
• Ognuna delle tre sezioni è suddivisa in due parti, la prima introduce i concetti generali mentre quelle successive guidano e stimolano verifiche di apprendimento<br />
in classe e esperienze sul campo. Così, all’inizio di ogni sezione ci sono delle schede generali che introducono l’argomento ed i principali temi ad esso legati<br />
con esempi sempre relativi al <strong>Parco</strong> e poi vi sono le schede di lavoro suddivise tra schede di campo e schede di analisi. Le prime permettono di pianificare,<br />
raccogliere ed organizzare le osservazioni/reperti legati all’esperienza di campagna per poi analizzarli con l’aiuto della relativa scheda di analisi. Le schede<br />
di analisi quindi hanno lo scopo di aiutare a ragionare su quanto appreso in classe o sul campo per arrivare così ad una sintesi generale e personale di ogni<br />
argomento.<br />
11
12<br />
Al termine del <strong>libro</strong> vi sono le norme di comportamento ut<strong>il</strong>i per una visita naturalistica del <strong>Parco</strong>, una piccola bibliografia per eventuali approfondimenti, e un<br />
elenco di luoghi dove è più fac<strong>il</strong>e venire in contatto con esperienze di ricerca scientifica naturalistica. I termini più complessi sono spiegati attraverso rimandi<br />
a lato del testo.<br />
Obiettivi generali<br />
Questo <strong>libro</strong> è una guida per un viaggio alla scoperta del <strong>Parco</strong> di <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong>. All’inizio di ognuna delle tre sezioni (paesaggio<br />
- flora - fauna), attraverso le schede generali, vengono forniti spunti per gli insegnanti (o approfondimenti per gli allievi) per preparare le lezioni introduttive<br />
alle esperienze di campo (schede di campo) ed alle verifiche successive (schede di analisi) dando quindi in definitiva le “coordinate d’insieme” di ogni<br />
argomento. Queste coordinate andranno a costituire una mappa mentale che ci guiderà nel lavoro in natura organizzato con l’aiuto della scheda di campo<br />
e le successive analisi delle conoscenze/osservazioni acquisite con l’aus<strong>il</strong>io delle relative schede di analisi. Questo percorso costituirà quindi, per completare<br />
la metafora, un viaggio di collaudo della nostra mappa mentale. L’ordine degli argomenti è solo uno dei possib<strong>il</strong>i, ma <strong>il</strong> percorso didattico potrà essere scelto<br />
liberamente a seconda della stagione, del tempo, degli ambienti e, perché no, del gusto degli insegnanti e degli allievi.<br />
Questa esperienza ci invoglierà probab<strong>il</strong>mente a formulare risposte ed ipotesi, ma soprattutto nuove domande che potranno stimolarci nella ricerca di nuove<br />
esperienze naturalistiche e di acquisizione di ulteriori conoscenze; per così dire cioè, ad aggiornare la nostra mappa, portando, ci auguriamo, un po’ di amore<br />
e di rispetto per l’ambiente naturale.<br />
Contenuti<br />
In base ai programmi ministeriali d’insegnamento delle materie scientifiche, si affrontano i seguenti temi tenendo presente la scala territoriale del <strong>Parco</strong>:<br />
• L’evoluzione del paesaggio: la formazione ed i componenti di un paesaggio e l’influenza dell’uomo.<br />
• Conoscenza delle caratteristiche del nostro ambiente: habitat e nicchie ecologiche; influenza sulla distribuzione degli esseri viventi, ambienti naturali,<br />
seminaturali e artificiali.<br />
• Gli esseri viventi e l’adattamento all’ambiente: migrazioni, riproduzione, alimentazione, osmosi e respirazione.<br />
• Le popolazioni animali e vegetali: come sono regolate e come influisce l’uomo.<br />
• Rapporto tra gli esseri viventi: reti alimentari, commensalismo, parassitismo.<br />
Approccio<br />
Viene ricercato lo sv<strong>il</strong>uppo di una sensib<strong>il</strong>ità verso l’ambiente con un approccio scientifico. È importante tuttavia, per evitare fraintendimenti, tenere presente<br />
che nelle scienze biologiche gli stessi fenomeni possono avere spiegazioni che sottendono almeno a quattro diverse sfaccettature (conosciute come le<br />
quattro domante di Tinbergen) 1 : adattativa (in funzione all’ut<strong>il</strong>ità per l’animale o la pianta) – causa (esterna o interna p.e. fisiologica) – sv<strong>il</strong>uppo (legata alla<br />
crescita dell’individuo) – storia evolutiva. In questo testo naturalmente, lavorando a livello descrittivo/percettivo, è soprattutto la prima, relativa alla funzione<br />
quella che è più ut<strong>il</strong>izzata nelle spiegazioni dei fenomeni biologici osservati. Tuttavia spesso sono accennate o sottese anche quelle evolutive o legate alle<br />
cause. Questo approccio vuole in ogni caso trasferire e fare applicare i contenuti appresi a scuola in un ambiente specifico, <strong>il</strong> <strong>Parco</strong>, attraverso esperienze<br />
dirette e concrete, sul campo, secondo lo schema:<br />
1. Definizione di una problematica generale. 2. verifica di quanto appreso. 3. Raccolta dati sul campo. 4. Analisi, sintesi ed interpretazione degli stessi.<br />
Tutto questo nella convinzione che sarà la conoscenza e non certo l’ignoranza o <strong>il</strong> pregiudizio, ad aumentare fascino, stupore e rispetto per la Natura.<br />
1 Tinbergen N. 1963. On aims and methods of ethology. Z. Tierpsychol. 20: 410-33.
IL PAESAGGIO TRA ECOLOGIA, GEOGRAFIA E STORIA<br />
LO STUDIO DELL’ECOLOGIA<br />
E DEL PAESAGGIO<br />
Cosa è un paesaggio?<br />
Il paesaggio è l’immagine d’insieme che si<br />
presenta ad un osservatore. È <strong>il</strong> risultato di<br />
una storia molto lunga, dell’interazione tra<br />
le numerose forze della natura, compreso <strong>il</strong><br />
lavoro dell’uomo.<br />
Che cosa è l’ecologia?<br />
L’ecologia è la scienza che studia come è<br />
costituito e come funziona l’ambiente, ai<br />
diversi livelli di organizzazione.<br />
Per esempio a livello di singoli individui,<br />
di popolazioni, di interazione tra specie<br />
diverse ed infine, tra queste ed <strong>il</strong> mondo fisico.<br />
Aren<strong>il</strong>i e foreste del <strong>Parco</strong><br />
Come e perché studiarli?<br />
Per studiare l’ambiente è necessario acquisire delle capacità di osservazione,<br />
di descrizione e di analisi supportate da un bagaglio teorico comune. Questo<br />
ABC dell’ecologia è necessario per affiancare, accanto alle sensazioni uniche<br />
che l’osservazione del mondo naturale darà a ciascuno di noi, un bagaglio<br />
comune, che ci permetta di comunicare e di confrontarsi nell’analisi e nel<br />
lavoro di gruppo. Si arriva così con tutti i nostri sensi a percepire, riconoscere<br />
e poi comprendere le componenti del paesaggio, le visuali d’insieme, le<br />
opere dell’uomo, i tipi di vegetazione, le specie animali attorno a noi. Studiare<br />
<strong>il</strong> paesaggio significa quindi comprendere <strong>il</strong> nostro territorio, come funziona,<br />
come si è formato, quale è stata l’azione dell’uomo, arrivando così ad una<br />
profonda consapevolezza della sua importanza per la nostra vita.<br />
1. La popolazione è un gruppo di<br />
individui della stessa specie che vivono<br />
su un’area geografi ca defi nita, detta<br />
areale, potendosi potenzialmente<br />
incrociare tra loro. Esempi di<br />
popolazioni biologiche sono le farnie<br />
in un bosco o le libellule di una certa<br />
specie in una palude.<br />
2. La specie è l’entità biologica<br />
comprendente tutti gli individui aventi<br />
caratteristiche sim<strong>il</strong>i, tali da essere<br />
capaci di incrociarsi tra loro e di<br />
produrre a loro volta prole fert<strong>il</strong>e.<br />
Il loro nome è per convenzione in<br />
latino, scritto in corsivo e composto<br />
da due nomi: quello del genere e<br />
quello della specie. P.e.: la ninfea è<br />
Nimphea alba.<br />
La s. è l’unità fondamentale della<br />
classifi cazione dei viventi (vedi<br />
Sistematica) al di sopra della quale<br />
vi sono <strong>il</strong> genere, la classe ecc. (vedi<br />
classe) mentre al di sotto vi è la sottospecie<br />
(o razza nel mondo animale;<br />
cultivar o varietà in quello vegetale).<br />
13
14<br />
Aren<strong>il</strong>e<br />
Dune<br />
Zona retrodunale<br />
Prof<strong>il</strong>o degli ambienti principali del bosco<br />
Pineta<br />
Le zone Dunali<br />
Boschi mesof<strong>il</strong>i<br />
Il Paesaggio del <strong>Parco</strong> Naturale di <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong><br />
Il <strong>Parco</strong> Naturale ha un paesaggio costituito da:<br />
•elementi naturali come <strong>il</strong> lago, le foci naturali, le torbiere, le paludi, le lame di fuori, le lame interne, i<br />
boschi mesof<strong>il</strong>i, le dune e le paleodune …<br />
•elementi seminaturali come le pinete di pino domestico e di pino marittimo …<br />
•elementi artificiali come le pioppete, i campi, i canali, le strade, le recinzioni, le abitazioni, le dighe, le<br />
idrovore …<br />
È l’insieme di tutto questo che dà la sensazione di paesaggio e che ci fa comunque percepire cinque<br />
unità fondamentali: la costa sabbiosa, le zone umide, le zone boscate, le zone agricole e le aree<br />
urbane.<br />
Lama Boschi mesof<strong>il</strong>i<br />
Le zone Agricole
Il territorio del <strong>Parco</strong> in cartografia<br />
Carta della Natura del <strong>Parco</strong> (© <strong>Parco</strong> MSRM-SELCA, 1997)<br />
UN PARCO TRA TERRA E ACQUA, DOVE IL MONDO È IN CONTINUO CAMBIAMENTO<br />
Inquadramento geografico<br />
Il <strong>Parco</strong> si trova nella pianura toscana nord<br />
occidentale tra le città di Livorno, Pisa, Lucca e<br />
Viareggio. È una striscia costiera larga tra 5 e 10<br />
ch<strong>il</strong>ometri e lunga da nord a sud circa 30 ch<strong>il</strong>ometri,<br />
con una superficie di circa 23000 ettari.<br />
Origine della pianura pisano-vers<strong>il</strong>iese<br />
Il <strong>Parco</strong> di <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong> è<br />
un territorio da sempre conteso tra terra ed acqua.<br />
120.000 anni fa per esempio, la Terra attraversò un<br />
periodo piuttosto caldo, ed <strong>il</strong> livello del mare superò<br />
di 6 metri quello di oggi, cosicché <strong>il</strong> nostro <strong>Parco</strong> fu<br />
quasi per intero una distesa sottomarina.<br />
Durante la fase più fredda dell’ultima glaciazione,<br />
18.000 anni fa, <strong>il</strong> livello del mare fu invece inferiore<br />
di 120 metri rispetto all’attuale, così da poter<br />
camminare fino alle Secche della Meloria ed oltre…<br />
La maggior parte del territorio attuale tuttavia si<br />
originò negli ultimi 4.000 anni (dall’età del Bronzo)<br />
con la formazione progressiva di nuove dune,<br />
alternata a depressioni allagate, e con tremende<br />
alluvioni che hanno portato grandi quantità di<br />
sedimenti e detriti nelle zone depresse. L’uomo poi,<br />
almeno fin dal tempo degli Etruschi, ha cercato di<br />
frenare o deviare i fiumi, di colmare o modificare le<br />
paludi, per guadagnare terra e allontanare l’acqua.<br />
È così che si sono formati <strong>il</strong> Lago del <strong>Massaciuccoli</strong>,<br />
le Lame di <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong>, gli stagni retrodunali della<br />
Macchia Lucchese e le piccole lagune di Bocca di<br />
Serchio. Ed è così che sono scomparsi <strong>il</strong> Padule di<br />
Vecchiano e <strong>il</strong> Padule di Coltano … che <strong>il</strong> Serchio<br />
non incontra più l’Arno o che <strong>il</strong> Fiume Morto Nuovo<br />
drena parte della Piana Pisana.<br />
Immagine satellitare del <strong>Parco</strong><br />
© NASA 2006<br />
15
16<br />
Evoluzione del Territorio del <strong>Parco</strong><br />
LE CARATTERISTICHE NATURALI DEL TERRITORIO<br />
Le esondazioni dei fiumi<br />
Le piene dei fiumi Arno, Serchio<br />
e, in seconda battuta, del Magra<br />
a nord, hanno apportato enormi<br />
masse di sedimenti. Durante le fasi<br />
glaciali, quando <strong>il</strong> mare era ai livelli più<br />
bassi, gli stessi hanno contribuito con le loro<br />
esondazioni ad interrire la depressione tettonica della<br />
Vers<strong>il</strong>ia, fino a determinare la formazione della pianura pisanovers<strong>il</strong>iese.<br />
Le esondazioni più recenti poi, hanno portato coni di<br />
materiale grossolano (alluvionale) che si trovano in superficie nelle<br />
adiacenze dei fiumi attuali o nei paleoalvei.<br />
La costa marina e le dune foss<strong>il</strong>i<br />
Durante le fasi di scioglimento dei ghiacciai, i livelli marini si<br />
sono innalzati ed è stato <strong>il</strong> mare a portare sabbie e ad interrire la fossa pisano-vers<strong>il</strong>iese.<br />
Questo ha portato ad un accumulo di sabbie s<strong>il</strong>icee; alternate ai depositi torbosi (vedi<br />
Parte 2 – La Flora) o alluvionali delle zone umide. E proprio questi accumuli di sabbie<br />
hanno costituito, fino al divieto imposto dal <strong>Parco</strong>, una grande risorsa economica per<br />
la produzione di cemento. Gli apporti di sedimenti fluviali, <strong>il</strong> vento e le correnti marine<br />
hanno contribuito allo sv<strong>il</strong>upparsi di dune che, almeno da 2800 anni fa ad oggi sono<br />
progredite verso mare.<br />
Le più antiche, di epoca etrusca, si trovano a 4-5 ch<strong>il</strong>ometri dall’attuale linea di costa.<br />
Negli ultimi 150 anni si è invece r<strong>il</strong>evato un effetto contrario: l’erosione costiera.<br />
MARE<br />
VENTO<br />
NUOVA DUNA<br />
LAMA<br />
DUNA CONSOLIDATA<br />
4. La depressione tettonica è la<br />
depressione delle crosta terrestre<br />
causata dallo scontro o dalla<br />
distensione di due zolle (o placche)<br />
che sono le unità in cui è formata la<br />
crosta terrestre.<br />
5. I paleoalvei sono zone in cui<br />
passava nel passato un corso fl uviale<br />
poi deviato per cause naturali o per<br />
l’intervento umano. E’ un esempio<br />
di paleoalveo la zona del Paduletto<br />
della Riserva Naturale omonima a<br />
<strong>San</strong> <strong>Rossore</strong>.<br />
6. Le sabbie s<strong>il</strong>icee sono un<br />
materiale minerale incoerente, in fi ni<br />
granuli di dimensioni comprese tra<br />
0,0625 e 2 mm, di solito costituita<br />
da quarzo (s<strong>il</strong>ice) con piccole<br />
proporzioni di altri minerali che non<br />
si sciolgono nell’acqua. La sabbia<br />
è <strong>il</strong> prodotto della disintegrazione<br />
chimica e meccanica di rocce per<br />
effetto dell’alterazione meteorica e<br />
dell’erosione. La sabbia è <strong>il</strong> costituente<br />
più importante della maggior parte<br />
dei suoli del <strong>Parco</strong>.
L’accumulo di acqua dolce<br />
Con <strong>il</strong> progressivo interrirsi del bacino tirrenico-vers<strong>il</strong>iese, <strong>il</strong> livello del terreno<br />
si è rialzato rispetto al mare e la linea di costa si è distanziata dalla laguna,<br />
formando un lago di acqua dolce, separato dal mare. Avviene in questo<br />
modo lo sv<strong>il</strong>uppo delle paludi (con i canneti, i giuncheti, le sfagnete, le piante<br />
acquatiche e gli animali tipici di tali zone.<br />
Canneti nel lago<br />
Paleodune nei boschi del <strong>Parco</strong> (linee<br />
rosse) e mancanza di sottobosco (ombreggiatura<br />
rosa) dovuta al grande numero<br />
di ungulati (Foto A. Perfetti).<br />
Le Lame<br />
Clima e microclimi<br />
La temperatura e la presenza abbondante di acqua, sia meteorica che nel<br />
terreno, determinano un’ulteriore chiave di lettura del paesaggio: da ovest<br />
ad est l’influenza delle acque salate diminuisce, in profondità (anche pochi<br />
decimetri), seguendo anche <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o delle paleodune o la depressione<br />
del <strong>Massaciuccoli</strong>. La distanza media dall’acqua di falda fa sv<strong>il</strong>uppare<br />
vegetazione igrof<strong>il</strong>a o arida (p.e. leccete e pinete vs. torbiere, farnie e<br />
ontanete); da nord a sud infine, un occhio esperto può individuare un netto<br />
aumento di specie mediterranee, legate ad estati secche e ciò è dovuto ad<br />
un aumento di precipitazione verso nord (di oltre 150 mm/anno in circa 30<br />
Km) a causa dell’effetto barriera per i venti marini carichi di nubi, esercitato<br />
dalle Alpi Apuane.<br />
17
I terreni del <strong>Parco</strong> (al = terreni alluvionali; p = terreni palustri<br />
con torbe; d = sabbie s<strong>il</strong>icee marine e altri terreni d’origine<br />
eolica. Qui è <strong>il</strong>lustrata la parte nord, quella di <strong>Massaciuccoli</strong>,<br />
<strong>Migliarino</strong> e della Macchia Lucchese con le Alpi Apuane e i<br />
Monti d’Oltre Serchio ad est; r = struttura delle Alpi Apuane e<br />
dei Monti d’Oltre Serchio).<br />
18<br />
LA GESTIONE DELL’AMBIENTE<br />
Un paesaggio costruito: cos’è una<br />
bonifica<br />
Almeno fin dall’epoca etrusca sono stati numerosi<br />
i tentativi di liberare i territori dall’acqua.<br />
Questo avveniva per ragioni di sicurezza,<br />
per la necessità di coltivare nuove terre<br />
e per combattere la malaria. Colmare zone<br />
depresse, naturalmente allagate, ha quindi<br />
sempre rappresentato un importante obiettivo,<br />
che in un primo tempo si realizzava<br />
sfruttando la forza delle piene e deviando<br />
i corsi d’acqua. L’allontanamento delle acque<br />
e l’apporto di sedimenti contribuivano<br />
a colmare un territorio. In seguito poi, con<br />
l’invenzione del motore ci furono pompe in<br />
grado di sollevare l’acqua e portarla attraverso<br />
canali regimati verso mare, anche da<br />
terreni sotto al livello del mare (bonifica per<br />
sollevamento).<br />
Il paesaggio delle bonifiche è attualmente<br />
un paesaggio agrario dove i terreni sono,<br />
alluvionali, arg<strong>il</strong>losi, sabbiosi o torbosi a seconda<br />
della loro storia precedente.<br />
Bonifica per colmata<br />
Bonifica per scolo<br />
naturale delle acque<br />
7. La malaria è una malattia legata<br />
alle zone umide perché l’organismo<br />
che la provoca (plasmodio della<br />
malaria) è “trasportato” da una<br />
zanzara (del genere Anopheles)<br />
che vive e si riproduce nelle paludi.<br />
Anticamente era molto diffusa anche<br />
nel Mediterraneo mentre, da circa 50<br />
anni, anche a causa delle bonifi che,<br />
è confi nata soprattutto all’Africa e al<br />
Sud America.
Gestire le zone umide regimate<br />
Una volta messe le dighe, si perde, dal punto di vista ecologico, quella straordinaria dinamicità tipica delle zone umide dove<br />
vecchi bracci fluviali e palustri s’interrano naturalmente, mentre se ne formano di nuovi, creando un gradiente fantastico di<br />
forme di vita più o meno legate all’acqua dolce o all’acqua salata.<br />
Aren<strong>il</strong>i e foreste del <strong>Parco</strong><br />
Il Lago si trasforma in Bosco<br />
Questa perdita di variab<strong>il</strong>ità ambientale<br />
porta ad una monotonia: le zone umide<br />
tendono al completo interrimento, con<br />
l’estinzione di tutte le specie ad esse legate.<br />
Questo fenomeno è specialmente<br />
contrastato con opportune operazioni di<br />
restauro ecologico, che fanno regredire<br />
la naturale evoluzione del lago verso la<br />
palude e la foresta: p.e. sfalcio dei canneti,<br />
creazione di nuovi chiari in paludi,<br />
riallagamento di vecchie bonifiche ecc.<br />
8. Sono defi nite operazioni di<br />
restauro ecologico tutte quelle azioni<br />
predisposte dall’uomo per accelerare<br />
i processi di naturalizzazione di un<br />
territorio in precedenza alterato.<br />
Spesso questo avviene “copiando”<br />
i processi naturali o accelerandone<br />
l’entità, p. e. : costruendo barriere<br />
sulla spiaggia che fac<strong>il</strong>itano<br />
l’accumulo di sabbia per ricreare le<br />
dune, o eliminando la brucatura degli<br />
ungulati (allontanandoli) laddove<br />
è necessario aumentare <strong>il</strong> rinnovo<br />
vegetazionale, o infi ne, ricreando<br />
“zone umide nuove” col taglio,<br />
la bruciatura della vegetazione<br />
palustre o lo scavo laddove l’uomo<br />
cementifi cando, erigendo argini o<br />
bonifi cando ha impedito la naturale<br />
formazione di nuove paludi o <strong>il</strong><br />
mantenimento di quelle preesistenti.<br />
9. Le foreste naturali e seminaturali<br />
sono ambienti in cui l’uomo<br />
è intervenuto, talora in maniera<br />
relativamente pesante, con taglio,<br />
pascolo, talora selezionando<br />
particolari specie, ma mai con<br />
l’introduzione di specie estranee<br />
attraverso la semina o la piantagione<br />
(foreste mesofi li, foreste igrofi li).<br />
Al suo opposto si trova la foresta<br />
artifi ciale che può avere caratteristiche<br />
di minore (p.e. pioppete, pinete di<br />
pino marittimo) o maggiore naturalità<br />
(pinete abbandonate con sottoforesta<br />
a essenze spontanee anche arboree).<br />
19
20<br />
Proteggere gli ambienti naturali dal mare<br />
Esempi di funzionamento<br />
di chiuse per regimare <strong>il</strong><br />
livello delle acque<br />
Adesso tuttavia, chi opera per la sicurezza idraulica della pianura (i Consorzi di Bonifica),<br />
sta pensando a come trattenere l’acqua dolce in zone umide. Una risorsa che un tempo<br />
era troppo abbondante, sta diventando scarsa per <strong>il</strong> sovrasfruttamento della falda pisanovers<strong>il</strong>iese<br />
per scopi agricoli, produttivi ed urbani e per l’erosione costiera, con danni sia<br />
all’ambiente naturale che all’agricoltura stessa.<br />
Ci sono diversi mezzi di protezione. Uno di questi, le dighe a trabocco, consistono in<br />
sbarramenti che fissano un limite in altezza, al di sopra del quale l’acqua dolce esce. Le<br />
porte vinciane invece, fanno uscire l’acqua dal lago e non entrare quella del mare. Per<br />
cui, durante l’alta marea o la siccità estiva la pressione del mare fa chiudere le porte,<br />
mentre, quando <strong>il</strong> lago è in piena le porte si aprono e l’acqua dolce può uscire.<br />
Infine, contro <strong>il</strong> proseguimento dell’erosione marina e quindi della salinizzazione della falda<br />
d’acqua dolce si stanno costruendo dighe a mare (orizzontali o verticali).<br />
Proteggere le città e i campi dall’acqua<br />
L’origine peculiare della pianura del <strong>Parco</strong><br />
ha quindi determinato la formazione di una<br />
pianura mediamente con pochi dislivelli,<br />
in cui le piene sono sempre avvenute con<br />
fac<strong>il</strong>ità. Accelerare <strong>il</strong> deflusso dell’acqua ha<br />
da sempre rappresentato un fattore vitale per<br />
un insediamento umano stab<strong>il</strong>e. Tutt’ora la<br />
presenza delle pompe (idrovore) permette di<br />
drenare la piana e mantenere città e campi<br />
privi di acqua nei momenti piovosi. Inoltre, per<br />
accelerare <strong>il</strong> deflusso dell’acqua si è rettificato <strong>il</strong><br />
corso dei fiumi, tagliando le anse. L’ultimo tratto<br />
dell’Arnoadesempioèstatorettificatoinbentre<br />
punti. Guarda a questo proposito Barbaricina e<br />
via delle Lenze (fà caso al nome!), e guarda la<br />
Vettola (“Vettola” viene da “Vettini”, cioè salici,<br />
che formano la normale vegetazione delle rive<br />
dei fiumi non cementificati)… perché la strada<br />
principale disegna curve così strane ? Una è<br />
sulla riva nord, e finisce proprio dove inizia la<br />
curva della Vettola… Guarda poi la curva del<br />
bosco a <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong>. Comincia proprio dove<br />
finisce, sull’altra riva, la curva della Vettola!<br />
Sono tutte anse, meandri, del fiume rettificati<br />
in tempi diversi.<br />
Avanzamento della costa (linee bianche)<br />
e modifiche del corso del fiume<br />
Arno (linea azzurra) nella storia e stato<br />
attuale della costa in fase di erosione<br />
(immagine di foto satellitare modificata<br />
da Minja Kukavicic e Enzo Pranzini Università<br />
di Firenze)
LE RISORSE ECONOMICHE DI UN TERRITORIO<br />
L’agricoltura<br />
L’agricoltura è forse l’uso del territorio più antico nella storia dell’umanità, che per m<strong>il</strong>lenni si è affaticata nei campi per sopravvivere. Solo recentemente<br />
(negli ultimi 50 anni) nel Nord del mondo l’uso dei prodotti chimici di sintesi (concimi e pesticidi) e la meccanizzazione (trattori sempre più rapidi e potenti)<br />
hanno portato ad un enorme aumento della produttività. L’obbiettivo era (ed è) la massima produzione per unità di superficie e quindi <strong>il</strong> passaggio è stato<br />
quasi ovunque da agricoltura estensiva ad agricoltura intensiva (monocolture su vasti appezzamenti, grande uso di prodotti chimici), da allevamenti estensivi<br />
(pascoli bradi) ad allevamenti intensivi (allevamento in batteria o in stalle: <strong>il</strong> massimo numero di animali per superficie, uso di alimenti e mangimi arricchiti,<br />
anche di origine animale).<br />
Ai vantaggi “immediati” in termini di ricchezza si sono così affiancati “inconvenienti” sempre più gravi: l’inquinamento delle acque (di superficie e di falda) e<br />
la perdita di diversità paesaggistica e biologica (degli elementi del paesaggio agricolo tradizionale come le siepi, si parla più avanti in questa sezione).<br />
Oggi in Europa si cerca di invertire la tendenza. Nel <strong>Parco</strong>, dove<br />
l’agricoltura è una delle attività economiche principali (9000 ettari di<br />
superficie, circa <strong>il</strong> 40% dell’intero territorio), si incoraggia l’uso di tecniche<br />
come l’agricoltura biologica (che non prevede l’uso di concimi e<br />
pesticidi chimici ) e l’agricoltura integrata che prevede l’uso razionale<br />
dei prodotti chimici integrandoli <strong>il</strong> più possib<strong>il</strong>e con metodi “dolci”.<br />
Analogamente, l’allevamento rispetta gli stessi criteri: ne sono esempio,<br />
sparsi nel <strong>Parco</strong>, i pascoli bradi, cioè liberi, su grandi superfici, con uso<br />
dei soli foraggi vegetali presenti, di bovini, ovini (pecore) e cavalli.<br />
Da queste tecniche rispettose dell’ambiente e della salute umana,<br />
assieme all’uso di varietà vegetali e razze animali storicamente usate<br />
nel territorio pisano e lucchese si arriva agli ormai famosi prodotti tipici<br />
(e di qualità) del <strong>Parco</strong>.<br />
DAL TERRITORIO DEL PARCO PRODOTTI TIPICI E DI QUALITà<br />
La nostra salute rappresenta <strong>il</strong> dono più prezioso che Dio ci ha donato. Per preservarla serve una meticolosa cura soprattutto nell’alimentazione che rappresenta<br />
<strong>il</strong> primo motore di vita del nostro corpo. Ma cosa mangiamo oggi?<br />
Merendini, cioccolate ecc non sono sempre cibi richiesti dal nostro organismo. È necessario curare la tavola in modo preciso per riuscire a crescere a preservare<br />
<strong>il</strong> nostro corpo dalle malattie e dunque sopravvivere. Dal territorio del <strong>Parco</strong> che ci mostra i suoi prodotti tipici parte un primo importante insegnamento che<br />
è quello legato alla volontà di conoscere la naturalità per saperla apprezzare e soprattutto per farne uso. Tra questi prodotti abbiamo <strong>il</strong> pinolo biologico del<br />
<strong>Parco</strong>, la famosa carne della razza Mucca pisana, <strong>il</strong> buonissimo miele di spiaggia, <strong>il</strong> formaggio pecorino, i bovini biologici ed infine anche gli ortaggi della<br />
Valle del Serchio.<br />
21
22<br />
DAI PINOLI BIOLOGICI DEL PARCO MOLTE DELIZIE<br />
Il pino domestico, che oggi rappresenta l’elemento caratteristico del territorio del parco, era già presente probab<strong>il</strong>mente all’epoca dei romani, anche se<br />
poi i primi impianti produttivi risalgono al ‘500. Una lunga storia dunque accompagna questa speciale pianta.<br />
Oggi <strong>il</strong> lavoro di raccolta delle pigne che un tempo veniva realizzato dagli uomini che si arrampicavano sui lunghi tronchi, è fatto grazie a delle macchine<br />
che scuotono le piante facendo cadere i frutti. Nonostante ciò i pinoli del parco sono estratti dalle pine in modo naturale e, cosa importante, non<br />
subiscono alcun tipo di trattamento chimico. Così <strong>il</strong> pinolo resta ancora quello di un tempo, naturale e genuino.<br />
Il <strong>Parco</strong> in collaborazione ad artigiani pasticceri, ha voluto valorizzare questo prodotto creando due prelibatezze a base di pinolo: <strong>il</strong> pasticcino “Kinzica” e <strong>il</strong><br />
cioccolatino “<strong>Migliarino</strong>”.<br />
Il pasticcino Kinzica è un impasto realizzato con sapiente lavorazione di pinoli, miele di spiaggia biologico del parco, zucchero e<br />
albume. Un pasticcino unico nel mondo perché ricco di sapori e di profumi della nostra terra.<br />
Diverso ma altrettanto prelibato <strong>il</strong> cioccolatino <strong>Migliarino</strong>, battezzato come una delle Tenute storiche del parco. Questo<br />
prodotto rappresenta una creazione innovativa e davvero speciale che ha saputo conquistare <strong>il</strong> cuore ed <strong>il</strong> palato di<br />
tanti estimatori del cioccolato e … dei prodotti genuini.<br />
I cioccolatini possono essere bianchi, cioè realizzati con cioccolata<br />
bianca o neri con cioccolata al latte e fondente: tutto finissimo<br />
cioccolato elaborato in modo meticoloso.<br />
Esiste anche <strong>il</strong> cantuccino Lame di Fuori, anch’esso un prodotto<br />
tradizionale che è diventato prelibato grazie all’introduzione di questi<br />
pinoli dal sapore inconfondib<strong>il</strong>e e dalle caratteristiche eccellenti.<br />
Ma altri sono i prodotti con i pinoli… Un esempio?<br />
I cantuccini con glassa ai pinoli o <strong>il</strong> semifreddo con crema di pinoli.<br />
Tra le novità anche un originale vasetto a forma di otricello che<br />
raccoglie insieme miele del <strong>Parco</strong> e pinoli: una vera leccornia.<br />
Pinoli e miele sono due alimenti prelibati che hanno una<br />
storia antica che mai ha trovato fine.<br />
I romani addirittura non usavano zucchero ma miele,<br />
mentre i pinoli venivano segnalati come perle preziose,<br />
per la ricchezza delle qualità del prodotto stesso.<br />
La cosa più importante che <strong>il</strong> parco ha fatto è proteggere<br />
i suoi prodotti rendendoli famosi e curando le qualità che<br />
ancora oggi sono lontane dalle manipolazioni chimiche<br />
che invece tanti alimenti della nostra terra subiscono.<br />
IL MIELE BIOLOGICO CHE SI PRODUCE SULLA SPIAGGIA<br />
Tra i prodotti del parco <strong>il</strong> miele è senza dubbio quello più<br />
caratteristico perché viene riconosciuto dal profumo: non solo<br />
<strong>il</strong> profumo del mare ma anche <strong>il</strong> profumo dei fiori – l’Elicriso ed<br />
<strong>il</strong> Cisto - che le api toccano nel loro tragitto quotidiano.
I fiori impollinati sono quelli che in primavera colorano le spiagge che vanno dalla marina di Levante<br />
(Viareggio) alla foce del Serchio. In questi due luoghi si trovano infatti le arnie dove prende vita <strong>il</strong> miele<br />
biologico di spiaggia del parco.<br />
Il miele di spiaggia è quindi un miele unico nel suo genere perché prende vita lungo <strong>il</strong> litorale marino del<br />
<strong>Parco</strong> dove sono presenti fiori unici e rari degli aren<strong>il</strong>i, come l’Elicriso (detto anche Camuciolo), che si<br />
riconosce per <strong>il</strong> colore giallo, la <strong>San</strong>tolina delle spiagge, <strong>il</strong> Fiordaliso delle sabbie, la rara Verga d’oro delle<br />
sabbie, <strong>il</strong> Cisto e molte altre specie pioniere.<br />
Per la varietà di fiori che si trovano in questa zona dunale, <strong>il</strong> miele è classificato come m<strong>il</strong>lefiori.<br />
DAI VERDI PASCOLI DI COLTANO ARRIVA IL PECORINO DEL PARCO<br />
L’attenzione per la conservazione del paesaggio agricolo ha portato <strong>il</strong><br />
<strong>Parco</strong> ad interessarsi del settore zootecnico, sperimentando diversi tipi di<br />
allevamento.<br />
Con <strong>il</strong> pecorino biologico e integrato <strong>il</strong> nostro <strong>Parco</strong> è riuscito ad adottare<br />
anche nuove tecniche di zootecnia biologica che ci permettono di poter<br />
assaporare un formaggio sano da tutti i punti di vista.<br />
Questo pecorino nasce dal latte di pecore che ancora oggi vengono<br />
allevate secondo tradizionali regole di pastorizia. L’alimentazione dei capi<br />
è selezionata, e basata su foraggi e mangimi provenienti da coltivazioni<br />
effettuate all’interno dell’area protetta, senza concimi chimici. I pascoli<br />
vengono turnati cioè cambiati per consentire al terreno di potersi rigenerare.<br />
È l’associazione degli Allevatori che vig<strong>il</strong>a questa catena produttiva,<br />
garantendo controlli dettagliati che assicurano <strong>il</strong> buon lavoro delle<br />
aziende e la genuinità dei prodotti.<br />
Dunque un pecorino ottimo che nasce da bestiame curato in<br />
modo certosino.<br />
E se un animale si ammala? Sono usate pratiche omeopatiche<br />
cioè cure a base di prodotti naturali.<br />
Insomma la genuinità non è certamente la produzione in<br />
batteria ma la produzione di un tempo, quella che rivediamo<br />
nei sogni.<br />
Prati puliti dove <strong>il</strong> bestiame vive naturalmente la propria vita<br />
senza costrizioni di sorta e senza mangimi artificiali che tanto<br />
hanno rovinato queste produzioni tradizionali.<br />
Elicriso<br />
I campi di girasoli<br />
23
24<br />
UNA RAZZA IN VIA DI ESTINZIONE VALORIZZATA DAL PARCO: LA MUCCA PISANA<br />
Era una razza in via di estinzione, <strong>il</strong> mucco pisano arrivato solo a 60 unità nel 1978. Una razza che<br />
si pensa sia derivata dall’unione di una razza autoctona cioè locale, la “Podolica Locale” con<br />
la razza Bruna Alpina.<br />
Nel 1997, protagonista della rinascita di questa specie ormai finita è stato l’Ente parco, che<br />
ha voluto ancora una volta riportare alla luce una tradizione recuperando capi storici, cioè<br />
indentificando gli esemplari rimasti della razza e facendoli riprodurre.<br />
La carne di mucco pisano allevata nel <strong>Parco</strong> poi viene certificata, con un marchio a fuoco sulle<br />
mezzane degli animali macellati.<br />
Ma come vivono queste mucche?<br />
Intanto possiamo dire che questo tipo di mucca è molto adattab<strong>il</strong>e e si muove anche in<br />
allevamenti non troppo ampi. Come gli ovini, anche questi bovini possono vivere serenamente<br />
in libertà senza essere costretti quotidianamente a vivere in modo “chiuso” in stalle. Così si può<br />
parlare di carne biologica.<br />
GLI ORTAGGI DELLA VALLE DEL SERCHIO<br />
Il Mucco pisano<br />
Il <strong>Parco</strong> “ coltivatore custode”! Vale a dire? Che <strong>il</strong> parco, per riuscire a tutelare alcune varietà locali, tipiche del territorio e in via d’estinzione, in collaborazione<br />
con alcune aziende orticole, ha deciso di ricoprire anche questo particolare ruolo di “promotore” di prodotti che sembravano essersi persi e che oggi invece<br />
hanno ripreso vita produttiva grazie ad una maggiore attenzione.<br />
Tra i prodotti recuperati e che ormai oltre ad esistere nel presente fanno anche parte della nostra tradizione antica, abbiamo <strong>il</strong> pomodoro Pisanello, la<br />
zucchina mora pisana, la piattella pisana. Quest’ultimo è un fagiolo un po’ piatto (appunto), bianco e lucido, spesso usato in cucina per la preparazione sia<br />
di piatti ricercati che di insalate e minestre. La varietà è stata selezionata nel lontano 1909.<br />
Di fatto, gli alimenti menzionati rappresentano un passo avanti nelle politiche gestionali che <strong>il</strong> parco desidera costruire nel nostro futuro, sempre cercando di<br />
rispondere alle rinnovate esigenze di un popolo, che pur camminando avanti desidera ritrovare i valori ed i sapori di un tempo attraverso colori e aromi che<br />
sono quasi scomparsi dalle nostre tavole e che invece qui vengono riproposti in modo originale sotto ogni punto di vista.<br />
L’augurio è che i giovani sappiano si, guardare avanti, ma sappiano prendere ancora dal passato quanto di buono questo ci ha offerto per creare quella<br />
continuità che serve a parlare di vita e di crescita sociale e culturale.
LA SELVICOLTURA<br />
Sembra strano, ma anche le foreste (le selve) si coltivano (senza concimi né pesticidi)! La “fame” di legname e carbone del passato aveva degradato,<br />
impoverito e spesso distrutto le foreste europee, tanto che si sv<strong>il</strong>upparono tecniche per riforestare e per tagliare gli alberi senza perdere la foresta. L’insieme di<br />
queste tecniche, che poggiano sulla botanica, sull’ecologia, ma anche sulla economia del territorio, si chiama Selvicoltura.<br />
Anche le foreste del <strong>Parco</strong> sono state usate, fin dall’antichità. In particolare le pinete, che fin dal ‘500 furono piantate proprio per scopi produttivi (legna e<br />
pinoli), ancora oggi sono coltivate. La differenza rispetto al passato (economia di sussistenza) è che ora della pineta non interessano più solo legno e pinoli (pur<br />
importanti), ma anche “servizi” (diremmo senza prezzo!) come <strong>il</strong> paesaggio, le passeggiate, la flora e la fauna che vi vivono, ecc. Quindi la Selvicoltura ora cerca<br />
di avere foreste con più funzioni: oltre a quella produttiva, anche quella naturalistica, paesaggistica e ricreativa; e questo specialmente in un <strong>Parco</strong>.<br />
La difficoltà, ma anche <strong>il</strong> fascino della Selvicoltura sta nel fatto che i cicli degli alberi<br />
sono di decine e centinaia di anni (e non brevi come <strong>il</strong> mais o la patata !) – per cui<br />
Diradamento del bosco<br />
bisogna immaginare dinamiche evolutive in un futuro molto lontano – e nel fatto che<br />
una foresta è un ecosistema molto più complesso di un campo!!!<br />
prima<br />
Forse non è bello vedere uno o più alberi tagliati, ma oltre questa prima impressione (che<br />
corrisponde ad un disturbo più o meno grande per l’ecosistema) conviene chiedersi<br />
com’era la foresta prima del taglio e perché è stato fatto l’intervento; e soprattutto,<br />
provare ad immaginare – sapendo che la foresta non è un monumento, ma un organismo<br />
in continua evoluzione - cosa succederà qualche anno e qualche decennio dopo. Per<br />
esempio, nelle pinete troppo fitte i pini si tagliano per lasciare a quelli che rimangono<br />
luce sufficiente per crescere sia in altezza che in larghezza (vedremo nella sezione flora<br />
che <strong>il</strong> pino è affamatissimo di luce). Una bella chioma poggiata su un tronco solido<br />
resiste bene al vento e fra le fronde può ospitare vari scoiattoli, ghiri, uccelli, pipistrelli<br />
(funzione naturalistica); in un foresta troppo densa invece i fusti sono es<strong>il</strong>i, le chiome sono<br />
strette e stentate; inoltre, non arriva abbastanza luce al suolo per far crescere rigoglioso dopo<br />
<strong>il</strong> sottobosco (fonte di nutrimento e rifugio per altri animali) e alberi di altre specie oltre<br />
al pino. Infine, una chioma grande, sana (a ombrello: funzione paesaggistica) e ben<br />
<strong>il</strong>luminata fruttifica abbondantemente. Ecco la famosa funzione produttiva, data dai<br />
pinoli, oltre che dal legno. Tagli di questo tipo si chiamano diradamenti.<br />
Nel parco si cerca anche di lasciare in piedi, e a terra, una certa quantità di alberi e<br />
legno morto e marcescente. Anche se sembra “brutto”, <strong>il</strong> legno morto brulica di vita !<br />
(vedi oltre in questo <strong>libro</strong>).<br />
ALTRE ATTIVITà<br />
Mentre in passato si affermavano attività legate ad un’economia di sussistenza; p.e caccia e pesca ad integrare <strong>il</strong> reddito derivante da attività agricole o<br />
artigianali; o ad attività estrattive (torba e sabbie s<strong>il</strong>icee) attualmente la realtà di una zona economicamente forte ha relegato principalmente queste attività<br />
al tempo libero.<br />
Così dopo lo sv<strong>il</strong>uppo degli insediamenti della Vers<strong>il</strong>ia e della costa pisana della prima metà del ‘900 e con <strong>il</strong> boom del consumismo e della speculazione ed<strong>il</strong>izia<br />
fino alla metà degli anni ’70. Successivamente si è affermata, dagli anni ‘80, un’idea di turismo sostenib<strong>il</strong>e che, passando dall’agriturismo, all’equiturismo,<br />
cicloturismo e trekking arriva a forme come <strong>il</strong> birdwatching e l’escursionismo naturalistico e fanno della conoscenza e dell’esperienza naturalistica un modo per<br />
creare reddito e attività economiche senza distruggere <strong>il</strong> patrimonio naturale (concetto di sostenib<strong>il</strong>ità).<br />
25
26<br />
LA RICCHEZZA ECOLOGICA DI UN TERRITORIO<br />
Questo <strong>Parco</strong>, pur trovandosi in area mediterranea, è ricco di piante ed animali dei climi caldi Centroeuropei, Atlantici, Boreali che permangono qui da tempi<br />
passati, grazie all’enorme varietà di microclimi presenti e alla ricchezza di acqua che hanno quindi permeato l’evoluzione e le caratteristiche degli ecosistemi.<br />
Ogni ambiente è caratterizzato da fattori chimici e fisici (umidità, profondità dell’acqua, temperatura, quantità di ossigeno, ecc.), biologici (animali e piante)<br />
e dall’interazione tra ed entro le specie (riproduttive, sociali, alimentari ecc,).<br />
Diversità degli ecosistemi<br />
Diversità della fauna<br />
Accanto alla varietà vegetale e legato alla grande produttività (grande crescita e diversità di piante ed animali) degli ambienti<br />
acquatici sono numerose le specie faunistiche presenti, anche molto rare. Vi sono numerosi insetti acquatici (libellule, ditischi<br />
ecc.), i coleotteri stercorari, <strong>il</strong> cervo volante, <strong>il</strong> rospo smeraldino, la testuggine d’acqua, l’istrice, ben sette specie di aironi, la tinca,<br />
<strong>il</strong> luccio, pipistrelli ecc. D’inverno inoltre le zone umide ospitano migliaia di uccelli acquatici provenienti dal Nord Europa. Sono<br />
circa 90 le specie di uccelli che nidificano nel <strong>Parco</strong> e decine quelle che vi passano l’inverno o che vi fanno le soste migratorie.<br />
Altri ruoli della ricchezza ecologica<br />
zONE UMIDE fOREStE AMbIENtI APERtI<br />
Acque libere<br />
✓ Mare entro 6 metri di profondità<br />
✓ Laghi e lagune (estuari, Lame di<br />
fuori, lame interdunali)<br />
✓ Canali<br />
Vegetazione erbacea<br />
✓ Canneti e cladieti (canna di<br />
palude, falasco, tifa)<br />
✓ Torbiere<br />
✓ Giuncheti<br />
✓ Salicornieti<br />
Foreste<br />
✓ Ontanete allagate<br />
✓ Boschi riparali (salice, pioppo)<br />
Foreste naturali<br />
✓ Ontanete o frassineti allagati<br />
✓ Boschi riparali (salice, pioppo)<br />
✓ Boschi a caducifoglie (farnia,<br />
carpino ecc.)<br />
✓ Querceti sempreverdi (leccio)<br />
Foreste seminaturali<br />
✓ Pinete a pino marittimo<br />
✓ Pinete a pino domestico<br />
Dune<br />
✓ Sabbia nuda<br />
✓ Dune in formazione con piante<br />
pioniere<br />
✓ Prima duna (agropiro) e<br />
seconda duna (ammof<strong>il</strong>a)<br />
✓ Ambienti interdunali (elicriso,<br />
ginepro ecc.)<br />
Colture agricole e pascoli<br />
✓ Grano, Orzo, Mais ecc<br />
✓ Pascoli bradi con bovini o ovini<br />
✓ Pioppete<br />
✓ Oliveti<br />
10. La produttività biologica è<br />
la quantità di sostanza organica<br />
prodotta in un ambiente delimitato.<br />
Gli ambienti più produttivi nelle nostre<br />
zone sono solitamente le paludi e gli<br />
estuari di fiumi.<br />
Molte altre sono le funzioni primarie svolte da questi ambienti naturali come: la ricarica della falda acquatica, la protezione dai venti marini delle foreste, la<br />
protezione dalle alluvioni potendo disporre di grandi bacini di zone umide, la depurazione naturale delle acque, esercitata dalle zone umide e una grande<br />
funzione sociale legata alla cultura e al tempo libero. Negli ambienti naturali la diversità della flora è massima, con numerose specie assai interessanti e rare.
Paludi<br />
Laddove le aree sono suffi cientemente depresse<br />
si formano zone umide con la tipica vegetazione.<br />
L’allagamento, l’altezza dell’acqua e la sua<br />
salinità condizionano poi quali habitat si formeranno.<br />
Troviamo quindi prati umidi salmastri o<br />
dolci, laghi, ambienti lagunari, torbiere, canneti,<br />
falascheti e vegetazione a idrofi te (ninfee, utricolaria,<br />
lemma miriofi llo ecc). Tipici animali delle paludi<br />
sono i limicoli, le sterne, <strong>il</strong> tarabuso, l’airone<br />
rosso,la cannaiola ed <strong>il</strong> cannareccione. Le lame<br />
sono specchi d’acqua di forma allungata, spesso<br />
d’origine intedunale.<br />
Dune<br />
Lungo la costa le condizioni sono estreme (sim<strong>il</strong>i<br />
a quelle dei deserti): <strong>il</strong> terreno è ancora essenzialmente<br />
minerale, la salinità è elevata ponendo<br />
problemi di osmosi (vedi commento n°26) e disidratazione<br />
e le temperature tendono a essere<br />
molto basse l’inverno e estremamente alte l’estate<br />
a causa dell’insolazione. Vi troviamo quindi un<br />
ambiente estremamente semplice e specializzato:<br />
con erbe fornite di apparati radicali estesi e<br />
consolidanti che favoriscono l’accumulo di sabbia<br />
delle dune (p.e. agropiro e ammofi la) e zone interdunali<br />
(p.e. elicriso e ginepro). Spesso questo<br />
ambiente è semplifi cato perché l’erosione della<br />
costa ha fatto scomparire le prime dune, o perché<br />
l’ut<strong>il</strong>izzo umano (turismo, stab<strong>il</strong>imenti balneari,<br />
eventi bellici ecc.) ha appiattito o fatto scomparire<br />
l’originale morfologia a tratti. Tipici animali<br />
dell’ambiente dunale sono <strong>il</strong> fratino, <strong>il</strong> gruccione,<br />
la calandrella e lo scarabeo stercorario.<br />
GLI ECOSISTEMI DEL PARCO<br />
foreste<br />
La foresta cresce dove <strong>il</strong> suolo è più maturo e<br />
la presenza d’acqua dolce più stab<strong>il</strong>e. Tralasciando<br />
le terminologie scientifi che si possono<br />
riconoscere le seguenti principali formazioni<br />
boscate: boschi igrofi li (ad ontano o frassino),<br />
boschi mesofi li, pinete di pino domestico e<br />
pinete di pino marittimo. Tipici animali dei boschi<br />
maturi sono <strong>il</strong> picchio rosso maggiore, <strong>il</strong><br />
picchio muratore, <strong>il</strong> rampichino e la martora.<br />
27
28<br />
MINACCE PER L’AMBIENTE<br />
Stranger in paradise: le specie esotiche<br />
Le specie esotiche risultano talora invasive, perché, dopo un periodo di acclimatamento, hanno crescite<br />
demografiche che le portano a divenire dominanti, per mancanza dei naturali fattori limitanti (rigidità climatica,<br />
competitori, parassiti, ecc.). Tra le specie non indigene si possono accennare l’a<strong>il</strong>anto, la yucca, la robinia, l’amorfa<br />
fruticosa, <strong>il</strong> gambero americano, <strong>il</strong> carassio ed <strong>il</strong> ratto delle chiaviche.<br />
Tra le specie più o meno indigene che però danno problemi di squ<strong>il</strong>ibrio ecologico nel parco per la loro<br />
sovrabbondanza ricordiamo invece <strong>il</strong> gabbiano reale, la cornacchia grigia ed <strong>il</strong> daino. La loro abbondanza è<br />
soprattutto legata rispettivamente alle discariche malgestite, ad un ambiente agricolo banalizzato e ad ambienti<br />
naturali troppo piccoli e recintati; anche se i motivi delle crescite demografiche sono in realtà sempre molto<br />
complessi.<br />
specie<br />
Gambero della Louisiana<br />
Procambarus clarkii<br />
Nutria<br />
Myocastor corpus<br />
Yucca<br />
Yucca gloriosa<br />
Amorfa fruticosa<br />
Amorpha fruticosa<br />
A<strong>il</strong>anto<br />
A<strong>il</strong>anthus altissima<br />
Robinia<br />
Robinia pseudoacacia<br />
origine<br />
Ambiente<br />
Nord<br />
America<br />
Zone umide<br />
Sud America<br />
Zone umide<br />
Nord<br />
America<br />
Dune costiere<br />
Nord<br />
America<br />
Zone umide<br />
Asia<br />
Foreste<br />
Nord<br />
America<br />
Foreste<br />
ecologia ed effetti<br />
Crostaceo portato in zona per allevamenti a scopo<br />
alimentare, una volta raggiunta la libertà è divenuto<br />
un elemento dominante producendo effetti negativi<br />
per la predazione su anfi bi e pesci, per l’attività di<br />
brucatura sui vegetali acquatici e inoltre, con le sue<br />
tane, indebolisce gli argini.<br />
Mammifero roditore portato in Europa per la<br />
possib<strong>il</strong>ità di ricavarne pellicce, è divenuto un<br />
elemento comune in alcune paludi e corsi d’acqua<br />
con effetti negativi legati alla brucatura sulla<br />
vegetazione acquatica e per calpestio sui nidi degli<br />
uccelli. Inoltre, con le sue tane, indebolisce gli argini.<br />
Pianta arbustiva piantata sulle dune molti anni fa<br />
per cercare di stab<strong>il</strong>izzarle o innalzarle si è diffusa<br />
a detrimento degli habitat naturali (p.e. le boscaglie<br />
retrodunali a ginepro).<br />
Pianta arbustiva diffusasi nelle zone umide del<br />
<strong>Parco</strong> accelerandone l’interrimento ed escludendo le<br />
comunità acquatiche locali.<br />
Albero usato spesso nei rimboschimenti di aree<br />
verdi urbane o su massicciate stradali; si è diffuso<br />
abbondantemente negli ambienti naturali dove risulta<br />
di diffi c<strong>il</strong>e estirpazione.<br />
Albero usato spesso nei rimboschimenti di aree<br />
verdi urbane o su massicciate stradali; si è diffuso<br />
abbondantemente negli ambienti naturali.<br />
L’effetto generale della sovrabbondanza<br />
di una specie<br />
può essere quello di una<br />
scomparsa di specie locali<br />
e/o la modifica e sostituzione<br />
degli habitat originali. P. es. la<br />
yucca tende a sostituirsi al ginepro<br />
nell’habitat retrodunale;<br />
l’amorfa occupa le piccole<br />
zone umide scalzando le altre<br />
specie; <strong>il</strong> daino non permette<br />
<strong>il</strong> rinnovamento della foresta,<br />
in quanto mangia i germogli<br />
giovani delle piante che rimpiazzerebbero<br />
gli alberi arrivati<br />
al termine del loro ciclo<br />
vitale. La soluzione di questi<br />
problemi risiede naturalmente<br />
sia nel controllo delle specie<br />
invasive diretto sia verso i<br />
fattori che ne hanno causato<br />
l’abbondanza e, dove è possib<strong>il</strong>e,<br />
nell’eradicazione delle<br />
specie esotiche.<br />
Yucche<br />
11. Le specie esotiche o aliene, o<br />
non indigene sono specie introdotte<br />
volontariamente o involontariamente<br />
dall’uomo al di fuori del proprio<br />
areale. Alcune di queste specie, dopo<br />
una fase di acclimatazione divengono<br />
comuni, capaci di riprodursi<br />
autonomamente e talora dominanti<br />
(invasive) nell’ambiente naturale<br />
minacciando le specie locali. Queste<br />
introduzioni, sempre avvenute su<br />
scala locale, a partire dal ‘500 sono<br />
cresciute a dismisura con lo sv<strong>il</strong>uppo<br />
dei trasporti e sono attualmente<br />
considerate tra i maggiori fattori di<br />
rischio per la conservazione della<br />
biodiversità nel pianeta. Nel <strong>Parco</strong><br />
sono evidenti per gli effetti negativi<br />
varie specie estotiche tra cui quelle<br />
della tabella qui accanto.
Zone umide: inquinamento chimico, eutrofizzazione, salinizzazione e interrimento<br />
Nel lago gli scarichi agricoli ed urbani mal depurati hanno portato ad un fenomeno chiamato eutrofizzazione.<br />
Il termine significa nutrimento abbondante, ed è infatti la quantità di elementi nutritivi come l’azoto e soprattutto <strong>il</strong> fosforo<br />
(presenti p.e. nei concimi agricoli) a favorire uno sv<strong>il</strong>uppo abnorme di fitoplancton (piccolissime alghe). Da qui partono una<br />
serie di processi che si autoalimentano, peggiorando sempre più le cose.<br />
Schema che <strong>il</strong>lustra come l’erosione fa avanzare verso l’interno l’acqua salata mettendo<br />
a rischio le specie vegetali e le riserve di acqua dolce (Vannozzi M. e L. Bargagna – Ufficio<br />
Fiumi e Fossi 2005)<br />
La vicinanza al mare, unita ad un<br />
grande uso di acque della falda (e<br />
dei piccoli affluenti del lago) per le<br />
città e per l’irrigazione, causa una<br />
depressione che “richiama” acqua<br />
salata dal mare (cioè “avvicina” la<br />
massa di acqua del mare alla massa<br />
di acqua dolce), con possib<strong>il</strong>ità di<br />
scambio attraverso <strong>il</strong> terreno, e quindi<br />
di salinizzazione delle acque.<br />
Infine, la quantità enorme di sedimenti<br />
provenienti dalle zone agricole interra<br />
progressivamente <strong>il</strong> lago: si calcola<br />
che se si continua a questo ritmo<br />
fra 120 anni <strong>il</strong> bacino lacustre del<br />
<strong>Massaciuccoli</strong> sarà completamente<br />
colmato!<br />
vento marino<br />
12. Il fi toplancton sono l’insieme<br />
degli organismi viventi vegetali<br />
appartenenti al plancton.<br />
Esso è l’insieme degli organismi<br />
acquatici, quasi sempre molto<br />
piccoli, che non riescono a nuotare<br />
attivamente e sono quindi trasportati<br />
dalle correnti. Ne esistono di<br />
“vegetali”, che fanno cioè fotosintesi<br />
(produzione di zucchero ed ossigeno<br />
ut<strong>il</strong>izzando acqua, anidride carbonica<br />
ed energia solare), e di “animali”, che<br />
si nutrono cioè di altri organismi. Il<br />
plancton costituisce la base delle reti<br />
alimentari negli ambienti acquatici.<br />
Effetto “fon”: aerosol marino<br />
29
30<br />
Erosione delle coste<br />
Causata essenzialmente dallo scarso apporto di sedimenti, dovuto alla cementificazione<br />
e la creazione di dighe a monte, e alle costruzioni lungo la costa che intercettano o<br />
deviano <strong>il</strong> normale “scorrimento” delle sabbie trasportate dai fiumi in mare.<br />
Frammentazione<br />
Come è fac<strong>il</strong>e osservare dalle foto aeree, o da una carta fisica della Toscana, <strong>il</strong> <strong>Parco</strong><br />
Naturale <strong>Migliarino</strong> <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> <strong>Massaciuccoli</strong> è un isola nel mare urbanizzato. Questo<br />
pone problemi di frag<strong>il</strong>ità ambientale perché ogni guasto (p.e. una malattia) che lo<br />
colpisce non può essere attenuato da ambienti vicini e inoltre, per alcune specie come<br />
ai grandi mammiferi, sta decisamente stretto. Infatti i grandi carnivori sono scomparsi e<br />
gli ungulati hanno problemi di sovrabbondanza. Uno dei modi per sopperire è quello di<br />
mantenere o installare siepi, canali, muretti a secco, piccole foreste o ruderi in buono<br />
stato con alto valore naturalistico, che funzionino da corridoi ecologici tra aree diverse.<br />
Perché conservare la natura<br />
Questi squ<strong>il</strong>ibri ambientali, causati<br />
da uno sv<strong>il</strong>uppo delle città e<br />
della produzione (agricola e<br />
industriale) senza regole, ha fatto<br />
capire l’esigenza di proteggere gli<br />
ambienti e dare limiti o alternative<br />
alleattivitàumane,perpermettere<br />
anche alle generazioni future di<br />
conoscere, vivere e usufruire dei<br />
benefici dell’ambiente naturale.<br />
Queste sono le idee che hanno<br />
generato la creazione delle aree<br />
protette come zone in cui cercare<br />
e sperimentare nuovi equ<strong>il</strong>ibri<br />
dell’uomo con la natura.<br />
Erosione del sistema dunale del <strong>Parco</strong> (Foto L. Lombardi)<br />
Le siepi nelle zone agricole<br />
APPROfONDIMENtO<br />
Le siepi svolgono la funzione di vie di collegamento,<br />
di alimentazione, riposo e rifugio<br />
non solo per gli uccelli, ma anche per<br />
piccoli animali come topolini, moscardini,<br />
conigli, e per i pipistrelli durante i loro voli<br />
notturni (vedi capitolo sulla fauna). I frutti<br />
delle piante, specialmente le bacche degli<br />
arbusti, sono apprezzate dagli uccelli, gli<br />
stessi che mangiano anche gli insetti, compresi<br />
quelli dannosi per le piante coltivate,<br />
che l’agricoltore combatte spesso con pesticidi.<br />
Alcune siepi riescono a rallentare i<br />
venti e quindi a proteggere le coltivazioni.<br />
Le siepi inoltre diversifi cano <strong>il</strong> paesaggio.<br />
Pensate a come sarebbe brutta una distesa<br />
di campi coltivati a perdita d’occhio,<br />
senza nemmeno un albero! Per questi motivi,<br />
e su invito del parco, gli agricoltori<br />
cercano di mantenere e favorire le siepi,<br />
malgrado diano fastidio al movimento ed<br />
al lavoro dei trattori.
Alla scoperta degli ambienti del <strong>Parco</strong> - Schede di lavoro<br />
IL PAESAGGIO ED I SUOI COMPONENTI<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo<br />
Nomi:…………………………………………..<br />
Ogni paesaggio viene percepito con molte caratteristiche, ed è importante riuscire ad avere sia una visione d’insieme che riuscire ad<br />
identificare i singoli componenti. Per cui prima proviamo a determinare a quali paesi o zone geografiche appartengono i seguenti gruppi<br />
di componenti e poi, nelle successive schede iniziamo lo studio in dettaglio dell’ambiente del parco identificandone i componenti<br />
principali.<br />
1. A quali regioni del mondo appartengono le seguenti componenti ? Patagonia, Cina, Sahara o Lapponia ?<br />
Caratteristiche Il paese (o la regione) è:<br />
Cammello – Steppa - Clima da freddo secco a piovoso tropicale – Camelia – Bambù – Panda - Risaie<br />
Araucaria – Pinguini – Lama - Clima secco, grandi escursioni termiche – Steppa – Tundra - Pastorizia<br />
Renne – Lupi – Orsi – Alche - Clima freddo estate breve – Tundra – Fiordo – Taiga - Allevamenti nomadi<br />
Dromedario – Ant<strong>il</strong>ope – Fennec – Palme -Clima caldo e secco –Savana - Nomadi<br />
2. Riportare le caratteristiche precedenti suddividendole per tipologie.<br />
Vegetazione<br />
Animali<br />
Presenza dell’uomo<br />
Componenti geografici<br />
Scheda n. 1<br />
31
32<br />
L’OSSERVAZIONE SUL CAMPO DEL PAESAGGIO<br />
Scheda di campo - Lavoro di gruppo<br />
Nomi dei r<strong>il</strong>evatori:…………………………………………..<br />
La scelta dei siti da studiare e <strong>il</strong> lavoro sul campo possono essere svolti con l’aiuto di una guida naturalistica.<br />
Data Località N° sito<br />
Tempo: soleggiato – nuvoloso – piovoso Vento: assente – brezza – media - intenso<br />
I. Angolo di visuale Stretto<br />
A. ComPoNeNTI geogrAFICI<br />
Ampio<br />
II. r<strong>il</strong>ievi Piano Ondulato<br />
III. Presenza d’acqua Assente Canale Fiume<br />
B. VegeTAzIoNe<br />
Lago Lama Palude<br />
I. Alberi e arbusti Foreste di latifoglie decidue Foreste di sempreverdi Boscaglia retrodunale Altro ______________________________<br />
II. erbacea Canneto / Cladieto Giuncheto Salicornieto Campo agricolo Altro ___________<br />
III. Aspetto d’insieme Vegetazione arborea dominante Vegetazione erbacea dominante<br />
C. ANImALI<br />
Equ<strong>il</strong>ibrio tra vegetazione<br />
erbacea ed arborea<br />
Assenza di vegetazione<br />
I. Animali selvatici Specie:<br />
II. Animali domestici Specie:<br />
D. PreseNzA umANA<br />
I. Case.<br />
Tipologia:<br />
Distribuzione:<br />
Agricole<br />
Allineate<br />
Abitazioni urbane<br />
Isolate<br />
V<strong>il</strong>le Altro: ___________<br />
Raggruppate<br />
II. Attività Agricoltura Allevamenti: _______________________ Colture: ___________________________<br />
Artigianato Pesca<br />
e. AsPeTTI seNsorIALI NoN VIsIVI<br />
Turismo Industria Altro: ___________<br />
I. odori: si - no II. Tatto: si - no III. suoni e rumori: si - no<br />
Descriv<strong>il</strong>i: Descriv<strong>il</strong>i: Descriv<strong>il</strong>i:<br />
Altre informazioni che sembrano interessanti.<br />
F. ALTro<br />
Scheda n. 2
SINTETIZZA LE INFORMAZIONI DEI VARI GRUPPI<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo<br />
Nomi:…………………………………………..<br />
Provate a sintetizzare le informazioni dei vari gruppi relative alla scheda ...<br />
Componenti del paesaggio sito 1<br />
1.<br />
sito 2 sito 3 ecc.<br />
Geografico<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Vegetazione<br />
Animali<br />
Presenza dell’uomo<br />
Altri aspetti sensoriali<br />
Altro<br />
Scheda n. 3<br />
33
34<br />
ANALIZZA LE OSSERVAZIONI RACCOLTE<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo<br />
Nomi:…………………………………………..<br />
Provate adesso ad analizzare le informazioni raccolte per i vari siti d’osservazione (schede … e …).<br />
1. Quali siti vengono analizzati ?<br />
Scheda n. 4<br />
P.e. <strong>il</strong> Sito 1, 3, 5, 6, 7. ………………………………………………………………………….....................................................................................................................……………<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
2. Perché viene scelto questo gruppo di siti da analizzare ?<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
3. Quali sono le principali differenze osservate tra i siti?<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
4. Quali sono le caratteristiche comuni osservate tra i vari siti?<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
................................................................................................................................................................................................................................................................................
RAPPRESENTA IL PROFILO DEL PAESAGGIO CHE HAI ATTRAVERSATO<br />
Scheda di analisi - Lavoro individuale<br />
Nome:…………………………………………..<br />
L’obiettivo del lavoro consiste nel rappresentare <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o dell’ambiente che hai attraversato mettendo in<br />
evidenza se <strong>il</strong> terreno è ondulato o pianeggiante, presenza d’acqua, paludi, foreste sempreverdi, foreste<br />
caducifoglie, colture, case, pascoli (ci si può riferire ad esempio a quello analizzato con la scheda 10). Di<br />
seguito abbiamo alcuni esempi in pianta e sezione.<br />
Sezioni<br />
Scheda n. 5<br />
Pianta<br />
35
36<br />
IMPARA AD UTILIZZARE UNA CARTA<br />
Scheda di analisi - Lavoro individuale<br />
Nome:…………………………………………..<br />
Ut<strong>il</strong>izzando una carta geografica ( es. Carta 1:25.000 della Regione Toscana) prova a:<br />
- posizionare i punti di partenza e arrivo<br />
della tua escursione;<br />
- tracciare <strong>il</strong> percorso che hai fatto sulla mappa;<br />
- segnare le stazioni dove hai compiuto<br />
le osservazioni riportate nelle schede.<br />
Scheda n. 6
LE DIFFERENTI UNITà DI PAESAGGIO DELLA PIANURA COSTIERA<br />
Scheda di analisi - Lavoro individuale<br />
Nome:…………………………………………..<br />
Scheda n. 7<br />
Dallo schema ambientale seguente cerca di individuare: l’ambiente dunale, le zone umide, le foreste ed i coltivi e, al loro interno le singole componenti<br />
numerandole con frecce sulla mappa.<br />
Dune<br />
zone umide<br />
Foreste<br />
Coltivi<br />
Nome e numero delle componenti del paesaggio individuate nello schema<br />
37
38<br />
DESCRIVI LE DIVERSE MORFOLOGIE, ORIGINE E FUNZIONE DEGLI ELEMENTI<br />
DI PAESAGGIO OSSERVATI<br />
Scheda di analisi - Lavoro individuale<br />
Nome:…………………………………………..<br />
Scheda n. 8<br />
Tenendo presente le osservazioni fatte all’inizio di questo lavoro prova ad individuare forme, origine e funzione dei componenti evidenziati (p.e. paleoduna,<br />
canale, canneto, ecc). Puoi poi verificare con una guida naturalistica o un ecologo <strong>il</strong> lavoro fatto.<br />
Esempio di scheda componente.<br />
Schema (disegno o foto)<br />
Descrizione<br />
Origine<br />
Funzione
DOVE E PERCHé NELLE DIVERSE AREE DEL PARCO CI SONO PROBLEMI AMBIENTALI<br />
Scheda di analisi - Lavoro individuale<br />
Nome:…………………………………………..<br />
I problemi ambientali tipici delle zone umide, la diffusione delle specie invasive, l’erosione<br />
sulla costa, la frammentazione e <strong>il</strong> disturbo antropico possono essere previsti in base alle<br />
tipologie di paesaggio ed ai meccanismi degli ecosistemi. Prova a prevedere sulla<br />
mappa dove possono sussistere questi problemi e perché.<br />
Discutetene poi con un esperto in ecologia e conservazione.<br />
Dune<br />
Zone umide<br />
Foreste<br />
Coltivi<br />
Nome, numero e ragioni delle problematiche ambientali ipotizzate nello schema<br />
IDEA !!<br />
APPROfONDIMENtO<br />
Scheda n. 9<br />
Osserva l’eutrofizzazione in diretta col disco Secchi<br />
Per poter vedere le i problemi d’interrimento ed eutrofizzazione,<br />
prova a collegare un bastone di almeno 150 cm con un disco di<br />
plastica bianco del diametro di circa 40 cm ad un’estremità. L’asta<br />
va graduata con lo 0 verso <strong>il</strong> disco. Sul campo in canali o specchi<br />
d’acqua più o meno grandi prova a misurare in diverse stagioni la<br />
profondità a cui si vede <strong>il</strong> disco bianco. Avrai un idea immediata<br />
di quali e quanto sono inquinati i vari corpi idrici. Tieni presente<br />
che dove non arriva luce non ci sarà fotosintesi, quindi produzione<br />
d’ossigeno, quindi piante … quindi vita.<br />
39
40<br />
IL CICLO DELL’ACQUA SULLA COSTA<br />
Scheda di analisi - Lavoro individuale<br />
Nome:…………………………………………..<br />
Prova a rintracciare <strong>il</strong> percorso dell’acqua nell’ambito del <strong>Parco</strong> attraverso lo schema sottostante.<br />
Delinea quindi con cerchi e frecce: pioggia, alta marea, inf<strong>il</strong>trazione, venti, evaporazione e<br />
traspirazione, canali, foreste, paludi, laghi, stagnazione d’acqua, ruscellamento, campi arati e<br />
vegetati. Discutetene poi con un esperto in ecologia e conservazione.<br />
IDEA !!<br />
APPROfONDIMENtO<br />
Scheda n. 10<br />
Osserva ora in diretta la capacità di autopurificazione<br />
dell’acqua<br />
Prova a mettere in un bicchier d’acqua una goccia di latte ed<br />
agita <strong>il</strong> bicchiere. Che cosa succede? L’acqua sicuramente<br />
s’intorbidisce. Ma, dopo due-tre giorni, tornerà limpida. Prova<br />
ancora a ripetere le operazioni più volte, magari fotografando<br />
con una fotocamera digitale l’acqua nelle medesime<br />
condizioni d’<strong>il</strong>luminazione…. Scoprirai che l’acqua torna ad<br />
essere limpida in tempi sempre più rapidi, magari in mezza<br />
giornata dopo circa 10 ripetizioni dell’esperimento, come<br />
mai?<br />
Bé un indizio sono le pareti del bicchiere. Su di esse albergano<br />
f<strong>il</strong>amenti grigio biancastri. Essi sono batteri che si<br />
nutrono delle sostanze del latte, e più ce ne sono più veloce<br />
è <strong>il</strong> processo. Hai così osservato che l’acqua si autopurifica.<br />
Prova ora a mettere 3 o più gocce di latte. Rapidamente<br />
l’acqua s’imputridisce e puzza (si forma idrogeno solforato!)<br />
formando uno strato indecomposto sul fondo. Questo è<br />
un modello di cosa succede anche nelle acque naturali in<br />
cui l’uomo troppo spesso inquina molto più velocemente di<br />
quanto l’acqua riesca a compiere la autodepurazione!!!
COMPARA TRE AMBIENTI RISPETTIVAMENTE<br />
DI FORESTA UMIDA, ARIDA E AGRICOLO DI<br />
BONIFICA<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo<br />
Nomi dei r<strong>il</strong>evatori:…………………………………………………<br />
L’obiettivo di questo lavoro è di comprendere la ricchezza<br />
ecologica analizzando tre ambienti vicini ma contrastanti.<br />
Vanno quindi scelti tre differenti siti:<br />
uno di lama interna (di interduna) con una ontaneta;<br />
uno di foresta asciutto (dunale) con pineta mista a leccio;<br />
uno di bonifica con campi agricoli (o pascoli).<br />
In questi siti possono essere osservate le caratteristiche<br />
geografiche, botaniche e di avifauna. Può essere ut<strong>il</strong>e<br />
l’aiuto di un botanico e di un ornitologo.<br />
SINTESI DEI DATI RACCOLTI COMPARANDO<br />
GLI AMBIENTI<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo<br />
Nomi:…………………………………………………………………<br />
Con la stessa impostazione della scheda, proviamo a fare<br />
una sintesi delle osservazioni raccolte tra i diversi gruppi.<br />
Anche qui può essere ut<strong>il</strong>e Il confronto con un botanico ed<br />
un ornitologo.<br />
Scheda n. 11<br />
Data Località N° sito<br />
Tempo: soleggiato – nuvoloso – piovoso Vento: assente – brezza – media - intenso<br />
Foresta umida Foresta arida Ambiente agricolo<br />
A) Componenti geografici<br />
B) Vegetazione<br />
C) uccelli<br />
D) Presenza umana<br />
e) Aspetti sensoriali<br />
non visivi<br />
F) Altro<br />
Struttura Struttura Struttura<br />
Alberi % Alberi % Alberi %<br />
Arbusti % Arbusti % Arbusti %<br />
Erbe % Erbe % Erbe %<br />
Specie di alberi ed arbusti: Specie di alberi ed arbusti:<br />
Specie di piante erbacee:<br />
Specie di piante acquatiche:<br />
Specie di piante erbacee:<br />
Specie di piante acquatiche:<br />
Specie di alberi ed arbusti:<br />
Specie di piante erbacee:<br />
Specie di piante acquatiche:<br />
41
42<br />
ANALISI DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo<br />
Nomi:………………………………………<br />
1. Quali sono gli aspetti comuni incontrati nei diversi ambienti ?<br />
2. In cosa consistono le principali diversità ?<br />
3. Quali sono i segni di naturalità dei tre ambienti ? E quali detengono la massima diversità biologica ?<br />
4. Quali sono le tracce dell’attività dell’uomo nei tra ambienti ?<br />
Scheda n. 12
LO STUDIO DELLA VEGETAZIONE<br />
Perché è importante conoscere e<br />
riconoscere la flora?<br />
Perché è importante conoscere e riconoscere le piante<br />
nel loro ambiente?<br />
• per la curiosità di (ri)conoscerne i caratteri distintivi;<br />
• Perché “stanno ferme”, lasciandosi osservare per intere<br />
stagioni e nelle diverse stagioni;<br />
• perché le piante, così diversamente legate ai fattori<br />
terreno, acqua, luce, temperatura, ecc possono,<br />
tramite <strong>il</strong> loro stato di salute, dare informazioni preziose<br />
sullo stato dell’ambiente (es. inquinamento acuto,<br />
siccità); inoltre, ad ambienti diversi (per i fattori suolo,<br />
umidità, <strong>il</strong>luminazione, temperatura) corrispondono<br />
piante diverse, che quindi diventano indicatrici di<br />
quell’ambiente, rendendolo riconoscib<strong>il</strong>e;<br />
• perché le piante sono alla base delle catene alimentari<br />
e quindi associate in modo diverso; esse sono habitat<br />
per le più varie specie di animali;<br />
• Perché una volta conosciuta nel suo ambiente naturale,<br />
ritrovare una pianta in un altro contesto - per esempio<br />
in un giardino di una città - può essere come ritrovare<br />
un’amica, e quindi un vero piacere… oppure un<br />
dispiacere! Per esempio, se l’albero è stato piantato<br />
dove non doveva, come un pino che ha bisogno di<br />
tanta luce, stretto fra le case…<br />
• Perché (trovate altri motivi)…<br />
In questo <strong>libro</strong> ci limiteremo ad <strong>il</strong>lustrare solo alcune<br />
specie vegetali caratteristiche del <strong>Parco</strong>, evidenziando<br />
i caratteri inconfondib<strong>il</strong>i. Per gli altri caratteri, e per altre<br />
specie “minori” che pur si possono ritrovare nel <strong>Parco</strong>,<br />
rimandiamo alle tante, ottime guide esistenti sul mercato,<br />
che anzi consigliamo di procurarsi.<br />
Cominciamo da uno sguardo sui boschi del <strong>Parco</strong>, là dove<br />
vivono le forme vegetali più complesse, più longeve e<br />
visib<strong>il</strong>i: gli alberi.<br />
43
44<br />
Aren<strong>il</strong>e<br />
Dall’Aren<strong>il</strong>e alle zone agricole<br />
Area retro-dunale<br />
I BOSCHI<br />
Questo è un bosco nel <strong>Parco</strong>,<br />
visto dall’alto. Si vedono le<br />
chiome a ombrello dei pini e<br />
strisce di bosco più variegato.<br />
Queste strisce si alternano più<br />
volte, più o meno parallele alla<br />
linea di costa.<br />
I boschi seguono l’alternanza di<br />
cordoni dunali e di depressioni<br />
interdunali (più vicine alla falda<br />
sotteranea).<br />
Pineta
Così abbiamo ambienti diversi: più<br />
asciutti sulle dune, più umidi e freschi,<br />
nelle interdune. Nelle interdune, le<br />
cosiddette “lame”, l’acqua ristagna<br />
per tutto l’inverno, non appena la<br />
falda si ingrossa, alimentata dalle<br />
piogge.<br />
È l’ambiente ideale per Ontani e<br />
Frassini, alberi le cui radici resistono<br />
per 4-5 mesi di sommersione. Perché<br />
si dice “resistere?” Perché le radici,<br />
come tutti gli esseri viventi, devono<br />
respirare. Nel suolo c’è aria, quella<br />
fra un granello di terra e l’altro,<br />
ma nell’acqua, specialmente se<br />
stagnante, l’ossigeno disponib<strong>il</strong>e<br />
è veramente poco. Questi boschi<br />
umidi sono detti “igrof<strong>il</strong>i”, cioè<br />
amanti dell’acqua. Molti altri alberi<br />
invece, come i Pini, ma anche <strong>il</strong><br />
Leccio e la Farnia, non sopportano<br />
terreni sommersi. E infatti non si<br />
trovano nelle interdune. Il pino ed<br />
<strong>il</strong> leccio, per esempio, sono alberi<br />
adattati al secco,<br />
Bosco igrof<strong>il</strong>o<br />
Spiaggia<br />
Dune Bosco<br />
Area retrodunale<br />
Zone agricole<br />
45
46<br />
Bosco di Pini e Lecci<br />
Bosco mesof<strong>il</strong>o – farnie lecci pini<br />
Bosco idrof<strong>il</strong>o – ontani frassini<br />
LE SEzIONI DEL bOSCO<br />
TRANSETTO: sezione trasversale<br />
PROFILO: sezione longitudinale<br />
tipico dei climi mediterranei, e quindi li troviamo<br />
solo sulle dune più rialzate.<br />
Ambienti intermedi fra le dune e le interdune, quindi<br />
né troppo umidi, né troppo secchi (ma comunque<br />
freschi), sono occupati da boschi di latifoglie<br />
(latifoglia sta per foglia larga, in opposizione agli<br />
aghi delle aghifoglie o conifere) molto variati. Ci<br />
si ritrova anche qualche pino e qualche leccio e<br />
ontano. Ma regnano la Farnia, <strong>il</strong> Carpino bianco,<br />
e altri alberelli “minori” come l’acero campestre<br />
e l’olmo campestre. Questi boschi “si chiamano<br />
“mesof<strong>il</strong>i”, cioè amanti delle condizioni intermedie.<br />
Sono alberi che rifuggono dalle condizioni<br />
climatiche estreme, come <strong>il</strong> troppo secco o <strong>il</strong><br />
troppo umido.<br />
Nel <strong>Parco</strong> quindi non c’è un solo bosco, ma almeno<br />
tre tipi di bosco! Ovviamente fra questi tipi<br />
ci sono tante varianti, che potrete riconoscere<br />
passeggiando nel bosco, anzi nei boschi del <strong>Parco</strong>.<br />
Il fatto che tanti ambienti diversi, con tanti alberi<br />
diversi,siano alternati e confinanti, oltre a rendere <strong>il</strong><br />
paesaggio più variato, spiega la grande ricchezza<br />
della fauna ospitata. Se ne possono trovare di tutti<br />
i tipi, adatta all’uno o all’altro ambiente, o a due<br />
nello stesso tempo. Ambienti diversi dove nutrirsi,<br />
riprodursi, nascondersi, come Robin Hood.<br />
Esempio “A”<br />
APPROfONDIMENtO<br />
COSA E’ UN tRANSEttO?<br />
Le immagini a fi anco si chiamano<br />
transetti.<br />
I transetti sono “sezioni” di un<br />
bosco, disegnate dai Forestali<br />
per schematizzare un’area boscata.<br />
Prova a leggere un trasetto!<br />
Potrai capire :<br />
- quali alberi compongono un<br />
bosco;<br />
- <strong>il</strong> lay-out (“sagoma”);<br />
- lo sv<strong>il</strong>uppo in altezza e lunghezza<br />
di alberi e arbusti.<br />
COME SI DISEGNA UN<br />
tRANSEttO?<br />
Si fa un “r<strong>il</strong>ievo “ in sito,<br />
misurando gli alberi e gli<br />
arbusti presenti nel bosco<br />
in esame.<br />
(vedi esempio “A”)
LE PINETE<br />
In questi boschi dominano, per altezza e numero, i pini. Ce ne sono di due tipi: <strong>il</strong> pino marittimo e <strong>il</strong> pino domestico. Solo dagli aghi i due pini non si distinguono<br />
fra loro. Due sono i caratteri inconfondib<strong>il</strong>i: <strong>il</strong> portamento e le pigne.<br />
Pino marittimo<br />
Il pino marittimo che non riesce a<br />
crescere diritto, nemmeno lontano<br />
dal mare!, resiste bene ai venti<br />
marini, perciò fu piantato proprio<br />
antistante <strong>il</strong> mare, per proteggere le<br />
retrostanti pinete di pino domestico.<br />
Resiste, come tutte le specie<br />
viventi, adattandosi. Notate come<br />
cambia <strong>il</strong> portamento e l’altezza<br />
del pino marittimo allontanandosi<br />
dal mare!!<br />
Il pino domestico è quello che<br />
fa i pinoli, raccolti ancora oggi.<br />
È per i pinoli, per la velocità di<br />
accrescimento dell’albero, e<br />
quindi anche per <strong>il</strong> legno, che<br />
furono piantate le pinete secoli fa.<br />
Per almeno due secoli centinaia<br />
di persone vivevano delle pinete:<br />
scuotitori (si arrampicavano sui<br />
pini e buttavano giù le pigne<br />
con le pertiche), raccattini,<br />
ghirai (cacciavano i ghiri, temib<strong>il</strong>i<br />
divoratori di pigne, uccidendone a<br />
migliaia ogni anno), pulitori di fossi,<br />
boscaioli, ecc.<br />
Pino domestico<br />
47
48<br />
BOSCO DI PINO MARITTIMO (Pinus pinaster) BOSCO DI PINO DOMESTICO (Pinus pinea)<br />
Pigna<br />
aperta<br />
Pigna chiusa<br />
Il Pino marittimo vive<br />
150-200 anni e ha un<br />
accrescimento relativamente<br />
rapido. Può<br />
raggiungere un’altezza<br />
di 30 mt. ed è caratteristico<br />
per <strong>il</strong> suo portamento<br />
a fusto inclinato,<br />
detto “a sciabola”,<br />
dovuto alla spinta<br />
dei venti marini.<br />
Corteccia: spessa, rosso<br />
violacea con profonde<br />
fenditure e placche<br />
che si staccano.<br />
foglie: aghi persistenti<br />
coriacei e appuntiti,<br />
riuniti a due, molto lunghi<br />
(sino a 20 cm). Tutte<br />
le foglie divergono<br />
dal ramo.<br />
Pigne: coniche se chiuse,<br />
ovoidali se aperte,<br />
lunghe 10-20 cm, asimmetriche,<br />
non resinose,<br />
con squame ad apici<br />
acuminati. Prive di pinoli.<br />
Corteccia: prima rosso<br />
bruno, scagliosa, suddivisa<br />
in grandi placche<br />
quadrango-lari.<br />
foglie: aghi persistenti<br />
riuniti a due, lunghi 10-<br />
20 cm.<br />
Pigne: generalmente<br />
solitarie, globose, lunghe<br />
8-15 cm. Al loro interno<br />
si sv<strong>il</strong>uppano i pinoli,<br />
semi commestib<strong>il</strong>i<br />
a guscio legnoso.<br />
Pigna<br />
Il Pino domestico, presenta<br />
<strong>il</strong> tipico portamento ad ombrello<br />
con chioma espansa<br />
nella pianta adulta, raggiungendo<br />
un’altezza di 25-30<br />
mt. Nella pianta giovane la<br />
chioma è globosa con i rami<br />
rivolti verso l’alto. Sopporta<br />
meno i venti marittimi.<br />
Pinolo
Sotto le pinete c’è <strong>il</strong> leccio e altre sclerof<strong>il</strong>le mediterranee. Queste sono piante, arboree ed arbustive adattate ai climi mediterranei, cioè alle estati siccitose<br />
con piogge concentrate in autunno ed inverno. Perciò sono sempreverdi: possono così approfittare delle piogge invernali. Dalla siccità estiva si “difendono”<br />
non solo riducendo al minimo la propria attività, ma anche tramite la spessa cuticola cerosa che ricopre le foglie, così da diventare coriacee, cioè “rigide”<br />
(da cui deriva <strong>il</strong> nome “sclerof<strong>il</strong>le”). Le leccete sono considerate tipiche delle fascia mediterranea e <strong>il</strong> leccio è certamente la specie autoctona per eccellenza<br />
della zona: infatti, se non è sistematicamente mangiato dagli animali, c’è sempre un denso strato di leccio sotto le chiome dei pini.<br />
Il leccio svolge almeno due funzioni nelle pinete. Prima di tutto, aiuta a mantenere una certa fert<strong>il</strong>ità al suolo, dato che gli aghi delle conifere danno origine<br />
a suoli poveri di elementi e acidi.<br />
2° livello:<br />
Pineta<br />
1° livello:<br />
Lecceta<br />
Inoltre un bosco a più strati diversi è certamente più ricco ed accogliente per tante specie diverse!<br />
Questa presenza contemporanea di due specie, una sopra e una sotto, è possib<strong>il</strong>e perché <strong>il</strong> pino è eliof<strong>il</strong>o, cioè ha bisogno di tanta luce, mentre <strong>il</strong> leccio sta<br />
bene anche sotto copertura (si dice sciaf<strong>il</strong>o = ama l’ombra).<br />
49
50<br />
Il leccio è una pinta sempreverde, come i pini, ma non è una conifera. Non ha i<br />
coni (infruttescenze che portano i semi), ma veri e propri frutti. È una latifoglia.<br />
È inconfondib<strong>il</strong>e, prima di tutto in inverno, perché è l’unica con le foglie.<br />
Anche in estate si fa vedere bene. Innanzitutto <strong>il</strong> leccio è una quercia, e come<br />
tutte le querce, ha le ghiande. Vedrete poi come sono diverse da quelle dell’altra<br />
quercia del <strong>Parco</strong>, la Farnia.<br />
Le foglie, coriacee, possono avere<br />
una grande variab<strong>il</strong>ità all’interno<br />
dello stesso albero. Quelle più<br />
basse infatti, accessib<strong>il</strong>i<br />
al morso degli animali, si difendono<br />
come possono e spesso sono<br />
spinose (a).<br />
Le foglie più alte invece non hanno<br />
nemmeno una spina (b).<br />
Un altro albero sim<strong>il</strong>e al leccio che<br />
si ritrova nel parco è la sughera. È<br />
sempre una quercia sempreverde<br />
e le foglie sono molto sim<strong>il</strong>i a quelle<br />
a) foglie alte b) foglie basse del leccio, così come la ghianda,<br />
la cui cupola ha però le squame<br />
rivolte verso l’esterno. La differenza<br />
maggiore sta (lo dice anche <strong>il</strong> nome) nella corteccia, spessa e, appunto,<br />
sugherosa. Ci sono luoghi, in Italia del sud ed in Portogallo, dove le sughere sono<br />
coltivate proprio per estrarre <strong>il</strong> sughero, scortecciando l’albero ogni dieci anni<br />
(circa). Il sughero infatti, oltre ad essere usato per i tappi, è un ottimo isolante<br />
del suono o del calore. La prima a sapere queste ottime qualità della corteccia<br />
è la sua proprietaria…abbiamo visto gruppi di sughere nelle quali sono passati<br />
incendi che si sono limitati bruciare le foglie, annerendo (e basta) <strong>il</strong> tronco!<br />
È forse la quercia più mediterranea che esista, esigente com’è in luce e calore.<br />
Nel <strong>Parco</strong> si trovano sughere isolate solo nella Tenuta di Tombolo, a margine dei<br />
boschi (proprio perché a differenza del leccio hanno bisogno di molta luce).<br />
A Tombolo c’è anche una enorme sughera inserita nell’elenco regionale degli<br />
alberi monumentali. Chiedete al <strong>Parco</strong> che vi indichi dove si trova!<br />
Ghianda di leccio<br />
Leccio (Quercus <strong>il</strong>ex)<br />
Gemma
I BOSCHI MISTI DI CADUCIFOGLIE<br />
La farnia è l’albero principe dei boschi mesof<strong>il</strong>i. È una grande quercia che prima era diffusa in<br />
tutti i boschi detti “planiziari” (= di pianura) che un tempo, almeno fino al Medioevo, ricoprivano<br />
tutte le pianure europee, compresa tutta la pianura padana.<br />
Elementi inconfondib<strong>il</strong>i sono:<br />
la foglia, lobata, allungata, più larga nel terzo superiore, con due “orecchiette” vicino al<br />
picciolo.<br />
La ghianda, portata da un lungo picciolo, più grande e lunga di quella del leccio, è sormontata<br />
da una cupola più piccola (che si stacca fac<strong>il</strong>mente). La ghianda (che cade in settembre); è<br />
una preziosa risorsa alimentare per i cinghiali in inverno.<br />
A <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong>, potrete ammirare le grandi farnie del bosco di S. Bartolomeo e, a <strong>Migliarino</strong>, la<br />
quercia del Cinto riconosciuta come albero monumentale.<br />
Foglia di farnia<br />
Schema della foglia<br />
Schema della ghianda<br />
Ghianda di farnia<br />
Farnia (Quercus robur)<br />
51
52<br />
Il pioppo bianco raggiunge altezze considerevoli: vive poco (relativamente agli altri alberi, che possono<br />
vivere centinaia di anni, i pioppi vanno raramente oltre i 100 anni), ma cresce vertiginosamente. È<br />
inconfondib<strong>il</strong>e non solo per la corteccia biancastra, ma soprattutto per le foglie, completamente bianche<br />
nella pagina inferiore.<br />
Il pioppo è una pianta dioica: esistono cioè pioppi maschi (con solo fiori masch<strong>il</strong>i) e pioppi femmina (con<br />
soli fiori femmin<strong>il</strong>i).<br />
Altri pioppi che potete incontrare nel parco non sono tipici della zona, sono pioppi ibridi ut<strong>il</strong>izzati nelle<br />
pioppete (piantagioni specializzate) oppure nei giardini.<br />
Un altro pioppo comune nel <strong>Parco</strong> e molto usato nei f<strong>il</strong>ari è <strong>il</strong> pioppo cipressino, che è una varietà del<br />
pioppo nero. Si chiama così per la sua forma allungata, sim<strong>il</strong>e ad un cipresso.<br />
Pioppo bianco (Populs alba) Pioppo cipressino
Il Carpino bianco è un altro grande albero che spesso si associa alla farnia nei boschi più maturi.<br />
Elementi inconfondib<strong>il</strong>i sono:<br />
- la foglia, seghettata<br />
- i frutti<br />
- <strong>il</strong> tronco, liscio, a costole<br />
Carpino bianco (Carpinus betulus)<br />
Altre specie minori sono l’acero campestre e l’olmo<br />
campestre.<br />
Tutte queste sono specie tipiche, come si è detto, del bosco<br />
mesof<strong>il</strong>o.<br />
L’olmo si riconosce per la particolare forma della foglia<br />
asimmetrica su un lato.<br />
Olmo campestre (Ulmus minor)<br />
Acero campestre (Acer campestris)<br />
53
54<br />
BOSCO IGROFILO<br />
I BOSCHI ALLAGATI (ONTANETE E FRASSINETE)<br />
Nelle depressioni troveremo:<br />
L’ontano nero, inconfondib<strong>il</strong>e<br />
per le foglie, come appiattite<br />
in cima.<br />
Si riconosce anche per i<br />
frutti come dei grappoli di<br />
piccole pigne.<br />
L’ontano si riconosce anche<br />
in inverno, perché è l’unico<br />
con le gemme picciolate.<br />
Ontano nero (Alnus glutinosa)<br />
Anche <strong>il</strong> frassino ossifi llo si riconosce in inverno. Le gemme infatti<br />
(come poi le foglie) sono opposte sul ramo, grandi, di colore<br />
marrone. Le foglie sono composte, cioè formate da 5-7 paia<br />
di foglioline, più una terminale. I frutti<br />
si chiamano “samare”, e sono dei<br />
semi portati da una grande ala.<br />
Il frassino appartiene alla<br />
famiglia delle oleacee,<br />
come l’olivo, <strong>il</strong> ligustro e la<br />
f<strong>il</strong>lirea.<br />
Frassino ossif<strong>il</strong>lo (Fraxinus oxicarpa)
Nel <strong>Parco</strong> ci sono altri due alberi con le foglie composte, ma sono alberi che vi auguriamo di non trovare (sono piante invasive): la robinia (detta anche<br />
acacia) e l’a<strong>il</strong>anto. Ma non vi potete sbagliare: la robinia ha molte più foglioline ovali, le foglie sono disposte in modo alternato (e non opposto) sui rametti,<br />
che hanno le spine; anche le foglie dell’a<strong>il</strong>anto sono disposte in modo alternato e sono più “pesanti” di quelle del frassino.<br />
Alianto (A<strong>il</strong>anthus altissima)<br />
Il Cipresso calvo<br />
Nelle lame di <strong>Migliarino</strong> puoi trovare piccoli gruppi<br />
di una strana pianta, <strong>il</strong> cipresso calvo. Si chiama<br />
così perché in estate ricorda <strong>il</strong> cipresso, ma in<br />
inverno perde le foglie, cioè diventa…calvo!<br />
Questo albero proviene dalla Louisiana, Stato<br />
degli USA con molte paludi. Fu piantato alla<br />
fine dell’’800 dai Salviati, proprietari della zona<br />
(Tenuta di <strong>Migliarino</strong>).<br />
È quindi una pianta esotica, che non ha niente<br />
a che vedere con i frassini e gli ontani con cui<br />
condivide gli ambienti di lama. Però si è ben<br />
adattata a questi ambienti, ed è caratteristica per gli pneumatofori: dei “ginocchi” che<br />
dalle radici, attraverso l’acqua della lama, emergono in superficie e servono alle radici per<br />
respirare (nelle acque stagnanti l’ossigeno è scarso), proprio come delle cannucce per chi<br />
di noi restasse sott’acqua! Gli pneumatofori sono strutture cave,che, allo stato spontaneo<br />
(foreste dell’Ariziona, da cui provengono) crescono fino a 3 metri sopra <strong>il</strong> suolo.<br />
Robinia (Robinia pseudoacacia)<br />
Cipresso calvo ( Taxodium distichum)<br />
55
56<br />
asimmetria<br />
L’olmo si riconosce per la particolare<br />
forma assimetrica della foglia<br />
CURIOSITà: FOGLIE PARTICOLARI A CONFRONTO<br />
L’OLMO L’ONTANO LA FARNIA<br />
a) b)<br />
L’ontano si riconosce per la foglia<br />
priva di punta<br />
IL LECCIO<br />
senza punta<br />
Il leccio ha foglie coriacee.<br />
Quelle più basse sono spinose, per<br />
difendersi dal morso degli animali,<br />
quelle più alte, invece, non hanno<br />
nemmeno una spina (b).<br />
La farnia si riconosce per la foglia<br />
lobata allungata, più larga nel terzo<br />
superiore e con due “orecchiette”<br />
vicino al picciolo
Robinia Frassino A<strong>il</strong>anto<br />
IL PIOPPO BIANCO<br />
Il Pioppo bianco si riconosce per le<br />
foglie completamente bianche nella<br />
pagina inferiore<br />
IL PINO<br />
Le foglie dei pini sono aghi coriacei e<br />
appuntiti, riuniti a due.<br />
Nel Pino domestico gli aghi sono lunghi<br />
10-20 cm.<br />
Nel Pino marittimo gli aghi sono più<br />
lunghi (oltre 20 cm) e divergono dal<br />
ramo.<br />
ALBERI DALLE FOGLIE COMPOSTE<br />
LA ROBINIA – IL FRASSINO – L’AILANTO<br />
La Robinia e <strong>il</strong> Frassino hanno foglie<br />
composte.<br />
- Il Frassino si riconosce per la foglia<br />
formate da 5-7 paia di foglioline, più<br />
una terminale.<br />
- La robinia si distingue per la foglia<br />
composta di molte più foglioline<br />
ovali. Le foglie sono disposte in modo<br />
alternato (e non opposto) sui rametti<br />
dotati di spine.<br />
- le foglie dell’a<strong>il</strong>anto sono disposte<br />
in modo alternato e sono più spesse<br />
di quelle del frassino. Terminano inoltre<br />
con apici affusolati.<br />
57
58<br />
GLI ARBUSTI<br />
Gli arbusti più comuni nel bosco sono:<br />
Il pungitopo<br />
La f<strong>il</strong>lirea<br />
L’erica<br />
Il biancospino<br />
La Berretta del prete<br />
L’alloro<br />
Biancospino<br />
Pungitopo<br />
Berretta di prete<br />
F<strong>il</strong>lirea<br />
Alloro
LE RAMPICANTI E LE LIANE<br />
Nei boschi del <strong>Parco</strong> ci sono tre liane, quasi come nei lussureggianti boschi<br />
equatoriali!<br />
Le liane sfruttano <strong>il</strong> piano intermedio delle foreste, dove non c’è né la<br />
competizione degli arbusti (più bassi), né quella delle chiome degli alberi (più<br />
alti). I loro fusti viaggiano fra i tronchi ed i rami degli alberi cercando gli spazi<br />
disponib<strong>il</strong>i.<br />
La periploca è la liana più caratteristica: in Italia si trova solo nel nostro <strong>Parco</strong>,<br />
in Calabria ed in una piccola località in Puglia ed è ciò che rimane della<br />
vegetazione italiana di m<strong>il</strong>lenni fa, quando <strong>il</strong> clima era più caldo e umido<br />
dell’attuale. Cresce a spirale, e a volte può “strozzare” i giovani fusti degli alberi<br />
sui quali si arrampica.<br />
Edera<br />
Strappabrache<br />
Vitalba<br />
59
60<br />
Periploca greca<br />
Altre piante rampicanti e liane sono:<br />
lo stracciabrache, la vitalba e l’edera.
APPROfONDIMENtO<br />
Ma l’edera soffoca gli alberi?<br />
Nel <strong>Parco</strong> molti alberi sono avvolti nell’edera. Forse<br />
ti hanno detto, o ti sarà sembrato, che questa<br />
pianta rampicante (come le altre) tolga linfa<br />
ed “aria” all’albero, facendolo morire, e perciò<br />
debba essere tagliata “salvando” così l’albero.<br />
In realtà l’edera non è parassita (usa <strong>il</strong> tronco<br />
solo come sostegno), nel senso che le radici non<br />
entrano dentro l’albero per succhiarne la linfa. Le<br />
radici sono nel suolo, tanto è vero che per farla<br />
morire si taglia ad una certa altezza interrompendo<br />
<strong>il</strong> collegamento con le radici. La competizione per<br />
la luce potrebbe essere problematica solo nel<br />
caso che le foglie dell’edera abbiano raggiunto<br />
la chioma dell’albero coprendola tutta. Questo<br />
accade molto raramente (all’edera basta<br />
raggiungere la luce, anche ad una certa altezza<br />
sul fusto), e in genere un albero sano reagisce<br />
bene alla competizione potendo crescere<br />
maggiormente in altezza.<br />
Solo se l’albero è già molto vecchio e malandato,<br />
allora l’edera “appesantendo” la chioma rende<br />
l’albero più vulnerab<strong>il</strong>e al vento, e in sostanza gli<br />
dà <strong>il</strong> colpo di grazia. Solo in questo caso quindi,<br />
volendo “allungare” (anche se di poco) la vita<br />
all’albero, le si può togliere l’edera, specialmente<br />
nel caso di alberi in giardini pubblici o sulle strade.<br />
Altrimenti, ripetiamo, conviene lasciarla: aumenta<br />
la biodiversità del bosco, dato che i fiori sono<br />
apprezzatidalleapielebacche,moltoabbondanti,<br />
dagli uccelli. Inoltre le foglie arricchiscono di buon<br />
humus <strong>il</strong> suolo del bosco.<br />
61
62<br />
Ibiscus<br />
LE SPECIE ACQUATICHE DELLE ZONE UMIDE<br />
Il fondale del Lago e del Padule di <strong>Massaciuccoli</strong>, dove le acque sono limpide, è coperto da<br />
praterie di ceratofi llo, che si intravede appena sotto <strong>il</strong> pelo dell’acqua. Le radici trattengono la<br />
terra del fondo e la pianta si muove, flessuosa, con l’acqua. Nelle praterie di idrofite (=piante<br />
immerse nell’acqua) come questa si rifugiano pesci e insetti, alcuni dei quali rimangono<br />
comunque preda degli uccelli! Altre idrofite più<br />
vistose, per <strong>il</strong> fiore colorato , sono le ninfee ed <strong>il</strong> raro<br />
ibisco rosa.<br />
Sulle zone di margine parzialmente asciutte<br />
riconoscerete, dal movimento rigido degli steli,la<br />
cannella o canna di palude,<br />
mentre dal movimento ondeggiante potrete<br />
riconoscere <strong>il</strong> falasco.<br />
Queste piante hanno radici molto<br />
compatte; fra i loro fitti steli<br />
si mimetizzano uccelli molto<br />
specializzati, come <strong>il</strong> Tarabuso.<br />
Ninfea bianca<br />
Cannella di palude
Falasco<br />
Typha<br />
Il falasco era falciato e usato per fare<br />
i tetti delle case.<br />
Altra alofita (= pianta semi sommersa<br />
di margine) è la tifa, inconfondib<strong>il</strong>e<br />
per la pannocchia.<br />
Nelle paludi a nord del Lago<br />
ci sono ambienti veramente<br />
singolari, dove si affiancano<br />
piante “tropicali”, piante<br />
boreali e piante carnivore!<br />
Le torbiere sono un tappeto<br />
spugnoso di sfagni, specie<br />
di muschi tipici degli<br />
ambienti boreali, relitto<br />
delle passate glaciazioni,<br />
che trovano ancora sul<br />
lago condizioni fredde<br />
(“inversione termica”),<br />
a pelo dell’acqua, per<br />
vivere. Appena qualche<br />
decimetro sopra <strong>il</strong> pelo<br />
dell’acqua <strong>il</strong> microclima<br />
cambia (l’aria calda,<br />
più leggera, sta sempre<br />
sopra quella fredda):<br />
anche nei giorni più rigidi la<br />
temperatura non scende mai<br />
sotto lo zero e sopravvivono<br />
piante come la felce florida,<br />
relitto dell’era terziaria con<br />
clima caldo umido (tropicale!).<br />
Iris giallo<br />
Cannella di palude<br />
63
64<br />
Drosera<br />
APPROfONDIMENtO<br />
Vuoi sapere come si forma la torba?<br />
Nella sfagneta c’è anche una piccola pianta<br />
carnivora (carnivora di insetti, non di persone!!): la<br />
Drosera (o Rosolida). Dato che le torbiere solo molto<br />
povere di sostanze nutritive, la Drosera completa la<br />
sua dieta catturando piccoli e grandi insetti. Il sistema<br />
di cattura è molto astuto. Gli insetti sono attirati<br />
dai peli lucenti delle foglie dove, ignari, si posano<br />
pensando di dissetarsi sulla falsa rugiada. Allora scatta<br />
la trappola: i peli imprigionano la preda e secernono<br />
un liquido che digerisce l’insetto. Ben 6000 peli per<br />
centimetro quadrato di superficie fogliare riescono<br />
a digerire anche una libellula! Vuoi sapere quanto<br />
tempo impiega a digerire? Secondo la grandezza<br />
della preda, da qualche ora a 2 giorni!<br />
Ogni anno, lo sfagno cresce, anche molto rapidamente, fino a 3 cm; ma al tempo stesso, alla base, la stessa lunghezza muore. Così la parte viva della<br />
sfagneta rimane di spessore costante, mentre lo strato inferiore di sfagni morti aumenta a formare la torba.<br />
Le foglie degli sfagni possono immagazzinare acqua fino a 29 volte <strong>il</strong> loro peso. La pianta, disidratata, diventa bianca, ma riacquista subito vigore alla prima<br />
ondata. La torba, estremamente acida, è ut<strong>il</strong>issima come concime e ha virtù medicinali. Nel passato veniva usato anche come combustib<strong>il</strong>e. Gli strati di<br />
torba, che si succedevano regolarmente nel corso dei m<strong>il</strong>lenni e poi delle ere geologiche hanno conservato residui animali e vegetali (soprattutto polline)<br />
di quei tempi. Si conservavano bene perché le condizioni acide impediscono la degradazione delle sostanze. I pollini ritrovati negli strati inferiori hanno<br />
consentito agli archeobotanici (archeologi delle piante!) di farsi un’idea della vegetazione nelle diverse ère geologiche (vedi approfondimento successivo<br />
“I ricordi del passato, ovvero, dimmi che polline hai e ti dirò di quando sei”).
Torniamo nell’acqua del lago, dove c’è un’altra pianta acquatica carnivora:<br />
l’utricolaria o erba vescia. D’estate la pianta viene portata a galla da piccole<br />
vescichette a livello delle radici. d’inverno le vescichette si sgonfiano portando la<br />
pianta sul fondo, dove la temperatura rimane più mite.<br />
Queste stesse vesciche servono a catturare nientedimeno che piccoli crostacei e<br />
insetti. Se i malcapitati si avvicinano ai peli delle vescichette, si apre una valvola<br />
e una corrente improvvisa risucchia l’animale all’interno, dove viene digerito in …<br />
20 minuti!<br />
Altro relitto terziario acquatico è <strong>il</strong> morso di rana, con le foglie cuoriformi e i fiori<br />
bianchi visib<strong>il</strong>i solo fra l’estate e l’autunno. Sim<strong>il</strong>e al morso di rana, ma<br />
con foglie di forme diverse, abbiamo la rara idrocot<strong>il</strong>e. Piccole<br />
lenticchie d’acqua galleggiano in superficie.<br />
Nelle zone umide si trovano altre specie già citate<br />
per le foreste allagati, come l’ontano (sulle rive,<br />
dove si può trovare anche <strong>il</strong> salice), <strong>il</strong> giunco<br />
(che in formazione estese forma <strong>il</strong> giuncheto)<br />
la periploca.<br />
Talvolta si vedono vagare nel lago degli strani<br />
isolotti galleggianti, grandi da pochi metri a<br />
decine di metri quadrati. Sono gli aggallati, cioè<br />
gruppi di rizomi (radici) di canne di palude e altre<br />
piante palustri che con i venti e le correnti del lago si<br />
staccano e cominciano a vagare, magari con sopra un<br />
albero a fare da vela, finché non vengono legati o ancorati per<br />
consentire la navigazione in sicurezza delle barche. Nelle zone umide<br />
salmastre, limitrofe al mare (come le Lame di Fuori di <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> e la zona dell’Ulivo a<br />
Erba vescia<br />
Tombolo), vivono piante adattate a concentrazioni elevate di sale. La pianta più diffusa e caratteristica<br />
per le fioriture rosse in questi ambienti è la salicornia (forma i salicornieti), comune, assieme ad altre piante<br />
erbacee come <strong>il</strong> già ricordato giunco e altre, alle “maremme” della Toscana del sud.<br />
65
66<br />
Libellula<br />
Lenticchie d’acqua<br />
Girini<br />
Typha<br />
Gerride<br />
Menta<br />
Ceratof<strong>il</strong>lo<br />
Cannelle di palude<br />
Ninfea bianca
Lenticchie d’acqua<br />
Carpa<br />
Falasco<br />
Felca florida<br />
Rizzomi (radici del canneto)<br />
Zanzare<br />
67
68<br />
Soldanella di mare<br />
Sulla sommità delle dune troviamo i primi cespi della gramigna<br />
delle sabbia: proprio la compattezza di questi cespi comincia<br />
a “fissare” le dune. Il consolidamento vero e proprio delle sabbie<br />
avviene in posizione ancora più arretrata, con lo Sparto pungente,<br />
detto anche Ammofi la, che forma vere e proprie barriere capaci di<br />
trattenere la sabbia portata dal vento (successivamente la pianta<br />
cresce e si espande sopra la sabbia che via via si accumula).<br />
Dietro le dune domina una pianta profumatissima (soprattutto se<br />
le foglie sono strofinate), dal fiore giallo vivo (in apr<strong>il</strong>e-maggio): <strong>il</strong><br />
camuciolo o Elicriso. Abbiamo poi l’eringio di mare, la pastinaca,<br />
ed <strong>il</strong> raro Giglio di mare.<br />
LE PIANTE DELLE SABBIE OVVERO UNA VITA AL LIMITE<br />
Sugli aren<strong>il</strong>i e sulle dune la vita è dura! In estate, i vostri piedi se ne saranno<br />
accorti, la sabbia scotta! La temperatura raggiunge, nelle ore centrali<br />
del giorno, anche i 60 °C, e la notte torna a temperature vicine a quelle<br />
dell’aria, cioè fresche.<br />
In profondità invece ci si trova più isolati dal calore del sole e le temperature<br />
si mantengono costanti nel corso delle giornata.<br />
Inoltre non ci sono solo gli sbalzi di temperatura a rendere la vita diffic<strong>il</strong>e.<br />
Sulle coste <strong>il</strong> vento soffia spesso molto forte e contiene minuscole particelle<br />
di acqua salata in sospensione (l’aerosol).<br />
Queste condizioni climatiche locali anche molto diverse dal clima generale<br />
si chiamano microclimi. Quello degli aren<strong>il</strong>i è uno dei microclimi più<br />
caratteristici del <strong>Parco</strong>.<br />
Chi potrebbe sopravvivere in ambienti così<br />
“estremi”, sim<strong>il</strong>i ai deserti? Eppure vi sono piante<br />
ed animali molto adattati (“specialisti”).<br />
La vegetazione segue una successione<br />
dalla battigia verso l’interno.<br />
Si comincia dalla soldanella, che con<br />
le sue lunghissime, profonde radici<br />
comincia a trattenere (e trattenersi)<br />
alla sabbia battuta dal vento, e dalla<br />
Ruchetta di mare.<br />
Elicriso o camuciolo
Ginepro coccolone<br />
A diverse decine di metri dal mare si insedia qualche arbusto, come <strong>il</strong> bel ginepro<br />
coccolone (le “coccole” sono le bacche”, i cisti e qualche pino marittimo (che qui<br />
assume la forma arbustiva). Con gli arbusti le piante erbacee sono la<br />
Verga d’oro delle sabbie e <strong>il</strong> fi ordaliso grigio.<br />
Alcune di queste piante sono annuali, non le trovate cioè in inverno.<br />
Ma in primavera comincerete a vedere emergere le foglioline dalla sabbia…<br />
Sparto pungente<br />
Elicriso<br />
Eringio<br />
69
70<br />
L’ALBERO UN MONUMENTO DELLA NATURA<br />
L’albero è la forma di vita vegetale più longeva che esiste. E’ veramente affascinante che esistano<br />
alberi con centinaia e centinaia di anni di età (molto di più dei nostri nonni e bisnonni!), che magari<br />
hanno assistito a vicende storiche che studiamo nei libri, e che continuano ad ospitare, fra le fronde,<br />
uccelli di ogni tipo, rare foglie e frutti .<br />
Alcuni alberi hanno stimolato così tanto la fantasia dei nostri antenati, da diventare protagonisti di<br />
fiabe e leggende, che entrano nella storia di un luogo.<br />
Questi alberi di eccezionali dimensioni, spesso legati a miti e racconti sono detti alberi monumentali.<br />
Di questi alberi, censiti in tutta Italia, esistono veri e propri elenchi. Nell’elenco toscano degli alberi<br />
monumentali ben cinque alberi sono nel nostro <strong>Parco</strong> .<br />
Funghi e piante, una relazione speciale<br />
I funghi, non solo quelli commestib<strong>il</strong>i, sono gli spazzini della natura. Infatti la loro attività principale è<br />
decomporre materiale. Molti funghi nel suolo decompongono le foglie morte, creandone sostanze<br />
nutritive di nuovo disponib<strong>il</strong>i per le piante. Altri decompongono <strong>il</strong> legno: i “chiodini” altro non sono<br />
che le parti emerse (quelle che daranno origine ad altri funghi) di un fungo che “mangia” <strong>il</strong> legno,<br />
e infatti si ritrovano su alberi o parti di alberi morti o, appunto, “marci”.<br />
Ma i funghi stab<strong>il</strong>iscono con molte piante, soprattutto con gli alberi, una relazione veramente<br />
speciale di simbiosi. La parte di fungo presente nel terreno (detto micelio) si collega con le radici<br />
dell’albero “ospite”. Il micelio, con la radice in collegamento è detta micorriza. Il fungo prende<br />
dall’albero le sostanze nutritive che questo produce con la fotosintesi (linfa elaborata); l’albero, in<br />
“cambio”, assorbe tramite <strong>il</strong> fungo le sostanze minerali che da solo non saprebbe assorbire.<br />
Quindi, quando vedete un porcino, sappiate che non serve solo…al risotto!!<br />
E che danneggiare un fungo, anche, mentre lo si raccoglie, distruggendone <strong>il</strong> micelio (per esempio<br />
raccogliendo con <strong>il</strong> rastrello) o senza permettere che le spore (i “semi” del fungo) ritornino al suolo,<br />
ha delle conseguenze sul bosco.<br />
Nel <strong>Parco</strong> sono state contate oltre 1000 specie diverse di funghi!
APPROfONDIMENtO<br />
Le torbiere del Lago di <strong>Massaciuccoli</strong> si sono rivelate dei preziosi scrigni della storia vegetale del lontano passato. Il segreto sta nel<br />
polline (anzi nel suo involucro), che visto al microscopio si presenta in tante forme diverse da consentire <strong>il</strong> riconoscimento della specie<br />
cui appartiene. Il polline, che si deposita al suolo, nella torba si conserva per migliaia di anni (non si degrada). Così gli strati di torba<br />
che si sono succeduti nel corso dei m<strong>il</strong>lenni hanno conservato le tracce della vegetazione presente in quell’epoca. Gli archeobotanici<br />
(archeologi delle piante!) hanno analizzato nel Lago una successione di strati di ben 90 metri, pari a almeno 130.000 anni di storia<br />
ambientale del territorio. Sono stati ritrovati pollini di specie tipiche di climi freddi postglaciali, alternati a (più recenti) pollini di specie<br />
testimoni di climi più miti, fino a pollini di piante coltivate (4000-2000 anni fa, l’età del Rame e del Ferro), compresa la vite: forse una<br />
traccia di antichissimi vigneti!<br />
I ricordi del passato, ovvero, dimmi che polline hai e ti dirò di quando sei<br />
71
72<br />
Alla scoperta della vegetazione del <strong>Parco</strong> - Schede di lavoro<br />
LAVORO NEL PARCO<br />
COSTRUISCI UN ERBARIO<br />
per ogni ambiente del <strong>Parco</strong> (bosco di latifoglie,<br />
pineta, siepe campestre o fosso, zona umida,<br />
ambiente di duna), raccogli le piante (un solo<br />
individuo per specie: non devastare la flora!)<br />
più intere possib<strong>il</strong>e: fusto e radice (se pianta<br />
erbacea, ovviamente!), foglia, fiore, frutto.<br />
Conservali subito, ben stesi ad appiattiti, dentro<br />
carta di gjornale (segui le istruzioni delle più<br />
comuni guide).<br />
Segnati la data della raccolta, l’ambiente e, se<br />
lo sai subito, <strong>il</strong> nome della pianta.<br />
Puoi ripetere la raccolta in stagioni diverse e<br />
fare confronti.<br />
APPROfONDIMENtO<br />
Scheda n. 13<br />
Come si seccano le foglie<br />
Per schiacciare le foglie , si usa un<br />
utens<strong>il</strong>e a morsa, chiamato “torchio”.<br />
Per praticità puoi usare anche una p<strong>il</strong>a di<br />
libri pesanti, sovrapposti l’’uno all’altro.<br />
Ti consigliamo di interporre le foglie in<br />
carta assorbente o carta di giornale.<br />
Lascia seccare le foglie per alcuni giorni, in<br />
un ambiente asciutto, controllando periodicamente<br />
<strong>il</strong> loro stato. Le foglie secche<br />
avranno colorazione più attenuata.
TROVA LA CHIAVE DI ACCESSO NEL LABIRINTO DELLA CONOSCENZA DELLE PIANTE<br />
Foglie aghiformi<br />
(aghifoglie o conifere)<br />
Foglie larghe<br />
(latifoglie)<br />
Aghi riuniti a gruppi<br />
di 2<br />
…………….…… (completa)<br />
(qui quale altra parte della<br />
pianta vi aiuta a distinguere?)<br />
Aghi in vertic<strong>il</strong>li ……………….… (completa)<br />
Foglie singole<br />
Coriacee ………………<br />
(quale altra parte<br />
della pianta vi aiuta a<br />
distinguere?)<br />
Erbacee<br />
Lobate<br />
Scheda n. 14<br />
…………………………<br />
…………………………<br />
Palmate …………………………<br />
Asimmetriche alla base …………………………<br />
Arrotondate in cima …………………………<br />
Seghettate<br />
Foglie composte Foglioline affusolate e seghettate ……........……. (completa)<br />
Foglioline ovali<br />
(e rametti spinosi)<br />
……........……. (completa)<br />
Puoi costruirti una chiave di riconoscimento<br />
degli alberi del <strong>Parco</strong> a partire dagli elementi<br />
e dai disegni che ti abbiamo fornito!<br />
Scegli una parte della pianta, per esempio<br />
la foglia, e prova a fare questa suddivisione:<br />
Prova a fare una chiave sim<strong>il</strong>e per distinguere<br />
le querce del parco sulla base delle ghiande,<br />
per esempio.<br />
…………………………<br />
…………………………<br />
73
74<br />
GLI ALBERI DANNO I NUMERI<br />
Quanto è alto…?<br />
Perché è importante l’altezza per un albero? In un<br />
popolamento forestale sono gli alberi più alti quelli che<br />
sono avvantaggiati nei confronti della luce.<br />
Puoi avere un’idea abbastanza precisa dell’altezza di<br />
un albero senza salirci sopra o abbatterlo !<br />
Basta applicare una semplice proporzione (per la serie:<br />
la matematica serve a qualcosa)…<br />
corteccia<br />
Quanti anni ha?<br />
C’è un modo sicuro per sapere l’età di un albero: contare gli anelli.<br />
Ogni anello, formato dalla successione di vasi primaver<strong>il</strong>i (grandi) e<br />
vasi estivi (piccoli) è un anno di vita. (schema legno)<br />
Solo che per farlo, ormai l’albero…non c’è più, perché deve essere<br />
abbattuto ! (in realtà i forestali usano <strong>il</strong> “succhiello”, specie di<br />
trapano che preleva un tassello di legno dall’albero vivo e permette<br />
di contarne gli anelli).<br />
Nelle pinete giovani però si può sapere l’età dei pini semplicemente<br />
contando gli spazi fra un gruppo di rami e l’altro. La “punta”<br />
delle conifere infatti, e quindi anche quella del pino, “guida”<br />
l’accrescimento in altezza di tutto l’albero, come se lo tirasse verso<br />
l’alto. Per molti anni questi strati annuali di crescita (detti internodi)<br />
rimangono visib<strong>il</strong>i, poi con tempo i rami più bassi si seccano e cadono<br />
e le cicatrici dei punti di inserzione di questi ultimi si chiudono, non<br />
sono più visib<strong>il</strong>i per cui non è più possib<strong>il</strong>e questa lettura.<br />
Scheda n. 15
Quanto spazio occupa? (area d’insidenza)<br />
L’area d’insidenza è la superficie della proiezione della<br />
chioma al suolo, un po’ come l’ombra dell’albero<br />
quando <strong>il</strong> sole si trova proprio sulla verticale.<br />
Per misurarla bisogna essere in due, con una rotella<br />
metrica, e disporsi ai due estremi della proiezione,<br />
là dove la chioma dell’albero sembra più “larga”,<br />
passando per <strong>il</strong> centro (<strong>il</strong> tronco) dell’albero (misura D in<br />
metri). la seconda misura (d, in metri) è perpendicolare<br />
alla prima, cioè ci si sposta di 90°.<br />
La superficie si calcola assim<strong>il</strong>ando la proiezone della<br />
chioma ad un ellisse, e cioè<br />
A = π * (D*d)/2<br />
TANTI ALBERI FORMANO…<br />
N.B. Ognuno di voi fermi la propria attenzione su un singolo albero<br />
Scheda n. 16<br />
Descrizione: (Colpo d’occhio e prime osservazioni sparse)<br />
Com’è quest’albero? Vi piace?<br />
Come si presenta? E’ Spoglio? Verde? Sempreverde in qualsiasi stagione? Usate tutti i sensi e provate a descriverlo.<br />
Che portamento ha? E’ diritto? Contorto? Perché secondo voi ha quella strana forma?<br />
Misurazioni: Misurate altezza (vedi: quanto è alto?), diametro o circonferenza ed area d’insidenza(*) della chioma.<br />
Quanti anni ha (vedi scheda)?<br />
Un occhio al cielo… ed uno a terra<br />
Riuscite a vedere <strong>il</strong> movimento nel terreno creato dalle radici? Ma le radici si mangiano?<br />
Ci sono foglie in terra? Frutti? Semi?<br />
A chi appartengono? Al vostro albero o ad un suo vicino?<br />
Vicini di casa<br />
A questo punto cominciate ad conoscere anche i vostri “vicini di casa”. Siete tutti della stessa specie? Siete tanti? Quanto siete vicini? Avete abbastanza<br />
luce, abbastanza spazio? Chi lotta con voi per avere più luce?<br />
75
76<br />
…IL BOSCO<br />
Scheda n. 17<br />
N.B. prima di rispondere alle seguenti domande fate una “vostra personale” descrizione del bosco e cominciate a parlarne tra di voi, a ruota libera, osservando<br />
e commentando tutto ciò che vi va<br />
Descrizione:<br />
Quante specie diverse osservate?<br />
C’è un’unica specie? Ce ne sono tante?<br />
Densità e distribuzione nello spazio<br />
Che tipo di densità ha <strong>il</strong> bosco?<br />
Come sono distribuiti gli alberi nello spazio?<br />
Hanno tutti la stessa altezza?<br />
Se si, questo significa che hanno tutti la stessa età?<br />
Le chiome si toccano? La luce riesce ad arrivare al suolo o viene f<strong>il</strong>trata dalle chiome?<br />
Sottobosco<br />
Esiste un sottobosco? Come si lega la presenza o meno del sottobosco al passaggio della luce tra le chiome? Che tipo di sottobosco c’è? Riuscite a trovare<br />
nel sottobosco della rinnovazione? (segnalatela in qualche modo, tornando dopo molti mesi potreste non riconoscerla)<br />
Stato fitosanitario<br />
Tutti gli alberi godono di ottima salute od alcuni sono più sofferenti? ad esempio: alcuni sono caduti al suolo per i forti venti, altri presentano attacchi di funghi,<br />
altri sono stati percorsi da incendio, altri hanno parte della chioma ingiallita…<br />
Sono presenti segni di tagli? Chi abita questo bosco? Trovate tracce di escrementi? Nidi? Uova? Orme? Fori nel legno? Ecc…<br />
NON TUTTI I BOSCHI SONO UGUALI<br />
Ognuno di voi all’ interno del proprio gruppo ha analizzato un bosco,<br />
descrivete ciò che avete visto agli altri gruppi, potete usare foto, racconti, materiale raccolto caduto al suolo, o ancora meglio potete condurre direttamente<br />
i vostri compagni a visitarlo.<br />
confrontate <strong>il</strong> materiale raccolto e provate a dire le affinità o le differenze incontrate.<br />
tirate le conclusioni
SCOVA GLI ALIENI!<br />
Diametro<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
…<br />
Totale<br />
Pioppo bianco Farnia robinia<br />
A<strong>il</strong>anto<br />
Pino domestico … (altra specie)<br />
Per ogni specie, elaborare un grafico (potete accorpare i risultati dei diversi gruppi) con in ascisse in diametro e in ordinata <strong>il</strong> numero.<br />
n.<br />
Diametro<br />
Scheda n. 18<br />
Scegliete un bosco “invaso” da robinia o<br />
a<strong>il</strong>anto.<br />
Suddividetevi in due-tre gruppi.<br />
Ogni gruppo fa un’area di saggio circolare<br />
di 10 m di raggio che sarà poi delimitata con<br />
picchetti.<br />
All’interno dell’area di saggio si misura la<br />
circonferenza (che sarà poi trasformata in<br />
diametro) di tutti gli alberi presenti. Via via<br />
che si misura, preparare una tabella come<br />
segue (esempio): e segnare con una x nel<br />
riquadro corrispondente<br />
Confrontate le curve e discutete le<br />
differenze.<br />
Quali sono i due tipi principali di<br />
distribuzione? Cosa significano?<br />
77
78<br />
MISSIONE DI RICERCA<br />
Lavoro in sottogruppi (massimo 10 persone)<br />
Ingredienti:<br />
una superficie piana (un tavolo o un lenzuolo steso a terra) per deporre <strong>il</strong> materiale raccolto, e… <strong>il</strong> vostro ingegno !<br />
• ogni sottogruppo riceve dall’insegnante, scritta su una scheda, una missione, che deve rimanere segreta agli altri sottogruppi.<br />
• avete 15 minuti per svolgere la missione<br />
• gli oggetti trovati vengono deposti sulla superficie piana<br />
• in base agli oggetti ritrovati da un gruppo, gli altri gruppi devono indovinare lo scopo della missione<br />
• si discute tutti assieme del lavoro svolto<br />
• si procede in questo modo per tutte le missioni<br />
Esempi di missioni:<br />
• trovare 10 specie di piante legnose (rametti e foglie)<br />
• trovare 6 stadi diversi di decomposizione, dalla foglia morta fino alla terra, o di legno (da appena morto a del tutto marcio)<br />
• trovare almeno 10 sfumature di colore che mostrino la transizione fra due colori (es. dal verde al giallo, dal giallo al marrone, ecc)<br />
• trovare 6 oggetti dagli odori molto diversi<br />
• trovare 6 oggetti molto diversi al tatto;<br />
• trovare 3 oggetti che non potrebbero esistere gli uni senza gli altri<br />
• trovare 6 indizi di vita animale<br />
• trovare 6 indizi di attività umane<br />
• ecc.<br />
Scheda n. 19
LO STUDIO DELLA FAUNA: GLI UCCELLI<br />
Lo studio degli uccelli<br />
Che cosa sono gli uccelli?<br />
Gli uccelli sono una classe di vertebrati, che si caratterizzano<br />
tra per avere un controllo della temperatura interno, un<br />
sistema circolatorio con circolo arterioso e venoso diviso<br />
(al pari dei mammiferi), le penne, <strong>il</strong> becco, la deposizione di<br />
uova, quest’ultime incubate da uno o entrambi i genitori e,<br />
naturalmente, per <strong>il</strong> fatto di essere essenzialmente dei volatori<br />
attivi.<br />
Come si studiano sul campo gli uccelli?<br />
Gli uccelli hanno da sempre attirato l’attenzione dei naturalisti<br />
e delle persone che hanno conosciuto e vissuto <strong>il</strong> <strong>Parco</strong>.<br />
Abbiamo infatti imparato che le zone umide, avendo una<br />
grandissima produttività biologica, attirano in gran numero gli<br />
uccelli assieme a tante altre specie. Va comunque detto che<br />
in passato la conoscenza dell’avifauna era di solito legata ad<br />
una caccia sussistenza, in cui l’ut<strong>il</strong>izzo delle proteine animali<br />
fornite dagli uccelli era in molti casi vitale. Attualmente invece<br />
la caccia è praticata per d<strong>il</strong>etto, durante <strong>il</strong> tempo libero.<br />
La conoscenza degli uccelli, a partire dall’ottocento, è<br />
diventata anche una pratica scientifica che si chiama<br />
ornitologia e che, oltre a numerosi scienziati, coinvolge molti<br />
appassionati, attraverso l’inanellamento a scopo scientifico<br />
(per <strong>il</strong> quale sono necessari specifici permessi) ed i censimenti<br />
ornitologici per la raccolta dati, ut<strong>il</strong>e alla ricerca scientifica e<br />
alla conservazione della natura. Inoltre col birdwatching molte<br />
persone appassionate di natura, decidono di stare a contatto<br />
con essa potendo ammirare gli uccelli che ancora oggi<br />
sopravvivono soprattutto nelle aree protette o comunque poco<br />
abitate, come quelle del <strong>Parco</strong>. Osservazioni che avvengono<br />
nelle diverse stagioni, nella moltitudine dei comportamenti e<br />
adattamenti e, perché no, nella loro straordinaria eleganza e<br />
bellezza.<br />
13. La classe è uno dei gruppi<br />
in cui la sistematica (vedi sistematica)<br />
classifi ca gli animali:<br />
Phylum – Classe - Ordine – Famiglia<br />
– Genere - Specie. Ad<br />
esempio l’uomo appartiene alla<br />
classe dei mammiferi: Cordati<br />
– Mammiferi - Primati – Ominidi<br />
– Homo – sapiens.<br />
14. I vertebrati sono animali<br />
dotati di colonna vertebrale. Ne<br />
fanno parte i pesci, gli anfi bi, i<br />
rett<strong>il</strong>i, gli uccelli ed i mammiferi.<br />
15. La circolazione sanguigna<br />
è la circolazione del sangue<br />
negli animali, ovvero del fl uido<br />
che è deputato agli scambi respiratori<br />
tra l’organismo e l’ambiente<br />
esterno; e che trasporta<br />
le sostanze nutritive a tutti i tessuti<br />
e al contempo ne rimuove<br />
le scorie.<br />
16. L’inanellamento a scopo<br />
scientifi co è un pratica ut<strong>il</strong>e allo<br />
studio della biologia degli uccelli<br />
soprattutto in relazione alla<br />
conoscenza dei loro spostamenti,<br />
longevità, fi siologia della muta<br />
delle penne ecc. ut<strong>il</strong>e soprattutto<br />
perchè legata al fatto che<br />
vi è <strong>il</strong> marcamento e quindi <strong>il</strong><br />
riconoscimento individuale degli<br />
uccelli durante fasi diverse della<br />
loro vita (nel caso in cui siano<br />
ricatturati dopo la prima volta).<br />
Nel nostro territorio esistono numerose<br />
stazioni d’inanellamento<br />
(vedi <strong>il</strong> capitolo: I luoghi).<br />
17. I censimenti ornirologici<br />
sono conteggi degli uccelli presenti<br />
in un’area effettuati con<br />
metodi diversi. Tali informazioni,<br />
raccolte a livello regionale, nazionale<br />
e mondiale, ci danno<br />
le informazioni base sullo stato<br />
di salute delle popolazioni e,<br />
indirettamente, su quello dell’ambiente.<br />
...[1]<br />
79
Gli ambienti degli uccelli<br />
Gli habitat<br />
Naturalmente la suddivisione in habitat non è rigida; infatti alcune specie sono più eclettiche di altre ed alcune dipendono<br />
da ambienti diversi per esigenze diverse. P.e. la ghiandaia marina può nidificare in vecchi alberi e nutrirsi in ambienti<br />
aperti, mentre <strong>il</strong> colombaccio dormire nel folto della foresta e nutrirsi nei campi<br />
80<br />
BOSCHI<br />
Vi vivono specie eclettiche<br />
come <strong>il</strong> merlo, la cinciallegra,<br />
la capinera, la ghiandaia, <strong>il</strong><br />
fringuello, <strong>il</strong> verdone, l’allocco,<br />
la poiana e <strong>il</strong> colombaccio,<br />
ed inoltre, nelle foreste mature<br />
tipiche del <strong>Parco</strong>, troviamo<br />
anche specialisti molto più rari<br />
come <strong>il</strong> picchio rosso maggiore,<br />
<strong>il</strong> picchio verde, <strong>il</strong> rampichino, <strong>il</strong><br />
fiorrancino, <strong>il</strong> picchio muratore,<br />
la colombella, e <strong>il</strong> rigogolo.<br />
Solo in questi boschi infatti la<br />
ricca presenza di cavità per<br />
nidificare e di invertebrati per<br />
nutrirsi (insetti) consente questa<br />
diversità faunistica.<br />
ZONE UMIDE<br />
Gli uccelli acquatici sono quelle specie<br />
che dipendono dalle zone umide. per<br />
una o per tutte le fasi della loro vita.<br />
Tra loro vi sono gruppi molto diversi<br />
che però sono accomunati dall’avere<br />
una profonda convergenza verso i<br />
medesimi adattamenti all’ambiente<br />
acquatico. Tra i più generalisti vi sono <strong>il</strong><br />
gabbiano reale, <strong>il</strong> gabbiano comune,<br />
la garzetta e l’airone cenerino, mentre,<br />
legate al mare, al lago e alle lagune<br />
troviamo le anatre marine, le strolaghe,<br />
i cormorani, lo svasso maggiore, <strong>il</strong><br />
tuffetto, <strong>il</strong> martin pescatore. Mentre,<br />
nelle zone paludose e di battigia<br />
incontriamo <strong>il</strong> fratino, l’occhione, <strong>il</strong><br />
germano reale, l’alzavola, la marzaiola,<br />
la gallinella, la folaga, <strong>il</strong> porciglione,<br />
<strong>il</strong> chiurlo maggiore, <strong>il</strong> beccaccino, le<br />
gru, <strong>il</strong> falco di palude, <strong>il</strong> pendolino, la<br />
cannaiola ed <strong>il</strong> cannareccione.<br />
AMBIENTI APERTI<br />
Sempre presenti troviamo le<br />
cornacchie e in misura inferiore<br />
le gazze, <strong>il</strong> verzellino, <strong>il</strong> cuculo,<br />
la rondine, <strong>il</strong> balestruccio e <strong>il</strong><br />
rondone; legati in particolare<br />
agli ambienti agrari e alle zone<br />
umide. Tra i più rari infine, la<br />
ghiandaia marina, l’upupa, <strong>il</strong><br />
gruccione, l’averla piccola, la<br />
calandrella, <strong>il</strong> succiacapre, <strong>il</strong><br />
gheppio, la pavoncella, l’oca<br />
selvatica, l’albanella minore e<br />
reale, l’assiolo e <strong>il</strong> barbagianni<br />
legati ad ambienti agrari<br />
diversificati o ad ambienti<br />
dunali sufficientemente<br />
indisturbati mentre <strong>il</strong> gruccione<br />
necessita di terreni sabbiosi per<br />
nidificare tipiche delle sponde<br />
di ambienti fluviali naturali e dei<br />
terreni del <strong>Parco</strong>.<br />
COSA SERVE PER L’OSSERVAzIONE<br />
L’attrezzatura necessaria per l’osservazione<br />
ed <strong>il</strong> riconoscimento<br />
sul campo degli uccelli è costituita<br />
dal taccuino ed un lapis (con<br />
l’umidità funziona molto meglio<br />
della penna) per annotarsi le osservazioni,<br />
da un buon binocolo<br />
(almeno 8 o 10 ingrandimenti) e,<br />
specialmente in ambienti aperti<br />
come <strong>il</strong> mare e le paludi, da un<br />
cannocchiale (almeno 20-45 ingrandimenti)<br />
montato su treppiede<br />
per poter osservare gli animali<br />
a distanze notevoli. Infine la guida<br />
per l’identificazione sarà una<br />
compagna inseparab<strong>il</strong>e per chi<br />
vuole riconoscere gli uccelli.<br />
Un gran cambiamento in positivo<br />
poi, lo possiamo avere potendo<br />
ut<strong>il</strong>izzare una torre (o altana) o un<br />
capanno per l’osservazione naturalistica.<br />
pettirosso
Gli adattamenti degli uccelli<br />
Gli adattamenti degli uccelli sono di tipo anatomico/morfologico: lunghezza delle zampe, forma e lunghezza del becco, forma delle ali, ecc.; fisiologico:<br />
muta delle penne per la migrazione o impermeab<strong>il</strong>izzazione delle penne tramite secrezioni ghiandolari; o comportamentale: ritmi di vita quotidiani tra<br />
riposo e alimentazione o stagionali tra svernamento, migrazione o riproduzione.<br />
Ad ognuno <strong>il</strong> suo ritmo<br />
Schema del ciclo giornaliero di attività di molti uccelli acquatici (es. anatre ed aironi).<br />
Zona di nutrimento Zona di riposo<br />
campi, paludi, canali, ecc. grandi canneti o specchi d’acqua<br />
I giorni - Gli uccelli alternano quotidianamente periodi di attività a periodi di riposo. In queste fasi possono anche ut<strong>il</strong>izzare ambienti molto diversi. Talora<br />
alcune specie hanno ritmi diversificati con vari periodi d’attività sia di giorno che di notte.<br />
Uccelli diurni - Conducono di giorno le attività alimentari, di pulizia, di corteggiamento ecc. mentre cercano al crepuscolo una zona appartata<br />
dove passare la notte in gruppo, quando non sono impegnati nelle attività riproduttive. Esempi sono le rondini, le garzette, <strong>il</strong> cormorano, le ghiandaie, <strong>il</strong><br />
picchio verde.<br />
Uccelli notturni - Conducono prevalentemente di notte o al crepuscolo le attività alimentari, di corteggiamento ecc. mentre <strong>il</strong> giorno cercano una<br />
zona appartata dove riposarsi. Esempi sono costituiti da molte anatre, limicoli, allocco, succiacapre, barbagianni, occhione, nitticora.<br />
Le stagioni. Sono diverse le attività che gli uccelli svolgono nelle varie stagioni: in linea di massima un uccello stanziale ha, alle nostre latitudini, un<br />
periodo riproduttivo che, pur variando a seconda delle specie, per la maggior parte avviene in primavera. D’inverno invece lo scopo principale è quello<br />
di superare la stagione fredda adottando tutte le strategie necessarie, compresi periodi d’accumulo di scorte di grasso e spostamenti se necessari (non<br />
migrazioni quindi), verso habitat o latitudini più temperate. Per le specie migratrici tra questi periodi generali vi sono gli spostamenti migratori a cui le<br />
specie si preparano mutando le penne ed accumulando le riserve energetiche costituite dai grassi.<br />
81
82<br />
GRUCCIONE<br />
Di cosa si nutrono ?<br />
Il becco spesso indica di cosa e dove si nutrono principalmente gli uccelli.<br />
Lo usano come: una sonda nel limo (limicoli), una pinzetta per i piccoli invertebrati<br />
(passeriformi insettivori), una pinza per spezzare semi duri (passeriformi granivori), uno<br />
scalpello nel legno (picchi), un “pugnale” per pescare (aironi), un f<strong>il</strong>tro nell’acqua<br />
(fenicotteri), o un attrezzo per d<strong>il</strong>aniare la carne (rapaci).<br />
PICCHIO MIRATORE<br />
CAVALIERE D’ITALIA
Una rondine non fa primavera…<br />
ma un rondone si !!!<br />
Le migrazioni degli uccelli<br />
Cosa sono le migrazioni?<br />
Le migrazioni sono spostamenti di animali prevedib<strong>il</strong>i nel<br />
tempo e nello spazio attraverso i quali essi vengono a trovarsi<br />
in situazioni ecologiche diverse, dove sfruttare la stagione di<br />
maggiore produttività (nei climi temperati o freddi) e minore<br />
competizione; ed evitare successivamente quella con <strong>il</strong><br />
clima più rigido.<br />
Perché migrano gli uccelli ?<br />
Per riprodursi gli uccelli cercano le migliori condizioni di<br />
alimentazione e disponib<strong>il</strong>ità di spazio. Queste, in molte parti<br />
del mondo sono stagionali ed hanno portato allo<br />
sv<strong>il</strong>uppo del comportamento migratorio in molte specie.<br />
Inoltre, durante le ere geologiche i continenti si sono spostati<br />
determinando un continuo (e lento) adattamento delle rotte<br />
migratorie.<br />
Che cosa determina <strong>il</strong> comportamento<br />
migratorio ?<br />
I fattori che innescano <strong>il</strong> comportamento migratorio sono:<br />
a) fattori interni b) fattori esterni<br />
- Orologio interno<br />
- Istinto (capacità innate)<br />
- Cambio di durata del giorno<br />
- Temperatura<br />
- Diminuzione del cibo<br />
- Interazioni sociali<br />
18. Le ere geologiche sono i periodi<br />
di tempo in cui è suddivisa la storia<br />
della Terra.<br />
83
84<br />
Come si orientano gli uccelli<br />
Gli uccelli quindi, oltre alla necessità di avere grandi capacità di movimento, hanno bisogno di orientarsi con precisione. Vi può<br />
essere infatti fedeltà al sito di nidificazione e svernamento. Questo presuppone la capacità di ritrovare di anno in anno le stesse<br />
zone e talora le stesse località (orientarsi significa mantenere una direzione scelta mentre navigare vuol dire fare <strong>il</strong> punto su di<br />
una mappa mentale, per determinare la rotta da seguire rispetto alla meta in assenza di riferimenti ambientali percepib<strong>il</strong>i dal<br />
luogo di partenza). Per far questo gli animali usano capacità sensoriali straordinarie e specifiche, usando <strong>il</strong> campo magnetico<br />
terrestre, le costellazioni, l’olfatto o vari riferimenti visivi terrestri.<br />
Come si osservano le migrazioni<br />
Gli uccelli hanno da sempre affascinato le persone per i loro spettacolari spostamenti. Nel <strong>Parco</strong>, è possib<strong>il</strong>e osservare questo<br />
fenomeno semplicemente visitando una palude nelle differenti stagioni. Vedremo così che ambienti ed avifauna sono<br />
completamente diversi in ogni visita. E questo fenomeno è spettacolare nelle zone umide ma, in maniera più discreta, è<br />
osservab<strong>il</strong>e anche visitando un bosco, un ambiente dunale o un pascolo brado<br />
Le rotte degli uccelli migratori<br />
Alcune prestazioni sono le seguenti, anche se va tenuto<br />
presente che molte specie hanno popolazioni con<br />
comportamenti misti (in parte migratrici ed in parte<br />
sedentarie):<br />
A sinistra: Migrazione transhaariana-europea a<br />
fronte stretto (frecce grandi) e a fronte largo<br />
(frecce piccole). Esempi della prima sono molti<br />
rapaci e le cicogne; mentre della seconda molti<br />
passeriformi come le rondini ed i tordi.<br />
A destra: Migrazione entro europea p.e. di molte<br />
anatre.<br />
19. La capacità di navigazione è<br />
una caratteristica dei piccioni p. e<br />
sfruttata dall’antichità fi no all’800 per<br />
le comunicazioni, sia per scopi civ<strong>il</strong>i<br />
che m<strong>il</strong>itari, facendo uso della loro<br />
capacità di navigazione verso la loro<br />
“casa” (piccionaia).
APPROfONDIAMO:<br />
PERCHé GLI UCCELLI MIGRATORI<br />
PASSANO DAL PARCO MIGLIARINO<br />
SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI ?<br />
In Primavera gli uccelli si spostano<br />
a nord e trovano nel parco aree<br />
tranqu<strong>il</strong>le dove sostare soprattutto<br />
nelle zone umide, prima di raggiungere<br />
le zone riproduttive (piovanello<br />
pancianera, combattente, fraticelli,<br />
falco pecchiaiolo). Alcuni di essi<br />
poi, si riproducono nel <strong>Parco</strong> come<br />
ad esempio i gruccioni, le upupe, le<br />
cannaiole ed i tarabusini.<br />
In estate ed autunno prima le<br />
specie più precoci, e poi le altre, tornano<br />
da nord e vi sostano per mutare<br />
le penne o fare tappa in luoghi<br />
tranqu<strong>il</strong>li dove trovare riparo ed accumulare<br />
le riserve necessarie alla<br />
migrazione nei quartieri meridionali<br />
(vedi ad esempio le specie precedenti)<br />
formando talora gruppi numerosi<br />
che si preparano collettivamente<br />
per affrontare <strong>il</strong> lungo viaggio<br />
(p. e. di aironi, gabbiani, rondini<br />
e balestrucci).<br />
In inverno molte specie sono arrivate<br />
dal nord per passare la cattiva<br />
stagione nel mite clima mediterraneo<br />
per poi fare ritorno nei quartieri<br />
riproduttivi in primavera (anatre, limicoli,<br />
oche, cormorani).<br />
Autonomia di volo<br />
Nel loro viaggio sono comprese soste in zone dove mutare<br />
le penne prima del viaggio (p.es. le anatre) e in zone ut<strong>il</strong>i al rifornimento di cibo<br />
(adattamento comportamentale), che si accumula sottoforma di grasso (adattamento fisiologico) che è <strong>il</strong><br />
loro carburante. In alcuni casi poi, riescono a compiere spostamenti di 2000 km e più senza fermarsi. Questi<br />
spostamenti possono variare in genere da poche decine di ch<strong>il</strong>ometri di un pettirosso che si riproduce sugli<br />
Appennini e sverna nella foresta di <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong>; ai circa 6000 Km di un piovanello pancianera che, dalla Russia,<br />
passa in autunno da Bocca di Serchio, per poi arrivare a passare l’inverno nelle coste dell’Africa occidentale per<br />
poi, in primavera, ripartire.<br />
LE ANATRE SPICCANO IL VOLO<br />
85
86<br />
La determinazione delle specie d’uccelli<br />
La scienza della sistematica<br />
In senso strettamente scientifico la scienza che descrive le singole specie e la<br />
lororelazioneevolutiva(vicinanzadiantenaticomuninelcosodell’evoluzione)<br />
è la sistematica. Per far ciò usano sia mezzi descrittivi e di comparazione<br />
delle forme del corpo (anatomia, embriologia), che funzionali (fisiologia e<br />
anatomia funzionale) e biochimici (genetica, biologia molecolare). Con<br />
queste conoscenze essa cerca ad esempio di discriminare le somiglianze tra<br />
specie, dovute a vicinanza di comuni antenati (omologie), da quelle dovute<br />
a comuni adattamenti (analogie) e ricostruire così, gli alberi f<strong>il</strong>ogenetici<br />
(una specie di albero genealogico che mette in relazione le diverse specie<br />
evidenziando la distanza rispetto al comune antenato).<br />
Riconoscimento sul campo<br />
Tuttavia, la straordinaria popolarità degli uccelli è determinata in gran parte<br />
dalla loro bellezza e visib<strong>il</strong>ità. Va inoltre detto che la determinazione degli<br />
uccelli in natura, è un’arte che si può affinare con gli anni e alla fine, quello<br />
che viene osservato sono un insieme di caratteristiche che, elencate tutte<br />
assieme, sono una lista lunghissima e apparentemente poco ut<strong>il</strong>e, ma che<br />
per <strong>il</strong> naturalista esperto si costituisce in un quadro d’insieme unico per ogni specie e per ogni condizione d’osservazione. E’<br />
l’ut<strong>il</strong>izzo, per così dire, del quadro giusto, che gli fa determinare in gran sicurezza ogni individuo che vede. Spesso, inoltre, questo<br />
avviene con rapidità e distanza, tali da far sembrare tutta l’operazione incredib<strong>il</strong>e ad un profano .<br />
Ma è proprio così che avviene.<br />
20. l’evoluzione è la progressiva<br />
modificazione nel tempo degli<br />
organismi attraverso la selezione<br />
della variab<strong>il</strong>ità ereditaria<br />
(legata alla genetica) selezionata<br />
nell’ambiente naturale attraverso<br />
la riproduzione differenziale degli<br />
individui che portano le variazioni<br />
migliori in senso adattativi (più<br />
figli fert<strong>il</strong>i degli individui meglio<br />
adattati).
E forse è proprio l’apprendimento di questo meccanismo che ad essere alla base della grande popolarità del birdwatching,<br />
essendo emotivamente coinvolgente ed intellettualmente stimolante. Ma iniziamo con gradualità: quali caratteristiche sono<br />
ut<strong>il</strong>i per determinare le specie di uccelli?<br />
Dimensioni È una caratteristica relativa ad un riferimento, per comodità ci possiamo fare l’occhio ai seguenti<br />
riferimenti: passero – merlo – cornacchia – germano – airone cenerino. È ut<strong>il</strong>e nella descrizione usare<br />
questa scala di riferimento per restringere notevolmente <strong>il</strong> campo d’incertezza.<br />
Forma L’aspetto delle varie parti del corpo: becco, collo, corpo, coda, ali, ecc. denotano spesso a quale<br />
gruppo di uccelli appartiene.<br />
S<strong>il</strong>houette La forma del corpo nel suo complesso: in volo, posato a terra o sull’acqua è per alcuni gruppi un<br />
ottimo carattere diagnostico spesso molto importante in cattive condizioni d’<strong>il</strong>luminazione.<br />
Modo di volo Per alcune specie <strong>il</strong> volo, a volte associato a particolari richiami o stagioni, assume una notevole<br />
importanza anche a grande distanza.<br />
Stagione Migrando, non tutte le specie sono presenti in tutti i periodi dell’anno. E questo è spesso d’aiuto per<br />
la discriminazione tra specie sim<strong>il</strong>i ma con diverso comportamento migratorio.<br />
Canto La comunicazione acustica è straordinariamente importante per gli uccelli ed è una caratteristica<br />
usata dai più esperti per discriminare anche in lontananza o al buio specie sim<strong>il</strong>i o specie che non si<br />
fanno vedere.<br />
Colori La colorazione, molto piacevole da osservare, è ut<strong>il</strong>e qualche volta per determinare la specie ma<br />
spesso più per determinare <strong>il</strong> sesso e l’età in specie dotate di dimorfismo sessuale e con un abito<br />
diverso in diverse stagioni e/o tra giovani o adulti.<br />
Ambiente L’habitatincuiavvienel’osservazione:p.e.laguna,boscomesof<strong>il</strong>o,duneecc.;e,piùspecificatamente:<br />
in acqua, su un tronco, sulla sabbia con vegetazione sparsa, ecc. portano ad avvicinarsi molto bene<br />
ed a distinguere anche tra specie sim<strong>il</strong>i.<br />
Comportamento Le specie spesso hanno comportamenti distintivi: p.e. coppia in volo circolare in alto senza sbattere<br />
le ali (rapace p.e. poiana), in volo osc<strong>il</strong>lante tra albero ed albero (picchio) o emettendo un bip ad<br />
ogni osc<strong>il</strong>lazione (beccamoschino), gruppo di piccoli uccelli chiari che corre seguendo l’andirivieni<br />
della linea di battigia (piovanello tridatt<strong>il</strong>o) o, infine, rimane in volo battuto alcune decine di secondi<br />
a 30 m da terra (alcuni rapaci p.e. gheppio). Questi sono tutti comportamenti caratteristici di specie<br />
o di gruppi di specie.<br />
21. Il dimorfismo sessuale è un<br />
fenomeno per cui, in molti viventi,<br />
gli esemplari dei due sessi sono<br />
più o meno marcatamente diversi.<br />
Si pensi per esempio alle anatre i<br />
cui maschi hanno colori sgargianti<br />
mentre le femmine sono mimetiche.<br />
Nei daini invece sono soprattutto le<br />
dimensioni e la presenza di corna a<br />
distinguere i due sessi.<br />
87
88<br />
3<br />
4<br />
5<br />
2<br />
16<br />
Becco da carnivoro (es. poiana)<br />
Becco per f<strong>il</strong>trare l’acqua<br />
(es. germano reale)<br />
1<br />
17<br />
6<br />
7<br />
8<br />
14<br />
15<br />
13<br />
12<br />
10<br />
11<br />
9<br />
Il corpo<br />
sono parti del corpo:<br />
1) ala, 2) remiganti, 3) coda, 4) timoniere, 5) groppone, 6) dorso, 7) nuca,<br />
8) capo,9) fronte, 10) becco, 11) mento, 12) guancia, 13) petto, 14) ventre,<br />
15) fianco, 16) zampe, 17) dita.<br />
Se sai riconoscere e nominare tutte le parti di un uccello, lo saprai descrivere. Se lo saprai<br />
descrivere, avrai la possib<strong>il</strong>ità di identificarlo.<br />
Il becco<br />
Becco per “agguantare” <strong>il</strong><br />
pesce (es. gabbiano reale)<br />
Becco per rompere semi duri<br />
(es. fringuello)<br />
Becco per arpionare <strong>il</strong> pesce<br />
(es. airone rosso)<br />
Becco per catturare piccoli<br />
insetti (es. lui piccolo)<br />
Becco per sondare <strong>il</strong> limo in<br />
profondità (es. chiurlo maggiore)<br />
Becco per forare <strong>il</strong> legno<br />
(es. picchio rosso maggiore)
Le penne, le ali e la coda<br />
Le penne e le piume, distribuite sul corpo, servono ad isolare termicamente <strong>il</strong> corpo e a fornire coi loro disegni informazioni ai conspecifici (p.e. colo-<br />
razioni sessuali, o di coesio-ne del gruppo), o a nascondere la loro presenza (piumaggio mimetico). Sulle ali e la coda però, vi sono penne speciali:<br />
le remiganti e le timoniere. Esse sono fondamentali per <strong>il</strong> volo: conferiscono forme aerodinamiche alle ali e alla coda, permettendo agli uccelli di<br />
“galleggiare in aria”, e di cambiare velocità e direzione.<br />
Coda a cuneo Coda squadrata Coda appuntita Coda arrotondata Coda forcuta<br />
89
90<br />
Le zampe<br />
Le zampe, con la loro forma e funzionamento si adattano alle diverse esigenze di vita dell’uccello.<br />
Zampe con dita lunghe per<br />
camminare nella vegetazione<br />
palustre (es. porciglione)<br />
Zampe robuste e con dita lunghe<br />
per non affondare nel fango (es.<br />
airone cenerino o garzetta)<br />
Zampe con artigli arcuati e<br />
dita flessib<strong>il</strong>i per afferrare le<br />
prede (es.gheppio)<br />
Zampe robuste con due coppie di<br />
dita opponib<strong>il</strong>i per arrampicarsi sui<br />
tronchi (es.picchio rosso maggiore)<br />
Zampe palmate per nuotare<br />
bene (es. alzavola o altra<br />
anatra)<br />
Zampe con dita prens<strong>il</strong>i ut<strong>il</strong>i ad<br />
un piccolo uccello per aggrapparsi<br />
ai rami (es. cinciallegra)<br />
Zampe lobate per nuotare e<br />
camminare: (es. folaga)<br />
Zampe piccole con dita lunghe<br />
da piccolo camminatore<br />
(es. allodola)
Gli uccelli acquatici<br />
Essi costituiscono un grande gruppo di uccelli di notevole fascino, mediamente di dimensioni piuttosto grandi e che vivono raggruppati (ricorda la grande<br />
produttività biologica degli ambienti acquatici) in ambienti spesso aperti come le zone umide.<br />
Folaga<br />
Cormorani<br />
Airone bianco<br />
Airone cinerino<br />
91
92<br />
Gallinella d’acqua<br />
Marzaiola<br />
Germano
Tuffetto<br />
Svasso piccolo<br />
Svasso maggiore<br />
93
94<br />
Tarabusino<br />
Cannuccia di<br />
palude<br />
Luccio
Tinca<br />
Martin pescatore<br />
Gambero della Louisiana<br />
95
96<br />
Airone rosso<br />
Falasco<br />
e Canna di palude<br />
Cavaliere<br />
d’Italia
Garzette<br />
97
98<br />
Fenicotteri
Fratino<br />
Occhione<br />
Gli uccelli degli ambienti aperti<br />
Gabbiano comune<br />
Gruccione<br />
99
100<br />
Upupa
Ghiandaia<br />
Gli uccelli delle foreste<br />
Picchio muratore<br />
101
102<br />
Picchio rosso<br />
Picchio verde
Verdone<br />
Pettirosso<br />
Fringuello<br />
103
Alla scoperta della fauna del <strong>Parco</strong> - Schede di lavoro Scheda n. 20<br />
104<br />
A CIASCUNO IL SUO… ALI, SILHOUETTE, BECCHI, E ZAMPE, UNA QUESTIONE DI STILI DI VITA<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo a due squadre<br />
Nomi Squadra “A” ………………………................. Nomi Squadra “B” ………………...............................<br />
Lavoro (per ogni singola squadra): Scegliete tre uccelli di specie diversa…. appartenenti ad es. a: aironi, rapaci, limicoli scolopacidi, limicoli caradridi,<br />
folaghe, anatre, picchi, fring<strong>il</strong>lidi, ecc…<br />
Aiutandovi con alcune guide ornitologiche, disegnate schematicamente la sagoma degli uccelli scelti, ut<strong>il</strong>izzando cartoncini rigidi monocromatici e un<br />
pennarello nero. Ora prendete un paio di forbici e ritagliate i singoli cartoncini in tanti pezzi, distinguendo la s<strong>il</strong>houette, <strong>il</strong> becco, le zampe, le ali di ciascun animale….<br />
Otterrete un puzzle !!! Le singole parti saranno mescolate e passate alla squadra opposta. Vince chi riesce a ricomporre più velocemente i pezzi !!!<br />
E ora passate alla discussione: Come si chiama questo uccello? …. A quale specie appartiene? Come è fatto <strong>il</strong> suo becco? Perché? …e le sue ali ….le sue<br />
zampe …… Perché sono fatte così? ….. A cosa gli servono? Buon Lavoro!!!!<br />
CONSIGLIO: disegnate le sagome in un formato piuttosto grande. Nel ricomporre <strong>il</strong> disegno, potrete incollare insieme le singole parti e colorarle con pennarelli<br />
e matite. A lavoro ultimato, otterrete delle immagini Poster da attaccare alle pareti. Potrete inoltre associare lo schema di sotto riportato<br />
Gruppi 1 /specie S<strong>il</strong>houette Becchi Zampe Ali
FORMA, COMPORTAMENTO E STRATEGIE D’ALIMENTAZIONE<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo.<br />
Nomi: .....................................................<br />
Osservando le forme della scheda precedente provare a capire i comportamenti, l’alimentazione ed in generale gli adattamenti che posseggono le diverse<br />
specie.<br />
1) Differenti gruppi.<br />
2) Differenze in un gruppo.<br />
3) Strategie alimentari<br />
Conclusioni<br />
Scheda n. 21<br />
105
106<br />
OSSERVARE GLI UCCELLI<br />
Scheda di campo - Lavoro di gruppo<br />
Nomi: .....................................................<br />
Ogni giornata e gruppo di lavoro può riportare i dati nella scheda relativa che servirà in un secondo tempo per riassumere, analizzare ed interpretare le<br />
osservazioni effettuate. Può essere ut<strong>il</strong>e l’aiuto di un esperto ornitologo o di una guida naturalistica. Servono buoni binocoli e almeno un cannocchiale per<br />
gruppo.<br />
1. Le informazioni generali<br />
Località Data Vento Pioggia<br />
Osservatori Ora in.-fine Rif. Mappa Scheda n°<br />
2. A quale gruppo appartiene?<br />
Uccello n° Taglia Forma Coda Becco Zampe Gruppo<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Scheda n. 22<br />
Approfondimento: Le migrazioni in diretta.<br />
IDEA !!<br />
Per poter vedere le migrazioni con i propri<br />
occhi, prova con un telescopio o un<br />
cannocchiale a osservare tra apr<strong>il</strong>e e<br />
maggio, di notte, <strong>il</strong> disco lunare; potrai<br />
vedere numerose specie che di notte<br />
in primavera stanno spostandosi verso <strong>il</strong><br />
nord Europa per riprodursi.<br />
Oppure organizza dal tramonto a mezzanotte<br />
un’escursione in palude; nel s<strong>il</strong>enzio<br />
e con la luce della luna scoprirai un mondo<br />
di cui non potevi nemmeno immaginare<br />
l’esistenza!
ANALISI DELLE OSSERVAZIONI ORNITOLOGICHE FATTE<br />
Il riconoscimento degli uccelli acquatici – schede di analisi<br />
3. A quale specie appartiene?<br />
Uccello n° 1 2 3 4<br />
Colore<br />
Becco<br />
Zampe<br />
Comportamento<br />
Luogo d’osservazione<br />
Socialità<br />
Nome dell’uccello:<br />
Scheda n. 23<br />
107
108<br />
LE OSSERVAZIONI ORNITOLOGICHE NEL TEMPO<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo<br />
Nomi: .....................................................<br />
Dai dati e dalle analisi delle schede precedenti prova a tracciare un quadro delle specie a te note nel <strong>Parco</strong>, in relazione alle diverse stagioni e a metterli in<br />
un grafico dove metterai in ascisse <strong>il</strong> tempo provando trovare la scala giusta per le tue osservazioni (p.e. su scala giornaliera, mens<strong>il</strong>e, bimestrale o trimestrale),<br />
ed in ordinata <strong>il</strong> numero di specie (ma puoi provare anche a mettere <strong>il</strong> numero d’individui per specie).<br />
1. Ut<strong>il</strong>izzando le schede precedenti prova a determinare quanti gruppi e quante specie riconosci in ogni uscita sul campo.<br />
Date uscite Gruppi Specie Habitat<br />
2. Prova a metterle su grafico<br />
Scheda n. 24
ANALISI DELLE OSSERVAZIONI ORNITOLOGICHE EFFETTUATE<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo. Nomi: .....................................................<br />
Alla luce dei risultati della esperienza precedente prova a trarre delle conclusioni sul comportamento migratorio ipotizzando i casi di specie che sono solo<br />
migratori di sola andata e/o ritorno da quelli che vi svernano e/o vi si riproducono nella piana pisano-vers<strong>il</strong>iese. Prepara e verifica i risultati di quest’analisi con<br />
l’aiuto di un ornitologo anche per completare alcuni “buchi” di conoscenza.<br />
NOTA. Il tempo può avere una scansione diversa.<br />
1. Quando sono presenti le specie osservate?<br />
N° specie<br />
2) Perché alcune specie si trovano solo in primavera?<br />
Inverno Primavera Estate Autunno<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3) Perché alcune specie si trovano solo d’inverno?<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4) Perché alcune si osservano solo in autunno?<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
5) Perché alcune specie si trovano solo in estate?<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6) Qual è <strong>il</strong> periodo con la maggiore diversità di specie?<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
7) Perché infine, alcune specie sono presenti tutto l’anno?<br />
Scheda n. 25<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
109
110<br />
TROVA LA ROTTA: RICOSTRUZIONE DEI VIAGGI DEGLI UCCELLI OSSERVATI<br />
Scheda di analisi - Lavoro individuale<br />
Nome: .....................................................<br />
Osservando le mappe qua riportate, e in base agli elementi noti, ricostruisci la rotta migratoria spiegandone i motivi in relazione alle necessità del<br />
combattente, del rondone e dell’albanella reale.<br />
Scheda n. 26<br />
1) Combattente: si riproduce in Europa e Asia Settentrionale; sverna lungo le coste: dal Mare del Nord al Sudafrica; passa dall’Italia, dall’Ungheria, dalla<br />
Germania ecc. in febbraio-maggio e luglio-ottobre<br />
2) Rondone: nidifica dal Nordafrica all’Eurasia; sverna nell’Africa tropicale; passa dal Mediterraneo e dal Sahara tra apr<strong>il</strong>e-maggio e luglio-settembre.<br />
3) Albanella reale: si riproduce nell’Europa Centrosettentrionale (ed in Nord America); sverna nell’Europa Centro-occidentale e nei paesi mediterranei; migra<br />
tra settembre e novembre e febbraio apr<strong>il</strong>e.
Macaone<br />
Cavolaia<br />
- Gli insetti: che sono costituiti da un corpo segmentato e rivestito di uno scheletro<br />
esterno rigido, sei zampe e di solito due paia di ali. Essi contano la maggioranza delle<br />
specie tra cui troviamo ad esempio:<br />
Farfalla atalanta<br />
LE FARFALLE<br />
DEL PARCO<br />
LO STUDIO DELLA FAUNA: GLI INVERTEBRATI<br />
I gruppi principali di<br />
invertebrati<br />
Tra gli invertebrati vi sono la maggio-<br />
ranza di specie viventi sulla terra. Essi<br />
costituiscono una parte fondamen-<br />
tale di tutti gli ecosistemi; e le loro di-<br />
mensioni variano da quelle microsco-<br />
piche dello zooplancton a quelle ben<br />
più grandi del cervo volante o dei<br />
crostacei marini.<br />
Nel parco i principali gruppi sono:<br />
Vanessa del cardo<br />
22. Lo zooplancton è l’insieme degli<br />
organismi viventi animali appartenenti<br />
al plancton.<br />
Vanessa io<br />
111
Mosca domestica<br />
112<br />
la mantide religiosa; i coleotteri come <strong>il</strong> cervo volante, i cerambici-<br />
di come <strong>il</strong> Cerambix cerdo, la cicindela, gli stercorari Pimelia e Geo-<br />
trupes, le farfalle pap<strong>il</strong>io, cavolaie, vanessa io, vanessa atalanta e<br />
vanessa del cardo; le libellule; gli imenotteri come calabroni, api e<br />
bombi e i ditteri: mosche, zanzare e chironomidi;<br />
- I crostacei: anch’essi possiedono uno scheletro esterno (esoscheletro)<br />
coriaceo. Il corpo è costituito da segmenti raggruppati in<br />
tre regioni corporee: <strong>il</strong> capo, <strong>il</strong> torace e l’addome.<br />
Il capo solitamente è fuso con un certo numero di segmenti del to-<br />
race e forma, così, un’unica regio-<br />
ne corporea chiamata cefalotora-<br />
ce. Ciascun segmento è dotato di<br />
un paio di appendici, che possono<br />
essere costituite da due rami distinti<br />
(bifide). Nel corso dell’evoluzione i<br />
segmenti e le relative appendici, ori-<br />
ginariamente indifferenziati, si sono<br />
Mantide religiosa<br />
specializzati a svolgere funzioni diverse, tra cui la respirazione, la lo-<br />
comozione e la nutrizione. Nel <strong>Parco</strong> la maggioranza sono microsco-<br />
pici come le dafnie o gli ostracodi che si trovano nel <strong>Massaciuccoli</strong><br />
o nelle pozze ed i canali o le pulci di mare (talitri) che possono essere<br />
visti saltare numerosi nelle battigie delle spiagge ancora naturali del<br />
<strong>Parco</strong>, semplicemente premendo <strong>il</strong> piede sulla sabbia bagnata. In-<br />
vece, dove vi sono troppi bagnanti, <strong>il</strong> loro intenso calpestio ne può<br />
azzerare la presenza. Il Gambero della Louisiana che è una specie<br />
esotica tra i crosracei diffusi nel <strong>Parco</strong>.<br />
- I ragni: scientificamente fanno parte della Classe degli Aracnidi<br />
che comprende specie carnivore o parassite terrestri quali scorpioni,<br />
Arginoreta<br />
acari e zecche, oltre ai ragni. Il corpo degli aracnidi è diviso in due<br />
Cervo volante
Chiocciola pisana<br />
La Zanzara<br />
parti: quella anteriore è chiamata cefalotorace, porta gli organi di senso ,<br />
otto paia di appendici e non ha antenne; quella posteriore, l’addome, è<br />
senza appendici. L’addome dei ragni porta solitamente le ghiandole che<br />
producono la seta. Particolarmente notevole nel <strong>Parco</strong> la presenza del ra-<br />
gno palombaro Argironeta unico ragno realmente acquatico che si porta<br />
sott’acqua, nella ragnatela bolle d’aria da cui attingere per respirare.<br />
- I molluschi caratterizzati da un corpo molle, non segmentato e, spesso,<br />
ricoperto da una conchiglia (spiralata nei gasteropodi, con due valve<br />
simmetriche nei bivalvi). Tra i bivalvi ne sono esempi le arselle in mare e le<br />
grandi Anodonta nelle acque interne; mentre tra i gasteropodi troviamo la<br />
chiocciola pisana Euparypha pisana e le chiocciole acquatiche Limnea e<br />
Planorbis.<br />
Anfibi: Raganella<br />
APPROfONDIMENtO<br />
Cicli di vita degli insetti<br />
Dopo essere sgusciati dalle<br />
uova possono avere essen-<br />
zialmente due tipi di sv<strong>il</strong>up-<br />
pi: diretto ed indiretto. Le<br />
forme più evolute hanno di<br />
solito questo secondo tipo<br />
di sv<strong>il</strong>uppo per cui giova-<br />
ni (larve) e adulti sembra-<br />
no due specie diverse nel-<br />
la forma e, spesso, condu-<br />
cono anche vite separate.<br />
Per esempio le libellule han-<br />
no larve acquatiche carni-<br />
vore e adulti che volano in<br />
aria, i coleotteri ditischi p.e.<br />
hanno grandi larve acqua-<br />
tiche come gli adulti.<br />
Mentre le zanzare hanno<br />
larve “f<strong>il</strong>iformi” con nume-<br />
rosi peli ed un tubicino ad<br />
un’estremità per respira-<br />
re dalla superficie dell’ac-<br />
qua.<br />
Anche i girini delle rane<br />
(che sono vertebrati anfi-<br />
bi) e gli adulti presentano<br />
questa forma di sv<strong>il</strong>uppo<br />
indiretto così tipico di gran<br />
parte delle specie acqua-<br />
tiche.<br />
113
114<br />
Gli adattamenti all’ambiente degli<br />
invertebrati: le specie dei diversi<br />
ambienti<br />
23. L’osmosi è un processo legato a<br />
soluzioni dove un solvente (in genere<br />
acqua) e/o <strong>il</strong> soluto (p.e. sale) fluiscono<br />
attraverso una membrana dalla<br />
zona della soluzione a concentrazione<br />
minore di soluto, a quella a concentrazione<br />
maggiore. Il processo si arresta<br />
quando le due soluzioni raggiungono<br />
la medesima concentrazione. È’ un<br />
processo importantissimo in biologia;<br />
p. e. si pensi alle piante che vivono<br />
vicino al mare come la salicornia che,<br />
per evitare la disidratazione mantiene<br />
molti sali all’interno del suo corpo in<br />
modo da attirare costantemente molecole<br />
d’acqua dall’ambiente e non<br />
disperdere questo elemento scarso e<br />
vitale.<br />
Invertebrati dei boschi. Nei boschi, c’è un microclima molto stab<strong>il</strong>e e<br />
mite, ed una grande massa legnosa che mette a disposizione un potenziale<br />
nutritivo enorme (costituita p.e. dalla lignina e dalla cellulosa che sono zuccheri).<br />
Numerosi sono gl’insetti che cercano di ut<strong>il</strong>izzarlo ut<strong>il</strong>izzando radici,<br />
funghi, cortecce, foglie ecc. come ambiente di foraggiamento, per la deposizione,<br />
per la crescita larvale, ecc.<br />
Invertebrati ed aridità. Il piccolo corpo degli invertebrati terrestri pone<br />
seri problemi di pericolo di disidratazione che vengono risolti:<br />
• con meccanismi comportamentali come ricercare ambienti umidi (p.e.<br />
infossandosi nella sabbia o cercando <strong>il</strong> buio);<br />
• con meccanismi fisiologici di che concentrano i liquidi nel corpo attraverso<br />
l’osmosi;<br />
• con adattamenti anatomici p.e. avendo cuticole spesse che impediscono<br />
l’evaporazione dei liquidi corporei.<br />
Invertebrati tra acqua ed aria. La fac<strong>il</strong>ità di galleggiamento in acqua,<br />
dovuta al principio di Archimede, consente agli invertebrati acquatici di<br />
ridurre le componenti di sostegno arrivando spesso ad avere corpi leggeri,<br />
trasparenti e morbidi.<br />
L’arrivo dell’ossigeno a tutte le cellule del corpo e l’espulsione dell’anidride<br />
carbonica fondamentale per quasi tutte le forme di vita, è assicurato da polmoni,<br />
da piccoli tubi (trachee) che si introflettono nel corpo, o direttamente<br />
dalla pelle (respirazione aerea); da branchie (respirazione acquatica) che<br />
permettono in ogni caso, gli scambi gassosi con l’ambiente esterno. Gli organismi<br />
unicellulari (batteri, alghe e protozoi) scambiano i gas direttamente<br />
attraverso la membrana cellulare.
Alla scoperta della fauna del <strong>Parco</strong> - Schede di lavoro Scheda n. 27<br />
DESCRIZIONE DELL’HABITAT, PRELIEVO E STUDIO DEGLI INVERTEBRATI<br />
Scheda di campo - Lavoro di gruppo<br />
Nomi: .....................................................<br />
Un albero morto o un canale possono essere luoghi pieni di vita. Con l’aiuto di uno zoologo:<br />
scegliete un sito adatto nella foresta con legno morto ben decomposto, per esempio un vecchio albero morto da tempo, oppure un canale con acqua<br />
limpida ricco di vegetazione su sponde ed in acqua;<br />
prendete appunti sulla foresta, sull’albero morto (specie, diametro, lunghezza) o sulla vegetazione del canale e annotate la data di raccolta;<br />
raccogliete una piccola quantità di legno morto o di acqua, vegetazione e sedimenti e mettete <strong>il</strong> tutto nella scatola;<br />
in classe, in primavera, prelevate periodicamente gli insetti o altri invertebrati che si saranno sv<strong>il</strong>uppati nel ternario o nell’acquario, analizzandoli sul vetrino con<br />
<strong>il</strong> microscopio o <strong>il</strong> lentino (e, beninteso, l’insegnante); e... tirate le vostre conclusioni.<br />
È meglio se lo stesso lavoro viene svolto in contemporanea da più gruppi: potete confrontare ed ampliare le esperienze, i risultati, i commenti. Al termine del<br />
lavoro puoi liberare molti individui dove li hai presi. Questo lavoro è da fare con l’aus<strong>il</strong>io di un entomologo.<br />
Strumenti:<br />
• retino e piccoli barattoli;<br />
• pinzette morbide;<br />
• sp<strong>il</strong>li entomologici;<br />
• provette e piastre petri;<br />
• flaconi contenitori in plastica;<br />
• alcool 70°;<br />
• microscopio stereoscopico (se non disponib<strong>il</strong>e, lentino contaf<strong>il</strong>i);<br />
• sacchetti di nylon;<br />
• chiodini in ottone (2-3 cm);<br />
• tulle;<br />
• acquario/Ternario: piccolo contenitore (circa 50 cm di lunghezza) in plastica dove mettere <strong>il</strong> legno morto per l’allevamento degli insetti Può essere necessaria<br />
una rete fitta per permettere la respirazione senza che gl’insetti svolazzino per la classe.<br />
115
116<br />
DETERMINAZIONE DELLE SPECIE O DEI GRUPPI DI INVERTEBRATI<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo<br />
Nomi: .....................................................<br />
Prova a determinare i gruppi o addirittura le specie di appartenenza con l’aiuto di uno zoologo esperto di invertebrati r<strong>il</strong>evate nelle esperienze riferite alla<br />
scheda precedente.<br />
Date uscite Gruppi Specie Descrizione Habitat<br />
Scheda n. 28
INCONTRO DI GENERAZIONI: CERCA QUELLO GIUSTO PER OGNI SPECIE<br />
Scheda di analisi - Lavoro individuale<br />
Nome: .....................................................<br />
Scheda n. 29<br />
Cercate di collegare, con le informazioni che avete, ogni larva con <strong>il</strong> giusto adulto … ad es. Zanzara, Ditisco, Libellula e Rana. Potrete anche disegnarne di<br />
nuovi in base alle informazioni raccolte tramite le esperienze relative alle schede precedenti.<br />
117
118<br />
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI DEGLI INVERTEBRATI<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo. Nomi: .....................................................<br />
Prova ora, dopo avere ragionato e compiuto le esperienze delle schede precedenti, a delineare delle conclusioni che tengano conto dei seguenti argo-<br />
menti.<br />
1. Diversità di specie nei vari ambienti.<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2. Diversità tra le stagioni<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3. Gruppi di particolare interesse.<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4. Osservazioni sul loro ciclo vitale (in particolare per quelli allevati).<br />
Scheda n. 30<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LO STUDIO DELLA FAUNA: I MAMMIFERI<br />
Sulle tracce dei mammiferi<br />
Cos’è un mammifero?<br />
I mammiferi sono la classe di vertebrati a cui<br />
appartiene anche l’uomo. Hanno in comune la<br />
caratteristica di possedere pelo sul corpo, una<br />
temperatura controllata da meccanismi interni<br />
(omeotermia), ghiandole mammarie che le<br />
femmine, usano per allattare i nuovi nati, sv<strong>il</strong>uppo<br />
del feto interno con nutrimento diretto da parte<br />
della femmina attraverso la placenta (a parte i<br />
monotremi p.e. l’ornitorinco che depone le uova),<br />
sistema circolatorio diviso, come per gli uccelli, tra<br />
venoso ed arterioso con cuore con due atri e due<br />
ventricoli.<br />
Come vivono i mammiferi?<br />
I mammiferi sono gli animali col più complesso<br />
sistema cerebrale; questo gli consente di avere<br />
adattamenti comportamentali complessi e di<br />
apprendere nuove abitudini con fac<strong>il</strong>ità. La<br />
diversificazione tra le loro forme e gli st<strong>il</strong>i di vita<br />
è enorme: vi sono forme carnivore, insettivore,<br />
erbivore e onnivore.<br />
Molte specie, come i roditori (p.e. gli scoiattoli o i<br />
topi selvatici) sono importantissime nella dissemi-<br />
nazione dei semi oleosi: pesanti (come le ghiande<br />
ad esempio) e altri nel contribuire a mantenere un<br />
equ<strong>il</strong>ibrio con le popolazioni predate (p.es. i pipi-<br />
strelli con gli insetti).<br />
119
120<br />
Tuttavia i più grandi o ai vertici delle catene alimentari come la lontra o <strong>il</strong> lupo si sono estinti da tempo e, l’aspetto di questo<br />
<strong>Parco</strong> come un’isola in un mare urbanizzato fa si che l’ambiente disponib<strong>il</strong>e anche per i più grandi erbivori (cinghiale e dai-<br />
no) sia troppo piccolo. Da questo consegue la mancanza di rinnovo forestale su gran parte degli ambienti naturali (man-<br />
canza di rinnovazione del bosco, scomparsa di specie vegetali) e la necessità di controllare le loro densità per riportarle a<br />
livelli sostenib<strong>il</strong>i.<br />
APPROfONDIMENtO<br />
Come si osservano i<br />
mammiferi?<br />
I mammiferi sono forse <strong>il</strong><br />
gruppo che attira più at-<br />
tenzione ma, al contrario<br />
degli uccelli, sarà molto più<br />
diffic<strong>il</strong>e scoprire la loro pre-<br />
senza. Infatti sono animali<br />
tendenzialmente notturni e<br />
dal comportamento schi-<br />
vo nei confronti dell’uomo,<br />
anche per le passate per-<br />
secuzioni e cacce.<br />
Solo un vero naturalista cu-<br />
rioso, con molta attenzio-<br />
ne, potrà scoprire i luoghi<br />
di passaggio dei cinghia-<br />
li attraverso lo studio delle<br />
piste e delle impronte, di<br />
riposo e pulizia attraverso<br />
l’insoglio e lo sfregamento<br />
degli alberi; o ancora do-<br />
ve gli scoiattoli, i topi selva-<br />
tici o le ghiandaie nascon-<br />
dono o hanno dimenticato<br />
le ghiande di leccio; dove<br />
hanno mangiato i pinoli i<br />
picchi o, infine, dove <strong>il</strong> tas-<br />
so, i conigli, gli istrici o la<br />
volpe hanno fatto la tana<br />
o dove la volpe ha marca-<br />
to <strong>il</strong> territorio.
IL DAINO<br />
121
122<br />
IL CINGHIALE
IL TASSO<br />
123
124<br />
L’ISTRICE
LO SCOIATTOLO<br />
125
126<br />
IL CONIGLIO SELVATICO
IL RICCIO<br />
127
Alla scoperta della fauna del <strong>Parco</strong> - Schede di lavoro<br />
128<br />
OCCHIO ALLE TRACCE DEI MAMMIFERI<br />
Scheda di lavoro - Lavoro di gruppo<br />
Nomi: .....................................................<br />
Spesso sul campo, l’unico modo per scoprire i segreti della vita dei mammiferi è quello di r<strong>il</strong>evarne<br />
le tracce ed interpretare <strong>il</strong> loro significato.<br />
Esci sul campo e, durante <strong>il</strong> tuo tragitto prova a raccogliere, fotografare o facendo i calchi tutte<br />
le tracce di animali. Le condizioni migliori si hanno su terreno morbido (p.e. dopo una pioggia),<br />
vicino a pozze d’acqua l’estate o sulla battigia.<br />
Riporta su una mappa (da incollare a lato) <strong>il</strong> percorso ed i luoghi dove hai trovato le tracce.<br />
RICCIO ISTRICE CONIGLIO SELVATICO<br />
INDICAZIONE DEL PERCORSO<br />
Mappa da disegnare<br />
SCOIATTOLO SCOIATTOLO DAINO CINGHIALE<br />
Scheda n. 31
ANALISI DEGLI INDIZI TROVATI SUI MAMMIFERI<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo. Nomi: .....................................................<br />
Prova a determinare i gruppi o addirittura le specie di appartenenza con l’aiuto di uno zoologo esperto di mammiferi riferendosi alle pagine precedenti o ad<br />
una guida naturalistica.<br />
Scheda n. 32<br />
Date uscite Traccia (e riferimento mappa) Numero / Abbondanza Specie Descrizione Habitat<br />
129
130<br />
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI SUI MAMMIFERI<br />
Scheda di analisi - Lavoro di gruppo<br />
Nomi: .....................................................<br />
Prova, confrontando <strong>il</strong> lavoro dei vari gruppi (schede 63 e 64), a delineare delle conclusioni che tengano conto dei seguenti argomenti.<br />
Scheda n. 33<br />
1. Diversità di specie/tracce nei vari ambienti.___________________________________________________________________________________________________________<br />
2. Diversità tra le stagioni _______________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3. Tracce di particolare interesse. _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
4. Quali sembrano le specie più abbondanti. ___________________________________________________________________________________________________________<br />
5. Osservazioni sullo st<strong>il</strong>e di vita delle varie specie desumib<strong>il</strong>e dalle tracce. ________________________________________________________________________________
Norme di comportamento per <strong>il</strong> naturalista curioso<br />
Sei veramente curioso? Allora rispetta la “privacy” della natura che scopri!<br />
Prima di tutto, vestiti in maniera adeguata: niente colori sgargianti, pantaloni lunghi, scarponi (o stivali di gomma se andate in zone umide) con suola<br />
antisdrucciolo ben stretti alla caviglia, che deve essere coperta.<br />
Zanzare, zecche, tafani, tafanelle, selvaggiume… nel foresta e nelle paludi del <strong>Parco</strong> gli insetti sono più curiosi di te! Copriti bene e cospargiti di liquido<br />
repellente.<br />
q Rimani nei sentieri e percorsi segnati: sono fatti apposta !<br />
q Per osservare bene gli animali, fa’ piano… non schiamazzare! Altrimenti scappano via!<br />
q Se vuoi raccogliere fiori, frutti, radici o altre parti vegetali, accertati che non siano rare e che comunque ce ne sia in abbondanza nel posto, in modo tale<br />
che ne rimanga dopo che siete passati, te e gli altri naturalisti … invasivi !<br />
q Se vuoi raccogliere funghi, non farlo! Se ci sono, vuol dire che servono al foresta. Inoltre potrebbe esser velenoso o tossico, e anche se riesci a prenderne<br />
uno commestib<strong>il</strong>e (e ci vuole esperienza per riconoscerli), non potresti, perché ci vuole <strong>il</strong> tesserino del <strong>Parco</strong> !<br />
q Non distruggere nidi, tane o altro, giusto per vedere la faccia dell’inqu<strong>il</strong>ino quando torna a casa!<br />
q Se mangi nella natura, buon appetito! Ma portati via tutto, anche i rifiuti, anche le bucce, in modo da lasciare <strong>il</strong> luogo come l’hai trovato.<br />
q Se capiti in un luogo dove stanno lavorando (per esempio dove tagliano la foresta, o dove arano un campo) tieniti a distanza: potrebbe essere<br />
pericoloso!<br />
Se tornando a casa scopri di essere stato punto da una zecca, falla togliere da qualcuno con cura: senza toccarle con le mani, e dopo aver disinfettato la<br />
zona con alcool, staccare (senza strappare!) la zecca con una pinzetta. La testa dell’insetto nnon deve rimanere nella pelle.<br />
Il selvaggiume è un piccolissimo acaro (come dei ragnetti) dele foreste che si trova in autunno e si nutre del primo strato delle pelle. Se <strong>il</strong> giorno dopo senti un<br />
gran prurito alle caviglie, sappi che è lui! Metti una crema rinfrescante e … resisti! Nel giro di un paio di giorni va via tutto.<br />
131
132<br />
Per saperne di più<br />
<strong>Parco</strong><br />
AA.VV. 1983 - Dal Calambrone alla Burlamacca. Guida alla natura del <strong>Parco</strong> M.S.R.M. - Nistri-Lischi ed., Pisa.<br />
AA.VV. 1984 - <strong>Parco</strong> Naturale M.S.R.M. – Itinerari. Ed. Consorzio del <strong>Parco</strong>.<br />
Cavalli, S., Lambertini, M. 1990 – Il <strong>Parco</strong> Naturale <strong>Migliarino</strong>-<strong>San</strong> <strong>Rossore</strong>-<strong>Massaciuccoli</strong> – Pacini ed., Ospedaletto (Pisa).<br />
Spinelli A. 1999 - Conoscere S. <strong>Rossore</strong>: la flora, la fauna, l’Ambiente - Felici ed., Pisa<br />
Mappe parco<br />
Cavalli, S., Cenni, M. 1997 - Carta della natura e degli ambiti territoriali. (Scala 1:33000)- SELCA, Firenze<br />
Carta turistica e dei sentieri del <strong>Parco</strong> regionale <strong>Migliarino</strong>-<strong>San</strong> <strong>Rossore</strong>-<strong>Massaciuccoli</strong> (Scala 1:25000) – Edizioni Multigraphic, Firenze 2005<br />
Animali<br />
Bang P. e Dahlstrøm P., 1993 – Animals tracks and sings – Collins.<br />
Arnold E.M. e Burton J.A, 1986 – Guida dei rett<strong>il</strong>i e degli anfibi d’Europa – Franco Muzzio Editore.<br />
Bruun B e Singer A. 1991. Uccelli d’Europa. Mondadori editore.<br />
Brown R., Ferguson J., Lawrence M., Lees D., 1989 – Tracce e segni degli uccelli d’Europa, guida al riconoscimento – Franco Muzzio Editore.<br />
Thomassin S., 1991 – Tracce di animali – Garzanti Editore s.p.a.<br />
Mac Donald D., Bourrett P. 1993 – Mammals of Britain & Europe – Harper Collins/Publishers<br />
Piante<br />
Christiansen M.S. e Brunerye L. 1983 – Piante e fiori di campagna e di bosco – Edizioni Paoline<br />
Rushforth K. 1991 – Guide per riconoscere gli alberi – ed. A. Vallardi<br />
Strada A., Spini G., 2000 - La vita segreta degli alberi polmoni della terra - Demetra,Verona<br />
Ambienti<br />
Domont P. e Zaric N. 1999 - I segreti del bosco. 300 domande sulla vita degli alberi e delle foreste - Armando Dadò Editore, Locarno (Svizzera).<br />
Macchia U., Pranzini E., Tomei P.E. (a cura di) 2005 – Le dune costiere in Italia. La natura ed <strong>il</strong> paesaggio. – Felici ed., Pisa<br />
Gérard L.,1991 – Laghi e fiumi mondi viventi – Garzanti Editore.<br />
Fitter R. e Manuel R., 1993 – La vita nelle acque dolci – Franco Muzzio Editore.<br />
Abbadie L., 1991 – La foresta regno di vita – Garzanti Editore.
I luoghi<br />
L’intero <strong>Parco</strong> Regionale si presta ad osservazioni e ricerche naturalistiche tuttavia esistono luoghi in cui è più fac<strong>il</strong>e incontrare naturalisti all’opera nel loro<br />
lavoro:<br />
• Orto Etnobotanico toscano<br />
Cos’è. Si tratta di un Orto Botanico dove vengono coltivate le specie vegetali (selvatiche e domestiche) che in Toscana sono ut<strong>il</strong>izzate per scopi medicinali,<br />
veterinari ecc.<br />
Dov’e. Presso i campi Sperimentali del Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agroecosistema in località Rottaia – <strong>San</strong> Piero a Grado – Pisa.<br />
Periodo consigliato. Apr<strong>il</strong>e – Maggio<br />
Orario. Su appuntamento al n° tel. 050/599271<br />
A chi chiedere. Serena Trimarchi e-ma<strong>il</strong>: seretrim@agr.unipi.it del Laboratorio di Botanica e Geobotanica Applicate del Dipartimento di Agronomia e Gestione<br />
dell’Agroecosistema.<br />
• Oasi LIPU della Riserva Naturale Il Chiarone<br />
Cos’è. L’Oasi LIPU Il Chiarone, è un a Riserva Naturale del parco gestita da molti anni dall’associazione ambientalista LIPU dove si effettuano periodiche<br />
campagne d’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico.<br />
Dov’è. Si trova in Via del Porto 6, loc. <strong>Massaciuccoli</strong> 55050 Massarosa.<br />
Periodo consigliato. Apr<strong>il</strong>e-maggio e settembre-ottobre.<br />
Orario. Visite da concordare tramite appuntamento al n° tel. 0584/975567 fax 0584/975488.<br />
A chi chiedere. Andrea Fontanelli e-ma<strong>il</strong>: oasi.massaciuccoli@lipu.it.<br />
• Osservatorio ornitologico Caterini<br />
Cos’è. È una struttura del <strong>Parco</strong> dove viene effettuato l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico che qui ha una tradizione di molti decenni.<br />
Dov’e. Tenuta di <strong>San</strong> <strong>Rossore</strong> (Fiume Morto Nuovo).<br />
Periodo consigliato. Apr<strong>il</strong>e-Maggio.<br />
Orario. Visite da concordare tramite appuntamento n° tel. 050 539111 (centralino);<br />
A chi chiedere. Antonio Perfetti, e-ma<strong>il</strong>: conservazione@sanrossore.toscana.it presso <strong>il</strong> Servizio Conservazione Ente <strong>Parco</strong>.<br />
• Stazione di Ricerca etologica di Arnino<br />
Cos’è. È una stazione di Ricerca dell’Università di Pisa dove da molti decenni si studia <strong>il</strong> comportamento animale ed in particolare le migrazioni ed i<br />
meccansmi di orientamento di piccioni, farfalle, passeriformi, crostacei, ecc.<br />
Dov’e. Si trova in località Arnino, Pisa nella Tenuta di Tombolo.<br />
Periodo consigliato. Tutto l’anno.<br />
Orario. Visite da concordare tramite su appuntamento al n° tel. 050 2219045<br />
A chi chiedere. Prof. P. Ioalè, e-ma<strong>il</strong>: pjoale@discau.unipi.it.<br />
133
Finito di stampare nel mese di Marzo 2006<br />
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.<br />
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa<br />
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300<br />
www.pacinieditore.it