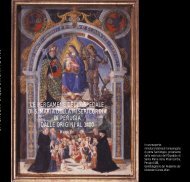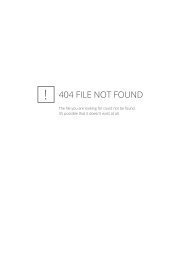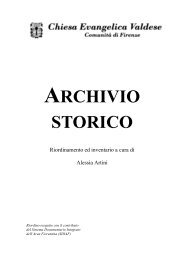esercito e città dall'unità agli anni trenta. tomo i - Sistema ...
esercito e città dall'unità agli anni trenta. tomo i - Sistema ...
esercito e città dall'unità agli anni trenta. tomo i - Sistema ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
lO PIERLUIGI BERTINARIA<br />
La grossa differenza tra il sistema di mobilitazione introdotto in Italia<br />
postato su base territoriale (oggi si direbbe regionale), per cui le reclute di<br />
e quello prussiano consisteva nel fatto che in Prussia il reclutamento era im<br />
una dtrminaa provincia ricevevano la loro istruzione militare presso il re<br />
parto 1v1 stanztato e ad esso si presentavano al momento della mobilitazio<br />
ne, accelerandone sensibilmente i tempi. In Italia, invece, non si ritenne op<br />
portuno adottare un sistema di reclutamento territoriale perché si temeva<br />
che usto, stimolando e incoraggiando separatismi e regionalismi, potesse<br />
costltmre una potenziale minaccia all'unità da pochi <strong>anni</strong> realizzata. Pertanto,<br />
sebbene non mancassero opinioni favorevoli all'introduzione anche in<br />
Italia el reclut _ amento su base territoriale, durante il dibattito parlamentare<br />
sulle nforme Rtcotti gran parte dello schieramento politico si dimostrò concord<br />
nel ritener inapplicabile in Italia un ordinamento analogo a quello<br />
russtano. Solo Gmseppe Sirtori ne parlò a favore, in quanto, oltre a ridurre<br />
una magg10re coes10ne formandoli con reclute provenienti dalla stessa area<br />
1 tempi ncessari pr la mobilitazione, avrebbe consentito di dare ai reparti<br />
e avrebbe infine permesso di risparmiare sulle spese causate dai cambi di<br />
guarnigine: _ ttto ciò, concludeva Sirtori, senza " mettere in pericolo l'Uni<br />
ta. ( ... )L Italia e fatta e non può essere disfatta se non da un grande disastro<br />
militare " 12.<br />
Quella<br />
.<br />
del Sirtori rimase una voce isolata e, come qualche anno prima,<br />
er tema dt compromettere l'unità faticosamente raggiunta era stato definitivamente<br />
affossato il principio di un decentramento politico-amministrativo<br />
del nuovo regno, difeso nel Parlamento di Torino dal solo Ferrari 13 così<br />
tra le riforme degli <strong>anni</strong> '70 non trovò posto l'introduzione del reclut;mento<br />
su base territoriale.<br />
Fu però necessario introdurre comunque un meccanismo che consentisse<br />
di snellire i tempi della mobilitazione; si procedette perciò all'istituzione<br />
dei distretti, che dovevano provvedere: alla fase iniziale dell'addestramento<br />
d:lle rclute di l a categoria, da inviare successivamente ai Corpi; all'intero<br />
Ciclo dt addestramento, relativamente breve, delle reclute di 2 a categoria; e<br />
dove:no soprttutt _prvvedere ad armare i richiamati ed inviarli ai reggimett<br />
m caso dt mobthtazwne. Si evitava in questo modo la perdita di tempo<br />
denvante dal fatto che gli uomini richiamati alle armi dovessero dapprima<br />
12 MINNITI, Esercito e politica, cit., p. 106. Le recenti ricerche che Christoph Berger<br />
W<br />
smente al corente, smbrano n parte modificare questo assunto, indicando un mag<br />
,<br />
aldenegg sta conducendo su qesto argomento, dei cui risultati egli mi ha messo corte<br />
giOr numero d1 sostemton dell mtroduzione del reclutamento su base territoriale<br />
13 ROBERT C. BINKLEY, Realism and nationalism, 1852-1871 New York Harpe a d<br />
Row, 1935, pp. 222-223. ' ' n<br />
LO STANZIAMENTO DELL'ESERCITO ITALIANO<br />
recarsi al deposito reggimentale - che poteva anche essere molto lontano<br />
dalla zona di provenienza della recluta - e, poi, spostarsi nell'area di raduna<br />
sembrava indicare nella relazione a Vittorio Emanuele n che ne accompagnava<br />
il decreto istitutivo, avrebbero dovuto costituire i capisaldi di quel « se<br />
ta dove si trovava il reparto,di destinazione. I distretti, infine, come Ricotti<br />
condo <strong>esercito</strong> " basato prevalentemente sulla milizia territoriale, destinato a<br />
provvedere alla sicurezza del territorio nazionale in caso di ostilità 14.<br />
La creazione dei distretti fu dunque un momento di particolare rilievo<br />
nella definizione del rapporto tra <strong>esercito</strong> e territorio, non solo perché co<br />
stituì l'alternativa all'introduzione del reclutamento territoriale, ma anche<br />
perché, creando le premesse per una nuova concezione della difesa del territorio,<br />
pose le basi per esonerare ulteriormente i reparti esistenti in tempo<br />
di pace dai compiti di difesa del territorio. È opportuno poi ricordare che<br />
con le riforme ricottiane furono istituite le compagnie di alpini: reclutate,<br />
queste sì, su base strettamente locale, avevano il compito specifico di difen<br />
dere le zone montane di frontiera, in modo da ritardare il più possibile la<br />
marcia di un eventuale aggressore sfruttando le asperità del terreno e consentendo<br />
in tal modo il regolare svolgimento della mobilitazione.<br />
stinate a rimodellare l'Esercito Italiano sul tipo di quello prussiano, il gover<br />
Negli <strong>anni</strong> in cui vennero messe a punto e poi approvate le riforme de<br />
no del Regno d'Italia mise altresì allo studio il problema più generale del<br />
l'impostazione da dare alla difesa del territorio nazionale. Un primo proget<br />
to generale, com'è noto, fu elaborato tra il l866 e il 1871 dalla Commissioni<br />
di fortificazione dei punti nevralgici del territorio italiano: ma tanto la ver<br />
ne permanente per la difesa dello Stato, la quale nel 1871 presentò due pia<br />
sione completa quanto quella ridotta del progetto non andarono oltre la fa<br />
furono poi ritirate dal governo nel 1874. Dopo varie vicissitudini, una seconda<br />
Commissione per lo studio della difesa dello Stato fu insediata nel<br />
1880: ne facevano parte gli ufficiali più brillanti di cui l'Esercito Italiano al<br />
se preliminare del dibattito parlamentare e a causa del loro eccessivo costo<br />
lora disponesse e i suoi lavori, svoltisi in varie sessioni dal 1880 al 1883, for<br />
nirono una serie di valide indicazioni per l'approntamento a difesa del terri<br />
torio nazionale. La Commissione studiò i vari teatri operativi nei quali avrebbero<br />
potuto svolgersi combattimenti: un teatro nord-orientale, uno nordoccidentale,<br />
la costa ionica e adriatica, il teatro meridionale e insulare, la di<br />
fesa interna del teatro nord-occidentale. È da aggiungere -ma soltanto in<br />
tri allora definiti sarebbe più corretto chiamarli scacchieri. Una prima distin-<br />
aderenza alla concezione dottrinale attuale - che, terminologicamente, i tea<br />
14 GALLINARI, I primi quindici <strong>anni</strong>, cit., pp. 74-75. MINNITI, Esercito e politica, cit.<br />
p. 107.<br />
11