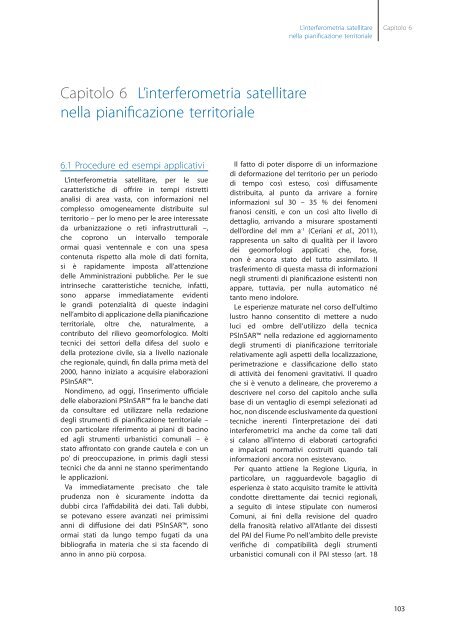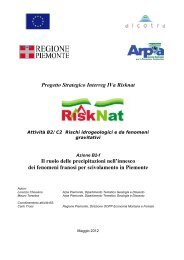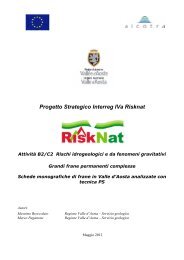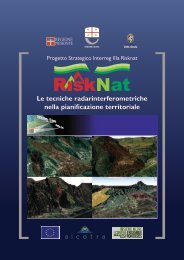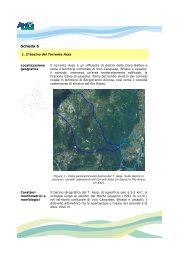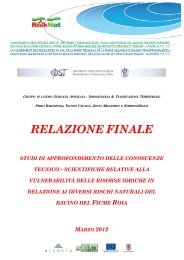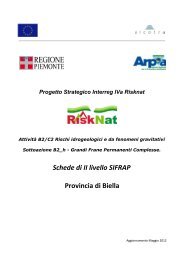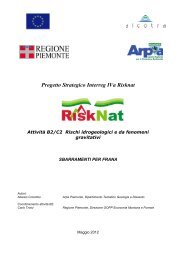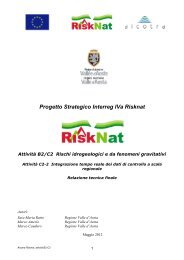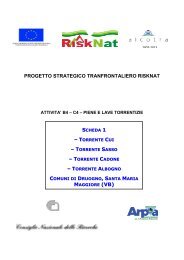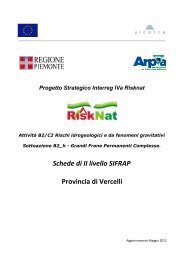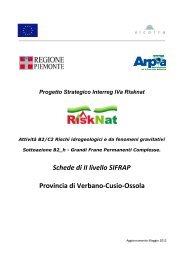Capitolo 6 L'interferometria satellitare nella pianificazione ... - RiskNat
Capitolo 6 L'interferometria satellitare nella pianificazione ... - RiskNat
Capitolo 6 L'interferometria satellitare nella pianificazione ... - RiskNat
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Capitolo</strong> 6 L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
6.1 Procedure ed esempi applicativi<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong>, per le sue<br />
caratteristiche di offrire in tempi ristretti<br />
analisi di area vasta, con informazioni nel<br />
complesso omogeneamente distribuite sul<br />
territorio – per lo meno per le aree interessate<br />
da urbanizzazione o reti infrastrutturali –,<br />
che coprono un intervallo temporale<br />
ormai quasi ventennale e con una spesa<br />
contenuta rispetto alla mole di dati fornita,<br />
si è rapidamente imposta all’attenzione<br />
delle Amministrazioni pubbliche. Per le sue<br />
intrinseche caratteristiche tecniche, infatti,<br />
sono apparse immediatamente evidenti<br />
le grandi potenzialità di queste indagini<br />
nell’ambito di applicazione della <strong>pianificazione</strong><br />
territoriale, oltre che, naturalmente, a<br />
contributo del rilievo geomorfologico. Molti<br />
tecnici dei settori della difesa del suolo e<br />
della protezione civile, sia a livello nazionale<br />
che regionale, quindi, fin dalla prima metà del<br />
2000, hanno iniziato a acquisire elaborazioni<br />
PSInSAR.<br />
Nondimeno, ad oggi, l’inserimento ufficiale<br />
delle elaborazioni PSInSAR fra le banche dati<br />
da consultare ed utilizzare <strong>nella</strong> redazione<br />
degli strumenti di <strong>pianificazione</strong> territoriale –<br />
con particolare riferimento ai piani di bacino<br />
ed agli strumenti urbanistici comunali – è<br />
stato affrontato con grande cautela e con un<br />
po’ di preoccupazione, in primis dagli stessi<br />
tecnici che da anni ne stanno sperimentando<br />
le applicazioni.<br />
Va immediatamente precisato che tale<br />
prudenza non è sicuramente indotta da<br />
dubbi circa l’affidabilità dei dati. Tali dubbi,<br />
se potevano essere avanzati nei primissimi<br />
anni di diffusione dei dati PSInSAR, sono<br />
ormai stati da lungo tempo fugati da una<br />
bibliografia in materia che si sta facendo di<br />
anno in anno più corposa.<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Il fatto di poter disporre di un informazione<br />
di deformazione del territorio per un periodo<br />
di tempo così esteso, così diffusamente<br />
distribuita, al punto da arrivare a fornire<br />
informazioni sul 30 – 35 % dei fenomeni<br />
franosi censiti, e con un così alto livello di<br />
dettaglio, arrivando a misurare spostamenti<br />
dell’ordine del mm a -1 (Ceriani et al., 2011),<br />
rappresenta un salto di qualità per il lavoro<br />
dei geomorfologi applicati che, forse,<br />
non è ancora stato del tutto assimilato. Il<br />
trasferimento di questa massa di informazioni<br />
negli strumenti di <strong>pianificazione</strong> esistenti non<br />
appare, tuttavia, per nulla automatico né<br />
tanto meno indolore.<br />
Le esperienze maturate nel corso dell’ultimo<br />
lustro hanno consentito di mettere a nudo<br />
luci ed ombre dell’utilizzo della tecnica<br />
PSInSAR <strong>nella</strong> redazione ed aggiornamento<br />
degli strumenti di <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
relativamente agli aspetti della localizzazione,<br />
perimetrazione e classificazione dello stato<br />
di attività dei fenomeni gravitativi. Il quadro<br />
che si è venuto a delineare, che proveremo a<br />
descrivere nel corso del capitolo anche sulla<br />
base di un ventaglio di esempi selezionati ad<br />
hoc, non discende esclusivamente da questioni<br />
tecniche inerenti l’interpretazione dei dati<br />
interferometrici ma anche da come tali dati<br />
si calano all’interno di elaborati cartografici<br />
e impalcati normativi costruiti quando tali<br />
informazioni ancora non esistevano.<br />
Per quanto attiene la Regione Liguria, in<br />
particolare, un ragguardevole bagaglio di<br />
esperienza è stato acquisito tramite le attività<br />
condotte direttamente dai tecnici regionali,<br />
a seguito di intese stipulate con numerosi<br />
Comuni, ai fini della revisione del quadro<br />
della franosità relativo all’Atlante dei dissesti<br />
del PAI del Fiume Po nell’ambito delle previste<br />
verifiche di compatibilità degli strumenti<br />
urbanistici comunali con il PAI stesso (art. 18<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
103
104<br />
delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI).<br />
Nell’ambito di tali attività, infatti, il quadro<br />
della franosità del PAI è stato rivisto a partire,<br />
innanzitutto dalla banca dati IFFI (Inventario<br />
dei Fenomeni Franosi in Italia), redatta e<br />
gestita, per la Liguria, dallo stesso team di<br />
tecnici; i dati IFFI, per l’occasione, sono stati<br />
ulteriormente riconsiderati e integrati con<br />
le segnalazioni fornite dagli stessi Comuni,<br />
nonché con l’analisi dei dati di interferometria<br />
<strong>satellitare</strong> disponibili. Tali dati si riferivano per<br />
lo più alla sola banca dati di immagini ERS<br />
e, quindi, al periodo 1992-2000. Le verifiche<br />
che di routine sono state eseguite sui dati<br />
PSInSAR possono essere così descritte:<br />
1. una prima verifica speditiva sulla<br />
distribuzione delle aree anomale<br />
2.<br />
onde accertare l’eventuale presenza di<br />
anomalie significative in aree totalmente<br />
esterne ai perimetri sia delle frane PAI sia<br />
IFFI, ovvero ricadenti in areali inquadrati<br />
in frane inattive;<br />
un ulteriore controllo puntuale specifico<br />
sul seminato dei bersagli radar relativamente<br />
a eventuali frane attive PAI o IFFI,<br />
che interessassero centri abitati, case<br />
sparse o infrastrutture, che non denotavano<br />
intersezioni con aree anomale;<br />
3. a seguito delle verifiche di cui al<br />
punto 1, sono stati condotti rilievi<br />
aerofotogrammetrici e di campagna ad<br />
hoc al fine di definire la genesi dell’area<br />
anomala e valutare l’inserimento di un<br />
nuovo fenomeno franoso o modificarne<br />
lo stato di attività.<br />
4. a seguito delle verifiche di cui al punto<br />
2, veniva innanzitutto controllata la<br />
presenza di bersagli radar all’interno del<br />
corpo di frana. Nel caso di assenza di<br />
bersagli, veniva valutato, in primis, se<br />
essa potesse derivare da problematiche<br />
tecniche di deformazione prospettica<br />
dei versanti rispetto alla linea di vista<br />
del satellite piuttosto che da questioni<br />
inerenti la copertura vegetale dell’area.<br />
In seconda battuta, in assenza delle<br />
suddette problematiche, si verificava<br />
la possibile sussistenza di cinematismi<br />
troppo rapidi rispetto alle capacità<br />
risolutive della tecnica per la base<br />
dati ERS. Qualora, invece, la frana<br />
contenesse bersagli associati a velocità<br />
di spostamento inferiori alla soglia dei 2<br />
mm a -1 , si valutava l’assetto morfologico<br />
del versante rispetto alla direzione<br />
orbitale del satellite e, quindi, nel caso<br />
di versanti favorevolmente esposti, i<br />
possibili cinematismi del dissesto. Tali<br />
verifiche erano finalizzate ad escludere la<br />
possibile sussistenza di moti deformativi<br />
con componenti geometriche invisibili<br />
o fortemente sottostimate dalla tecnica<br />
PSInSAR (cfr cap. 5).<br />
A valle di tutte le verifiche sopra riportate si<br />
sono, quindi, svolte le considerazioni di sintesi,<br />
tenendo conto, fra l’altro, anche del quadro<br />
dello stato di conservazione dei manufatti<br />
rilevato e dell’eventuale esistenza di ulteriori<br />
informazioni conoscitive circa l’assetto<br />
stratigrafico e le deformazioni in atto. Alla luce<br />
di tali considerazioni, veniva, infine, condiviso<br />
con i Comuni interessati il nuovo quadro dei<br />
dissesti proposto, ai fini della chiusura della<br />
procedura di verifica di compatibilità da parte<br />
della stessa amministrazione comunale.<br />
Nel seguito, quindi, sono riportati in forma<br />
di scheda una serie di esempi – in alcuni<br />
casi si tratterà di casi pratici già affrontati e<br />
conclusi o in fase di completamento, in altri<br />
di casi di studio che non sono ancora sfociati<br />
<strong>nella</strong> fase di recepimento pratico da parte<br />
degli strumenti di <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
– finalizzati ad evidenziare soprattutto le<br />
problematiche pratiche di utilizzo dei dati<br />
PSInSAR.<br />
6.2 Esempi applicativi in Regione<br />
Liguria<br />
Le pagine che seguono riportano otto<br />
schede descrittive relative a casi pratici<br />
affrontati <strong>nella</strong> Regione Liguria.
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Tematizzazione grafica dei PS rappresentati nelle schede riportate nelle pagine<br />
seguenti<br />
Legenda_dataset discendente<br />
-32 to -28<br />
-28 to -24<br />
-24 to -20<br />
-20 to -16<br />
-16 to -13<br />
-13 to -10<br />
-10 to -8<br />
-8 to -6<br />
-6 to -4<br />
-4 to -3<br />
-3 to -2<br />
-2 to -1<br />
-1 to 0<br />
0 to 1<br />
1 to 2<br />
2 to 3<br />
3 to 4<br />
4 to 6<br />
6 to 10<br />
10 to 16<br />
Legenda_dataset ascendente<br />
-32 to -28<br />
-28 to -24<br />
-24 to -20<br />
-20 to -16<br />
-16 to -13<br />
-13 to -10<br />
-10 to -8<br />
-8 to -6<br />
-6 to -4<br />
-4 to -3<br />
-3 to -2<br />
-2 to -1<br />
-1 to 0<br />
0 to 1<br />
1 to 2<br />
2 to 3<br />
3 to 4<br />
4 to 6<br />
6 to 10<br />
10 to 16<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
105
106<br />
SCHEDA 1 Frana attiva PAI riclassificata a stabilizzata<br />
Comune di: torriglia<br />
Località: Casabianca<br />
Frana PAI: attiva<br />
Esposizione versante: E-SE<br />
Piattaforma <strong>satellitare</strong>: ERS<br />
Caratteristiche aree anomale e distribuzione PS:<br />
i bersagli risultano distribuiti esclusivamente <strong>nella</strong> porzione mediana dell’accumulo, ove sono<br />
localizzati edifici e infrastrutture. L’unica area anomala individuata è scarsamente significativa<br />
(formata da 3 PS, 2 soli dei quali con vel poco superiori alla soglia). L’assetto del versante rispetto<br />
alla LOS e le caratteristiche cinematiche del fenomeno inducono ad escludere la possibilità di<br />
una forte sottostima di eventuali deformazioni da parte della tecnica PSInSAR.<br />
Presenza di indagini e monitoraggi:<br />
note:<br />
monitoraggi non reperiti<br />
Caratteristiche geomorfologiche:<br />
Presenza di PS discendenti: N° 18<br />
Presenza di PS ascendenti: N° 8<br />
Presenza di aree anomale in orbita desce:<br />
Presenza di aree anomale in orbita asce:<br />
l’area risulta caratterizzata dalla presenza di un vasto e profondo fenomeno di deformazione<br />
gravitativa in roccia, nel complesso stabilizzato, e presenta alcune locali riattivazioni dell’accumulo<br />
per colamento lento nei settori a morfologia concava, maggiormente depressi e ricchi di acqua.<br />
Stato di conservazione dei manufatti:<br />
tolte alcune limitate lesioni individuate a carico di manufatti pertinenziali e di poche abitazioni,<br />
si è rilevato il generale buono stato di conservazione dei manufatti insistenti nell’area, ivi<br />
comprese le infrastrutture viarie che attraversano trasversalmente il corpo d’accumulo.<br />
Esito:<br />
è stata proposta la riperimetrazione della vasta frana attiva individuata nell’Atlante dei dissesti<br />
del PAI del Fiume Po, che è stata inquadrata come scorrimento profondo in roccia stabilizzato.<br />
All’interno della porzione medio bassa dell’accumulo sono stati riconosciuti alcuni locali<br />
fenomeni di colamento lento attivi e quiescenti, ubicati nei settori ad assetto concavo, sede di<br />
diffuse emergenze idriche ed aree di impregnazione.<br />
Problematiche pratiche uso PS:<br />
il principale problema in questo caso è stato quello della disomogenea distribuzione dei<br />
bersagli all’interno del perimetro di frana. Le porzioni di nicchia e al piede del fenomeno sono,<br />
infatti, prive di bersagli, così come le aree prative dove sono state individuate le porzioni attive.<br />
Anche la scarsità dei dati in orbita ascendente in corrispondenza di un versante esposto a SE<br />
riduce l’affidabilità del dato.
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Seminato PS ErS e aree anomale orbita desce Seminato PS ErS e aree anomale orbita asce<br />
Stralcio carta Pai Stralcio proposta nuova perimetrazione frana<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
107
108<br />
SCHEDA 2 Area non vincolata da PAI inquadrata in frana quiescente<br />
Comune di: torriglia<br />
Località: Obbi<br />
Frana PAI: non presente<br />
Esposizione versante: NO<br />
Piattaforma <strong>satellitare</strong>: ERS<br />
Caratteristiche aree anomale e distribuzione PS:<br />
Presenza di PS discendenti: N° 8<br />
Presenza di PS ascendenti: N° 0<br />
Presenza di aree anomale in orbita desce:<br />
Presenza di aree anomale in orbita asce:<br />
i bersagli risultano distribuiti esclusivamente <strong>nella</strong> porzione medio bassa del versante, ove<br />
sono localizzati edifici e infrastrutture. L’area anomala individuata è molto significativa (formata<br />
da n PS, tutti con velocità superiori alla soglia, comprese fra 12 e 4 mm a -1 ). L’assetto del<br />
versante rispetto alla LOS e le caratteristiche cinematiche del fenomeno inducono ad escludere<br />
la possibilità di una forte sottostima di eventuali deformazioni da parte della tecnica PSInSAR<br />
e le velocità registrate dovrebbero corrispondere a circa il 60% delle deformazioni reali (Notti,<br />
2011). Le verifiche di campagna non hanno consentito di fugare alcuni dubbi circa l’associazione<br />
di alcuni target a edifici piuttosto che a manufatti pertinenziali agricoli fatiscenti ad essi limitrofi.<br />
Presenza di indagini e monitoraggi:<br />
note:<br />
Caratteristiche geomorfologiche:<br />
sebbene la cartografia geologica di realizzazione relativamente recente non riportino coperture<br />
detritiche significative o DGPV nell’areale, le verifiche da foto aerea e i rilievi di campagna<br />
sembrano evidenziare la possibile presenza di un vasto e profondo fenomeno di deformazione<br />
gravitativa.<br />
Stato di conservazione dei manufatti:<br />
si è rilevato il generale buono stato di conservazione degli edifici insistenti nell’area,<br />
compatibilmente con la vetustà e la carenza di manutenzione osservata. Anche le infrastrutture<br />
viarie che attraversano trasversalmente il corpo d’accumulo non manifestano particolari<br />
problematiche.<br />
Esito:<br />
in conseguenza delle indicazioni desunte dai rilievi condotti e dell’analisi dei dati satellitari<br />
nell’areale è stato proposto l’inserimento di un nuovo scorrimento profondo classificato in<br />
stato di quiescenza. Tale valutazione è motivata dal fatto che, se da un lato non si sono potute<br />
individuare direttamente sul terreno evidenze di deformazioni in atto, le indicazioni cinematiche<br />
desumibili dai dati PSInSAR (anche da piattaforma Envisat, sia pure con tassi di spostamento<br />
inferiori) appaiono piuttosto inequivocabili. L’opzione adottata relativamente alla quiescenza<br />
della frana è apparsa, quindi, come un giusto compromesso fra le esigenze di imporre opportune<br />
cautele di carattere pianificatorio e quelle di non innescare un ingiustificato allarmismo <strong>nella</strong><br />
popolazione e nell’amministrazione comunale.
Problematiche pratiche uso PS:<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
il principale problema in questo caso, oltre alla disomogenea distribuzione dei bersagli<br />
all’interno del perimetro di frana, che si ripete <strong>nella</strong> gran parte dei casi analizzati in territorio<br />
ligure, risiede nell’assenza di evidenze fisiche della sussistenza di un fenomeno deformativo in<br />
atto. L’inserimento di una nuova frana e dei conseguenti vincoli in questo caso è stato accettato<br />
senza particolari problemi dall’Amministrazione comunale in quanto in quest’area non sussistono<br />
particolari esigenze urbanistiche.<br />
Seminato PS ErS e aree anomale orbita desce Seminato PS ErS e aree anomale orbita asce<br />
Stralcio carta Pai Stralcio proposta nuova perimetrazione frana<br />
Nessuna frana riportata<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
109
110<br />
SCHEDA 3 Area in frana quiescente PAI riclassificata come attiva<br />
comune di: Fascia<br />
Località: Cassingheno<br />
Frana PAI: quiescente e piccole porzioni attive<br />
Esposizione versante: SO<br />
Piattaforma <strong>satellitare</strong>: ERS<br />
Caratteristiche aree anomale e distribuzione PS:<br />
Presenza di PS discendenti: N° 18<br />
Presenza di PS ascendenti: N° 4<br />
Presenza di aree anomale in orbita desce:<br />
Presenza di aree anomale in orbita asce:<br />
i bersagli risultano distribuiti esclusivamente <strong>nella</strong> parte alta del versante, ove sono<br />
localizzati edifici e infrastrutture. Sono individuate 2 aree anomale abbastanza significative<br />
(formate da 6 e 7 PS, con velocità, comprese fra 1 e 6 mm a -1 ). L’assetto del versante rispetto<br />
alla LOS e le caratteristiche cinematiche del fenomeno inducono a valutare la possibilità di<br />
una significativa sottostima delle deformazioni da parte della tecnica PSInSAR e le velocità<br />
registrate dovrebbero corrispondere a circa il 40% delle deformazioni reali (Notti, 2011). I tassi di<br />
spostamento sembrerebbero aumentare <strong>nella</strong> parte bassa del paese. Le verifiche di campagna<br />
hanno consentito di associare con sufficiente sicurezza la gran parte dei target a edifici. I dati<br />
Envisat, pur intrinsecamente meno affidabili degli ERS, confermano il quadro suesposto, pur con<br />
velocità leggermente inferiori.<br />
Presenza di indagini e monitoraggi:<br />
note:<br />
monitoraggi non reperiti<br />
Caratteristiche geomorfologiche:<br />
l’area è nota storicamente per essere interessata da problematiche di carattere gravitativo<br />
(SCAI). I caratteri morfologici dell’area evidenziano la presenza di una estesa frana complessa<br />
per scorrimento e colata di genesi relitta, il cui accumulo risulta nel complesso riattivato con<br />
cinematiche di colamento lento.<br />
Stato di conservazione dei manufatti:<br />
si è rilevato un quadro lesivo a carico degli edifici piuttosto diffuso ancorché non particolarmente<br />
preoccupante, più marcato ed evidente <strong>nella</strong> parte bassa del paese.<br />
Esito:<br />
in conseguenza delle indicazioni desunte dai rilievi condotti e dell’analisi dei dati satellitari<br />
nell’areale, si è valutato, in accordo con l’Amministrazione comunale di rivedere il perimetro<br />
della frana quiescente del PAI riclassificandola come frana attiva<br />
Problematiche pratiche uso PS:<br />
nessun particolare problema in questo caso, oltre alla più volte citata disomogenea distribuzione<br />
dei bersagli all’interno del perimetro di frana.
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Seminato PS ErS e aree anomale orbita desce Seminato PS ErS e aree anomale orbita asce<br />
Stralcio carta Pai Stralcio proposta nuova perimetrazione frana<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
111
112<br />
SCHEDA 4 Area a rischio PAI la cui perimetrazione e’ stata rivista e zonizzata in porzioni<br />
attive, quiescenti e stabilizzate<br />
Comun Savignone<br />
Località: capoluogo<br />
Frana PAI: area a rischio sul capoluogo,<br />
nulla sul versante NO<br />
Esposizione versante: S-SE e NO<br />
Piattaforma <strong>satellitare</strong>: ERS<br />
Caratte aree anomale e distribuzione PS:<br />
Presenza di PS discendenti: N° 166<br />
Presenza di PS ascendenti: N° 31<br />
Presenza di aree anomale in orbita desce:<br />
Presenza di aree anomale in orbita asce:<br />
i bersagli risultano estesamente distribuiti sul versante esposto a S, dove insiste il capoluogo,<br />
mentre sul versante di fronte, esposto a NO (loc. Sementella), denotano una distribuzione più<br />
sporadica, dovuta alla minor presenza di manufatti ed edifici. Le aree anomale individuate<br />
sono posizionate in corrispondenza del versante di Sementella e una soltanto è ubicata <strong>nella</strong><br />
porzione NO dell’insediamento del capoluogo (loc. Gabbie). Quest’ultima area anomala presenta<br />
caratteristiche peculiari: trovandosi, infatti, posizionata fra la nicchia e la testata di un’area in<br />
frana con direzione di movimento circa N170, denota una forma arcuata che riprende quella<br />
della morfostruttura che ne determina la presenza.<br />
A causa dell’interazione fra l’assetto morfologico del fenomeno franoso e l’assetto geometrico<br />
delle acquisizioni satellitari, i target posizionati sulla parte O dell’area anomala registrano moti in<br />
avvicinamento, mentre quelli <strong>nella</strong> parte E appaiono in allontanamento dal satellite. Per questo<br />
motivo la velocità media dei target costituenti l’area anomala è prossima allo zero, mentre le<br />
velocità di deformazione, in valore assoluto, superano i 6 mm a -1 .<br />
Presenza di indagini e monitoraggi:<br />
note:<br />
le indagini si riferiscono alla sola frana di loc. Gabbie<br />
Caratteristiche geomorfologiche:<br />
l’areale del capoluogo è storicamente noto per essere interessato da problematiche di<br />
carattere gravitativo (SCAI). I caratteri morfologici dell’area evidenziano la presenza di imponenti<br />
fenomeni di scorrimento in roccia che determinano il progressivo smantellamento dei<br />
conglomerati oligocenici in corrispondenza della porzione marginale del loro affioramento, che<br />
è impostato, in discordanza stratigrafica, su un basamento mesozoico argillitico molto plastico.<br />
L’abitato di Savignone insiste su un’estesa falda detritica caratterizzata da forte eterometria dei<br />
clasti e da importanti fenomeni di impregnazione. Anche il versante opposto, ove è ubicata la<br />
frazione di Sementella, è caratterizzato dalla presenza di un’imponente falda detritica generata<br />
dalla detrizione dei flysch calcareo marnosi del M. Antola e dei sovrastanti conglomerati in<br />
corrispondenza del contatto con le argilliti. In entrambi i casi significative porzioni delle coperture<br />
detritiche appaiono interessate da fenomeni secondari di genesi gravitativa a cinematica lenta.<br />
Stato di conservazione dei manufatti: nel capoluogo si è rilevato un quadro lesivo a carico<br />
degli edifici piuttosto diversificato a seconda dei diversi settori del versante, maggiormente<br />
marcato <strong>nella</strong> zona di Gabbie ed in quella del campo sportivo. Nell’abitato di Sementella, invece,<br />
le lesioni appaiono distribuite in maniera più uniforme, ancorché non siano quasi mai di grande<br />
rilevanza.
Esito:<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
l’areale, data anche la sua notevole importanza urbanistica, è stato oggetto di ripetuti<br />
sopralluoghi e discussioni con tecnici nominati dal Comune e di estrazione accademica. La<br />
sintesi di tutte le indagini svolte e delle informazioni raccolte ha consentito di individuare un<br />
quadro del dissesto particolarmente complesso. In estrema sintesi, tuttavia, si può rilevare come<br />
le anomalie deformative individuate con le analisi PSInSAR ricadano sulle più estese porzioni<br />
di frana attiva riportate.<br />
Problematiche pratiche uso PS:<br />
se in questo caso la distribuzione dei bersagli all’interno dell’area in esame risulta<br />
sufficientemente omogenea, qui si riscontra un problema di interazione fra la LOS sia ascendente<br />
che discendente e la geometria dei versanti in una zona soggetta a forti interessi urbanistici e<br />
in larga parte priva di altri dati di monitoraggio delle deformazioni. La zonizzazione della frana,<br />
quindi, si è necessariamente basata maggiormente sul rilievo geomorfologico tradizionale e sul<br />
rilievo dei marker rigidi piuttosto che sui dati satellitari.<br />
Seminato PS ErS e aree anomale orbita desce Seminato PS ErS e aree anomale orbita asce<br />
Stralcio carta Pai Stralcio proposta nuova perimetrazione frana<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
113
114<br />
SCHEDA 5 Frana stabilizzata PAI all’interno della quale sono state individuate porzioni attive<br />
Comune di: Diano arentino<br />
Località: capoluogo<br />
Frana PAI: estesa area di frana in parte<br />
quiescente in parte stabilizzata<br />
Esposizione versante: E<br />
Piattaforma <strong>satellitare</strong>: Radarsat<br />
Caratteristiche aree anomale e distribuzione PS:<br />
Presenza di PS discendenti: N° 386<br />
Presenza di PS ascendenti: N° 566<br />
Presenza di aree anomale in orbita desce:<br />
Presenza di aree anomale in orbita asce:<br />
i bersagli risultano estesamente distribuiti sul versante, in particolare per quanto riguarda<br />
quelli acquisiti in orbita ascendente. Si rileva la presenza di due estese aree anomale derivanti<br />
dal dataset ascendente in corrispondenza delle frazioni Poggio e Villa Chiesa; in loc. Poggio si<br />
osserva la presenza di un’anomalia anche da dati discendenti. La Borgata Villa Costa, invece, è<br />
coperta da numerosi bersagli che, nell’insieme, sembrano denotare una sostanziale assenza di<br />
deformazioni.<br />
Presenza di indagini e monitoraggi:<br />
note:<br />
sono stati reperiti alcuni vecchi sondaggi lunghi al massimo 18 m nell’areale di Poggio<br />
Caratteristiche geomorfologiche:<br />
L’areale è interessato dalla presenza di un imponente fenomeno franoso antico che si estende<br />
su oltre 1 km2 comprendendo numerose frazioni, oltre al capoluogo (SCAI). L’accumulo appare<br />
articolato in numerosi corpi secondari sede di parziali riattivazioni parziali verificatesi nel tempo.<br />
Il piede della frana è ubicato in corrispondenza del fondovalle, dove scorre il T. Evigno che<br />
manifesta un’importante attività erosiva che, soprattutto nei tratti in sponda esterna delle anse,<br />
determina estese riattivazioni per scorrimento, quale quella recentemente registratasi nei pressi<br />
di Borgata Maccari, a seguito delle piogge della tarda primavera 2011.<br />
Stato di conservazione dei manufatti:<br />
il quadro lesivo a carico degli edifici maggiormente esteso e significativo è stato osservato<br />
in fraz. Poggio. Anche la fraz. Villa Chiesa, tuttavia, manifesta lesioni diffuse su buona parte<br />
delle abitazioni e la stessa Chiesa appare vistosamente vulnerata, con evidenti fuori piombo.<br />
La fraz. Villa Costa, invece, non evidenzia la presenza di particolari problematiche di instabilità<br />
dei manufatti. Va, infine, segnalato il verificarsi di importanti deformazioni delle sedi stradali, sia<br />
della provinciale che della comunale, nel settore fra Poggio e Maccari, verificatesi a seguito degli<br />
eventi meteorici della primavera 2011.<br />
Esito:<br />
le evidenze di terreno unitamente al dato PS suggeriscono la revisione della classificazione<br />
dello stato di attività della frana da relitta a quiescente con l’individuazione di alcune porzioni<br />
attive all’interno del corpo principale, in particolare in corrispondenza delle frazioni di Villa<br />
Chiesa e Poggio, e <strong>nella</strong> porzione basale nel settore fra quest’ultima e località Maccari
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Problematiche pratiche uso PS:<br />
in questo caso la distribuzione dei bersagli all’interno dell’area in esame risulta abbastanza<br />
omogenea, fatta eccezione per la porzione settentrionale del piede della frana. Le maggiori<br />
problematiche di interpretazione dei dati e di traduzione pratica <strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> di bacino<br />
riguardano l’areale di Villa Chiesa, dove le evidenze di cinematismi in atto desunte dai dati<br />
PSInSAR e dal quadro lesivo sui manufatti non sono così univoche da poter supportare<br />
soluzioni normative fortemente penalizzanti. Un’ulteriore criticità consiste nel fatto che i dati<br />
disponibili coprono il periodo gennaio 2003- settembre 2009, che, nonostante sia lungo ben 6<br />
anni, non include piogge particolarmente significative. Gli eventi più significativi, infatti, si sono<br />
verificati negli inverni del 2000 e 2002 e nel corso degli ultimi 2 anni.<br />
Seminato PS ErS e aree anomale orbita desce Seminato PS ErS e aree anomale orbita asce<br />
Stralcio carta Pai Stralcio proposta nuova perimetrazione frana<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
115
116<br />
SCHEDA 6 Frana attiva PAI riperimetrata in parte come quiescente<br />
Comune di: Mendatica<br />
Comune di: Mendatica<br />
Località: capoluogo<br />
Frana PAI: estesa area di frana interamente<br />
classificata come attiva<br />
Esposizione versante: E - SE<br />
Caratteristiche aree anomale e distribuzione PS:<br />
Piattaforma <strong>satellitare</strong>: Radarsat<br />
Presenza di PS discendenti: N° 171<br />
Presenza di PS ascendenti: N° 233<br />
Presenza di aree anomale in orbita desce:<br />
Presenza di aree anomale in orbita asce:<br />
i bersagli risultano estesamente distribuiti sul versante, in particolare per quanto riguarda<br />
quelli acquisiti in orbita ascendente. Si rileva la presenza di due estese aree anomale derivanti<br />
dal dataset ascendente in corrispondenza della frazione Piani e della parte del centro storico<br />
in prossimità del campo sportivo. La porzione più estesa del centro storico, ubicata <strong>nella</strong> parte<br />
meridionale dell’accumulo, è connotata dalla presenza di numerosi bersagli associati in larga<br />
maggioranza a tassi di spostamento inferiori alla soglia dei 2 mm a -1 . L’aggiornamento dei dati<br />
fino al 2010 ha consentito di verificare, tuttavia, una rilevante accelerazione delle deformazioni<br />
a seguito delle forti piogge occorse fra il 2008 ed il 2009 (vedi cap. 4.4)<br />
Presenza di indagini e monitoraggi:<br />
Caratteristiche geomorfologiche:<br />
L’areale è interessato dalla presenza di un imponente fenomeno franoso antico che si estende<br />
su oltre 1 km 2 , dal crinale a circa 2.000 m s.l.m. fino al fondovalle del T. Cagnasso a 600 m,<br />
comprendendo l’intero capoluogo (SCAI). L’accumulo appare articolato in numerosi corpi<br />
secondari sede di parziali riattivazioni parziali verificatesi nel tempo. I risultati dei monitoraggi in<br />
corso confermano, sostanzialmente, le indicazioni fornite dai dati PS, evidenziando la presenza<br />
di una estesa porzione in evidente stato di attività su più superfici di scorrimento fino a 28 metri<br />
di profondità <strong>nella</strong> porzione settentrionale della parte medio bassa dell’accumulo.<br />
Stato di conservazione dei manufatti:<br />
il quadro lesivo a carico degli edifici maggiormente esteso e significativo è stato osservato in<br />
frazione Piani, tuttavia, lesioni più o meno significative possono essere riscontrate a carico di<br />
svariati edifici in tutto il centro storico, compresa la porzione centrale e meridionale ubicata sul<br />
colmo e a S della dorsale che suddivide il corpo d’accumulo e che, in base ai dati di monitoraggio<br />
raccolti, sembra anche separare la parte attiva da quella inattiva.<br />
Esito:<br />
le evidenze di terreno unitamente al dato PS suggeriscono la revisione di perimetrazione<br />
e classificazione delle frane che interessano la porzione di versante su cui sorge Mendatica,<br />
con l’individuazione di alcune porzioni attive che interessano il settore del campo sportivo<br />
e la frazione di Piano, fino al Rio Cagnasso, con meccanismi sia di scorrimento traslativo sia<br />
complessi. Frane complesse quiescenti sono state individuate nel settore del cimitero e in destra<br />
orografica del Rio Molino mentre scorrimenti traslativi, quiescenti, interessano la località Pian di<br />
Ciose. Non si escludono potenziali scorrimenti di roccia in blocco <strong>nella</strong> porzione di versante a<br />
sud del centro abitato.
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Problematiche pratiche uso PS:<br />
il caso in questione è particolarmente fortunato in quanto a distribuzione dei bersagli e<br />
presenza contemporanea di dati in entrambe le direzioni orbitali. L’unico elemento di dubbio<br />
nell’interpretazione dei dati per la porzione di accumulo quiescente è inizialmente consistito<br />
<strong>nella</strong> già citata problematica della piovosità non eccezionale del periodo inizialmente monitorato<br />
con i dati Radarsat che, in questo caso, si sovrappone alla scarsa attendibilità delle letture<br />
inclinometriche per i tubi posizionati in questa parte dell’accumulo. L’aggiornamento dei dati<br />
al 2010, con la fase di forti piogge occorse fra il 2008 ed il 2009, ha consentito, di contro, di<br />
chiarire meglio le dinamiche del versante.<br />
Seminato PS ErS e aree anomale orbita desce Seminato PS ErS e aree anomale orbita asce<br />
Stralcio carta Pai Stralcio proposta nuova perimetrazione frana<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
117
118<br />
SCHEDA 7 Frana quiescente PAI riclassificata come attiva e area non vincolata PAI<br />
inquadrata come frana attiva<br />
Comune di: rezzoaglio<br />
Località: Magnasco e Cerisola<br />
Frana PAI: estese aree di frana quiescenti<br />
ubicate rispettivamente <strong>nella</strong> porzione di<br />
versante a valle di Cerisola e Villa Rocca e<br />
in corrispondenza del nucleo di Magnasco<br />
Caratteristiche aree anomale e distribuzione PS:<br />
Esposizione versante: NO<br />
Piattaforma <strong>satellitare</strong>: ERS<br />
Presenza di PS discendenti: N° 60<br />
Presenza di PS ascendenti: N° 26<br />
Presenza di aree anomale in orbita desce:<br />
Presenza di aree anomale in orbita asce:<br />
i bersagli risultano distribuiti esclusivamente <strong>nella</strong> porzione medio-basale del versante, ove<br />
sono localizzati edifici e infrastrutture. Le due aree anomale più estese e significative derivano<br />
dal dataset discendente e interessano rispettivamente i nuclei abitati di Magnasco (formata<br />
da 39 PS) e Cerisola (formata da 20 PS), tutti con velocità superiori alla soglia e comprese<br />
tra 24 mm/anno -1 e oltre 35 mm a -1 . L’assetto del versante rispetto alla LOS e le caratteristiche<br />
cinematiche del fenomeno franoso inducono ad escludere la possibilità di una forte sottostima<br />
di eventuali deformazioni da parte della tecnica PSInSAR. I tassi di spostamento maggiori si<br />
registrano in corrispondenza del nucleo di Cerisola. I dati ENVISAT, pur intrinsecamente meno<br />
affidabili degli ERS, confermano il quadro esposto se pur con velocità di poco inferiori.<br />
Presenza di indagini e monitoraggi:<br />
note:<br />
Caratteristiche geomorfologiche:<br />
l’intero versante su cui sorgono i nuclei abitati di Magnasco e Cerisola è storicamente noto<br />
per essere interessato da problematiche gravitative (SCAI). I caratteri morfologici del comparto<br />
evidenziano la presenza di imponenti fenomeni di scorrimento in roccia riconducibili ad<br />
un’antica deformazione gravitativa profonda che ha interessato l’intero versante, dal crinale al<br />
fondovalle (Roccati, 2011). I nuclei abitati insistono su potenti coperture detritiche articolate in<br />
diversi corpi secondari, sedi di riattivazioni parziali verificatesi nel tempo.<br />
Stato di conservazione dei manufatti:<br />
il quadro fessurativo osservato è risultato poco rilevante se confrontato con gli elevati tassi di<br />
spostamento registrati e gli edifici si presentano in un generale buono stato di conservazione,<br />
compatibilmente con l’età e la tipologia costruttiva adoperata, ad eccezione di un numero<br />
esiguo di manufatti che risultano però in uno stato di totale abbandono da diversi anni (Roccati,<br />
2011). Anche le infrastrutture viarie che attraversano trasversalmente i corpi di accumulo non<br />
manifestano particolari problematiche; da segnalare, tuttavia, lungo il margine del corpo su cui<br />
sorge il nucleo di Cerisola, una evidente deformazione strutturale del ponte sul R. Crosa Scura.
Esito:<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
in conseguenza delle indicazioni derivanti dai rilievi condotti sul terreno e dall’analisi dei<br />
dati di interferometria <strong>satellitare</strong>, si prevede la riclassificazione della frana quiescente del PAI<br />
in corrispondenza del nucleo di Magnasco come frana attiva e l’inserimento della zona su cui<br />
insiste il nucleo di Cerisola in frana attiva, con la proposta di classificare entrambe come aree a<br />
rischio molto elevato (Zona 1 - PAI)<br />
Problematiche pratiche uso PS:<br />
il principale problema, oltre alla disomogenea distribuzione dei bersagli all’interno dei corpi di<br />
frana già vista in altri casi, risiede, a fronte dei tassi di spostamento registrati, <strong>nella</strong> assenza di<br />
evidenze fisiche significative della presenza di fenomeni deformativi in atto.<br />
Seminato PS ErS e aree anomale orbita desce Seminato PS ErS e aree anomale orbita asce<br />
Stralcio carta Pai Stralcio proposta nuova perimetrazione frana<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
119
120<br />
SCHEDA 8 Area non vincolata PAI inquadrata come DgPV<br />
Comune di: neirone<br />
Località: Corsiglia<br />
Frana PAI: nessuna frana indicata<br />
Esposizione versante: O<br />
Piattaforma <strong>satellitare</strong>: ERS<br />
Caratteristiche aree anomale e distribuzione PS:<br />
Presenza di PS discendenti: N° 29<br />
Presenza di PS ascendenti: N° 1<br />
Presenza di aree anomale in orbita desce:<br />
Presenza di aree anomale in orbita asce:<br />
i bersagli risultano distribuiti in maniera fortemente disomogenea, essendo esclusivamente<br />
localizzati <strong>nella</strong> porzione media del versante, ove sono ubicati edifici e infrastrutture. L’ area<br />
anomala che insiste sull’intero borgo è caratterizzata dalla massima omogeneità e da tassi di<br />
spostamento compresi fra i 3 ed i 9 mm a -1 . La geometria del versante risulta ottimale per le<br />
analisi PSInSAR, che, in queste condizioni, dovrebbero registrare circa il 70% delle deformazioni.<br />
Presenza di indagini e monitoraggi:<br />
note:<br />
Caratteristiche geomorfologiche:<br />
l’intero versante su cui sorge l’abitato di Corsiglia non è mai stato inquadrato fra le aree in frana.<br />
Nella parte alta del versante la cartografia CARG localizza un limitato dissesto inattivo, che, però,<br />
lambirebbe solo marginalmente l’abitato. Nel complesso, i caratteri morfologici del comparto<br />
richiamano quelli di un imponente fenomeno di scorrimento in roccia che ha interessato l’intero<br />
versante, dal crinale al fondovalle. Fenomeni gravitativi superficiali sono evidenti solo al piede<br />
del versante, in fregio al corso d’acqua.<br />
Stato di conservazione dei manufatti:<br />
sebbene gli edifici del centro abitato siano mediamente vecchi, prevalentemente in pietra<br />
e privi di fondazioni, il quadro fessurativo osservato è di fatto nullo, fatta eccezione per<br />
pochi singoli edifici i cui proprietari lamentano problemi di infiltrazioni e presenza di sorgenti<br />
temporanee a seguito degli eventi piovosi più significativi.<br />
Esito:<br />
allo stato attuale, non è stata intrapresa alcuna azione di rettifica degli strumenti di <strong>pianificazione</strong><br />
territoriale. In assenza di ulteriori elementi che possano far ipotizzare il possibile aumento del<br />
livello di rischio, si potrebbe valutare l’inserimento di una DGPV e, quindi, di semplici indicazioni<br />
prescrittive cautelative in caso di interventi urbanistico-infrastrutturali nell’area.<br />
Problematiche pratiche uso PS:<br />
il principale problema, oltre alla disomogenea distribuzione dei bersagli all’interno dei corpi di<br />
frana già vista in altri casi, risiede, a fronte dei tassi di spostamento registrati, <strong>nella</strong> assenza di<br />
evidenze fisiche significative della presenza di fenomeni deformativi in atto.
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Seminato PS ErS e aree anomale orbita desce Seminato PS ErS e aree anomale orbita asce<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
121
122<br />
6.3 Esempi applicativi in Regione<br />
Valle d’Aosta<br />
L’esperienza della Regione Valle D’Aosta<br />
nell’utilizzo pratico dei dati PS per l’analisi<br />
dei fenomeni di versante si riferisce<br />
all’approfondimento dello stato delle<br />
conoscenze circa alcuni dissesti censiti nel<br />
progetto IFFI condotto mediante analisi<br />
dei dati satellitari della piattaforma ESA-<br />
ERS nel periodo 1992-2001, integrata con<br />
le conoscenze derivanti dalle consuete<br />
osservazioni da fotointerpretazione e di<br />
rilevamento geologico. In tal modo si è potuta<br />
verificare la congruità delle perimetrazioni IFFI<br />
relative alle DGPV con le risultanze dell’analisi<br />
interferometrica, in particolar modo in quei<br />
casi in cui le conoscenze disponibili non<br />
avevano permesso l’individuazione e/o una<br />
ricostruzione affidabile da un punto di vista<br />
geomorfologico e cinematico del fenomeno<br />
gravitativo.<br />
Allo scopo di confrontare la distribuzione dei<br />
PS con i perimetri dei fenomeni individuati<br />
nell’ambito del progetto IFFI, sono stati<br />
esplorati i dataset PS alla ricerca di settori in<br />
cui la copertura di PS fosse soddisfacente ed<br />
inoltre il segnale PS fosse diverso da zero.<br />
Queste aree sono state analizzate tramite<br />
foto-interpretazione utilizzando il volo RAVA<br />
1997, ritenuto un buon compromesso tra<br />
quota di volo, copertura e anno di volo (si<br />
ricorda che il dato PSInSAR TM da piattaforma<br />
ERS si riferisce al decennio 1992-2000).<br />
La foto-interpretazione è stata finalizzata<br />
alla definizione speditiva del quadro<br />
geomorfologico locale con particolare<br />
riferimento agli elementi della dinamica<br />
gravitativa, nonché sulla base dell’interferenza<br />
con l’antropizzazione e attività dell’uomo da<br />
una parte e la presenza di ampia copertura<br />
PS dall’altra.<br />
Fra le aree precedentemente identificate<br />
sono state ulteriormente selezionate 22 aree<br />
significative (Figura 6-1), per le quali si è stata<br />
Figura 6-1 – Ubicazione dei fenomeni gravitativi (arancione: DGPV; rosa: frane) per i quali è stata prodotta la scheda<br />
monografica (di cui si riporta il numero).
edatta una serie di schede monografiche,<br />
in cui sono state raccolte le caratteristiche<br />
geomorfologiche, di distribuzione spaziale<br />
dei PS e per le quali sono state proposte<br />
delle interpretazioni di carattere dinamico dei<br />
fenomeni gravitativi analizzati.<br />
Nella tabella 6-1 seguente, vengono elencati<br />
i casi studio selezionati, comprensivi di<br />
Tabella 6-1. Casi di studio in Valle d’Aosta.<br />
Scheda Fenomeno gravitativo PiF iFFi Comune<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
identificativo scheda, località e comune di<br />
appartenenza.<br />
Di seguito sono riportate le sintesi delle<br />
monografie relative a due fenomeni<br />
particolarmente rappresentativi: la DGPV.<br />
di Punta Chaligne e la frana complessa di<br />
Bosmatto<br />
1 DGPV di Valtournenche 51445 Valtournenche<br />
2 DGPV di Cervinia 10099 Valtournenche<br />
3 DGPV di Pta Chaligne 40086 Gignod, Aosta<br />
4 DGPV di Torgnon 20426 Torgnon<br />
5 Frana complessa di Bosmatto 20423 Gressoney Saint-Jean<br />
6 DGPV di Quart 40067 Quart<br />
7 DGPV di Emarèse 50165 Emarèse, Montjovet<br />
8 DGPV di Becca di Vioù - Closelinaz 40075 Roisan, Saint-Christophe<br />
9 DGPV di Chambave 50060 Chambave, Saint Denis,<br />
Verrayes<br />
10 DGPV di La Raye du Sodz Saint- Rhémy en Bosses<br />
11 DGPV di Cote-de-la-Tsoi 40118 Valsavarenche<br />
12 DGPV di Grand Clapey – Vallon de Money 52239 Valsavarenche<br />
13 DGPV di Cote de Lavincusse (Epinel) 40123 Cogne<br />
14 14 DGPV di Cote de Barasson 20409 Saint-Rhémy en Bosses<br />
15 Frana del Tunnel del G. S. Bernardo 20410 Saint Rhémy en Bosses<br />
16 Settore in deformazione della Diga di<br />
Place Moulin<br />
Bionaz<br />
17 DGPV di Pointe de Mascognaz 20213 Ayas<br />
18 DGPV e frana di Corno Vitello 20219 Gressoney Saint-Jean<br />
19 Fenomeno complesso di Plan de Chenaly 10053 Perloz<br />
20 Fenomeno complesso di Chichiaz 10050 Lillianes<br />
21 DGPV di Cime-de-Marmontana 10058 Fontainemore<br />
22 Fenomeno complesso di Mont de Leretta 10054 Fontainemore<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
123
124<br />
Figura 6-2 – Carta geologico-strutturale della Valle d’Aosta.
6.3.1 la DGPV di Punta Chaligne<br />
L’inventario IFFI censisce una deformazione<br />
gravitativa profonda di versante ed un<br />
accumulo di frana nel settore alto del<br />
versante orientale della Punta Chaligne (2607<br />
m s.l.m.) nei Comuni di Aosta e Gignod, fino a<br />
coinvolgere l’abitato di Arpuilles e altre piccole<br />
frazioni poste ad una quota approssimativa<br />
di 1.200 m s.l.m. La parte sottostante del<br />
versante è articolata da una serie di scarpate<br />
trasversali che delimitano settori in cui<br />
mancano evidenze geomorfologiche di<br />
deformazione in atto.<br />
Da un punto di vista geologico, la DGPV di<br />
Punta Chaligne è situata in corrispondenza<br />
del contatto tettonico tra la Zona Piemontese<br />
e l’Unità del Mont Mary (Figura 6-2).<br />
La Zona Piemontese è un grande sistema<br />
multi falda, costituito da Unità ad affinità<br />
oceanica, che separa con continuità le unità<br />
Austroalpine dalle sottostanti falde Pennidiche<br />
del Monte Rosa-Gran Paradiso e del Gran San<br />
Bernardo. L’Unità di Mont Mary fa, invece,<br />
parte dei lembi Austroalpini settentrionali in<br />
facies scisti blu/scisti verdi.<br />
Per quanto riguarda l’analisi interferometrica<br />
Tabella 6-2. Dati disponibili per la deformazione di Punta Chaligne.<br />
Geometria n° PS<br />
contenuti<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
con tecnica PSInSAR TM da immagini ERS1 e<br />
ERS2, sono state analizzate le serie storiche<br />
nel periodo 1992-2000 in entrambe le<br />
geometrie (Figura 6-3), di cui si riportano i<br />
dati <strong>nella</strong> Tabella 6-2.<br />
Nel settore inferiore del versante, sfruttando<br />
l’acquisizione di entrambe le geometrie,<br />
è stato possibile ottenere una stima delle<br />
componenti verticali e orizzontali del moto<br />
(Fig. 6-4 e 6-5). L’analisi dei dati PSInSAR TM<br />
a disposizione ha consentito di individuare<br />
un movimento generalizzato di alcuni<br />
mm anno -1 (sempre minori di 10 mm a -1 ),<br />
che non ha trovato riscontro in sede di<br />
foto - interpretazione (assenza di evidenti<br />
deformazioni superficiali).<br />
Nella parte mediana della DGPV (Figura<br />
6-6), al di sopra della scarpata principale, è<br />
osservabile un movimento generalizzato con<br />
velocità di spostamento di alcuni mm/anno,<br />
sempre senza alcuna evidenza superficiale<br />
visibile.<br />
Grazie all’analisi dei dati interferometrici, si<br />
è potuto quindi delimitare con più precisione<br />
l’estensione della DGPV, così come proposto<br />
in figura 6-7.<br />
Velocità PS media<br />
(mm a-1)<br />
Intero versante Ascendente 1604 -3.28 2.18<br />
Intero versante Discendente 808 1.65 1.11<br />
Dev. standard<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
125
126<br />
Figura 6-3 – DGPV di Punta Chaligne (Fonte: IFFI).<br />
Figura 6-4 – Componente verticale.<br />
Delimitazione
Figura 6-5 – Componente orizzontale.<br />
Figura 6-6 – Settore mediano della DGPV.<br />
Figura 6-6 – Settore mediano della DGPV.<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Grazie all’analisi dei dati interferometrici, si è potuto quindi delimitare con più precisione<br />
l’estensione della D.G.P.V., così come proposto in figura 6-7.<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
127
128<br />
Figura. 6-7 – Nuova perimetrazione della DGPV sulla scorta dell’analisi interferometrica.<br />
Figura. 6-7 – Nuova perimetrazione della DGPV sulla scorta dell’analisi interferometrica.<br />
6.3.2 Il fenomeno gravitativo di Bosmatto<br />
DGPV Punta<br />
Chaligne<br />
Il bacino del torrente Letze si apre sul versante sinistro della Valle di Gressoney<br />
corrispondentemente alla frazione Bosmatto, storico nucleo abitativo presso il quale il torrente<br />
recapita le sue acque al Torrente Lys.<br />
L’area del bacino risulta pari a 1.16 km 2 e presenta forma molto allungata, con asse maggiore<br />
orientato E-O di raccordo tra la massima elevazione (Punta Rossa o Hore, 2750 m) e la sezione di<br />
chiusura (1460 m) da cui prende origine il conoide alluvionale.<br />
Da un punto di vista geologico, nell’area in esame affiorano litologie appartenenti all’Unità dei<br />
micascisti eclogitici e alla Zona Sesia-Lanzo.<br />
Il Lembo dei Micascisti Eclogitici di Punta Plaida è costituito da scisti eclogitici in genere<br />
retrocessi rappresentati da micascisti a glaucofane, con intercalate anfiboliti in parte eclogitizzate e<br />
marmi.<br />
L’elemento tettonico superiore della Zona Sesia Lanzo o II Zona Dioritico – Kinzigitica è<br />
costituito dalla classica trilogia di paragneiss pegmatitici, marmi ed anfiboliti. Tale unità si<br />
caratterizza inoltre per l’estesa conservazione delle associazioni mineralogiche prealpine e, a<br />
differenza dell’Elemento Strutturale Inferiore, per l’assenza di graniti.<br />
Il versante sinistro del torrente Letze è stato coinvolto essenzialmente in due movimenti<br />
gravitativi di grande estensione.<br />
Il primo settore in movimento, identificato negli studi precedenti come paleofrana 1, occupa la<br />
parte settentrionale del versante; è in corrispondenza di questa paleofrana che si è avuta la<br />
riattivazione dei movimenti gravitativi nell’ottobre 2000.<br />
Il secondo settore in movimento, che è indicato come paleofrana 2, sembrerebbe il più antico in<br />
quanto ricoperto da una fitta vegetazione boschiva ed il maggiormente evoluto dal punto di vista<br />
gravitativo. Esso occupa la porzione di versante compresa tra la frana attuale ed il crinale<br />
meridionale del bacino del T. Letze. Questo fenomeno franoso mostra una morfologia superficiale<br />
simile a quella che caratterizza la frana più recente con gradinature trasversali in corrispondenza
6.3.2 il fenomeno gravitativo di Bosmatto<br />
Il bacino del torrente Letze si apre sul<br />
versante sinistro della Valle di Gressoney<br />
corrispondentemente alla frazione Bosmatto,<br />
storico nucleo abitativo presso il quale il<br />
torrente recapita le sue acque al Torrente Lys.<br />
L’area del bacino risulta pari a 1.16 km 2 e<br />
presenta forma molto allungata, con asse<br />
maggiore orientato E-O di raccordo tra la<br />
massima elevazione (Punta Rossa o Hore,<br />
2750 m) e la sezione di chiusura (1460 m) da<br />
cui prende origine il conoide alluvionale.<br />
Da un punto di vista geologico, nell’area<br />
in esame affiorano litologie appartenenti<br />
all’Unità dei micascisti eclogitici e alla Zona<br />
Sesia-Lanzo.<br />
Il Lembo dei Micascisti Eclogitici di Punta<br />
Plaida è costituito da scisti eclogitici in<br />
genere retrocessi rappresentati da micascisti a<br />
glaucofane, con intercalate anfiboliti in parte<br />
eclogitizzate e marmi.<br />
L’elemento tettonico superiore della Zona<br />
Sesia Lanzo o II Zona Dioritico – Kinzigitica è<br />
costituito dalla classica trilogia di paragneiss<br />
pegmatitici, marmi ed anfiboliti. Tale unità si<br />
caratterizza inoltre per l’estesa conservazione<br />
delle associazioni mineralogiche prealpine e, a<br />
differenza dell’Elemento Strutturale Inferiore,<br />
per l’assenza di graniti.<br />
Il versante sinistro del torrente Letze è stato<br />
coinvolto essenzialmente in due movimenti<br />
gravitativi di grande estensione.<br />
Il primo settore in movimento, identificato<br />
negli studi precedenti come paleofrana 1,<br />
occupa la parte settentrionale del versante;<br />
è in corrispondenza di questa paleofrana<br />
che si è avuta la riattivazione dei movimenti<br />
gravitativi nell’ottobre 2000.<br />
Il secondo settore in movimento, che è<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
indicato come paleofrana 2, sembrerebbe il<br />
più antico in quanto ricoperto da una fitta<br />
vegetazione boschiva ed il maggiormente<br />
evoluto dal punto di vista gravitativo. Esso<br />
occupa la porzione di versante compresa tra<br />
la frana attuale ed il crinale meridionale del<br />
bacino del T. Letze. Questo fenomeno franoso<br />
mostra una morfologia superficiale simile a<br />
quella che caratterizza la frana più recente<br />
con gradinature trasversali in corrispondenza<br />
della quale affiora un substrato roccioso molto<br />
fratturato e disarticolato. Il piede di questa<br />
frana sembra essere situato in corrispondenza<br />
del torrente Letze, dove affiorano detriti di<br />
frana inglobanti porzioni di roccia isolate.<br />
I franamenti indotti al piede della paleofrana<br />
dai processi erosivi verificatisi lungo il<br />
torrente Letze hanno destabilizzato un ampio<br />
settore di accumulo a monte del ciglio di<br />
erosione; tale destabilizzazione è evidenziata<br />
dalla presenza di fratture aperte nel detrito<br />
e i fenomeni correlati sono destinati ad<br />
estendersi progressivamente più a monte.<br />
A completamento del quadro sopra esposto,<br />
si ricorda che, in concomitanza con l’evento<br />
alluvionale dell’ottobre 2000, si sono verificati<br />
fenomeni di debris flow, i cui depositi hanno<br />
raggiunto il fondovalle distruggendo alcuni<br />
edifici, oltre che franamenti più superficiali<br />
alla base del versante opposto sotto le<br />
baite di Stadelte, che hanno interessato<br />
i depositi glaciali poggianti sul substrato<br />
roccioso affiorante al piede. Fortunatamente,<br />
nonostante l’entità e la rapidità dei fenomeni,<br />
non vi sono state vittime.<br />
Gli studi condotti nel corso del 2010,<br />
supportati da indagini geofisiche, hanno<br />
permesso di ricostruire con maggior<br />
dettaglio la geometria del complesso franoso<br />
(Paleofrane 1 e 2, Stadelte), definendone<br />
anche i rispettivi volumi:<br />
Paleofrana 1 Paleofrana 2 Stadelte totale<br />
Volume (m 3 ) 4.900.000 1.150.000 350.000 6.400.000<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
129
130<br />
sembra essere situato in corrispondenza del torrente Letze, dove affiorano detriti di frana inglobanti<br />
porzioni di roccia isolate. I franamenti indotti al piede della paleofrana dai processi erosivi<br />
verificatisi lungo il torrente Letze hanno destabilizzato un ampio settore di accumulo a monte del<br />
Figura 6-8- La frana di Bosmatto.<br />
ciglio di erosione; tale destabilizzazione è evidenziata dalla presenza di fratture aperte nel detrito e i<br />
fenomeni correlati sono destinati ad estendersi progressivamente più a monte.<br />
A completamento del quadro sopra esposto, si ricorda che, in concomitanza con l’evento<br />
alluvionale dell’ottobre 2000, si sono verificati fenomeni di debris flow, i cui depositi hanno<br />
raggiunto il fondovalle distruggendo alcuni edifici, oltre che franamenti più superficiali alla base del<br />
versante opposto sotto le baite di Stadelte, che hanno interessato i depositi glaciali poggianti sul<br />
substrato roccioso affiorante al piede. Fortunatamente, nonostante l’entità e la rapidità dei<br />
fenomeni, non vi sono state vittime.<br />
Stadelte<br />
Paleofrana 1<br />
Figura 6-8- La frana di Bosmatto.<br />
Paleofrana 2<br />
Gli studi condotti nel corso del 2010, supportati da indagini geofisiche, hanno permesso di<br />
ricostruire con maggior dettaglio la geometria del complesso franoso (Paleofrane 1e 2, Stadelte),<br />
definendone anche i rispettivi volumi:
Nell’autunno del 2001 è stato realizzato<br />
il sistema di monitoraggio del movimento<br />
franoso di Letze – Bosmatto, attrezzato con<br />
una stazione meteorologica, una rete di<br />
stazioni GPS ad acquisizione automatica,<br />
una rete di capisaldi topografici, quattro<br />
estensimetri a filo, con trasduttore a corda<br />
vibrante e trasmissione dati via GSM, due<br />
fotocamere automatiche per il controllo visivo<br />
della frana e un piezometro ad acquisizione<br />
continua all’interno del foro di sondaggio<br />
realizzato nel corpo della paleofrana 1.<br />
L’inventario IFFI censisce tre corpi distinti,<br />
Geometria n° PS<br />
contenuti<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
a partire da una frana olocenica (A), il cui<br />
fianco destro (B) mostra un’evoluzione<br />
più recente ed una colata detritica (C)<br />
attivatasi nell’ottobre 2000. Fra tutti, l’unico<br />
settore coperto da PS è il corpo B: questo<br />
attualmente evolve come scivolamento di<br />
materiale detritico grossolano a partire dalla<br />
scarpata principale B1; da qui il corpo muove<br />
verso la scarpata che separa il corpo B dal C,<br />
area dove si originano le colate detritiche; le<br />
velocità sono relative alle misure effettuate<br />
con tecnica PSInSAR TM nel periodo 1992-2000<br />
(Figura 6-9).<br />
Velocità PS<br />
media (mm a -1 )<br />
Dev. standard<br />
Corpo B Discendente 158 -16,39 6,81<br />
Figura 6-9 – Risultati dell’analisi PSInSARTM relativa all’intervallo temporale 1992-2000. La scala di spostamento è saturata<br />
a 10 mm a-1 ; i punti rossi rappresentano pertanto velocità medie annue di spostamento in allontanamento dal satellite<br />
superiori a 10 mm a-1 (Satelliti ERS-1 ed ERS-2, gemetria discendente) Un dettaglio della parte medio-alta del settore B è<br />
rappresentato in figura 6-10.<br />
C<br />
a<br />
B<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
131
132<br />
Figura 6-10 – Risultati dell’analisi PSInSAR TM relativa all’intervallo temporale 1992-2000. La scala di spostamento è saturata<br />
a 30 mm a -1 . In basso vengono rappresentate le serie storiche di spostamento di due punti di misura, la cui ubicazione è<br />
rappresentata <strong>nella</strong> parte alta della figura.
Si osserva un’elevata deformazione per tutto<br />
il settore medio-alto del corpo B (NB: la scala<br />
di velocità in figura è stata saturata a 30 mm<br />
a -1 per esaltare le differenze di deformazione):<br />
la velocità PS è massima ai piedi della<br />
nicchia B1 (30 mm a -1 nel settore B2) per poi<br />
decrescere gradualmente fino a 10 mm a -1 nel<br />
settore B4.<br />
BDisponendo, quindi, di numerosi dati di<br />
monitoraggio acquisiti con tecniche diverse,<br />
distribuiti con continuità su quasi vent’anni<br />
e con parziali sovrapposizioni fra i diversi<br />
dataset, è stato possibile tentare un esempio<br />
di integrazione tra misure radar satellitari<br />
e misure a terra, che consente di ricostruire<br />
l’evoluzione storica del versante.<br />
Il diagramma di figura 6-11 rappresenta gli<br />
spostamenti superficiali del settore sommitale<br />
della frana nel periodo 1992-2009 ed è stato<br />
ottenuto dall’unione di quattro serie storiche<br />
relative a punti di misura ubicati in posizioni<br />
molto prossime tra loro, ottenute, in ordine<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
cronologico, con le seguenti tecniche di<br />
misura:<br />
- PSInSARTM nel periodo 1992-2000 (dati ERS-<br />
1 ed ERS-2);<br />
- stazioni topografica totale tra il 2001 ed il<br />
2003;<br />
- GPS manuale tra il 2002 ed il 2009;<br />
- PSInSARTM tra il 2005 ed il 2009 (dati<br />
RADARSAT-1),<br />
interpretazione.<br />
attualmente in corso di<br />
Vi è sovrapposizione parziale tra le serie<br />
di misure rappresentate, ad eccezione delle<br />
prime due; pertanto manca nel grafico lo<br />
spostamento verificatosi in occasione della<br />
riattivazione dell’autunno 2000, di entità<br />
presumibilmente metrica. Ciò è dovuto<br />
alla mancanza di misure, sia satellitari, sia<br />
a terra, durante la riattivazione. Pertanto le<br />
prime due serie storiche sono state poste<br />
arbitrariamente in continuità, per comodità di<br />
rappresentazione.<br />
Figura 6-11 – Storia degli spostamenti superficiali del settore sommitale della frana nel periodo 1992-2009. Gli spostamenti<br />
sono rappresentati lungo la LOS (Line-Of-Sight) dei satelliti ERS, inclinata rispetto alla verticale di circa 23° e orientata da<br />
Est a Ovest.<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
133
134<br />
Va inoltre segnalato che, dovendo confrontare<br />
tra loro misure mono e tridirezionali acquisite<br />
con strumenti e geometrie diverse, è stato<br />
necessario proiettare le misure lungo la LOS<br />
(Line of Sight) dei satelliti ERS1 ed ERS2 per<br />
rendere tra loro compatibili le serie storiche<br />
di spostamento parziali. Gli spostamenti<br />
rappresentati sono quindi monodirezionali,<br />
misurati lungo una direzione inclinata di circa<br />
23° rispetto alla verticale, con orientamento<br />
da Est a Ovest (geometria di acquisizione<br />
discendente).<br />
Il diagramma di quasi vent’anni di<br />
spostamenti evidenzia, oltre all’incremento<br />
della velocità di spostamento superficiale della<br />
frana a seguito della riattivazione dell’ottobre<br />
2000, una risposta alle precipitazioni stagionali<br />
fino al 2002.<br />
Dal 2003 si osserva una progressiva<br />
diminuzione della velocità di spostamento,<br />
che però non sembra essere ancora essere<br />
rientrata ai valori misurati prima dell’autunno<br />
2000.<br />
Nell’ottica di un ulteriore proseguimento<br />
dell’utilizzo dei dati satellitari della piattaforma<br />
RADARSAT finalizzato all’integrazione delle<br />
conoscenze disponibili, il Servizio geologico<br />
ha messo a disposizione sul Geoportale<br />
cartografico regionale (http://geoportale.<br />
partout.it/) i dati satellitari grezzi, non<br />
interpretati, al fine di agevolare i professionisti<br />
nelle proprie attività di <strong>pianificazione</strong> del<br />
territorio. Gli stessi dati saranno messi a<br />
disposizione sul Geoportale di Risknat.<br />
Inoltre verrà valutata la possibilità di<br />
definire apposite procedure per l’uso dei<br />
PS ai fini di <strong>pianificazione</strong> territoriale. A tal<br />
proposito, si ritiene utile evidenziare come<br />
l’attuale normativa regionale in materia di<br />
urbanistica e <strong>pianificazione</strong> territoriale (L.R. n.<br />
11/1998 e s.m.i.) non preveda il ricorso all’uso<br />
esclusivo dell’interferometria <strong>satellitare</strong> per la<br />
definizione delle diverse classi di pericolosità<br />
per terreni sedi di frane (zone ad alta, media<br />
e bassa pericolosità). I dati PSInSAR TM o<br />
SqueeSAR TM ad oggi sono impiegati come<br />
elemento di supporto alle consuete indagini<br />
di foto interpretazione e di rilevamento<br />
geologico, escludendo pertanto l’impiego<br />
dei dati radar come unico strumento volto<br />
ad accertare l’esistenza o meno di fenomeni<br />
franosi e della relativa pericolosità sulla scorta<br />
delle velocità di spostamento individuate.
6.4 Problematiche riscontrate<br />
In estrema sintesi, quindi, le problematiche<br />
riportate negli esempi suesposti circa la<br />
traduzione pratica delle indicazioni desunte<br />
dai dati PSInSAR negli strumenti di<br />
<strong>pianificazione</strong> territoriale possono essere così<br />
sintetizzate:<br />
a. Disomogeneità della distribuzione dei<br />
bersagli sulle aree in frana e conseguente<br />
presenza di settori “bui” dove, in assenza<br />
di altre misurazioni, le interpretazioni<br />
sullo stato di attività potranno derivare<br />
esclusivamente da valutazioni qualitative<br />
sull’assetto geomorfologico e sullo stato<br />
dei manufatti eventualmente presenti;<br />
b. Discontinuità della copertura temporale<br />
dei dataset di immagini radar che,<br />
sfortunatamente, sono incompleti proprio<br />
per annate fortemente critiche per gli<br />
eventi meteorici che si sono registrati<br />
(1994, 2000-2002);<br />
c. Difficoltà nel giustificare la presenza di<br />
aree anomale molto significative per<br />
omogeneità, numero di bersagli e velocità<br />
medie nelle aree dove gli strumenti di<br />
<strong>pianificazione</strong> non rilevano l’esistenza di<br />
frane e non si rilevino riscontri fisici evidenti<br />
di dissesti sul terreno e sui manufatti;<br />
d. Difficoltà interpretative dei dati nel caso di<br />
frane con potenziali significativi movimenti<br />
a componente orizzontale in direzione<br />
N-S, ove non si disponga del supporto di<br />
monitoraggi con altre tecniche e il quadro<br />
delle lesioni ai manufatti sia poco uniforme;<br />
e. Difficoltà nell’uniformare il flusso<br />
interpretativo delle evidenze desunte<br />
dai dati PSInSAR TM nelle 3 classi di stato<br />
di attività delle frane che determinano<br />
il quadro della pericolosità dei piani di<br />
bacino;<br />
f. Indisponibilità di dati aggiornati per le<br />
annualità più recenti.<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Nei seguenti capoversi le questioni<br />
sintetizzate nell’elenco verranno affrontate<br />
più in dettaglio.<br />
- Punti a e b - Per quanto attiene questi aspetti,<br />
non c’è molto da aggiungere. La questione<br />
della disomogeneità di distribuzione dei<br />
bersagli è solo parzialmente attenuata<br />
dall’introduzione del nuovo algoritmo<br />
SqueeSAR, che consente di avere qualche<br />
informazione in più, almeno sulle aree<br />
coltivate o prative, ma nulla può per le aree<br />
boscate, che nell’area appenninica sono le<br />
più diffuse. I “buchi” di copertura temporale<br />
derivanti dalla sovrapposizione dei dataset<br />
ERS, Envisat e Radarsat sono, ovviamente,<br />
incolmabili.<br />
- Punti c, d ed e – relativamente a queste<br />
problematiche è importante cercare<br />
quanto prima di fornire risposte adeguate.<br />
Innanzitutto, è necessario osservare come<br />
tutte e tre siano originate dal complesso<br />
rapporto fra questioni estremamente<br />
tecniche, quali la definizione dei modelli<br />
geologici tridimensionali di fenomeni che si<br />
sviluppano nel sottosuolo, dei quali per lo<br />
più si ha solo una conoscenza di superficie,<br />
e aspetti di carattere essenzialmente<br />
normativo legati alla <strong>pianificazione</strong> di<br />
bacino stralcio per il rischio idrogeologico.<br />
A questo proposito è necessaria una<br />
digressione che esce un po’ dall’alveo degli<br />
argomenti di stretta attinenza del presente<br />
volume, funzionale a illustrare alcune<br />
problematiche di carattere prettamente<br />
gestionale che si stanno riscontrando <strong>nella</strong><br />
applicazione sul territorio delle disposizioni<br />
dei piani di bacino, nelle quali l’avvento<br />
dei dati PSInSAR determina un impatto<br />
rilevante.<br />
- Punto f - Infine, per quanto riguarda il<br />
punto 6 dell’elenco, l’attuale incertezza<br />
circa la possibilità di garantire un costante<br />
aggiornamento dei dati e l’omogeneità<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
135
136<br />
della loro distribuzione sul territorio, a causa<br />
anche delle problematiche di carattere<br />
economico che si fanno di anno in anno<br />
più stringenti, impone serie riflessioni circa<br />
l’opportunità di introdurre questo strumento<br />
come base necessaria per la formazione di<br />
tematismi quali le carte geomorfologiche<br />
o di franosità reale, piuttosto che della<br />
subsidenza, nell’ambito di strumenti di<br />
<strong>pianificazione</strong> di nuova redazione. Come<br />
si potrebbe, infatti, imporre di valutare lo<br />
stato di attività delle frane su una porzione<br />
di territorio in base anche ai dati PSInSAR,<br />
consci del fatto che per la stragrande<br />
maggioranza dei fenomeni gravitativi tali<br />
dati sono gli unici disponibili di carattere<br />
quantitativo, ma si riferiscono ad una fase<br />
temporale che si interrompe 5 o 10 anni fa?<br />
Appare lampante, infatti, che, nei casi di<br />
frane che interessino aree sulle quali vi<br />
siano forti interessi urbanistici, eventuali dati<br />
interferometrici non aggiornati potrebbero<br />
essere strumentalizzati, a seconda dei casi,<br />
sia da chi vuole costruire sia da coloro i<br />
quali vogliono impedire che si costruisca.<br />
Per non parlare, poi, delle questioni correlate<br />
alla valutazione economica degli immobili<br />
preesistenti.
APPROFONDIMENTO<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
L’impatto dei dati di interferometria <strong>satellitare</strong> sulla normativa dei piani<br />
di bacino stralcio rischio idrogeologico<br />
All’allungarsi del periodo di ordinaria gestione del territorio a valle dell’approvazione<br />
dei piani di bacino stralcio per il rischio idrogeologico, le Autorità di Bacino hanno visto<br />
progressivamente ma inesorabilmente aumentare le pressioni dall’esterno per riconsiderare<br />
le normative vincolistiche che gravano sulle aree ad alta e molto alta suscettività. Gli<br />
aspetti che fin da subito hanno suscitato i maggiori dibattiti sono stati, almeno in Liguria,<br />
quelli relativi alla pericolosità idraulica e, quindi, ai regimi normativi associati alle fasce<br />
esondabili, poiché le aree perifluviali, essendo spesso pianeggianti, sono connotate da<br />
un’elevata propensione all’urbanizzazione. Tali problematiche sono state affrontate da<br />
alcune Autorità di Bacino, quali, ad esempio, quella ligure e quella interregionale del<br />
Fiume Magra, adottando criteri che consentono l’approfondimento degli studi idraulici<br />
al fine di definire, nell’ambito degli areali interessati da fasce esondabili per i tempi di<br />
ritorno più ravvicinati, settori a maggiore e minore pericolosità, in funzione dei tiranti<br />
idrici e delle velocità della corrente (per l’AdB Regionale della Liguria DGR 250/05, DGR<br />
1532/05, per l’AdB del Fiume Magra l’Art. 19 delle NTA ed il relativo All. 8). A tali ambiti<br />
sono stati, quindi, associati regimi normativi maggiormente modulati.<br />
Con l’andar del tempo, analoghe problematiche hanno cominciato a farsi via via più<br />
pressanti anche per i contesti di versante connotati da alta o molto alta pericolosità<br />
per frana. Il parallelo con la soluzione intrapresa per le questioni inerenti la pericolosità<br />
idraulica, a questo punto, è stato automatico. Altrettanto automaticamente, peraltro,<br />
i tecnici del settore hanno sollevato numerosi distinguo: mentre per eseguire un<br />
approfondimento di uno studio idraulico è sufficiente disporre di un rilievo topografico<br />
adeguato, con costi relativamente bassi e tempi di realizzazione contenuti, per una frana<br />
occorrono indagini geognostiche dirette e indirette e, soprattutto, un monitoraggio degli<br />
spostamenti, con costi elevati e tempi lunghi. In più, se uno studio idraulico attento,<br />
a meno di imprevisti ben noti legati ad un trasporto solido anomalo o a ostruzioni di<br />
attraversamenti causati da carichi flottanti inattesi, consente di stimare con un certo<br />
margine di affidabilità l’andamento delle piene al variare dei contributi pluviometrici,<br />
non esistono analoghe certezze in merito all’uniformità del regime cinematico di un<br />
fenomeno franoso nel tempo, neppure a valle di un approfondito monitoraggio delle<br />
deformazioni. Ciò perchè ogni fenomeno franoso ha caratteristiche geomorfologiche,<br />
geotecnico-geomeccaniche ed idrogeologiche a sé stanti ed è inserito in un contesto<br />
territoriale sempre diverso, da un punto di vista climatico, orografico e di uso del suolo. In<br />
definitiva, mentre la pericolosità idraulica risulta più o meno affidabilmente modellizzabile<br />
in quanto le piene sono fenomeni prodotti dalla somma dei contributi provenienti da un<br />
intero bacino idrografico, e, pertanto, eventuali anomalie locali sono tanto più mitigate<br />
quanto più è vasto il bacino sotteso, la pericolosità per frana è frutto delle sole situazioni<br />
locali di ogni singolo fenomeno franoso, che difficilmente possono essere modellizzate e<br />
non possono giammai essere generalizzate.<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
137
138<br />
Pur con tutte le summenzionate premesse, si deve, tuttavia, rilevare che, <strong>nella</strong><br />
<strong>pianificazione</strong> di bacino, la scelta di classificare le frane in base allo stato di attività <strong>nella</strong><br />
carta geomorfologica, e, quindi, da questa derivare la suscettività al dissesto, alla quale<br />
sono associati i regimi normativi, fa sì che, alle voci “frana attiva” e “frana quiescente”,<br />
siano associati fenomeni fra loro fortemente diversificati: dal piccolo crollo in roccia,<br />
debris flow o soil slip di poche migliaia di metri cubi alla grande frana complessa che si<br />
estende per decine di ettari. Conseguentemente, essendo i regimi normativi di piano<br />
associati al grado di suscettività al dissesto, che per le frane discende dallo stato di<br />
attività, indipendentemente dalla loro tipologia cinematica, si verifica che le poche<br />
decine di metri quadri del debris flow e le decine di ettari della grande frana complessa<br />
hanno assunto i medesimi vincoli d’uso. Se tale approccio è, in prima battuta, corretto e<br />
giustificato dal fatto che i piani di bacino derivano da studi di area vasta che, in quanto<br />
tali, hanno comportato necessariamente rilievi speditivi, considerati i vincoli stringenti<br />
che sono applicati agli elaborati da essi derivati, alla lunga distanza, appare opportuno<br />
affrontare la tematica della sua revisione e aggiornamento.<br />
Da qui, il grave disagio che da alcuni anni avvertono i tecnici delle Autorità di Bacino nel<br />
dover fronteggiare sindaci e cittadini con esigenze urbanistiche o aspettative economiche<br />
frustrate da un vincolo di inedificabilità assoluto, apposto talvolta su vasti areali classificati<br />
in frana attiva o quiescente, ma associabili a cinematismi lenti o estremamente lenti e tali<br />
da non lasciar presupporre tassi di spostamento più elevati di pochi millimetri annui, né<br />
improvvise accelerazioni complessive, per lo meno per vaste porzioni dell’accumulo.<br />
Tale problematica è stata in qualche modo affrontata da alcune Autorità di Bacino già in<br />
fase di redazione della normativa da associare alle diverse classi di suscettività al dissesto,<br />
come nel caso del Fiume Magra e del Po. Nel primo caso, infatti, sebbene il vincolo di<br />
inedificabilità assoluto sia confermato per le aree in frana attiva, le norme associate<br />
alle frane quiescenti prevedono anche la possibilità di realizzare interventi di nuova<br />
edificazione, purché in ambiti di tessuto urbano consolidato e a condizione che siano<br />
supportati da progetti, da sottoporre a parere obbligatorio e vincolante del Comitato<br />
Tecnico dell’Autorità di Bacino, che dimostrino la compatibilità delle opere in progetto<br />
con l’assetto del versante, anche in base a indagini adeguatamente approfondite.<br />
Nel caso dell’AdB del Fiume Po, invece, la norma rimanda parte del problema agli<br />
strumenti urbanistici comunali. Anche qui le frane attive sono associate al vincolo di<br />
inedificabilità assoluta e, addirittura, non è consentita la manutenzione straordinaria<br />
per gli edifici esistenti. Si lascia aperta, di contro, la possibilità di realizzare nuove<br />
costruzioni anche su aree in frana quiescente, demandando interamente alla fase di<br />
verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PAI la valutazione<br />
dell’opportunità di consentire tale fattispecie urbanistica. A questo proposito la Regione<br />
Liguria si è dotata di una propria direttiva, con DGR 1182/02, finalizzata alla definizione<br />
delle procedure e dei contenuti delle verifiche di compatibilità, delimitando in maniera<br />
piuttosto stringente la possibilità di arrivare a consentire la nuova costruzione in aree<br />
di frana quiescente e aprendo alla possibilità di autorizzare quantomeno gli interventi
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
di manutenzione straordinaria anche sulle frane attive classificate “a cinematica lenta” a<br />
seguito dell’iter di verifica di compatibilità. A proposito della normativa inerente le aree<br />
in frana in ambito padano, è opportuno, inoltre, richiamare che il PAI prevede anche la<br />
fattispecie delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, di cui all’art. 49 delle NTA. A<br />
tali aree, che corrispondono di fatto ad un sottoinsieme di frane attive che interessano<br />
centri abitati, vengono associati vincoli leggermente diversi e meno pesanti rispetto a<br />
quelli relativi alle aree in frana tout court, modulati in funzione del rischio potenziale<br />
associato alle diverse aree a rischio o a loro porzioni.<br />
Per quanto attiene, infine l’Autorità di Bacino regionale della Liguria, di fatto, ad oggi le<br />
norme di piano sono rigidamente legate alla classificazione di stato di attività delle frane<br />
e, peraltro, anche i vincoli che insistono sulle frane, sia attive sia quiescenti, risultano<br />
essere piuttosto severi. Pertanto, il problema del raffinamento del regime di vincolo in<br />
funzione della cinematica del dissesto resta critico. La Regione ha, tuttavia, avviato, alcuni<br />
anni or sono, un percorso di avvicinamento a questa problematica, finanziando studi<br />
specifici i cui esiti vengono discussi diffusamente in seguito.<br />
Per tutte e tre le Autorità di Bacino, infine, le frane stabilizzate non sono associate ad<br />
alcuna particolare restrizione d’uso, demandandone la disciplina agli strumenti urbanistici<br />
comunali.<br />
In conclusione, quindi, l’attuale disciplina normativa associata agli areali in frana, pur<br />
con tutte le differenze sopra sottolineate, è impostata in maniera tale per cui l’unica<br />
strada possibile per attenuare il regime di vincolo vigente consiste <strong>nella</strong> revisione della<br />
classificazione dello stato di attività, a prescindere da qualsiasi considerazione circa le<br />
caratteristiche geomorfologiche e cinematiche caso per caso rilevate. Se, tuttavia, la<br />
classificazione di una frana come attiva o inattiva può essere resa oggettiva tramite<br />
l’acquisizione di misure di spostamento (pur se con il margine di dubbio legato alla<br />
presenza di fenomeni sospesi che, dopo una fase più o meno lunga di inattività, si reinnescano),<br />
molto più soggettiva e non standardizzabile risulta essere la classificazione<br />
di una frana inattiva allo stato di attività “quiescente” piuttosto che “stabilizzata”, e,<br />
conseguentemente, l’attribuzione di un regime di vincolo molto severo piuttosto che di<br />
nessuna restrizione.<br />
In questo contesto normativo piuttosto articolato e non privo di criticità, l’avvento dei<br />
dati di interferometria <strong>satellitare</strong>, in taluni casi, non ha fatto che ampliare ulteriormente<br />
le problematiche. Se in precedenza misure quantitative di deformazione erano disponibili<br />
solo su un limitatissimo numero di frane, peraltro generalmente ben conosciute e<br />
universalmente note per essere fenomeni attivi, improvvisamente ci si trova a disporre di<br />
informazioni quantitative di elevata precisione su vasta parte del territorio; e non sempre<br />
tali informazioni coincidono con il quadro dei dissesti delineato dalla <strong>pianificazione</strong> di<br />
bacino o proposto dagli amministratori locali. Da qui la necessità di dotarsi di specifiche<br />
linee guida che definiscano più precisamente possibile i confini di utilizzo dei dati PS<br />
nell’ambito della <strong>pianificazione</strong> territoriale, con particolare riferimento all’analisi dei<br />
fenomeni franosi.<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
139
140<br />
6.5 Linee guida esistenti<br />
Nell’ambito delle attività relative al Piano<br />
Straordinario di Telerilevamento Ambientale<br />
(PST-A, cap. 3-2), coordinato dalla Direzione<br />
Generale per la Difesa del Suolo del<br />
Ministero dell’Ambiente, in collaborazione<br />
con il Dipartimento di Scienze della Terra<br />
dell’Università di Firenze, sono state<br />
redatte le linee guida per l’analisi di dati<br />
interferometrici satellitari in aree soggette a<br />
dissesti idrogeologici (link web: http://www.<br />
pcn.minambiente.it).<br />
Questo elaborato fornisce numerosi<br />
interessanti indicazioni relativamente al<br />
corretto utilizzo dei dati PS nell’ambito<br />
dell’analisi dei fenomeni franosi, sia per le<br />
finalità di revisione delle perimetrazioni sia per<br />
la definizione delle velocità rappresentative e,<br />
quindi, per la definizione dello stato d’attività.<br />
Per quest’ultima finalità viene proposta una<br />
matrice di incrocio fra le velocità medie annue<br />
di spostamento derivanti da dati ERS (1990<br />
– 2000) ed Envisat (2003 – 2010) attraverso<br />
la quale valutare l’attività o l’inattività del<br />
fenomeno ed una scala per la valutazione<br />
della scala di intensità dei fenomeni.<br />
Nella matrice viene proposta la soglia dei 2<br />
mm a -1 per discriminare la presenza o assenza<br />
di movimento, mentre per la definizione<br />
della scala di intensità viene introdotta una<br />
ulteriore soglia a 10 mm a -1 per distinguere<br />
i movimenti estremamente lenti dai molto<br />
lenti. Quest’ultima soglia differisce da quella<br />
di 16 mm a -1 individuata da Cruden & Varnes<br />
(1994) in quanto, ragionando in termini di<br />
VLOS, si presume che i tassi di spostamento<br />
registrati dai PS siano comunque sempre<br />
mediamente inferiori a quelli reali, come,<br />
peraltro, confermato e quantificato da Notti et<br />
al. (2010). Occorre, infine, sottolineare che nel<br />
testo viene affermato che questo approccio<br />
è da intendersi come una valutazione<br />
preliminare che deve poi essere corroborata<br />
da indagini geomorfologiche specifiche e dati<br />
di monitoraggio in situ.<br />
Per parte sua, la Regione Liguria, presa<br />
coscienza della necessità di definire criteri<br />
standard per la riclassificazione dello stato<br />
di attività delle frane e valutare la possibilità<br />
di una miglior modulazione della normativa<br />
associata alla pericolosità, nel 2007 ha attivato<br />
una convenzione con il Dipartimento di<br />
Scienze della Terra dell’Università di Firenze,<br />
Centro di Competenza del Dipartimento di<br />
Protezione Civile, dal titolo “Definizione di<br />
linee guida di approfondimento sulle frane<br />
per la riperimetrazione e la zonazione di areali
a differente grado di pericolosità”. L’ambizioso<br />
obbiettivo di tale iniziativa era proprio quello<br />
di individuare indirizzi procedurali quanto più<br />
possibile standardizzati sia per le istanze di<br />
revisione dei perimetri delle frane individuate<br />
negli strumenti di <strong>pianificazione</strong> di bacino<br />
sia per quelle di riclassificazione dello stato<br />
di attività di interi accumuli gravitativi o di<br />
loro porzioni significative. Il perseguimento di<br />
questo obbiettivo è stato supportato tramite<br />
l’allestimento di due casi studio sul territorio<br />
regionale che sono andati ad integrare<br />
la già vasta esperienza su scala nazionale<br />
del gruppo di ricerca dell’Università. La<br />
convenzione, chiusasi nel 2009, ha consentito<br />
di individuare le procedure richieste, che<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
sono state successivamente formalizzate<br />
con la DGR 265/2010, recante “Criteri per la<br />
definizione di classi di pericolosità relativa in<br />
aree a suscettività al dissesto elevata e molto<br />
elevata per frana a cinematica ridotta (…)”.<br />
Per ovvi motivi di sintesi non vengono qui<br />
riportati i dettagli dell’allegato tecnico della<br />
deliberazione (reperibile al link web www.<br />
ambienteinliguria.it alla pagina dell’autorità di<br />
bacino di rilievo regionale). Per le finalità del<br />
volume è sufficiente riportare che, in analogia<br />
a quanto proposto in ambito nazionale per<br />
il PST-A, viene proposta la classificazione<br />
dello stato di attività delle frane in quattro<br />
classi in funzione di una matrice che riporta<br />
in ascissa la velocità media annua in mm a-1<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
141
142<br />
mediata sugli ultimi 10 anni ed in ordinata lo<br />
stesso parametro mediato, però, sugli ultimi<br />
3 anni. L’utilizzo della matrice è chiaramente<br />
possibile esclusivamente in presenza di dati<br />
di monitoraggio geotecnico e <strong>satellitare</strong> con<br />
tecnica PSInSAR TM . I primi devono essere<br />
acquisiti almeno per le 3 annualità più<br />
recenti, mentre i secondi non sono del tutto<br />
indispensabili. La matrice, di seguito riportata<br />
in figura, infatti, viene proposta in due diverse<br />
forme, la seconda delle quali tiene conto<br />
della possibile indisponibilità di informazioni<br />
di interferometria <strong>satellitare</strong>. Le soglie di<br />
velocità introdotte riprendono, di fatto, quelle<br />
già proposte nelle linee guida predisposte<br />
nell’ambito del PST-A, con la variante della<br />
soglia superiore, qui fissata da Regione Liguria<br />
a 16 mm a -1 .*<br />
Per completezza, appare opportuno<br />
richiamare che nel testo dei criteri deliberati<br />
vengono indicate alcune importanti cautele<br />
da applicare nell’utilizzo dei dati PSInSAR,<br />
che si riportano in forma letterale:<br />
- I dati desunti dalla tecnica PSInSAR<br />
-<br />
possono essere ritenuti significativi per le<br />
prescritte finalità solo se all’interno del corpo<br />
geomorfologico esaminato ricadono almeno<br />
5 PS distanziati fra loro non più di 100 metri;<br />
la velocità di spostamento medio annua<br />
associata ai target radar si riferisce alla<br />
congiungente sensore-bersaglio, e presenta,<br />
pertanto, una forte componente verticale; ciò<br />
implica che i movimenti a prevalente carattere<br />
orizzontale<br />
sottostimati;<br />
possono essere fortemente<br />
- la risoluzione planimetrica del dato PS non<br />
consente una precisa individuazione del<br />
riflettore, pertanto può accadere che PS<br />
ubicati in corrispondenza di fabbricati siano,<br />
in realtà, associati a manufatti od oggetti<br />
presenti nel loro immediato intorno, non<br />
particolarmente idonei per caratteristiche<br />
strutturali a fornire indicazioni circa la<br />
stabilità di un comparto territoriale (Es.:<br />
-<br />
manufatti pertinenziali di abitazioni edificati<br />
in maniera approssimativa, baracche in<br />
lamiera, guard-rail, ricoveri attrezzi, tettoie,<br />
massi disarticolati, ecc.);<br />
tutti i satelliti dotati di sistemi SAR percorrono<br />
orbite grossomodo dirette N-S ed i sensori<br />
acquisiscono con geometria obliqua. Tali<br />
caratteristiche orbitali fanno sì che le<br />
deformazioni che vengono meglio rilevate,<br />
oltre che nel piano verticale, avvengono<br />
anche in quello orizzontale purché abbiano<br />
direzione grossomodo E-O;<br />
Tali cautele riassumono, in maniera<br />
estremamente sintetica, tutte le problematiche<br />
di interpretazione dei dati satellitari più<br />
diffusamente descritte in questo volume.<br />
Per scelta, inoltre, non vengono menzionate<br />
le operazioni di post-processing dei dati PS,<br />
quali la scomposizione del moto in presenza<br />
di dati sia ascendenti sia discendenti e<br />
la proiezione della V lungo la massima<br />
LOS<br />
pendenza del versante, in quanto, come già<br />
diffusamente esplicitato, tali analisi possono<br />
risultare efficaci e opportune solo in talune<br />
situazioni, mentre, in altri casi, possono<br />
generare risultati fuorvianti.<br />
Confrontando le metodologie proposte dal<br />
Ministero dell’Ambiente e da Regione Liguria,<br />
la più significativa differenza fra le due matrici<br />
consiste nel fatto che, mentre quella riportata<br />
nell’ambito del PST-A è basata esclusivamente<br />
su dati di carattere interferometrico, quella di<br />
Regione Liguria mette a sistema i dati radar<br />
satellitari con quelli derivanti da sistemi di<br />
monitoraggio “tradizionali”. I differenti valori<br />
della seconda soglia di velocità dipendono<br />
anche da valutazioni di merito effettuate<br />
sulla base della banca dati dei monitoraggi<br />
dei versanti.<br />
Viene proposto di seguito un esempio di<br />
applicazione della procedura di cui alla citata<br />
DGR 265/10, tuttora in fase di elaborazione,<br />
relativa al caso di loc. Ville S. Pietro in Comune<br />
di Borgomaro (IM).<br />
* Per correttezza, va detto che il report finale della menzionata convenzione fra Regione Liguria e Università di Firenze<br />
riportava la matrice con soglia superiore a 10 mm a-1 , come per il PST-A. La scelta operata dalla Regione di riportare tale<br />
valore a 16 mm a-1 è stata dettata da valutazioni derivanti dall’esperienza diretta maturata nell’analisi di fenomeni gravitativi<br />
sul territorio regionale.
La frazione di Ville S. Pietro, in Comune<br />
di Borgomaro (IM), è ubicata in parte sulla<br />
testata di un vasto corpo di accumulo di<br />
una grande frana complessa relitta in parte<br />
riattivata. Tale dissesto geomorfologico si<br />
è impostato su un versante esposto a NE<br />
caratterizzato da un substrato flyschoide di<br />
natura prevalentemente calcareo-marnosa che<br />
in quest’areale assume un assetto prevalente<br />
a franapoggio inclinato grossomodo quanto il<br />
pendio (Figura 6-12).<br />
Il piano di bacino del T. Impero inquadra<br />
questo areale in frana quiescente con una<br />
porzione attiva proprio <strong>nella</strong> parte di testata,<br />
dove insistono gli insediamenti dei diversi<br />
rioni che, nell’insieme costituiscono l’abitato<br />
di Ville S. Pietro. Il Comune ha realizzato nel<br />
Settembre 2006 una campagna di indagini<br />
geognostiche costituita da 5 sondaggi<br />
a carotaggio continuo poi attrezzati con<br />
colonne inclinometriche, affiancati da<br />
perforazioni a distruzione di nucleo attrezzate<br />
con tubi piezometrici (Figura 6-13).<br />
Il monitoraggio inclinometrico si è, quindi,<br />
protratto da Novembre ’06 al Dicembre ’10<br />
ed ha consentito di registrare deformazioni in<br />
tutte le postazioni con tassi di spostamento<br />
compresi fra i 6 ed i 12 mm a -1 in testa-tubo<br />
(Figura 6-14).<br />
L’analisi dello stato di conservazione dei<br />
manufatti ha consentito di individuare<br />
come gli edifici maggiormente lesionati<br />
siano localizzati <strong>nella</strong> porzione centrale<br />
dell’accumulo, nell’intorno della Chiesa e in<br />
loc. Case Soprane, nonché <strong>nella</strong> parte più<br />
occidentale di loc. Marpero, sul fianco destro<br />
della frana (Figura 6-15).<br />
Le abitazioni sparse fra la Chiesa e loc.<br />
Costa, sul fianco sinistro della frana, appaiono,<br />
invece, in un migliore stato di conservazione,<br />
con lesioni assenti o lievi.<br />
I dati SqueeSAR Radarsat, con particolare<br />
riferimento a quelli in orbita ascendente,<br />
acquisiti per l’area evidenziano, per il periodo<br />
2003 – 2009, tassi di deformazione lungo<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
la LOS molto variabili e generalmente non<br />
superiori ai 5 mm a -1 , in molte aree anche più<br />
bassi e oscillanti attorno alla soglia dei 2 mm<br />
a -1 (Fig. 6-16).<br />
Un’analisi superficiale o inesperta del<br />
dato PS, quindi, evidenzierebbe, al più,<br />
un’incongruenza con i dati inclinometrici,<br />
trascurando la quale ed applicando<br />
pedissequamente la matrice di cui alla DGR<br />
265/10, la parte centrale della frana ricadrebbe<br />
<strong>nella</strong> categoria I 10 , fra le frane riattivate.<br />
Tuttavia, analizzando meglio il fenomeno, si<br />
osserva che l’esposizione media del versante,<br />
orientato mediamente a N-NE, coincide<br />
di fatto con la direzione azimutale dello<br />
spostamento registrato dagli inclinometri,<br />
compresa fra i 20° ed i 45°N, e che il modello<br />
cinematico del fenomeno, sebbene denoti una<br />
componente di scorrimento rotazionale <strong>nella</strong><br />
parte alta, per il resto può essere assimilato<br />
ad uno scivolamento planare. Ciò implica che<br />
i PS registrano solo una frazione modesta<br />
della deformazione reale (presumibilmente<br />
fra il 50 ed il 60% per i bersagli in orbita<br />
ascendente) e che l’operazione di calcolo<br />
della V LOS proiettata lungo la retta di massima<br />
pendenza del versante (V slope ) può essere<br />
considerata in linea di massima realistica e<br />
affidabile (figura 6-14). Infatti, i valori di V slope<br />
appaiono decisamente più vicini a quelli<br />
registrati dagli inclinometri rispetto alle V LOS<br />
(Figura 6-17).*<br />
A questo punto, applicando la matrice di<br />
cui sopra, si evidenzia come la porzione<br />
centrale della ricada <strong>nella</strong> categoria I 11 , fra<br />
le frane attive continue. Solo la parte più<br />
occidentale dell’accumulo sembrerebbe poter<br />
essere inquadrata in una delle sottocategorie<br />
di frane inattive, anche se la distribuzione<br />
delle postazioni inclinometriche, concentrata<br />
<strong>nella</strong> parte centro-orientale dell’accumulo,<br />
non consente di avere osservazioni dirette<br />
specifiche per questo settore e, pertanto,<br />
rende meno affidabile la procedura di<br />
applicazione della matrice.<br />
* Va, tuttavia, sottolineato che, ove la direzione azimutale dello spostamento di una frana si avvicini molto alla N-S e la<br />
componente di movimento orizzontale sia prevalente rispetto alla verticale, la frazione di deformazione registrata lungo la<br />
LOS sarà talmente bassa e, quindi, influenzata dai limiti di accuratezza della tecnica, che eventuali operazioni di proiezione<br />
lungo la massima pendenza introdurranno necessariamente amplificazioni del margine di incertezza del dato tali da<br />
renderlo inutilizzabile.<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
143
144<br />
Figura 6-12 – Carta geologico-geomorfologica di dettaglio dell’area di Ville S. Pietro (Enotarpi, 2011)
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Figura 6-13 – Stralcio della carta di suscettività al dissesto del PdB del T. Impero e localizzazione degli strumenti di<br />
monitoraggio (Enotarpi, 2011).<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
145
146<br />
Figura 6-14 – Risultati del monitoraggio inclinometrico e ricostruzione della superficie di scorrimento (Enotarpi, 2011).
Figura 6-15 – Rilievo dello stato di conservazione dei manufatti (Enotarpi, 2011).<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
147
148<br />
Fig. 6-16 – Distribuzione dei bersagli in orbita ascendente classificati in base alle V LOS<br />
Figura 6-17 - Interpolazione del dato PS ascendente proiettato lungo la linea di massima pendenza e velocità degli<br />
inclinometri
6.6 Effetti delle deformazioni<br />
registrate con tecnica PSInSAR TM<br />
sui fabbricati<br />
Nella definizione dello stato di attività delle<br />
frane, tradizionalmente, ha sempre giocato<br />
un ruolo fondamentale l’analisi dello stato di<br />
conservazione dei manufatti.<br />
I fabbricati, infatti, sono sempre stati<br />
considerati marker rigidi molto efficaci ed<br />
affidabili nell’evidenziare gli spostamenti del<br />
terreno Nell’ambito del Progetto Risknat, in<br />
analogia a quanto già realizzato in precedenza,<br />
Regione Liguria ha commissionato al DICAT<br />
dell’Università di Genova un’attività di<br />
indagine allo scopo di analizzare le relazioni<br />
fra i dati di spostamento registrati con tecnica<br />
PSInSAR TM e le condizioni di danno rilevate a<br />
carico dei manufatti bersaglio, tenuto conto<br />
anche delle caratteristiche strutturali e di<br />
fondazione.<br />
Per gli obiettivi traguardati sono state<br />
Tabella 6-3. Elenco siti<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
selezionate le Aree Anomale più significative<br />
che interessano territori edificati. Più<br />
precisamente sono stati considerati i PS<br />
relativi ai siti indicati in Tabella 6-3.<br />
Per ogni target è stato effettuato un rilievo<br />
strutturale speditivo per interpretare il<br />
meccanismo che ha determinato le lesioni,<br />
valutando anche la presenza di evidenze di<br />
interventi di ristrutturazione o manutenzione<br />
che possano aver cancellato o alterato il<br />
quadro delle lesioni.<br />
Nell’analisi di strutture, spesso di non<br />
facile “lettura” per caratteristiche proprie<br />
dei manufatti, per il possibile difficile<br />
riconoscimento di un esplicito quadro<br />
fessurativo, nonché, sovente, per la carenza<br />
di informazioni di dettaglio, l’attività di<br />
rilevamento e la preparazione tecnica dei<br />
rilevatori rappresentano aspetti cruciali per<br />
la positiva creazione di una banca dati.<br />
Analoghe considerazioni valgono in relazione<br />
iD Sito Comune note numero PS<br />
1 Acquetico Pieve di Teco Sito SCAI 9<br />
2 Diano Arentino Diano Arentino Sito SCAI 61<br />
3 Mendatica Mendatica Sito SCAI 87<br />
4 Monesi Triora Sito SCAI 9<br />
5 Quartarole Borghetto d'Arroscia Sito SCAI 19<br />
6 San Romolo-Borello Sanremo Sito SCAI 15<br />
7 Ville San Pietro Borgomaro Sito SCAI 23<br />
8 Olivetta San Michele Olivetta San Michele Frana IFFI 11<br />
9<br />
Valcona Soprana<br />
e Sottana<br />
Mendatica 26<br />
10 Ottano Pornassio Frana IFFI 76<br />
11 Castellaro Taggia/Castellaro 105<br />
12 Ventimiglia Alta Ventimiglia Sito SCAI 2<br />
13 Ceriana Ceriana Sito SCAI 18<br />
14 Baiardo Baiardo Sito SCAI 49<br />
15 Duranti Stellanello SV Frana IFFI 5<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
149
150<br />
allo studio dell’interazione tra terreno e<br />
struttura. Ovviamente l’affidabilità del<br />
risultato finale di una campagna di rilievo è<br />
anche intrinsecamente connesso alla qualità<br />
dei dati di partenza.<br />
Il censimento è avvenuto sulla base di un<br />
apposito data-base, utilizzando una procedura<br />
di rilevamento interamente informatizzata,<br />
appositamente strutturata nell’ambito di<br />
<strong>RiskNat</strong>.<br />
Per ogni singolo bersaglio è stata compilata<br />
una scheda (Appendice C) che contempla le<br />
seguenti voci:<br />
Indicazioni geografiche:<br />
comprendono informazioni precise<br />
sull’indirizzo del civico e, ove disponibile,<br />
sul mappale catastale del fabbricato (da<br />
compilarsi a tavolino); viene indicato anche<br />
il codice della Scheda di sintesi in modo da<br />
mantenere una correlazione fra le due entità<br />
ed il codice del PS;<br />
Descrizione del manufatto:<br />
in questa parte sono inserite le informazioni<br />
relative alla tipologia del manufattobersaglio<br />
(abitazione, annesso rustico, ecc.),<br />
le caratteristiche geometriche e strutturali<br />
(numero di piani fuori terra e interrati,<br />
stato di conservazione e utilizzo, epoca di<br />
costruzione, tipologia fondazionale) e gli<br />
eventuali interventi subiti dallo stesso dopo la<br />
sua costruzione (ampliamenti, ristrutturazioni,<br />
ecc.),<br />
Descrizione del quadro lesionativo:<br />
vengono inserite alcune indicazioni<br />
di massima relativamente al livello di<br />
danneggiamento della struttura, alla<br />
diffusione delle lesioni sui diversi prospetti ed<br />
alla tipologia del meccanismo di danno che<br />
può essere associato al quadro fessurativo<br />
rilevato; le schede relative ai bersagli<br />
maggiormente significative vengono, inoltre,<br />
corredate con uno schizzo a filo di ferro,<br />
non necessariamente in scala, in cui sono<br />
riportate l’andamento delle fessurazioni<br />
rispetto al rilievo (in particolare alla posizione<br />
delle aperture) e le indicazioni relative alle<br />
caratteristiche delle lesioni (passanti, più<br />
aperte verso il basso o verso l’alto, ecc.); viene,<br />
inoltre, valutato se siano presenti cedimenti<br />
sulle strutture pertinenziali (fasce terrazzate,<br />
piazzali, scale o marciapiedi, terrapieni, corpi<br />
adiacenti ) circostanti il manufatto-bersaglio<br />
in un intorno tale (circa 10 m dall’ubicazione<br />
del PS in carta) da poter ipotizzare che il<br />
bersaglio radar possa essere associato a tali<br />
strutture.<br />
Analogamente ai gradi presenti nelle scale<br />
macrosismiche europee EMS98 ed utilizzati<br />
nei metodi di rilievo di vulnerabilità di I livello<br />
per gli edifici ordinari (0-danno nullo; 1-danno<br />
lieve; 2-danno moderato; 3-danno grave;<br />
4-danno molto grave; 5-crollo), per quanto<br />
riguarda il giudizio dell’entità del danno, esso<br />
è stato graduato su 5 livelli:<br />
a. il danno NULLO (D0) rappresenta l’assenza<br />
di danno;<br />
b. il danno LIEVE (D1) rappresenta la prima<br />
evidenza di dissesti connessi all’iniziale<br />
attivazione di meccanismi visibili ad<br />
una osservazione accurata, di limitata<br />
estensione;<br />
c. il danno MODERATO (D2) rappresenta<br />
l’evidenza di dissesti e leggibilità<br />
complessiva di meccanismi attivati<br />
nell’insieme del manufatto, ma in fase<br />
iniziale di sviluppo, con dissesti di limitata<br />
entità;<br />
d. il danno GRAVE (D3) rappresenta la<br />
marcata evidenza di dissesti e leggibilità<br />
complessiva di meccanismi compiutamente<br />
attivati che interessano il manufatto in fase<br />
intermedia di sviluppo;<br />
e. il danno MOLTO GRAVE (D4) rappresenta<br />
l’evidenza macroscopica dei dissesti e dei<br />
meccanismi prossimi alla fase di ultimo<br />
spostamento con parti al limite del crollo,<br />
a seguito di dissesti complessivi di forte e<br />
fortissima entità;<br />
f. il CROLLO (D5) rappresenta il crollo<br />
prevalente del manufatto.<br />
g. La possibilità di potere graduare il proprio<br />
giudizio su 5 livelli diversi permette, infatti,<br />
di poter rilevare la gravità di uno stato<br />
fessurativo con maggior accuratezza, senza<br />
legarlo a misurazioni fisiche dell’apertura<br />
delle lesioni o della loro estensione. Un<br />
giudizio su più livelli consente di disporre
di dati più omogenei, in cui anche il<br />
possibile errore, legato all’inevitabile<br />
soggettività di giudizio, ha un peso minore<br />
sulla valutazione globale della gravità del<br />
danneggiamento dell’opera.<br />
Documentazione fotografica:<br />
acquisita con macchina fotografica dotata di<br />
GPS.<br />
Nella scheda per il censimento dei bersagli<br />
radar particolare enfasi viene data all’analisi<br />
della struttura ed al pertinente danno. A<br />
tale scopo e per maggior chiarezza vengono<br />
distinti ed opportunamente messi in evidenza:<br />
- parametri di esposizione;<br />
- parametri dimensionali;<br />
- parametri di vulnerabilità;<br />
- parametri di danno.<br />
L’ appendice C riporta il modello della<br />
scheda di rilevamento.<br />
La scheda di censimento è stata compilata<br />
per ogni PS individuato sul terreno, nei<br />
casi in cui tale bersaglio potesse essere<br />
ricondotto ad un manufatto chiaramente<br />
identificabile, significativo per le finalità dello<br />
studio. Vale la pena sottolineare come talvolta<br />
più PS fossero riconducibili alla medesima<br />
struttura. In questo caso una sola scheda è<br />
stata compilata, precisando però il codice<br />
identificativo di tutti i PS.<br />
Il bersaglio è stato considerato “non<br />
significativo” quando è risultato un manufatto<br />
non suscettibile di danni strutturali (Es.<br />
ricoveri in lamiera, terrapieni, affioramenti<br />
rocciosi, oggetti, ecc.).<br />
Quando possibile, i manufatti sono stati<br />
visionati dall’interno per una più approfondita<br />
comprensione degli elementi strutturali e<br />
dello stato di danno.<br />
Per meglio interpretare il grado di danno<br />
osservato (anche nullo) si sono riportate,<br />
nelle schede, indicazioni sulla eventuale<br />
manutenzione/ristrutturazione per identificare<br />
manufatti in uno stato di conservazione<br />
più che buono, sui quali eventuali danni<br />
subiti non sono più leggibili o, al contrario,<br />
si sono riproposti nonostante l’avvenuta<br />
ristrutturazione.<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
E’ ben noto come la definizione del danno<br />
subito da una struttura è operazione complessa<br />
e non univoca, in quanto trattasi di aspetto<br />
legato a molteplicità di fattori, dipendenti<br />
da tipologia strutturale, stato conservazione,<br />
destinazione d’uso, considerazioni<br />
economiche. Notevole importanza rivestono<br />
anche aspetti inerenti l’effetto tempo<br />
(sviluppo fenomeno deformativo) e “l’effetto<br />
età” (nuove ed antiche costruzioni, diverse<br />
tecnologie, diverse cause, ecc.).<br />
Dal quadro fessurativo si è anche cercato<br />
di desumere, per situazioni non suscettibili<br />
di dubbie interpretazioni (si consideri che<br />
frequentemente il censimento dei manufatti<br />
è stato possibile solo mediante sopralluogo<br />
esterno), direzione e verso di movimento,<br />
da mettere in relazione con il cinematismo<br />
atteso, particolarmente nelle area sedi di<br />
frane censite e perimetrate.<br />
Le principali criticità riscontrate nel<br />
censimento sono state:<br />
- mancanza di accessibilità al PS;<br />
- impossibilità<br />
dall’interno;<br />
di visionare il manufatto<br />
- difficoltà nel definire con esattezza alcuni<br />
dei parametri da indicare <strong>nella</strong> scheda,<br />
quali Stato di Utilizzo, N° di Unità d’Uso, Età;<br />
- difficoltà di conoscere nel dettaglio le<br />
caratteristiche dei manufatti (ad esempio le<br />
strutture orizzontali e le fondazioni);<br />
- difficoltà nel valutare lo stato di danno<br />
quando il manufatto era stato di recente<br />
ristrutturato oppure si trovava in uno<br />
stato di quasi abbandono da non riuscire<br />
a comprendere con chiarezza se le lesioni<br />
fossero da imputarsi a movimenti del<br />
suolo (a tal proposito si sottolinea come<br />
opportune voci indicate <strong>nella</strong> scheda di<br />
censimento permettano di evidenziare tali<br />
situazioni).<br />
Il data-base realizzato consta di circa 480<br />
schede relative a circa 550 PS, fornisce utili<br />
informazioni circa i bersagli radar nelle aree<br />
oggetto di studio e ha permesso un’opportuna<br />
interpretazione dei dati, come descritto nel<br />
seguito.<br />
In Tabella 6-4 sono riportate le caratteristiche<br />
dei siti investigati in termini di numerosità<br />
dei bersagli radar (PS) e dei campi di velocità<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
151
152<br />
media associati a ciascuno di essi. In tabella<br />
è, in particolare, evidenziato l’intervallo di<br />
velocità misurato lungo la congiungente<br />
satellite – riflettore, ovvero la linea di vista del<br />
satellite, nel periodo studiato.<br />
Le informazioni rilevate in sito tramite la<br />
scheda di rilievo, e archiviate in una banca<br />
dati cartografica, possono, quindi, essere<br />
associate alla mappa dei bersagli radar. Tale<br />
operazione, effettuata in ambiente GIS, ha<br />
permesso di ottenere una visualizzazione<br />
a livello territoriale dei dati rilevati e della<br />
correlazione spaziale tra danno e velocità.<br />
La corrispondenza con il dato di danno<br />
osservato è stata ricercata con riferimento<br />
non solo alla velocità misurata lungo la<br />
congiungente satellite – riflettore (V LOS ) ma<br />
anche alla velocità proiettata lungo il pendio<br />
(V SLOPE ). Le misure di spostamento rilevate<br />
dal satellite rappresentano, infatti, solo una<br />
componente del vettore di spostamento<br />
reale, la cui direzione può discostarsi anche<br />
notevolmente dalla linea di vista del satellite<br />
(vedi capitolo 2 e 4).<br />
La correlazione tra il danno e la velocità è stata<br />
Tabella 6-4. Elenco siti: numero di PS e campo di velocità.<br />
iD Sito Comune<br />
valutata considerando unicamente i bersagli<br />
ritenuti significativi anche con riferimento<br />
alle caratteristiche di conservazione del bene<br />
censito e alla tipologia di dissesto rilevata. In<br />
relazione alle caratteristiche di conservazione,<br />
si sottolinea come un recente intervento di<br />
ristrutturazione o al contrario un pessimo<br />
stato di conservazione possano portare ad una<br />
non corretta lettura del danno. Escludendo di<br />
conseguenza tali casistiche, il campione di<br />
PS utilizzato per lo studio della correlazione<br />
danno-velocità, è stato ridotto considerando<br />
unicamente i tipi di dissesto direttamente<br />
correlabili ad un problema di interazione<br />
terreno-struttura o ad un movimento di<br />
versante.<br />
Si riportano di seguito come esempio i rilievi<br />
e le analisi dei dati per tre casi (immagini<br />
Radarsat, periodo 2003 – 2009):<br />
Diano Arentino;<br />
Ville San Pietro, comune di Borgomaro;<br />
e per un caso relativo a immagini ERS<br />
(periodo 1992-2001):<br />
Lemeglio, comune di Moneglia.<br />
numero<br />
PS<br />
V loS min<br />
mm a -1<br />
V loS max<br />
mm a -1<br />
1 Acquetico Pieve di Teco 9 -2.99 -1.81<br />
2 Diano Arentino Diano Arentino 61 -6.63 2.23<br />
3 Mendatica Mendatica 87 -7.91 4<br />
4 Monesi Triora 9 -4.72 -1.11<br />
5 Quartarole Borghetto d'Arroscia 19 -9 -0.71<br />
6 San Romolo-Borello Sanremo 15 -3.4 0.39<br />
7 Ville San Pietro Borgomaro 23 -4.13 -0.81<br />
8 Olivetta San Michele Olivetta San Michele 11 -5.76 -0.32<br />
9 Valcona Soprana e Sottana Mendatica 26 -3.75 2.35<br />
10 Ottano Pornassio 76 -6.32 -0.55<br />
11 Castellaro Taggia/Castellaro 105 -7.14 0.06<br />
12 Ventimiglia Alta Ventimiglia 2 -6.47 -6.11<br />
13 Ceriana Ceriana 18 -4.54 -0.63<br />
14 Baiardo Baiardo 49 -11.02 0.03<br />
15 Duranti Stellanello SV 5 -7.54 2.16
Diano arentino<br />
L’area d’indagine di Diano Arentino è<br />
caratterizzata da 61 bersagli radar (PS) dei<br />
quali 33 significativi ai fini dell’indagine e<br />
28 non significativi (Figura 6-18). I PS sono<br />
in prevalenza localizzati in corrispondenza<br />
del centro abitato del comune e in località<br />
Poggio; in entrambi i gruppi di PS si sono<br />
rilevati danni di entità significativa con più di<br />
un caso di danno “grave e con una punta di<br />
danno “molto grave” in località Poggio (Figura<br />
6-19).<br />
La legenda dei colori utilizzata per la<br />
rappresentazione del grado di danno è la<br />
stessa anche per i casi studio seguenti.<br />
I manufatti censiti sono in prevalenza<br />
Tabella 6-5. Diano Arentino: grado di danno, numero di PS e velocità (mm a -1 )<br />
Grado di danno n° PS<br />
n° PS<br />
mur<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
costituiti da strutture in muratura (75% del<br />
campione) caratterizzati da un numero di<br />
piani inferiore o uguale a 3. La rimanente<br />
parte del campione è costituito da edifici in<br />
cemento armato con struttura a telaio. Come<br />
si osserva in Tabella 6-5 un grado di danno<br />
superiore al medio è stato rilevato su edifici<br />
sia in muratura che in cemento armato.<br />
In Tabella 6-5 è inoltre riportata la<br />
correlazione tra grado di danno e velocità<br />
media, con riferimento alla velocità misurata<br />
lungo la linea di vista del satellite V LOS e alla<br />
velocità proiettata lungo il pendio V SLOPE . Si<br />
osserva come la migliore correlazione si abbia<br />
con riferimento alla V SLOPE , pur rilevando una<br />
notevole dispersione del dato.<br />
n° PS<br />
c.a.<br />
V loS (ass)<br />
media<br />
V SloPE (ass)<br />
media<br />
1 - Nullo 6 5 0 3.91 5.83<br />
2 - Lieve 17 16 1 3.10 5.79<br />
3 - Medio 5 1 2 2.93 4.80<br />
4 - Grave 3 1 2 3.32 14.50<br />
5 - Molto grave 1 1 0 4.85 7.00<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
153
154<br />
Figura 6-18 - Diano Arentino: PS significativi (verde) e non significativi (rosso)<br />
Figura 6-19 - Diano Arentino: grado di danno rilevato
Figura 6-20 - Edifici lesionati <strong>nella</strong> frazione di Villa Chiesa<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
155
156<br />
Figura 6-21 - Edifici lesionati <strong>nella</strong> frazione di Villa Chiesa
Ville San Pietro<br />
L’area d’indagine di Ville San Pietro nel<br />
Comune di Borgomaro è caratterizzata da 23<br />
bersagli radar (PS) dei quali 19 significativi ai<br />
fini dell’indagine e 4 non significativi (Figura<br />
6-22). Il danno rilevato è stato classificato<br />
in prevalenza come “lieve” con una punta<br />
di danno “grave” per il PS in corrispondenza<br />
della chiesa (Figura 6-23).<br />
I manufatti censiti anche in questo caso<br />
mostrano una prevalenza di strutture in<br />
muratura (76% del campione) caratterizzati in<br />
prevalenza da un numero di piani inferiore o<br />
uguale a 3. I rimanenti edifici sono in cemento<br />
armato con struttura a telaio.<br />
Tabella 6-6. Ville San Pietro: grado di danno, numero di PS e velocità (mm a -1 )<br />
Grado di danno n° PS n° PS<br />
mur<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Come si osserva in Tabella 6-6 un grado di<br />
danno grave è stato rilevato solo su edifici in<br />
muratura.<br />
In Tabella 6-6 è inoltre riportata la correlazione<br />
tra grado di danno e velocità media,<br />
con riferimento alla velocità misurata lungo<br />
la linea di vista del satellite V LOS , alla velocità<br />
proiettata lungo il pendio V SLOPE . Si può in<br />
questo caso notare, nonostante la dispersione<br />
dei dati, una correlazione con entrambe le<br />
misure di velocità. I valori più alti di V LOS sono<br />
associati a bersagli caratterizzati da un danno<br />
medio e il valore maggiore di V SLOPE è in<br />
corrispondenza di uno dei due PS con danno<br />
grave nell’area censita.<br />
n° PS<br />
c.a.<br />
V loS (ass)<br />
media<br />
V SloPE (ass)<br />
media<br />
1 – Nullo 4 3 1 1.25 3.00<br />
2 – Lieve 11 8 3 1.93 5.64<br />
3 – Medio 2 0 0 3.97 6.00<br />
4 – Grave 2 2 0 2.25 10.00<br />
5 - Molto grave 0 0 0 - -<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
157
158<br />
Figura 6-22 - Ville San Pietro: PS significativi (verde) e non significativi (rosso)<br />
Figura 6-23 - Ville San Pietro: grado di danno rilevato
Figura 6-24 - Lesioni su edifici e infrastrutture nell’abitato di Ville San Pietro<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
159
160<br />
Figura 6-24 - Lesioni su edifici e infrastrutture nell’abitato di Ville San Pietro
Figura 6-25 - Lemeglio: PS e frana perimetrata<br />
Figura 6-26 - Lemeglio: grado di danno rilevato e verso di<br />
movimento dall’analisi dei quadri fessurativi (frecce rosse)<br />
lemeglio<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
Nel sito in oggetto i bersagli radar censiti<br />
ricadono all’interno di una vasta e nota area<br />
in frana, tra l’abitato di Lemeglio (verso Nord),<br />
fino alla zona costiera denominata Acquario<br />
(Figura 6-25).<br />
Il numero dei PS derivanti dall’elaborazione<br />
di immagini ERS nell’area in frana è pari a<br />
circa 100; sono stati censiti circa 80 bersagli, la<br />
maggior parte (>80%) significativi. I manufatti<br />
censiti sono costituiti prevalentemente<br />
da edifici di civile abitazione in pietra/<br />
muratura ed in c.a. I primi sono concentrati<br />
maggiormente nell’abitato di Lemeglio,<br />
mentre i secondi, di più recente costruzione,<br />
<strong>nella</strong> zona residenziale verso la costa. Proprio<br />
in tale zona sono stati censiti alcuni manufatti<br />
non identificati da bersagli (limitrofi a zone in<br />
cui si avevano indicazioni di PS) in quanto in<br />
gravissimo stato di dissesto.<br />
I principali danni osservati, strutturali, si<br />
sono riscontrati negli edifici in c.a. e muratura<br />
localizzati verso la costa: i danni consistono in<br />
ampie lesioni e spostamenti pluricentimetrici.<br />
In queste zone le velocità di spostamento<br />
sono elevate (-5÷-25 mm a -1 ) (Figura 6-26).<br />
Anche nell’abitato di Lemeglio si sono<br />
osservati casi di danno strutturale medio/<br />
grave su bersagli caratterizzati da velocità<br />
significative (-6÷-9 mm a -1 ). In altri casi, con<br />
velocità (positive) modeste (0÷1 mm a -1 ) si<br />
sono osservati danni medi su edifici in pietra.<br />
Dall’analisi dei quadri fessurativi è stato<br />
possibile identificare direzioni di movimento<br />
ben definite, concordi con il cinematismo<br />
della frana di Lemeglio, evidenziate in figura<br />
6-26 dalle frecce in colore rosso.<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
161
162<br />
Figura 6-27 - Edifici gravemente lesionati in località Lemeglio
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
163
164<br />
In conclusione, quindi, per quanto attiene<br />
gli aspetti inerenti la correlazione fra i dati<br />
di spostamento registrati con tecnica PS ed<br />
il grado di danno rilevato sui fabbricati è<br />
possibile osservare quanto segue:<br />
- l’analisi dei dati provenienti dal monitoraggio<br />
<strong>satellitare</strong>, per i siti investigati, ha indicato<br />
un’elevata affidabilità dello strumento, in<br />
quanto si è sempre verificata una precisa<br />
“materializzazione” del PS sul territorio e,<br />
generalmente, una buona correlazione tra<br />
il dato di velocità ed il riconoscimento di<br />
danni e/o cinematismi;<br />
- A velocità medie di spostamento elevate<br />
non corrispondono necessariamente danni<br />
elevati sul costruito identificato come<br />
-<br />
bersaglio riflettente, per le ovvie influenze<br />
della situazione locale dell’area ove si<br />
colloca il bersaglio, dell’esposizione e delle<br />
caratteristiche strutturali di quest’ultimo.<br />
Per il motivo di cui sopra, le velocità<br />
rilevate dai PS sono strettamente<br />
riferite alla particolarità di ogni area<br />
indagata e producono effetti diversificati<br />
nelle diverse aree, rendendo, quindi,<br />
problematica l’individuazione di valori di<br />
soglia “assoluti” per la modulazione del<br />
livello di pericolosità associato alle frane.<br />
Quanto osservato nell’ambito delle attività<br />
condotte, infatti, restituisce un quadro di<br />
sostanziale decorrelazione fra le velocità di<br />
spostamento registrate, anche se proiettate<br />
lungo la retta di massima pendenza, e lo<br />
stato di conservazione dei fabbricati (Figura<br />
6-28). Tale risultato, imputabile a tutte le<br />
considerazioni sopra riportate, non fa che<br />
confermare un’impressione già maturata,<br />
sia pure in maniera qualitativa, a seguito<br />
dell’osservazione di svariati casi in cui a<br />
tassi di deformazione relativamente elevati<br />
(tenuto conto dei limiti di capacità di<br />
rilevazione della tecnica) si riscontravano<br />
quadri lesionativi a carico dei fabbricati<br />
assai lievi (vedi schede 7 e 8). Altre volte,<br />
al contrario, si osservavano situazioni nelle<br />
quali a tassi di spostamento limitati era<br />
associato uno stato di conservazione dei<br />
manufatti molto più preoccupante (vedi<br />
schede 3 e 4, così come il caso sopra<br />
riportato di Ville S. Pietro).<br />
Figura 6-28 – Confronto tra velocità di spostamento (proiettate lungo la retta di massima pendenza) e lo stato di<br />
conservazione dei fabbricati. Classi V : 0
Per quanto riguarda aspetti più riferibili<br />
all’analisi specifica degli effetti sui manufatti,<br />
alcuni approfondimenti dei casi studiati<br />
evidenziano, come è logico attendersi, come<br />
manufatti con caratteristiche strutturali<br />
diverse manifestino reazioni diverse agli<br />
spostamenti registrati.<br />
Si è potuto osservare come, in generale,<br />
all’interno delle aree in frana analizzate,<br />
la distribuzione dei danni rapportata alla<br />
tipologia strutturale dei manufatti evidenzi<br />
una maggiore vulnerabilità degli edifici in<br />
pietra o muratura rispetto a quelli in c.a.,<br />
anche quando le velocità di spostamento<br />
medie annue sono basse o addirittura<br />
dell’ordine del valore minimo definito.<br />
In alcuni casi , inoltre, si è osservata una<br />
minore correlazione tra la velocità media e<br />
il danno per gli edifici in pietra o muratura<br />
rispetto a quelli in c.a.: in questi ultimi il<br />
legame fra l’entità delle lesioni osservate e la<br />
velocità di spostamento ad essi associata è<br />
più marcato, seppur con ampia dispersione:<br />
all’aumentare delle velocità di spostamento<br />
aumenta il grado di danno osservato.<br />
In tutti i casi, comunque, la dispersione dei<br />
risultati è molto evidente: ciò può essere<br />
dovuto sia all’osservazione precedente<br />
(presenza prevalente di strutture in muratura),<br />
sia alla definizione che si è adottata per il<br />
danno (non scevra da una componente di<br />
soggettività), sia a informazioni a volte carenti<br />
che non permettono una migliore analisi,<br />
nonché, infine, ad una inerente difficoltà<br />
complessiva del problema (interazione<br />
complessa fra la reazione delle diverse<br />
strutture, in rapporto alle loro caratteristiche<br />
di forma, costruttive e fondative, con le<br />
caratteristiche geotecniche del terreno<br />
d’imposta, per lo più molto scadenti, nonché<br />
con le proprietà cinematiche del fenomeno<br />
franoso, in rapporto a loro volta con la<br />
posizione relativa del manufatto indagato<br />
all’interno dell’area in frana stessa) .<br />
Nei casi in cui è stato possibile stimare il<br />
valore di v SLOPE , si è, in generale, ottenuta infatti<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
una migliore correlazione fra quest’ultimo e il<br />
grado di danno.<br />
Ulteriore considerazione degna di nota, e<br />
che potrebbe indurre ad erronee conclusioni,<br />
è la possibile non contemporaneità tra<br />
acquisizione del dato (immagine radar)<br />
e rilievo del danno (sopralluogo). Nelle<br />
località oggetto del censimento, il livello di<br />
manutenzione/ristrutturazione dei manufatti<br />
(residenziali) è generalmente molto alto,<br />
e può così rendere difficile “leggere” un<br />
effettivo meccanismo di causa–effetto (franastato<br />
fessurativo).<br />
Infine, in prospettiva futura, sarebbe<br />
auspicabile sperimentare l’esecuzione di rilievi<br />
puntuali su pochi manufatti ben identificati,<br />
significativi e ben documentati, con criteri<br />
di rilievo del danno più “rigorosi”, tipici<br />
dell’ingegneria strutturale e geotecnica, che si<br />
basano su grandezze quali, ad es., i cedimenti,<br />
le rotazioni, i rapporti di inflessione e che<br />
permettono di definire livelli deformativi da<br />
mettere in relazione con possibili stati limite<br />
della struttura in esame.<br />
Nell’ambito delle attività di analisi dei<br />
dati PS in Piemonte si è anche operata una<br />
sperimentazione finalizzata a definire una<br />
potenziale correlazione tra danni agli edifici<br />
e presenza di indicatori di movimento in aree<br />
di instabilità di versante. Sono state prese in<br />
considerazione alcune grandi frane e DGPV<br />
in alta Valle di Susa (TO) tra le quali la “frana<br />
di Millaures” nel comune di Bardonecchia<br />
(TO). Per le elaborazioni sono stati esaminati i<br />
dati PS acquisiti dai satelliti ERS e RADARSAT.<br />
Sui siti di esame sono stati verificati gran<br />
parte degli edifici, rilevando presenza,<br />
caratteristiche, numero ed entità delle lesioni<br />
eventualmente presenti. Tali elementi sono<br />
poi stati messi in relazione con la presenza<br />
di PS tramite metodi statistici basati su GIS.<br />
Ne è derivata una proposta di classificazione<br />
degli edifici e la realizzazione di un database<br />
con circa 200 record a cui a fatto seguito la<br />
creazione di una matrice danni/presenza PS<br />
(Tabella 6-7).<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
165
166<br />
La fase di analisi sul terreno ha evidenziato<br />
una maggiore visibilità delle lesioni sugli<br />
edifici in muratura, mentre i muri in pietrame<br />
risultano di difficile valutazione. Le immagini<br />
RADARSAT, rispetto agli ERS, generano un<br />
maggior numero di PS ma, durante le verifiche<br />
sul terreno, si è rilevato un forte elemento<br />
di disturbo costituito dalle costruzioni con<br />
copertura in lamiera che, in alcuni casi,<br />
rappresentano anche il 50 % degli edifici sede<br />
di PS. Tali coperture sembrerebbero inoltre<br />
mostrare una velocità media di spostamento<br />
amplificata; una tendenza più evidente per i<br />
dati ERS rispetto a quelli RADARSAT.<br />
Le analisi hanno evidenziato alcune<br />
apparenti incongruenze, ad esempio:<br />
PS con dislocazioni ridotte (< 2 mm a -1 )<br />
su edifici palesemente lesionati in frane<br />
considerate attive; PS con dislocazioni elevate<br />
in corrispondenza di edifici od elementi<br />
strutturali privi di lesioni (quantomeno visibili)<br />
in settori considerati quiescenti o comunque<br />
poco attivi. Le risultanze delle analisi saranno<br />
utilizzate per rivedere i modelli concettuali e<br />
gli scenari evolutivi dei fenomeni franosi.<br />
Il lavoro svolto ha permesso di definire<br />
alcuni limiti nell’uso dei dati PS dimostrando<br />
che è indispensabile, per l’interpretazione di<br />
fenomeni a scala locale, la verifica dei dati PS<br />
sul campo al fine del corretto filtraggio degli<br />
stessi; sono infatti poco affidabili bersagli<br />
quali le coperture in lamiera, pali della luce,<br />
recinzioni fatiscenti, cumuli di pietre e altri<br />
elementi presenti in cantieri edili.<br />
Le risultanze integrali delle analisi sono<br />
riportate <strong>nella</strong> relazione finale dell’attività<br />
B2_l del progetto Risknat, disponibile sul sito<br />
http://www.risknat-alcotra.org/.
Tabella 6-7. Matrice danni/presenza PS.<br />
Classificazione (per singolo edificio) Matrice creata<br />
Danni rilevati PS su edificio<br />
L’interferometria <strong>satellitare</strong><br />
<strong>nella</strong> <strong>pianificazione</strong> territoriale<br />
N° di danni Classe N° Classe P0 P1 P2<br />
0 Da0 0 P0 Da0 A0 D1 D2<br />
1-4 Da1 1-4 P1 Da1 C1 A1 B2<br />
>4 Da2 >4 P2 Da2 C2 B1 A2<br />
A0 : Nessun danno all’edificio (Da0); nessun PS registrato (P0)<br />
A1 : Danni sugli edifici 1 ÷ 4 (Da1); PS registrati 1 ÷ 4 ( P1)<br />
A2 : Danni sugli edifici > 4 (Da2); PS registrati > 4 (P2)<br />
B1 : Danni sugli edifici > 4 (Da2); PS registrati 1 ÷ 4 ( P1)<br />
B2 : Danni sugli edifici 1 ÷ 4 (Da1); PS registrati > 4 (P2)<br />
C1 : Danni sugli edifici 1 ÷ 4 (Da1); nessun PS registrato (P0)<br />
C2 : Danni sugli edifici > 4 (Da2); nessun PS registrato (P0)<br />
D1 : Nessun danno all’edificio (Da0); PS registrati 1 ÷ 4 ( P1)<br />
D2 : Nessun danno all’edificio (Da0); PS registrati > 4 (P2)<br />
Fig. 6-29 - Frana di Millaures, Bardonecchia (TO) . Esempio di risultanze dell’analisi effettuate.<br />
Nessun danno/Nessun PS<br />
Danni limitati/Nessun PS<br />
Molti danni/Nessun PS<br />
Nessun danno/molti PS<br />
Danni limitati/Pochi PS<br />
Danni limitati/Molti PS<br />
Nessun danno/Pochi PS<br />
Molti danni/Pochi PS<br />
<strong>Capitolo</strong> 6<br />
167
<strong>Capitolo</strong> 7 Considerazioni conclusive<br />
Alla luce delle considerazioni svolte nei<br />
precedenti capitoli, a distanza di poco più<br />
di dieci anni dalle prime pionieristiche<br />
applicazioni di questa innovativa tecnica<br />
di indagine nel settore dello studio dei<br />
fenomeni franosi, possiamo affermare che<br />
questi dati e le misure in essi contenute sono<br />
ormai divenuti uno strato informativo di base<br />
che deve essere analizzato ogniqualvolta<br />
ci si accinga a redigere o revisionare una<br />
carta geomorfologica. Conseguentemente,<br />
siccome è evidente che le indagini con<br />
tecniche PS/DS, soprattutto se di area vasta,<br />
verranno di norma acquisite dalle pubbliche<br />
amministrazioni, appare imprescindibile che i<br />
dati vengano resi disponibili e siano utilizzati<br />
correntemente per la redazione di tutti gli<br />
strumenti di <strong>pianificazione</strong> territoriale.<br />
D’altra parte, il processo di acquisizione e<br />
divulgazione non vincolata di questi dati, a<br />
seguito dell’azione del Ministero dell’Ambiente<br />
con il Piano Straordinario di Telerilevamento<br />
Ambientale, è ormai irreversibile ed è,<br />
quindi, indispensabile individuare le soluzioni<br />
tecnicamente più corrette e efficaci, in<br />
funzione delle scelte politiche operate sia a<br />
livello nazionale sia regionale, affinché la loro<br />
introduzione non produca distorsioni.<br />
Le pubbliche amministrazioni sono quindi<br />
chiamate a svolgere uno sforzo significativo<br />
su due principali questioni. La prima attiene<br />
la problematica dell’aggiornamento regolare<br />
della copertura dei dati PS sul territorio. In<br />
assenza di una specifica programmazione<br />
delle attività su base regionale o nazionale<br />
che consenta di perseguire questo obbiettivo<br />
qualsiasi sforzo di carattere tecnico sarebbe<br />
scarsamente efficace ed un’eccessiva enfasi<br />
sull’utilizzo di questi dati nell’ambito della<br />
<strong>pianificazione</strong> territoriale ingiustificata.<br />
A questo proposito, tenuto conto che<br />
dal 2007 è stata concretamente avviata<br />
la missione Cosmo-SkyMed dell’Agenzia<br />
Spaziale Italiana e che è stato recentemente<br />
completato il lancio della costellazione dei<br />
4 satelliti radar che potrebbe consentire<br />
l’acquisizione di immagini adatte all’analisi<br />
Considerazioni conclusive <strong>Capitolo</strong> 7<br />
con tecnica interferometrica con cadenza di<br />
16 giorni, questo traguardo appare a portata<br />
di mano.<br />
La seconda questione è più prettamente di<br />
carattere tecnico: è possibile prefigurare la<br />
definizione di una linea guida standard per<br />
l’utilizzo dei dati PS/DS <strong>nella</strong> definizione dello<br />
stato di attività delle frane in <strong>pianificazione</strong><br />
territoriale? La risposta a questa domanda<br />
deve discendere da altre due risposte alle<br />
seguenti questioni:<br />
- è lecito e ragionevolmente credibile<br />
ipotizzare l’affinamento della cartografia<br />
della pericolosità per frana di piano di bacino<br />
in funzione delle velocità di spostamento<br />
e delle tipologie cinematiche e, quindi,<br />
traguardare una miglior modulazione dei<br />
regimi normativi?<br />
- esistono valori assoluti e generalizzabili<br />
della soglia di velocità media annua di<br />
deformazione delle frane, indipendenti<br />
dalle tipologie costruttive e fondative del<br />
costruito e dalle caratteristiche cinematiche<br />
delle frane stesse, oltre le quali ritenere non<br />
sostenibile la convivenza con il rischio?<br />
Crediamo che una risposta univoca e<br />
condivisa a queste domande non sia, ad oggi,<br />
proponibile, anche se la bibliografia sulla<br />
materia si sta rapidamente popolando. Quello<br />
che, però, si può senza dubbio affermare è<br />
che i dati di interferometria <strong>satellitare</strong> hanno<br />
avuto il merito di fare sì che la comunità<br />
scientifica abbia iniziato seriamente a porsi<br />
questi interrogativi, potendo contare su<br />
una buona base di partenza per cercare<br />
di fornire risposte supportate in maniera<br />
robusta. Grazie anche all’enorme mole di<br />
informazioni acquisite, all’approfondimento<br />
delle conoscenze conseguito ed allo scambio<br />
di esperienze e buone pratiche sviluppatosi<br />
nell’ambito del Progetto Alcotra <strong>RiskNat</strong> tra<br />
i vari partner si possono gettare fondamenta<br />
solide e condivise sulle quali costruire un<br />
nuovo capitolo della gestione delle aree<br />
in frana nell’ambito della <strong>pianificazione</strong><br />
territoriale.<br />
169
Appendice A Diffusione del dato PS/DS<br />
A.1 Il portale Risknat<br />
La consultazione e la diffusione dei dati<br />
interferometrici e delle elaborazioni prodotte<br />
nell’ambito del Programma Operativo<br />
Obiettivo 3 Alcotra (Italia - Francia) viene<br />
gestita mediante il nuovo Geoportale<br />
<strong>RiskNat</strong>, il punto di accesso singolo a risorse<br />
geospaziali distribuite, dedicato alla diffusione<br />
e condivisione dell’informazione geografica<br />
sui rischi naturali.<br />
Grazie al Geoportale è possibile accedere a<br />
dati, cartografie, servizi webGIS e modelli 3D<br />
del territorio realizzati e messi a disposizione<br />
dai vari partner del progetto.<br />
Il nuovo Geoportale <strong>RiskNat</strong> (Figura A-1)<br />
si pone come elemento centrale di una rete<br />
transfrontaliera consolidata, con l’obiettivo<br />
principale di creare e gestire una piattaforma<br />
interregionale di scambio di esperienze,<br />
di valorizzazione delle informazioni e di<br />
Figura A-1. Prima pagina del portale <strong>RiskNat</strong><br />
riflessione strategica. La volontà di realizzare<br />
una base cartografica comune ed il più<br />
possibile omogenea dell’area di cooperazione<br />
transfrontaliera è stato uno degli elementi<br />
cardine al supporto del progetto strategico<br />
<strong>RiskNat</strong> e dello sviluppo del Geoportale<br />
quale punto di accesso unificato a tutte le<br />
informazioni spaziali (dati, cartografia, servizi<br />
geografici, metadati ecc.) gestite dai diversi<br />
partner.<br />
I servizi presentati, infatti, sono gestiti<br />
ed aggiornati in modo autonomo dai<br />
diversi Partner dell’area di cooperazione<br />
transfrontaliera, in linea con i principi di<br />
cooperazione ed interoperabilità promossi<br />
della direttiva europea INSPIRE.<br />
Il Geoportale è uno dei principali risultati del<br />
Progetto Strategico RISKNAT sui rischi naturali<br />
nell’area di cooperazione transfrontaliera Italia<br />
- Francia (Programma Alcotra 2007-2013):<br />
realizzato da Arpa Piemonte in qualità di<br />
Appendici<br />
171
172<br />
Figura A-2 Visualizzatore geografico 2D del geoportale<br />
Figura A-3. Finestra di ricerca del catalogo dei metadati
soggetto attuatore per la Regione Piemonte,<br />
ad esso hanno collaborato numerosi partner<br />
istituzionali del progetto (Regione Piemonte,<br />
Regione Valle d’Aosta, Regione Liguria,<br />
Provincia di Cuneo, Provincia di Imperia,<br />
Region PACA, Regione Rhone Alpèes, Canton<br />
du Valais).<br />
Oltre a una sezione dedicata alle news, ai<br />
contributi tematici e al download dei dati, il<br />
Geoportale <strong>RiskNat</strong> rende disponibili servizi<br />
geografici on line sia per gli Enti cooperanti,<br />
sia per il pubblico (imprese, professionisti,<br />
altri enti PA, cittadini).<br />
La piattaforma Esri ArcGIS è stata sfruttata<br />
a pieno per la realizzazione del Geoportale<br />
costituendone il motore della fornitura dei<br />
servizi geografici attraverso ArcGIs Server,<br />
le ArcGIS API for Flex per lo sviluppo delle<br />
applicazioni e l’ultima versione del Esri<br />
Geoprtal Server.<br />
Attraverso il il Geoportale è quindi possibile<br />
accedere a diversi servizi ed applicazioni quali:<br />
Geoviewer 2D<br />
Il Geoportale <strong>RiskNat</strong> si compone di servizi<br />
basati su un visualizzatore geografico fruibile<br />
via Web ed in grado di integrare tutti i dati<br />
e i servizi tematici (frane, valanghe, aree<br />
inondabili, ghiacciai, carte geologiche etc.)<br />
condivisi dai partner attraverso i protocolli di<br />
interoperabilità WMS e WFS.<br />
Il Geoviewer 2D (Figura A-2) integra le nuove<br />
basi topografiche transfrontaliere e offre<br />
numerose funzionalità GIS quali la ricerca<br />
indirizzi, la ricerca per località, le selezioni<br />
spaziali ed alfanumeriche e la costruzione di<br />
query. E’ inoltre possibile effettuare ricerche<br />
dirette sui cataloghi dei metadati dei partner<br />
e caricare nel visualizzatore le risorse trovate.<br />
il catalogo dei metadati<br />
Il catalogo dei metadati (Figura A-3)<br />
rappresenta una delle componenti principali<br />
del Geoportale <strong>RiskNat</strong> ed è stato progettato<br />
come un “catalogo distribuito” alimentato<br />
con le schede metadati prodotte dai diversi<br />
partner di progetto.<br />
Il servizio di ricerca sul catalogo consente<br />
quindi di rendere facilmente fruibili dati<br />
e servizi che sono prodotti gestiti ed<br />
aggiornati in modo autonomo dai diversi<br />
soggetti. Sulla base del catalogo metadati<br />
comune sono stati realizzati servizi di ricerca<br />
basati su tematiche, parole chiave, ambito<br />
spaziali, ambiti temporali, tipologie di risorse<br />
informative etc. Gli standard di metadati<br />
adottati sono quelli ISO con profilo INSPIRE e<br />
RNDT (Repertorio Nazionale Dati Territoriali) e<br />
Dublin Core.<br />
Geoviewer 3D<br />
Attraverso un complesso processo di<br />
integrazione ed elaborazione dei dati<br />
altimetrici è stato realizzato il primo<br />
modello tridimensionale transfrontaliero<br />
completamente fruibile in rete come<br />
servizio WebGIS 3D (Figura A-4). Il modello,<br />
rilasciato in una prima versione nel luglio<br />
2011 comprendente le tre regioni italiane<br />
interessate dal progetto (Piemonte – Liguria<br />
– Valle d’Aosta), integra ora anche le realtà<br />
dei territori confinanti del Canton du Valais<br />
(CH) e delle Regioni PACA e Rhône Alpes<br />
(Francia), per un totale di circa 120.000 km2 .<br />
Sul modello sono attualmente visualizzabili<br />
diversi tematismi sui rischi naturali sotto<br />
forma di servizi interoperabili (WMS-WFS).<br />
Il dato dei PS/DS consultabile nel servizio è<br />
corredato della propria base dati alfanumerica<br />
ed è integrato con il tema delle frane del<br />
progetto IFFI/SIFRAP.<br />
Appendici<br />
173
174<br />
Figura A-4. visualizzatore geografico 3D del geoportale<br />
Figura A-5. Home page del portale regionale ligure.
A.2 Visualizzatore cartografico<br />
PS/DS e aree anomale sul sito<br />
www.ambienteinliguria.it<br />
La cartografia dei PS/DS e delle aree<br />
anomale, ricadenti sul territorio della Regione<br />
Liguria, è accessibile dal portale dell’ambiente<br />
regionale all’indirizzo:<br />
www.ambienteinliguria.it<br />
Il Portale è finalizzato a rendere fruibili agli<br />
uffici interni di Regione Liguria e degli Enti<br />
collegati, agli utenti istituzionali ed al pubblico<br />
le informazioni ambientali e le informazioni<br />
regionali a queste correlate, secondo i<br />
rispettivi profili e nel rispetto degli standard<br />
di sicurezza prestabiliti dalla Regione Liguria.<br />
Fornisce un’interfaccia unica per l’accesso via<br />
Internet alle banche dati del SIRAL (Sistema<br />
Informativo Regionale Ambientale), e<br />
costituisce il principale canale informativo per<br />
Figura A-6. Pagina dedicata al Progetto Europeo <strong>RiskNat</strong> e ai dati interferometrici.<br />
la divulgazione delle informazioni (a beneficio<br />
di enti e pubblico), relative alle materie<br />
trattate dal Dipartimento Ambiente, con<br />
ciò adempiendo agli obblighi imposti dalla<br />
normativa comunitaria e nazionale in materia<br />
di accesso alle informazioni ambientali.<br />
Sul Portale Ambientale, oltre alle informazioni<br />
contenute nelle banche dati SIRAL, si trovano<br />
i documenti relativi a normative (atti,<br />
regolamenti, linee guida), procedure, piani e<br />
programmi, finanziamenti e pubblicazioni.<br />
I dati messi a disposizione sono organizzati<br />
in canali che raggruppano le diverse<br />
tematiche ambientali: sviluppo sostenibile,<br />
territorio, natura, acqua ed aria (Figura<br />
A-5) e sono fruibili sia tramite specifiche<br />
applicazioni, sia attraverso un visualizzatore<br />
cartografico, che rende disponibili alcuni<br />
servizi di consultazione e scarico di dati<br />
e metadati, secondo le disposizioni della<br />
Direttiva europea 2007/2/CE del 14 marzo<br />
2007 INSPIRE.<br />
Appendici<br />
175
176<br />
I PS/DS e le aree anomale sono consultabili<br />
dal canale Territorio nel sottocanale geologia,<br />
scegliendo, tra i servizi on line sulla destra,<br />
all’interno dell’elenco delle banche dati<br />
disponibili, “geologia: interferometria<br />
<strong>satellitare</strong>” ed, una volta entrati <strong>nella</strong><br />
pagina specifica dedicata all’interferometria,<br />
cliccando su “vai all’applicazione” della prima<br />
opzione “Consultazione cartografia PS/DS,<br />
aree anomale e dati del Progetto Europeo<br />
<strong>RiskNat</strong>”. Si accede, in questo modo, alla<br />
pagina dedicata al Progetto Europeo <strong>RiskNat</strong><br />
e ai dati interferometrici (Figura A-6).<br />
La pagina è distinta in 2 sezioni:<br />
a) “Interferometria Differenziale Multitemporale<br />
Radar Satellitare”: i 4 link consentono di:<br />
1. accedere al Geoportale di <strong>RiskNat</strong>, dove<br />
sono raccolti tutti i dati del progetto<br />
europeo, che possono essere visualizzati<br />
sia in 2D, che in 3D, attraverso specifici<br />
visualizzatori cartografici<br />
Figura A-7. Caricamento Target<br />
2. accedere al sito del progetto Europeo<br />
<strong>RiskNat</strong><br />
3. consultare il visualizzatore cartografico<br />
dei PS/DS ed aree anomale della Regione<br />
Liguria<br />
4. scaricare i servizi WMS e conoscere i<br />
metadati di PS/DS e aree anomale del<br />
Progetto Europeo <strong>RiskNat</strong><br />
b) “Documentazione tecnica”: i 4 link consentono<br />
di scaricare alcuni documenti in formato<br />
pdf, riguardanti:<br />
5. il manuale per l’utilizzo del visualizzatore<br />
cartografico<br />
6. l’elenco dei metadati di tutti i dataset<br />
presenti<br />
7. un documento sintetico per la<br />
comprensione del dato interferometrico<br />
8. una nota per l’interpretazione delle aree<br />
anomale
a.2.1 Cartografia regionale aree anomale e<br />
PS/DS<br />
Il visualizzatore cartografico dedicato alla<br />
consultazione dei PS/DS e delle aree anomale<br />
della Regione Liguria riguarda dati da<br />
piattaforme satellitari ERS ed ENVISAT, messi<br />
a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e<br />
della Tutela del Territorio e del Mare all’interno<br />
del POT– A (Piano Ordinario di Telerivamento<br />
Ambientale) e RADARSAT, acquisiti nell’ambito<br />
del Progetto Europeo <strong>RiskNat</strong>, nonché le<br />
elaborazioni “local area” relative all’areale<br />
di Framura (SP), messe a disposizione dalla<br />
Provincia della Spezia e di S. Stefano d’Aveto,<br />
fornite da ESA nell’ambito del Progetto<br />
Terrafirma (http://www.terrafirma.eu.com/).<br />
I dati sono consultabili accedendo a<br />
“Cartografia Regionale Aree Anomale e PS/<br />
DS” dalla pagina dell’applicazione “geologia:<br />
interferometria <strong>satellitare</strong>”, attraverso l’utilizzo<br />
di 3 appositi bottoni, sviluppati per il<br />
visualizzatore cartografico:<br />
Caricamento Target:<br />
consente di caricare il dataset di PS/DS<br />
selezionato e di visualizzarlo sulla cartografia,<br />
Figura A-8. Informazioni sul dataset.<br />
oltre a scaricare il pdf contenente i metadati<br />
relativi al dataset stesso<br />
Caricamento Aree Anomale:<br />
consente di caricare le aree anomale<br />
generate a partire dal dataset selezionato e di<br />
scaricare il pdf dei metadati relativi al dataset<br />
stesso.<br />
Modifica Tematismo Target:<br />
permette di modificare la tematizzazione<br />
standard dei PS/DS e di crearne una a proprio<br />
piacimento.<br />
Per le funzionalità degli altri bottoni, si<br />
rimanda all’HELP on line<br />
L’immagine di apertura del servizio mostra<br />
l’estensione del territorio ligure con i riquadri<br />
di impronta dell’area coperta da ognuno dei<br />
dataset disponibili.<br />
1. Caricamento Target (Figura A-7)<br />
Cliccando sul bottone, si apre la mascherina<br />
che permette di scegliere il dataset di PS/DS<br />
da visualizzare. Una volta selezionatone uno,<br />
si possono conoscere i metadati associati<br />
al dataset, cliccando su “informazioni sul<br />
dataset” ed, in una nuova pagina, si apre<br />
il pdf relativo. Premendo sul tasto “Invia”,<br />
Appendici<br />
177
178<br />
si caricano in legenda i PS/DS del dataset<br />
selezionato, tematizzati in 20 classi sul<br />
valore di velocità media e visualizzati<br />
secondo la scala cromatica normalmente<br />
utilizzata (Figura A-8). Ad ogni PS/DS<br />
sono associate alcune informazioni, che è<br />
possibile conoscere cliccando sui bottoni<br />
“Info”, tra le quali, ad esempio, la geometria<br />
orbitale, le coordinate, la deviazione<br />
standard e la velocità media annua di<br />
spostamento lungo la LOS. E’ possibile,<br />
inoltre, visualizzare, ove disponibile, la serie<br />
storica di spostamento medio annuo per il<br />
periodo di osservazione.<br />
2. Caricamento Aree Anomale:<br />
Cliccando sul bottone, si apre la mascherina<br />
che permette di scegliere le aree<br />
anomale generate a partire da un<br />
determinato dataset di PS/DS da<br />
Figura A-9. Aree anomale.<br />
visualizzare. Come nel caso dei PS/DS, si<br />
possono conoscere i metadati associati<br />
al dataset selezionato, cliccando su<br />
“informazioni sul dataset”.<br />
Ancora una volta, cliccando sui bottoni<br />
“info”, è possibile conoscere le informazioni<br />
relative all’area anomala selezionata, tra<br />
le quali ad esempio: la velocità media,<br />
il numero di target all’interno dell’area,<br />
l’indice di omogeneità e la coerenza (Figura<br />
A-9).<br />
3. Modifica Tematismo Target:<br />
Una volta caricato un dataset in legenda,<br />
è possibile modificare la tematizzazione<br />
standard con altre definite dall’utente<br />
scegliendo tra:<br />
1. intervalli di uguale ampiezza;<br />
2. uguale numero di occorrenze;<br />
3. totalmente personalizzata.
Appendice B Analisi di fattibilità e redazione dei<br />
capitolati<br />
Il paragrafo riporta alcuni elementi di<br />
utilità per le amministrazioni che intendano<br />
effettuare analisi PD/DS e comprende<br />
indicazioni per l’effettuazione dell’analisi di<br />
fattibilità e per la redazione di capitolati.<br />
B-1 Fattibilità<br />
Un’amministrazione che intenda<br />
commissionare un’analisi PS/DS avente come<br />
fine la identificazione e caratterizzazione<br />
di fenomeni franosi dovrebbe effettuare<br />
un’analisi di fattibilità che consideri i seguenti<br />
punti.<br />
Elementi da valutare per analisi a scala<br />
regionale o provinciale:<br />
- quali sono le coperture satellitari<br />
disponibili per l’analisi PS/DS sull’area di<br />
interesse, quante immagini sono disponibili<br />
(sia per le orbite ascendenti che per quelle<br />
discendenti) e quale arco di tempo coprono;<br />
- attenta valutazione delle coperture<br />
-<br />
relative ai satelliti utilizzati per l’analisi e<br />
suo confronto con l’area che si intende<br />
investigare. Poiché l’acquisto delle immagini<br />
rappresenta, di norma, la maggior frazione<br />
della spesa è possibile che escludendo, ad<br />
esempio, una minima porzione di territorio,<br />
non sia necessario acquistare un intero set<br />
di immagini, con risparmio considerevole;<br />
valutazione delle condizioni di innevamento;<br />
le zone innevate sono di interpretazione<br />
più problematica in quanto sono di norma<br />
disponibili solo immagini per una parte<br />
dell’anno (non vi sono PS/DS in area<br />
innevata);<br />
- valutazione generale (tramite l’utilizzo di<br />
strumenti quali quello descritti al capitolo<br />
4) di quale percentuale di territorio meglio<br />
si presti all’analisi PS/DS. Valutazioni<br />
sfavorevoli (vuoi per la copertura al suolo<br />
vuoi per le relazioni geometriche terrenosatellite)<br />
potrebbero sconsigliare o rendere<br />
antieconomica un’indagine PS/DS.<br />
Elementi da valutare per analisi a scala di<br />
dettaglio od a scala della singola frana:<br />
- quali sono le coperture satellitari disponibili<br />
per l’analisi PS/DS che meglio si prestano<br />
(in termini di: intervallo temporale, numero<br />
di immagini disponibili, densità di punti<br />
ecc. ) alla caratterizzazione del fenomeno;<br />
- valutazione delle eventuali condizioni di<br />
innevamento; se la neve è presente al suolo<br />
per molti mesi all’anno potrebbe essere<br />
opportuno richiedere analisi separate per i<br />
diversi periodi dell’anno;<br />
- valutazione della densità dei potenziali PS/<br />
DS al suolo (preferibilmente tramite analisi<br />
aereofotografica, rilievo diretto, utilizzo di<br />
coperture GIS a scala adeguata);<br />
- attenta valutazione della tipologia di<br />
movimento franoso, per verificare che<br />
rientri nelle classi di velocità indagabili dalla<br />
tecnica (vedi capitolo 4-5);<br />
- attenta valutazione dell’orientazione<br />
spaziale del versante e dei vettori cinematici<br />
attesi rispetto ai parametri geometrici delle<br />
coperture satellitari disponibili. In generale i<br />
versanti orientati lungo l’asse EO si prestano<br />
di gran lunga meglio all’analisi che non<br />
quelli ad orientazione NS.<br />
Appendici<br />
179
180<br />
B.2 Redazione di capitolati<br />
Si riportano di seguito alcune considerazioni<br />
utili per la redazione di un capitolato di<br />
gara per analisi PS/DS. La fattispecie, infatti,<br />
presenta alcune peculiarità che possono<br />
creare problemi in fase di redazione dei<br />
documenti stessi.<br />
Aspetti generali ed amministrativo-finanziari<br />
L’analisi PS/DS è una tecnica relativamente<br />
recente, innovativa ed in rapida evoluzione.<br />
Al momento della stesura delle presenti note<br />
(marzo 2012) sono numerosi i soggetti (istituti<br />
di ricerca, università, società di ingegneria<br />
ecc.) che, disponendo delle immagini, sono<br />
in grado di effettuare elaborazioni a scala<br />
locale o su aree limitate. Per contro, un<br />
numero estremamente limitato di soggetti<br />
(meno di 10 a scala mondiale, la metà circa a<br />
scala europea) è in grado di effettuare analisi<br />
a livello provinciale o regionale. Ciascuno<br />
di tali soggetti effettua le elaborazioni<br />
sulla base di algoritmi proprietari che, pur<br />
operando in maniera consimile, presentano<br />
un certo margine di diversità. Non è quindi<br />
possibile richiedere, a livello di capitolato,<br />
un algoritmo specifico anziché un altro e,<br />
<strong>nella</strong> formulazione del capitolato, occorrerà<br />
richiamare i prodotti richiesti e le relative<br />
caratteristiche più che non una certa specifica<br />
modalità di elaborazione e trattamento dei<br />
dati.<br />
Quanto sopra può presentare un ulteriore<br />
problema qualora un’amministrazione intenda<br />
effettuare un indagine per estendere la serie<br />
temporale di una già affidata in precedenza.<br />
In tal caso, causa la diversità degli algoritmi<br />
prima richiamata, l’incarico può essere affidato<br />
unicamente al soggetto che ha già effettuato<br />
l’indagine precedente, a meno di non avere<br />
due serie temporali tra di loro discontinue. In<br />
altri termini se:<br />
- il soggetto A ha vinto nel 2008 una gara per<br />
effettuare un’analisi di immagini satellitari<br />
dalla piattaforma Y per l’intervallo 2002-<br />
2008;<br />
- nel 2012 l’amministrazione intende affidare<br />
un ulteriore incarico per estendere la<br />
copertura dalla piattaforma Y sino a tutto il<br />
2012;<br />
l’incarico potrà essere affidato unicamente<br />
al soggetto A; elaborazioni da parte di altri<br />
soggetti porterebbero a due serie storiche<br />
separate e difficilmente confrontabili (2002-<br />
2008 e 2008-2012), cosa tecnicamente poco<br />
accettabile e, soprattutto, poco utile. In<br />
alternativa, affidato l’incarico ad un secondo<br />
soggetto (B), si potrebbe richiedere allo<br />
stesso di acquistare e rielaborare tutta la<br />
serie di immagini dal 2002 al 2012, cosa<br />
che comporterebbe però un forte (ed<br />
ingiustificato) aggravio di costi. La questione<br />
potrebbe essere risolta mediante i disposti<br />
dell’ art. 57/2b del Codice degli Appalti (D.Lgs.<br />
163/2006), relativo alla privativa industriale ma<br />
potrebbero comunque sussistere questioni di<br />
ordine legale relativamente al fatto che, con<br />
tali meccanismi, il soggetto A avrebbe di fatto<br />
“ipotecato” qualsiasi incarico successivo.<br />
Il soggetto che effettua le elaborazioni<br />
non è il soggetto che produce le immagini<br />
satellitari necessarie, che devono quindi<br />
essere acquistate. L’acquisto delle immagini<br />
rappresenta il costo maggiore delle<br />
elaborazioni (dell’ordine del 70%). I soggetti<br />
che forniscono le immagini sono diversi:<br />
alcuni privati, altri pubblici altri ancora<br />
parte privati e parte pubblici; le politiche di<br />
vendita sono diverse, come diversi sono i<br />
rapporti commerciali che le (poche) società<br />
che svolgono indagini a scala regionale<br />
intrattengono con i fornitori di immagini.<br />
Questo fa sì che a seconda dei soggetti<br />
coinvolti e dell’area da coprire i costi delle<br />
immagini possano essere anche di molto<br />
differenti. Benché tale elemento sia piuttosto<br />
ininfluente per la stazione appaltante occorre<br />
però tener conto che potrebbe fornire<br />
materia per ricorsi o per contenziosi relativi<br />
alla correttezza degli importi di base d’asta
(… era noto che il soggetto X disponeva già<br />
delle immagini W, T e D avendo effettuato un’<br />
analisi per la regione limitrofa e che inoltre, in<br />
funzione dell’accordo VVVV, lo stesso soggetto<br />
poteva ottenere sull’area di interesse un prezzo<br />
più basso sulle immagini, pertanto ecc. ecc. …).<br />
In linea di massima, la PA interessata effettua<br />
una gara per effettuare un’elaborazione, che<br />
norma non prevede la proprietà del dato<br />
originale (più costosa). Una successiva<br />
divulgazione in toto (ad esempio via internet)<br />
delle risultanze delle elaborazioni potrebbe<br />
quindi collidere con le specifiche contrattuali.<br />
Sul capitolato occorre quindi specificare se, e<br />
con quali modalità, l’amministrazione intende<br />
divulgare le risultanze. In linea di larga<br />
massima, la divulgazione dei dati tramite<br />
semplice visualizzazione non dovrebbe<br />
comportare alcuna problematica particolare<br />
mentre la possibilità di scarico dei dati<br />
vettoriali dovrebbe essere prevista in chiaro<br />
nel capitolato. Nessun problema comporta<br />
invece la libera diffusione di elaborazioni delle<br />
risultanze (aree anomale ecc. , vedi cap. 4).<br />
Data la già citata unicità degli algoritmi, la<br />
stazione appaltante deve anche prevedere nel<br />
capitolato di essere sollevata da qualsivoglia<br />
responsabilità legale nel caso che l’affidatario<br />
utilizzi in maniera fraudolenta algoritmi od<br />
applicativi da altri brevettati.<br />
Un altro punto particolarmente delicato è<br />
quello del collaudo e della validazione delle<br />
risultanze. Data la fattispecie non sono infatti<br />
applicabili i classici disposti di legge che<br />
prevedono controlli a campione (di norma del<br />
5%) dei dati forniti. Questo perché la natura<br />
della tecnica e della relativa elaborazione<br />
impedisce che si possano verificare<br />
sistematicamente e puntualmente, con altre<br />
tecniche di tipo topografico, gli spostamenti<br />
rilevati da PS/DS, tanto più su di un numero<br />
di punti enorme (alcuni milioni nel caso di<br />
indagini a scala regionale o provinciale). Per<br />
la validazione ed il collaudo si suggerisce<br />
quindi un meccanismo quale quello infra<br />
riassunto.<br />
- Creazione di una commissione di<br />
verifica e collaudo che includerà tecnici<br />
dell’amministrazione appaltante ed anche<br />
tecnici di altre amministrazioni, istituti<br />
universitari o di ricerca che abbiano<br />
esperienza di trattamento dati PS/DS.<br />
Tale commissione svolgerà la verifica<br />
in contraddittorio con tecnici incaricati<br />
dall’affidatario. Potrebbe essere opportuno<br />
richiedere, già in sede di capitolato, che le<br />
imprese partecipanti forniscano almeno un<br />
nominativo di tecnico di istituti universitari<br />
o di ricerca (con esperienza di trattamento<br />
dati PS/DS) che affiancherà i tecnici<br />
-<br />
dell’impresa stessa in fase di validazione e<br />
collaudo.<br />
Verifica che la fornitura, per quanto riguarda<br />
la densità di bersagli rilevati, gli scostamenti<br />
dei valori di deviazione standard delle<br />
velocità medie e delle quote, rientrino negli<br />
standard prestabiliti.<br />
- Verifica che l’insieme dei dati presentati<br />
e delle relative velocità medie siano<br />
-<br />
verosimili e congruenti con le conoscenze<br />
generali delle zone indagate.<br />
Controllo a campione dei valori di velocità<br />
registrati da alcuni gruppi di bersagli<br />
radar compresi nel territorio indagato,<br />
nell’intorno dei quali siano disponibili dati<br />
di monitoraggio geotecnico o topografico<br />
in numero sufficiente da formulare modelli<br />
cinematici attendibili; la totale mancanza<br />
di coerenza tra i due gruppi di dati (PS/<br />
DS e convenzionali) su una frazione non<br />
trascurabile del campione può essere letta<br />
come inadeguatezza delle analisi effettuate.<br />
Aspetti tecnici<br />
Nel definire a livello di capitolato le<br />
caratteristiche dell’indagine, specificare:<br />
- in modo chiaro l’area per la quale si richiede<br />
l’analisi;<br />
- le piattaforme satellitari da utilizzare;<br />
- quali gruppi di immagini utilizzare:<br />
ascendenti, discendenti od entrambe;<br />
Appendici<br />
181
182<br />
- l’intervallo di tempo da prendere in<br />
-<br />
considerazione;<br />
il numero/numero di minimo di immagini<br />
da utilizzare per l’elaborazione;<br />
- la tecnica da utilizzare, per le considerazioni<br />
viste sopra, è opportuno utilizzare<br />
la denominazione “utilizzo della<br />
tecnica denominata Persistent Scatterer<br />
-<br />
Interferometry (PSI)”, termine generale che<br />
comprende l’intera famiglia delle tecniche<br />
al momento disponibili;<br />
se devono o meno essere consegnate, al<br />
termine dell’indagine, le immagini radar<br />
utilizzate per l’elaborazione; si tenga<br />
-<br />
presente che la consegna delle immagini<br />
comporta di norma un forte aggravio dei<br />
costi;<br />
qual’è il fine principale dell’indagine (es.<br />
identificazione dei fenomeni di instabilità<br />
sui versanti) al fine di permettere<br />
-<br />
l’ottimizzazione dell’indagine per tale fine;<br />
che la scelta dei punti di riferimento sarà<br />
effettuata di concerto con i geologi della<br />
stazione appaltante: questo per evitare che<br />
gli stessi punti, essenziali per una corretta<br />
elaborazione, siano scelti in area instabile<br />
dal punto di vista geologico;<br />
- quale tipo di elaborazione effettuare per le<br />
zone sottoposte a forte innevamento;<br />
- quale tipo di proiezione utilizzare per la<br />
restituzione dei dati (si suggerisce il formato<br />
WGS84 geografico).<br />
Prodotti da fornire.<br />
Segue un elenco di massima con i prodotti<br />
che, da capitolato, dovrebbero essere forniti.<br />
Relazione tecnica<br />
Relazione tecnica generale che illustri<br />
in dettaglio le modalità di acquisizione<br />
ed elaborazione dati e che contenga<br />
tutti i parametri necessari per successive<br />
elaborazioni quali:<br />
- Selezione dei dati.<br />
- Selezione dell’immagine master.<br />
- Principi di funzionamento dell’algoritmo<br />
PSI, e del modello di spostamento utilizzato.<br />
- Coseni direttori dei frame radar.<br />
- Risultati dataset discendenti e ascendenti.<br />
- Scelta dei punti di riferimento.<br />
- Campo di velocità registrato.<br />
- Struttura del database dei risultati.<br />
- Precisione ed accuratezza del dato (sia in<br />
termini di posizionamento spaziale sia di<br />
campi di velocità riscontrati nelle diverse<br />
subaree processate).<br />
Dati in formato numerico<br />
Per ciascuna area o subarea <strong>nella</strong> quale<br />
l’area di indagine è suddivisa e per ciascun<br />
dataset (ascendente e discendente) devono<br />
essere forniti:<br />
a. Shape file con il punto di riferimento;<br />
b. Shape file con listato dei PS individuati<br />
<strong>nella</strong> subarea;<br />
c. Shape file con le serie storiche degli<br />
spostamenti per ogni PS individuato.<br />
I file di cui al punto a) dovranno contenere<br />
le coordinate geografiche, la data relativa<br />
alla prima ed all’ultima immagine del dataset<br />
utilizzato e quella della master image, nonché<br />
la quota associata al punto di riferimento<br />
adottato.<br />
I file di cui al punto b) dovranno contenere<br />
le seguenti informazioni:<br />
- codice identificativo univoco del punto di<br />
misura all’interno del file;<br />
- coordinate geografiche del punto;<br />
- data relativa alla prima immagine del<br />
dataset utilizzato;<br />
- data relativa all’ultima immagine del dataset<br />
utilizzato;<br />
- data della master image;<br />
- parametro di qualità del target; “coerenza”<br />
- quota del PS calcolata rispetto all’ellissoide<br />
di riferimento WGS84;<br />
- deviazione standard del valore di quota;
- velocità media annua di spostamento<br />
(mm/a) misurata lungo la linea di vista<br />
del sistema (LOS) e stimata sull’intero arco<br />
temporale in cui sono state acquisite le<br />
immagini; l’entità della velocità di ciascun<br />
PS/DS è relativa al punto di riferimento,<br />
considerato per ipotesi a velocità nulla;<br />
- deviazione standard della velocità media<br />
annua.<br />
I file di cui al punto c) dovranno contenere<br />
le seguenti informazioni:<br />
- codice identificativo univoco del punto di<br />
misura all’interno del file;<br />
- valori di spostamento relativo (mm)<br />
associati a ciascun PS/DS, dai quali è<br />
possibile ricostruire la serie storica del<br />
punto di misura rispetto al valore zero.<br />
Tolleranze<br />
In linea di massima le tolleranze relative ai<br />
valori di deviazione standard della velocità<br />
media annua per ogni subarea oggetto<br />
dell’indagine dovrebbero essere ± 2 mm a -1<br />
per le analisi a scala provinciale/regionale e ±<br />
1 mm a -1 per le analisi a scala locale.<br />
assistenza<br />
Al fine di poter risolvere eventuali<br />
problematiche che possano riscontrarsi in<br />
fase di interpretazione dei dati da parte<br />
della committente, occorre prevedere in<br />
capitolato un servizio di assistenza per una<br />
durata adeguata all’entità dell’indagine.<br />
In linea di larga massima si suggerisce un<br />
periodo minimo di sei mesi (per analisi locali)<br />
che può arrivare a 24 mesi per indagini a<br />
scala regionale. Tale servizio deve prevedere<br />
essenzialmente la disponibilità dei tecnici che<br />
hanno eseguito materialmente le elaborazioni<br />
a fornire qualsiasi delucidazione, chiarimento<br />
o verifica circa i dati ottenuti e le procedure<br />
di analisi utilizzate, ivi inclusa la possibilità<br />
di ripetere alcune elaborazioni modificando<br />
i punti di riferimento o i parametri<br />
dell’algoritmo di calcolo utilizzato.<br />
Appendici<br />
183
Appendice C Scheda per il censimento dei bersagli<br />
radar sui fabbricati sviluppata dall’Università di<br />
genova, Dip. Ingegneria Costruzioni, Ambiente e<br />
Territorio per la Regione Liguria.<br />
Appendici<br />
185
186
Appendici<br />
187
188
Bibliografia di base<br />
Berardi R., Baretto A., Poggi F. (2009) Analysis<br />
of structure and infrastructure movements via<br />
PSInSAR data over large areas (poster). Geoitalia<br />
VII Forum Italiano di Scienze della Terra. 9-11<br />
Settembre 2009, Rimini;<br />
Bottero D., Cespa S., Poggi F. (2006) Nuove<br />
tecnologie di analisi delle frane - Il Monitoraggio<br />
<strong>satellitare</strong>: primi risultati in Liguria della<br />
sperimentazione dell’utilizzo della tecnica PSInSAR.<br />
Quarry and Construction, Anno XLIV, N. 526 pagg.<br />
87-99.<br />
Burgmann R., Hilley G., Ferretti A., Novali F. (2006)<br />
Resolving vertical tectonics in the San Francisco<br />
Bay Area from permanent scatterer InSAR and GPS<br />
analysis. Geology, March 2006, Volume 34, N. 3, pp.<br />
221-224<br />
Cascini L., Fornaro G., Peduto D. (2010) Advanced<br />
low- and full-resolution DInSAR map generation<br />
for slow-moving landslide analysis at different<br />
scales, Engineering Geology, Volume 112, Issues<br />
1–4, 26 March 2010, Pages 29-42, ISSN 0013-7952,<br />
10.1016/j.enggeo.2010.01.003.<br />
Ceriani M., Colombo A., Meisina C., Notti D., Poggi<br />
F., Roccati A., Zaccone A, Zucca F. (2011) The use of<br />
PSInSAR and SqueeSAR techniques for updating<br />
landslide inventories: Piedmont, Lombardy and<br />
Liguria case study. Catani F., Margottini C., Trigila<br />
C., Iadanza C. (Eds), The Second World Landslide<br />
Forum, Abstract book, 3-9 ottobre 2011, FAO,<br />
Roma, Italy, ISPRA, 71, ISBN 9788844805159<br />
Cigna F., Del Ventisette C., Liguori V. and Casagli<br />
N. (2011) Advanced radar-interpretation of InSAR<br />
time series for mapping and characterization of<br />
geological processes Natural Hazards and Earth<br />
System Science, Volume 11, Issue 3, 2011, pp.865-<br />
881<br />
Colesanti C., Ferretti A., Prati C., Rocca F. (2003)<br />
Monitoring Landslides and Tectonic Motions with<br />
the Permanent Scatterers Technique. Engineering<br />
Geology, N. 68, 2003; pages 3-14<br />
Colesanti C., Ferretti A., Novali F., Prati C., Rocca F.<br />
(2003) SAR Monitoring of Progressive and Seasonal<br />
Ground Deformation Using the Permanent<br />
Scatterers Technique. IEEE TGARS, Vol. 41, N. 7, July<br />
2003; pp. 1685-1701<br />
Colesanti C. and Wasowsky J. (2006) Investigating<br />
landslides with space-borne Synthetic Aperture<br />
Radar (SAR) interferometry- Eng Geol., 88, 173-199<br />
Colombo, A., Mallen, L., .Pispico, R., Giannico C.,<br />
Bianchi M. & Savio G. (2006). Mappatura regionale<br />
delle aree monitorabili mediante l’uso della tecnica<br />
PS In Proceedings of 10° National Conference<br />
ASITA, 14 - 17 November 2006, Bolzano<br />
Cruden D.M., Varnes, D.J., 1994. Landslides Types<br />
and Processes. In: Turner A.K. & Schuster R.L.<br />
(Eds.) Landslides: Investigation and Mitigation.<br />
Transportation Research Board Special Report 247.<br />
National Academy Press, WA, 36-75.<br />
Dixon T., Amelung F., Ferretti A., Novali F., Rocca<br />
F., Dokka R., Sella G., Kim S., Wdowinski S., Whitman<br />
D. (2006) Subsidence and Flooding in New Orleans.<br />
Nature, Vol. 441, June 2006<br />
Enotarpi M. (2011) Problematiche di dissesto<br />
idrogeologico frazione di Ville S. Pietro. Studio<br />
geologico-tecnico professionale.<br />
Federici P.R., Capitani M., Chelli A., Del Seppia<br />
N., Serani A., 2004. Atlante dei centri instabili<br />
della Liguria –Vol. IV, Provincia di Imperia e Vol. II,<br />
Provincia di Genova. Programma speciale SCAI del<br />
CNR-GNDI Regione Liguria<br />
Ferretti A., Fumagalli A., Novali F., Prati C., Rocca<br />
F., Rucci A. (2010) A new algorithm for processing<br />
interferometric data-stacks: SqueeSAR. IEEE Trans.<br />
on Geoscience and Remote Sensing, September<br />
2011<br />
Ferretti A., Prati C., Rocca F. (2001) Permanent<br />
Scatterers in SAR Interferometry. IEEE Transactions<br />
on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 39, NO. 1,<br />
January 2001, Pages 8 – 20<br />
Ferretti A., Prati C., Rocca F. (2000) Nonlinear<br />
Subsidence Rate Estimation Using Permanent<br />
Scatterers in Differential SAR Interferometry. IEEE<br />
Transactions on Geoscience and Remote Sensing,<br />
Vol. 38, NO. 5, September 2000, pp. 2202 – 2212<br />
Greif, V. and Vlcko, J. (2011): Monitoring of<br />
post-failure landslide deformation by the PS-<br />
InSAR technique at Lubietova in Central Slovakia,<br />
Environmental Earth Sciences, doi:10.1007/s12665-<br />
011-0951-x<br />
Hilley G., Bürgmann R., Ferretti A., Novali F., Rocca<br />
F. (2004) Dynamics of Slow-Moving Landslides from<br />
Permanent Scatterer. Analysis, Science, Vol. 304, 25<br />
June 2004 Volume 304, Number 5679, Pages 1952-<br />
1955<br />
Lu P., Casagli N., Catani F., Tofani V. (2011).<br />
Persistent Scatterers Interferometry Hotspot and<br />
Cluster Analysis (PSI-HCA) for extremely slow<br />
moving landslides detection. INTERNATIONAL<br />
JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol. 0, pp. 1-12,<br />
ISSN:0143-1161
Meisina C., Zucca F., Notti D., Colombo A., Cucchi<br />
A., Savio G., Giannico C. and Bianchi M. (2008).<br />
Geological interpretation of PSInSAR data at<br />
regional scale. Sensors 8, 7469-7492; DOI: 10.3390/<br />
sensor<br />
Notti. D., Meisina C., Zucca F & Colombo A.<br />
(2011). models to predict persistent scatterers<br />
data distribution and their capacity to register<br />
movement along the slope In Proceedings<br />
of Fringe 2011 ESA Workshop, Frascati 19 -23<br />
September 2011<br />
Notti D., Meisina C., Zucca F. Crosetto M. and<br />
Montserrat O. (2011) Factors that have an<br />
influence on time series Proceedings Fringe<br />
20011, 17-23 September 2011 ESRIN, Frascati, Italy<br />
Poggi F., Riccelli G. (2011) PSI technique for slow<br />
landslides analysis: a useful tool to handle with<br />
care. International Journal of Remote Sensing,<br />
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/014<br />
31161.2011.565376;<br />
Roccati A. (2011) Assetto geomorfologico e<br />
fenomeni di instabilità del versante compreso tra<br />
la dorsale dei monti Penna, Aiona, degli Abeti ed<br />
il Torrente Gramizza (Alta Val d’Aveto, Appennino<br />
Ligure). Tesi di Dottorato di Ricerca, Università<br />
degli Studi di Genova<br />
Testi consigliati<br />
- nota tecnica sintetica per la comprensione<br />
del dato PSinSar.<br />
Nota che riassume i principi del metodo PSInSAR,<br />
i limiti dello stesso e la tecnica delle aree anomale<br />
adottate per la presentazione dei dati; (http://<br />
webgis.arpa.piemonte.it/website/ps_ers_06/doc/<br />
guida_sintetica.pdf)<br />
- PSinSar - Manuale d`uso.<br />
Metadocumentazione prodotta dalla Telerilevamento<br />
Europa TRE di Milano, che descrive la<br />
produzione del dato dal rilevamento <strong>satellitare</strong><br />
sino al PS; http://webgis.arpa.piemonte.it/website/<br />
ps_ers_06/doc/manuale_ps.pdf<br />
- linee guida interpretazione PS.<br />
Metadocumentazione prodotta da Arpa Piemonte<br />
in collaborazione con l’Università di Pavia<br />
che descrive il processo di elaborazione e di<br />
presentazione dei dati sino alla creazione delle<br />
aree anomale nonché la valutazione di dettaglio<br />
su alcuni siti campione sul territorio regionale;<br />
http://webgis.arpa.piemonte.it/website/ps_ers_06/<br />
doc/linee_guida.pdf<br />
- Guida sintetica alla lettura della Scheda “aree<br />
anomale”.<br />
Breve documento necessario per la corretta<br />
comprensione della scheda allegata a ciascuna<br />
geometria consultabile da web e scaricabile.<br />
http://webgis.arpa.piemonte.it/website/ps_ers_06/<br />
doc/guida_aree_anomale.pdf<br />
- nota sintetica per la comprensione del dato<br />
<strong>satellitare</strong> PSinSar e Squeesar.<br />
Nota che riassume i principi delle due tecniche ed<br />
i loro limiti.<br />
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/<br />
<strong>RiskNat</strong>/doc/NOTA%20SINTETICA_PSInSAR.pdf<br />
- nota sintetica per l’interpretazione e l’utilizzo<br />
delle aree anomale individuate sulla base dei<br />
dati satellitari PSinSar e Squeesar.<br />
Documento sintetico che illustra i principi di base<br />
e fornisce le istruzioni per un corretto uso delle<br />
aree anomale estratte da dati interferometrici.<br />
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/<br />
<strong>RiskNat</strong>/doc/METADATI_AREE_ANOMALE.pdf<br />
- Ministero dell’ambiente (2009) Linee guida<br />
per l’analisi di dati interferometrici satellitari in<br />
aree soggette a dissesti idrogeologici - Piano<br />
Straordinario di Telerilevamento Ambientale<br />
(PST-A) Lotto 2- http://www.pcn.minambiente.<br />
it/GN/leggi/LINEE%20GUIDA%20PER%20<br />
ANALISI%20DI%20DATI.pdf<br />
- STRATEGIC INTERREG III B PROJECT CLIMCHALP:<br />
Climate Change, Impacts and Adaptation<br />
Strategies in the Alpine Space (ClimChAlp). WP 6 -<br />
Monitoring, Prevention & Management of Specific<br />
Effects of Climate Change on Nature. Slope<br />
Monitoring Methods A State of the Art Report;<br />
http://climchalp.uirs.si/podatki/ClimChAlp_Slope_<br />
Monitoring_Methods.pdf
Questo libro è stato stampato rispettando l’ambiente<br />
Stampato rispettando<br />
l'ambiente<br />
. con energia rinnovabile<br />
. offset senza sviluppo chimico<br />
. inchiostri a base vegetale<br />
www.eco-print.it<br />
Finito di stampare nel mese di<br />
maggio 2012<br />
da Grafica KC<br />
stampatori in Genova