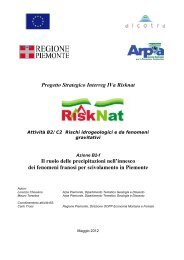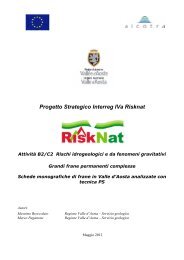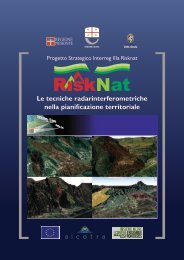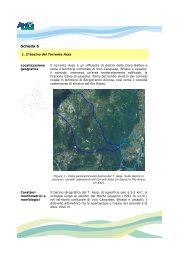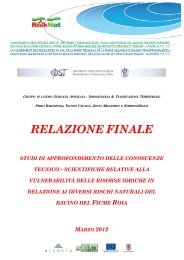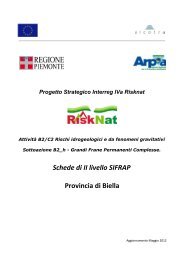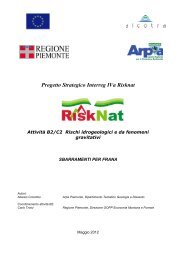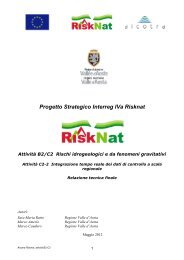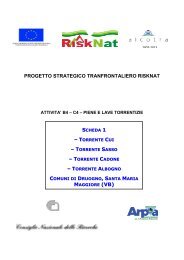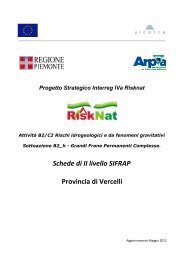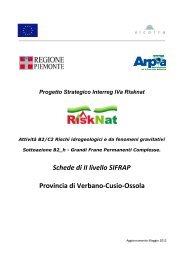Inventario dei conoidi alluvionali in Piemonte - RiskNat
Inventario dei conoidi alluvionali in Piemonte - RiskNat
Inventario dei conoidi alluvionali in Piemonte - RiskNat
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2007‐2013PROGETTO STRATEGICO TRANFRONTALIERO RISKNATATTIVITA’ B4 – C4 – PIENE E LAVE TORRENTIZIEINVENTARIO DEI CONOIDIALLUVIONALI IN PIEMONTERedazione:C. Giampani, C. Girelli, F. Marco, G. Moletta, - Arpa <strong>Piemonte</strong> – Dipartimento TematicoGeologia e Dissesto, Via Pio VII, 9 10135 Tor<strong>in</strong>o – ItalyG. Bellardone – Regione <strong>Piemonte</strong> – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economiamontana e foreste, C.so Bolzano, 44 – Tor<strong>in</strong>o - Italy
1. INVENTARIO DEI CONOIDI ALLUVIONALI IN PIEMONTELa conoscenza pregressa sui <strong>conoidi</strong> <strong>alluvionali</strong> a livello regionale consiste da un latonel censimento <strong>dei</strong> <strong>conoidi</strong> <strong>in</strong> scala 1:100.0000, realizzato negli anni '80 dalla Regione<strong>Piemonte</strong> e dal CNR-IRPI, e dall’altro nel Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI).Il diverso livello di conoscenza sui fenomeni di dissesto raggiunto negli ultimi decennie l'aff<strong>in</strong>amento degli strumenti tecnici a disposizione hanno offerto l’opportunità di unarevisione generale e di un significativo approfondimento del quadro delle conoscenzesui fenomeni torrentizi e sui <strong>conoidi</strong>. In questo percorso si colloca l’attività <strong>in</strong>trapresada Arpa <strong>Piemonte</strong> nel Progetto <strong>RiskNat</strong> mirata a creare un archivio sui <strong>conoidi</strong><strong>alluvionali</strong> piemontesi, con particolare attenzione alle componenti geologiche s.l. checoncorrono alla caratterizzazione <strong>dei</strong> processi sedimentari attivi.L’ambito di analisi comprende i corsi d’acqua con pendenze medie superiori a 5-7gradi, caratterizzati da confluenze nel recettore poste a quote <strong>in</strong>feriori o uguali a 2000m s.l.m.L'attività svolta a scala regionale si può s<strong>in</strong>tetizzare <strong>in</strong> tre componenti, corrispondentiad altrettanti layer geografici del dataset Conoidi <strong>alluvionali</strong> <strong>in</strong> <strong>Piemonte</strong> delGeoportale <strong>RiskNat</strong>:
1) Distribuzione e classificazione morfologica <strong>dei</strong> <strong>conoidi</strong> <strong>alluvionali</strong> -cartografia numerica di perimetrazione <strong>dei</strong> settori di conoide alluvionale classificatisecondo criteri morfologici con riferimento al corso d’acqua che li ha generati;2) Archivio <strong>conoidi</strong> - copertura numerica puntuale simbolica (baricentro del conoide)per la consultazione <strong>dei</strong> dati contenuti nelle schede alfanumeriche descrittive dellecaratteristiche generali dell’apparato di conoide e delle <strong>in</strong>formazioni disponibili suglieventi pregressi di colata detritica e piena torrentizia;3) Caratterizzazione morfo-litologica <strong>dei</strong> bac<strong>in</strong>i di alimentazione evalutazione a scala regionale della propensione all’<strong>in</strong>nesco <strong>dei</strong> processitorrentizi nelle diverse zone climatiche - copertura numerica di perimetrazione<strong>dei</strong> bac<strong>in</strong>i di alimentazione, prodotta con criteri morfologici e corredata da:a) parametri morfometrici del sistema bac<strong>in</strong>o-conoide,b) classificazione geolitologica del substrato affiorante nel bac<strong>in</strong>o,c) valutazione della severità del fenomeno torrentizio atteso nel bac<strong>in</strong>o e del tempo diritorno delle precipitazioni potenzialmente <strong>in</strong>nescanti <strong>in</strong> base all’area climatica.
Figura 1 - Esempio di perimetrazione <strong>dei</strong> settori di conoide alluvionale
Per l'identificazione <strong>dei</strong> settori di conoide riattivati da fenomeni torrentizi nelle diversezone del <strong>Piemonte</strong> sono state visionate numerose riprese aeree (Tabella 2):Nome Periodo ScalaVolo G.A.I. 1954 – Istituto Geografico Militare 1954 1:35000Volo Ferretti 1978 - Compagnia Riprese Aeree Parma 1978 1:13000Volo alluvione 1994 - Compagnia Riprese Aeree Parma 1994 1:20000Volo 1996 - Aima 1996 1:10000Volo evento 2000 (lotto sud) - Rossi 2001 1:15000Volo alluvione 1968 - IRTA Milano 1968 1:20000Volo 1970 - Istituto Geografico Militare 1970 1:20000Volo alluvione 1987 - Alifoto 1987 1:14000Volo 1991 - Regione <strong>Piemonte</strong> 1991 1:37000Volo alluvione Ossola 1978 - Alifoto 1978 1:25000Volo 1951 - Istituto Geografico Militare 1951 1:20.000Volo Orco 1973 - Alifoto 1973 1:20000Volo evento 2000 Orco - Compagnia Riprese Aeree Parma 2000 1:13000Volo Traversella 1969 - Rossi 1969 1:15000Volo alluvione 1981 - Ferretti 1981 1:25000Volo 1970 - Istituto Geografico Militare 1970 1:25000Volo evento 2000 (lotto nord) - Compagnia Riprese AereeParma2000 1:15000Tabella 2 - Riprese aeree consultate per l’identificazione <strong>dei</strong> settori di conoideriattivati da fenomeni torrentizi
Ogni geometria è corredata dall’<strong>in</strong>formazione sull’eventuale contributo di fenomenigravitativi e valanghivi nella genesi e nell’alimentazione del settore di conoide.Per l'identificazione del contributo di fenomeni valanghivi si è fatto riferimento alSistema Informativo Valanghe di Arpa <strong>Piemonte</strong> e a dati di archivio.I codici <strong>dei</strong> <strong>conoidi</strong> sono stati att<strong>in</strong>ti dal Sistema Informativo Territoriale Ambientaledella Regione <strong>Piemonte</strong> <strong>in</strong>tegrato laddove necessario da nuove aste o, per corsid’acqua esistenti ma privi di nomenclatura, dall’attribuzione di un nome att<strong>in</strong>todall’orografia o da località <strong>in</strong> posizione significativa rispetto al bac<strong>in</strong>o, quandopossibile.Per ogni conoide è <strong>in</strong>dicato l’ambito vallivo (Macrobac<strong>in</strong>o) di appartenenza.Le geometrie descritte <strong>in</strong> questo paragrafo sono contenute e scaricabili dal layergeografico “Distribuzione e classificazione morfologica <strong>dei</strong> <strong>conoidi</strong> <strong>alluvionali</strong>”attraverso il servizio WebGIS, sul geoportale <strong>RiskNat</strong>.1.2 ARCHIVIO CONOIDIL’archivio <strong>conoidi</strong> è visitabile attraverso una copertura geografica simbolica di ogniapparato di conoide, i cui attributi, accanto al codice identificativo univoco del conoide,sono schematizzabili <strong>in</strong>:• maggiori <strong>in</strong>formazioni di natura morfologica sull’apparato di conoide nel suocomplesso: evoluzione morfologica dell’apparato, posizione rispetto alfondovalle, posizione rispetto ad altri <strong>conoidi</strong>, grado di <strong>in</strong>cisione/artificialità delcanale attivo <strong>in</strong> conoide, caratteristiche morfo-litologiche dell’apice, punti diesondazione potenziale <strong>dei</strong> deflussi nel tratto <strong>in</strong> conoide;• <strong>in</strong>formazioni relative ai dissesti e ai processi torrentizi storici afferenti aciascun corso d'acqua, <strong>in</strong> forma di Report delle schede danni della Banca DatiStorici di Arpa <strong>Piemonte</strong> aggiornati al 2012.Maggiori <strong>in</strong>formazioni sono contenute nella metadocumentazione specifica “Archivio<strong>conoidi</strong> Descrizione dato”.Il layer geografico è “Archivio <strong>conoidi</strong>” nel servizio WebGIS, sul geoportale <strong>RiskNat</strong>.
1.3 CARATTERIZZAZIONE MORFO-LITOLOGICA DEI BACINI DI ALIMENTAZIONE EVALUTAZIONE A SCALA REGIONALE DELLA PROPENSIONE ALL’INNESCO DEIPROCESSI TORRENTIZI NELLE DIVERSE ZONE CLIMATICHEI bac<strong>in</strong>i di alimentazione <strong>dei</strong> <strong>conoidi</strong> piemontesi sono stati perimetrati secondo criterimorfologici con l’ausilio delle più recenti ortofotoimmag<strong>in</strong>i disponibili per tutto ilterritorio piemontese (Ortofoto terraitaly IT2000 - aggiornamento 2007) e della CartaTecnica Regionale <strong>in</strong> scala 1:10.000.I parametri morfometrici (superficie del bac<strong>in</strong>o, superficie del conoide, <strong>in</strong>dice diMelton) derivano da analisi <strong>in</strong> ambiente GIS effettuate con l’ausilio del Modello Digitaledel Terreno della Regione <strong>Piemonte</strong> (maglia 10 m x 10 m).Per la classificazione del substrato roccioso affiorante nei bac<strong>in</strong>i è stata utilizzatapr<strong>in</strong>cipalmente la Carta Geologica d’Italia <strong>in</strong> scala 1:100.000, <strong>in</strong>tegrata laddovepossibile con le <strong>in</strong>formazioni contenute nella Carta geologica d’Italia <strong>in</strong> scala 1:50.000e con Cartografie geologiche e geomorfologiche di maggiore dettaglio disponibili nellaBanca Dati di Arpa <strong>Piemonte</strong>.La classificazione litologica, applicata ad oltre 2000 bac<strong>in</strong>i idrografici di ambito alp<strong>in</strong>o,permette di valutare il tipo di processo torrentizio che può verificarsi <strong>in</strong> conoide conmaggiore probabilità (Tiranti et al., 2008; De Angeli et al., 2011; Marco et al., 2012).Il substrato roccioso affiorante nei bac<strong>in</strong>i afferenti ai <strong>conoidi</strong> è stato ricondotto a treclassi pr<strong>in</strong>cipali, che si differenziano per tipologia e granulometria del deposito chederiva dalla disgregazione delle rocce e <strong>in</strong> particolare per il ruolo giocato dalla matricef<strong>in</strong>e nei processi che <strong>in</strong> caso di apporto idrico improvviso <strong>in</strong>teressano il reticoloidrografico, a determ<strong>in</strong>are un flusso altamente, mediamente o scarsamente coesivo.Per questa analisi sono stati considerati i bac<strong>in</strong>i idrografici che non contengono al loro<strong>in</strong>terno <strong>conoidi</strong> <strong>alluvionali</strong> e quelli <strong>in</strong> zona appenn<strong>in</strong>ica, che saranno trattati dal puntodi vista dell’analisi litologica di dettaglio <strong>in</strong> una successiva fase di lavoro.Il litotipo affiorante nel bac<strong>in</strong>o <strong>in</strong> modo prevalente, date le pendenze rilevanti <strong>in</strong> gioco,è stato ricavato considerando la superficie effettiva di affioramento con l’ausilio del
Modello Digitale del Terreno; il litotipo prevalente fa ricadere il bac<strong>in</strong>o stesso <strong>in</strong> unadelle seguenti classi: a) Excellent Clay Maker – ECM (Figura 2), b) Good Clay Maker –GCM (Figura 3), c) Bad Clay Maker – BCM (Figura 4), che identificano rispettivamentebac<strong>in</strong>i il cui substrato è costituito prevalentemente da:a) rocce metamorfiche fittamente foliate e ricche <strong>in</strong> m<strong>in</strong>erali fillosilicatici(calcescisti filladici, black shale, argilloscisti) e/o rocce sedimentarie ricche <strong>in</strong>m<strong>in</strong>erali argillosi;b) rocce carbonatiche massicce (calcari massicci, dolomie,…);c) rocce ignee o metamorfiche massicce (granitoidi, gneiss, metabasiti, ultrabasiti,quarziti, micascisti massicci).Ciò che dist<strong>in</strong>gue tali famiglie di rocce è la capacità di produrre, a seguito di fenomenidi disgregazione meccanica e fisica rilevanti quantità di m<strong>in</strong>erali argillosi o argillosimili(fillosilicati s.l.) nella frazione f<strong>in</strong>e del detrito. Le caratteristiche della matrice<strong>in</strong>fluenzano <strong>in</strong> modo determ<strong>in</strong>ante una serie di aspetti dist<strong>in</strong>tivi <strong>dei</strong> processi torrentiziche si possono verificare nel bac<strong>in</strong>o, come la reologia e lo stile deposizionale <strong>dei</strong>fenomeni, la distribuzione e la stagionalità prevalente degli <strong>in</strong>neschi, nonché più nellospecifico la tipologia di precipitazione <strong>in</strong> grado di <strong>in</strong>nescarli (estensione, durata ed<strong>in</strong>tensità). Le caratteristiche litologiche <strong>dei</strong> bac<strong>in</strong>i si rispecchiano molto spessonell’architettura e nella morfometria <strong>dei</strong> <strong>conoidi</strong> <strong>alluvionali</strong>.Figura 2 - T. Gioglio (Val Cenischia) (Classe ECM)Figura 3 - Valle Thuras (Classe GCM)
Figura 4 - Omegna. Rio San Rocco (Classe BCM)Nei gruppi ECM e GCM ricadono bac<strong>in</strong>i <strong>in</strong> grado di produrre rispettivamenteabbondanti e discrete quantità di m<strong>in</strong>erali argillosi e argillosimili, a determ<strong>in</strong>are uncomportamento visco-plastico <strong>dei</strong> flussi detritici; i bac<strong>in</strong>i del gruppo BCM produconotrascurabili quantità di tali costituenti della frazione f<strong>in</strong>e, da cui deriva uncomportamento <strong>dei</strong> flussi di tipo collisionale-frizionale.Una cospicua parte <strong>dei</strong> bac<strong>in</strong>i alp<strong>in</strong>i piemontesi, variamente distribuiti dall’Ossola alleValli Cuneesi, ricade nella Classe BCM (Tabella 3, Figura 5, Figura 6); anche gli ECMsono ben rappresentati, mentre i GCM costituiscono meno di un decimo del totale; ibac<strong>in</strong>i non classificati sono quelli per i quali la copertura quaternaria <strong>in</strong> affioramentosupera il 90% della superficie totale del bac<strong>in</strong>o.Classe litotipo prevalente %Excellent Clay Maker 23Good Clay Maker 9Bad Clay Maker 64Tabella 3 - S<strong>in</strong>tesi della classificazione litologica <strong>dei</strong> bac<strong>in</strong>i piemontesi
ECMGCMBCMFigura 5 - Distribuzione delle classi litologiche <strong>dei</strong> bac<strong>in</strong>i alp<strong>in</strong>i piemontesi
20018016014012010080BCMGCMECM6040200TOCE ALTOTOCE MEDIOAGOGNAANZACOLLOBIASCAMELEZZO_OCCIDENTALECERVOSESIA MEDIOSESIASESSERAELVO1401201008060BCMGCMECM40200DORA BALTEACHIUSELLAORCOSOANASTURA DI LANZODORA RIPARIACHISONEPELLICESANGONE
120100806040BCMGCMECM200POVARAITAGRANAMAIRASTURA DI DEMONTEGESSO-VERMENAGNATANARO ALTOFigura 6 - Distribuzione delle tre tipologie di bac<strong>in</strong>o nei diversi contesti vallivi piemontesi
Nell’ambito del Progetto <strong>RiskNat</strong>, l’analisi attraverso matrici <strong>dei</strong> parametrimorfometrici relativi ai bac<strong>in</strong>i e ai <strong>conoidi</strong> (rapporti di superficie, Indice di Melton) edelle classi litologiche ha condotto ad una valutazione a scala regionale della severità<strong>dei</strong> fenomeni attesi (Fa, crescente da 1 a 3) (Figura 7).Fa1Fa2Fa3Figura 7 - Classificazione <strong>dei</strong> bac<strong>in</strong>i sulla base <strong>dei</strong> fenomeni attesi
Studi recenti (Tiranti, 2008; Tiranti et al., 2008; Cremon<strong>in</strong>i et al., 2010; De Angeli etal. 2011) suggeriscono che aff<strong>in</strong>ché si verifichi un debris flow nei tre contesti litologici,sia necessaria un’<strong>in</strong>tensità oraria di pioggia m<strong>in</strong>ima di <strong>in</strong>nesco:- bac<strong>in</strong>i ECM: <strong>in</strong>tensità orarie maggiori o uguali a 20 mm/h;- bac<strong>in</strong>i GCM: <strong>in</strong>tensità orarie maggiori o uguali a 30 mm/h;- bac<strong>in</strong>i BCM: <strong>in</strong>tensità orarie maggiori o uguali a 50 mm/h.Tali valori di soglia nell’ambito del Progetto <strong>RiskNat</strong> sono stati confrontati con i regimipluviometrici caratteristici delle differenti zone climatiche piemontesi, al f<strong>in</strong>e diassegnare un effettivo tempo di ritorno di tali <strong>in</strong>tensità orarie nei vari bac<strong>in</strong>i, <strong>in</strong> baseall’area geografica.Integrando le <strong>in</strong>formazioni derivate dall'analisi degli aspetti morfometrici, geolitologici,e pluviometrici è stato possibile def<strong>in</strong>ire a scala regionale, per ogni apparatoconoide/bac<strong>in</strong>o, un valore di severità e ricorrenza del fenomeno atteso (Figura 8).Queste <strong>in</strong>formazioni sono state utilizzate dalla Regione <strong>Piemonte</strong> Settore ProtezioneCivile nell’ambito dell’Attività B.7.1-C.7.1 “Realizzazione di scenari di rischio <strong>in</strong> ambitotransfrontaliero” del Progetto <strong>RiskNat</strong>.Per una descrizione di dettaglio del metodo seguito si veda la relazione “Analisiregionale f<strong>in</strong>alizzata alla valutazione della severità e della ricorrenza del fenomenoatteso <strong>in</strong> conoide” e la metadocumentazione specifica “Caratterizzazione bac<strong>in</strong>iDescrizione dato”.
Fa1Fa2Fa350 Tr (anni)Figura 8 - Severità (Fa) e ricorrenza (Tr) e <strong>dei</strong> fenomeni attesi <strong>in</strong> conoideQuesti risultati valutati a scala regionale sono stati approfonditi a scala locale susiti campione attraverso l'analisi critica <strong>dei</strong> dati storici, della variazione di uso delsuolo nel corso <strong>dei</strong> decenni, dell’assetto lito-strutturale del bac<strong>in</strong>o alimentatore, dellacopertura vegetazionale e del ruolo delle opere di mitigazione, evidenziando lepeculiarità locali.I dati descritti nel presente paragrafo sono contenuti e consultabili nel layer geografico“caratterizzazione morfo-litologica <strong>dei</strong> bac<strong>in</strong>i di alimentazione e valutazione a scalaregionale della propensione all’<strong>in</strong>nesco <strong>dei</strong> processi torrentizi nelle diverse zoneclimatiche” attraverso il servizio WebGIS, sul geoportale <strong>RiskNat</strong>.
Riferimenti bibliograficiAA.VV. (2005) Mitigation of hydro-geological risk <strong>in</strong> alp<strong>in</strong>e catchments (CatchRisk).Guidel<strong>in</strong>es - Leitl<strong>in</strong>ien - L<strong>in</strong>ee Guida Program Interreg IIIb – Alp<strong>in</strong>e SpaceAutorità di Bac<strong>in</strong>o del fiume Po (1999) Progetto di Piano stralcio per l’AssettoIdrogeologico (PAI). Interventi sulla rete idrografica e sui versanti. Legge 18 Maggio1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter. Allegato 3 all’Atlante <strong>dei</strong> rischi idraulici eidrogeologici: <strong>Inventario</strong> <strong>dei</strong> centri abitati montani esposti a pericolo.Cremon<strong>in</strong>i R., Tiranti D., Pispico R., Rabuffetti D., Bech<strong>in</strong>i R., Tomassone L. (2010) Anearly warn<strong>in</strong>g system for channelized debris flows based on radar storm track<strong>in</strong>g andGIS technique. In: ERAD 2010 - The 6-th European Conference on Radar <strong>in</strong>Meteorology and Hydrology, 6-10 September 2010, Sibiu, Romania.Deangeli C., Paltr<strong>in</strong>ieri E., Tiranti D. (2011) Debris flow analysis: from lithologicalclassification of the bas<strong>in</strong> to deposition. In: Proceed<strong>in</strong>g of The Second World LandslideForum (WLF2) - Putt<strong>in</strong>g science <strong>in</strong>to practice - Roma 3-9 October 2011.Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione - Mondovì Regione <strong>Piemonte</strong> (2001)Campeggi turistici nella Regione <strong>Piemonte</strong>. Identificazione degli ambiti e <strong>in</strong>dicazionisulla compatibilità ambientale nei confronti della pericolosità geologica, catasto <strong>dei</strong>dati, testo delle raccomandazioniMarco F., Forlati F. (2003) Pericolosità geologica <strong>in</strong> conoide: ricerca bibliografica eanalisi critica - Collana <strong>in</strong>formativa tecnico-scientifica di Arpa <strong>Piemonte</strong>; Quaderno n.18.
Marco F., Tiranti D., Cremon<strong>in</strong>i R., Barbero S. (2012) Attività torrentizia <strong>in</strong> ValCenischia. Inquadramento delle recenti riattivazioni rispetto alla classificazioneregionale <strong>dei</strong> <strong>conoidi</strong> <strong>alluvionali</strong> - Collana <strong>in</strong>formativa tecnico-scientifica di Arpa<strong>Piemonte</strong>; Quaderno n. 21.Moscariello A., Marchi L., Maraga F. & Mortara G. (2002) Alluvial fans <strong>in</strong> the Alps:sedimentary facies and processes. Spec. Publs <strong>in</strong>t. Ass. Sediment. 32, 141-166.Santangelo N., Santo A., Faillace PI. (2006) Valutazione della pericolosità alluvionaledelle <strong>conoidi</strong> del Vallo di Diano (Salerno, Italia meridionale). Il Quaternario 19(1),2006-3-17.Tiranti D. (2008) The sediment gravity flows trigger<strong>in</strong>g mechanisms, evolution andsedimentary processes <strong>in</strong> Western Italian Alps - Ph.D. Dissertation, Department ofEarth Sciences, University of Tor<strong>in</strong>o (IT) and Cambridge Quaternary, Department ofGeography, University of Cambridge (UK); pp. 100.Tiranti D., Bonetto S., Mandrone G. (2008) Quantitative bas<strong>in</strong> characterization toref<strong>in</strong>e debris-flow trigger<strong>in</strong>g criteria and processes: an example from the ItalianWestern Alps. Landslides, 5 (1): 45-57; Spr<strong>in</strong>ger-Verlag. DOI: 10.1007/s10346-007-0101-4.