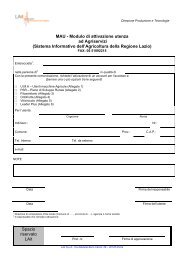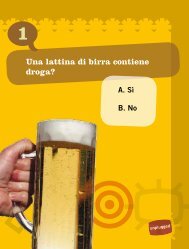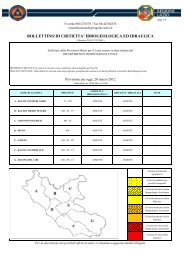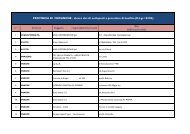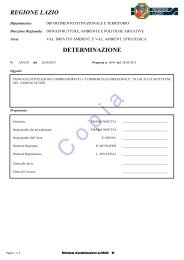Scarica il catalogo della mostra (pdf 3.006,32Kb) - Regione Lazio
Scarica il catalogo della mostra (pdf 3.006,32Kb) - Regione Lazio
Scarica il catalogo della mostra (pdf 3.006,32Kb) - Regione Lazio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La statua di Nerone, ricordata da Francesco<br />
Bianchini come proveniente da Anzio<br />
e conservata presso la famiglia Borghese,<br />
potrebbe riconoscersi nel “patricius puer”<br />
inciso nel 1638 da François Perrier nei<br />
Segmenta Nob<strong>il</strong>ium Signorum et Statuarum<br />
(tav. 40) e identificato nelle descrizioni<br />
seicentesche di V<strong>il</strong>la Borghese come<br />
un “Nerone giovinetto, in habito consolare<br />
con la bulla al collo”. A seguito <strong>della</strong><br />
vendita ottocentesca <strong>della</strong> collezione da<br />
parte del principe Cam<strong>il</strong>lo a Napoleone<br />
Bonaparte, l’esemplare è confluito nel<br />
Museo del Louvre (Ma 1210). Storicamente<br />
probab<strong>il</strong>e è la collocazione di una<br />
statua del giovane Nerone nel luogo che<br />
gli diede i natali.<br />
Altri due ritratti vicini all’iconografia giulio-claudia,<br />
che, come sopraricordato, si<br />
trovano attualmente nel Museo Torlonia<br />
alla Lungara, furono indicati da Carlo<br />
Lodovico Visconti, nella seconda metà<br />
dell’Ottocento, come di origine anziate.<br />
Alcune delle sculture trattate potrebbero<br />
aver fatto parte di una galleria di ritratti<br />
di famiglia ubicata nel settore residenziale,<br />
del tipo di quelle rinvenute in altre<br />
v<strong>il</strong>le di proprietà imperiale extraurbane,<br />
come Lanuvium, Gabi e V<strong>il</strong>la Adriana<br />
stessa. Si tratta di cicli che non si formarono<br />
in un’unica fase, ma che subirono<br />
progressivi ampliamenti secondo le vicende<br />
dinastiche.<br />
Elio Vero, adottato e designato da<br />
Adriano all’Imperium nel 136 d.C. e<br />
morto nel 138 d.C, non salì mai al trono.<br />
Il suo ritratto, che misura sessantaquattro<br />
centimetri, sicuramente postumo, si presta<br />
ad essere inserito nella propaganda<br />
imperiale per la promozione <strong>della</strong> continuità<br />
dinastica degli Antonini.<br />
Non è escluso neppure <strong>il</strong> collegamento<br />
con immagini erette in luoghi pubblici,<br />
quali <strong>il</strong> foro, individuato tra V<strong>il</strong>la Albani e<br />
Palazzo Corsini, come indica <strong>il</strong> ritrovamento<br />
di numerose dediche epigrafiche in<br />
onore di Germanico, Tiberio, Claudio,<br />
Nerva, Lucio Vero, Commodo, Caracalla,<br />
cui potevano accompagnarsi statue o busti.<br />
Dal territorio di Anzio proviene probab<strong>il</strong>mente<br />
anche <strong>il</strong> ritratto di età gallienica,<br />
previsto per l’inserimento in una<br />
statua, conservato nella Ny Carlsberg<br />
Glyptotek di Copenhagen (inv. 831) e<br />
procurato nel 1887 a Carl Jacobsen da<br />
Wolfgang Helbig, protagonista assai discusso<br />
del mercato d’arte di fine Ottocento<br />
(fig. 12).<br />
La lussuosa marmorizzazione <strong>della</strong> v<strong>il</strong>la<br />
imperiale è attestata dall’impiego di pavimenti<br />
in opus sect<strong>il</strong>e (fig. 13), dalle colonne<br />
e dai frammenti architettonici in<br />
marmo bigio e dalle lastre in giallo antico<br />
purtroppo dispersi, ma noti da disegni e<br />
dagli appunti di Pier Leone Ghezzi e ricordati<br />
anche da altri personaggi che visitarono<br />
Anzio nel Settecento. A questo<br />
proposito è degno di interesse un altro disegno<br />
<strong>della</strong> stessa epoca che <strong>mostra</strong> due<br />
colonne frammentarie e una base giacenti<br />
presso alcuni ruderi, situab<strong>il</strong>i nella zona<br />
nord di Anzio, pressapoco al pianoro delle<br />
Vignacce, ivi indicati come “palazzo di<br />
Nerone”, ma forse appartenenti alla V<strong>il</strong>la<br />
Spigarelli o al Teatro (fig. 14).<br />
La monumentalità dell’architettura che<br />
doveva contraddistinguere oltre alla residenza<br />
<strong>della</strong> famiglia imperiale, anche gli<br />
edifici pubblici e alcune domus private<br />
viene riflessa dal gran numero di ritrovamenti<br />
di colonne (con fusti in granito, cipollino,<br />
bigio, bardiglio, verde e giallo<br />
antico; dalle forme lisce, scanalate e buccellate)<br />
che in varie occasioni furono segnalati<br />
nella v<strong>il</strong>la imperiale, nei quartieri<br />
dell’entroterra (V<strong>il</strong>le Adobrandini, Albani),<br />
presso <strong>il</strong> porto romano e durante la<br />
costruzione del molo innocenziano. I recuperi<br />
dal mare si avvantaggiarono dei<br />
crolli degli edifici antistanti la linea di<br />
costa, ma potrebbero anche attestare<br />
un’attività di importazione di epoca romana<br />
non andata a buon fine.<br />
Questi materiali condivisero <strong>il</strong> destino del<br />
reimpiego nella vicina Nettuno, dove Rodolfo<br />
Lanciani nel 1870 (BullInst, 18)<br />
contò quarantanove fusti di antiche colonne<br />
impiegate per usi diversi, e in nuove<br />
costruzioni di chiese e palazzi nob<strong>il</strong>iari di<br />
Roma, dove vennero trasferiti sia via terra<br />
che per mare: se ne avvalse la Reverenda<br />
Camera Apostolica, nel 1596, ai tempi<br />
del pontificato di Clemente VIII Aldo-<br />
Anzio e Nerone.<br />
Tesori dal British Museum e dai Musei Capitolini<br />
31




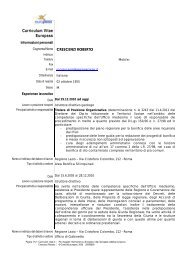

![Appendice B [.pdf 30 Kb] - Regione Lazio](https://img.yumpu.com/51120841/1/184x260/appendice-b-pdf-30-kb-regione-lazio.jpg?quality=85)