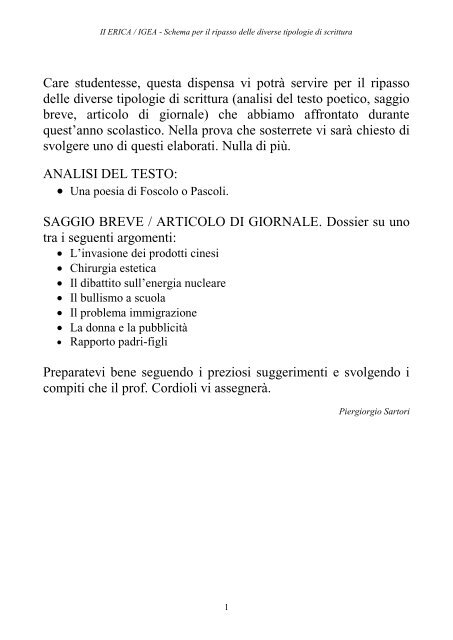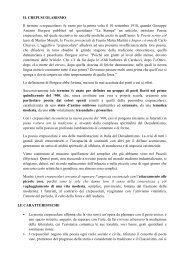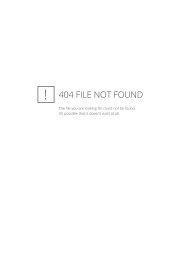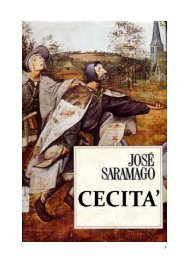You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Care studentesse, questa dispensa vi potrà servire per il ripasso<br />
delle diverse tipologie di scrittura (analisi del testo poetico, saggio<br />
breve, articolo di giornale) che abbiamo affrontato durante<br />
quest‟anno scolastico. Nella prova che sosterrete vi sarà chiesto di<br />
svolgere uno di questi elaborati. Nulla di più.<br />
<strong>ANALISI</strong> <strong>DEL</strong> <strong>TESTO</strong>:<br />
Una poesia di Foscolo o Pascoli.<br />
SAGGIO BREVE / ARTICOLO DI GIORNALE. Dossier su uno<br />
tra i seguenti argomenti:<br />
L‟invasione dei prodotti cinesi<br />
Chirurgia estetica<br />
Il dibattito sull‟energia nucleare<br />
Il bullismo a scuola<br />
Il problema immigrazione<br />
La donna e la pubblicità<br />
Rapporto padri-figli<br />
Preparatevi bene seguendo i preziosi suggerimenti e svolgendo i<br />
compiti che il prof. Cordioli vi assegnerà.<br />
1<br />
Piergiorgio Sartori
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
<strong>ANALISI</strong> <strong>DEL</strong> <strong>TESTO</strong> <strong>POETICO</strong><br />
1. Linguaggio poetico e linguaggio comune<br />
Avvicinandoci allo studio del testo poetico dobbiamo sottolineare come il principale obiettivo del<br />
linguaggio comune sia di trasmettere in modo chiaro, inequivocabile, un particolare messaggio, ad esempio :<br />
“Antonio chiudi la finestra!”, il senso del testo è chiaro, chi l‟ha codificato si è preoccupato, innanzitutto, di<br />
elaborare un testo di facile comprensione per raggiungere l‟obiettivo fissato. Nel linguaggio comune il testo<br />
diventa uno “strumento” inteso a soddisfare una particolare esigenza, una volta raggiunto lo scopo<br />
diventa inutile, possiamo tranquillamente abbandonarlo.<br />
Un discorso completamente diverso bisogna fare per il testo poetico, in questo caso il testo “non è mai<br />
uno strumento” finalizzato ad ottenere obiettivi esterni al testo stesso. Il poeta-emittente non si<br />
preoccupa di elaborare un testo che sia, innanzitutto, di facile comprensione; il testo non deve essere<br />
soprattutto chiaro, la sua funzione non è strumentale; esso ha valore in sé, trova in sé stesso il fine, come<br />
d‟altronde tutta la produzione che appartiene al mondo dell‟arte.<br />
Per aiutarci a comprendere meglio la distinzione tra linguaggio poetico e linguaggio comune leggiamo<br />
questa bella pagina tratta da S. Guglielmino, T. S. Silvestrini “Guida alla lettura”, Milano 1988, ed.<br />
Principato:<br />
“Il materiale usato dal poeta è lo stesso del linguaggio comune, cioè lo stesso materiale che ci serve<br />
ogni giorno e in ogni circostanza per le necessità di comunicazione e di rapporto della vita quotidiana.<br />
Consideriamo di nuovo il verso:<br />
“Dolce e chiara è la notte e senza vento...”<br />
Se noi volessimo esprimere lo stesso contenuto per riferire a qualcuno una nostra esperienza o<br />
percezione potremmo dire abbastanza indifferentemente:<br />
“E‟ una notte serena e senza vento... “, “La notte è serena e non tira vento...”, “E una notte calma e<br />
luminosa” e via cambiando e mutando i termini o il loro ordine e la loro combinazione: il nostro<br />
destinatario riceverebbe sia in un modo che nell‟altro l‟informazione che vogliamo dargli riguardo alla<br />
realtà di quella notte e alla nostra percezione della sua bellezza. Questi mutamenti, nel linguaggio comune<br />
non intaccano sostanzialmente il senso di quanto si vuole comunicare.<br />
Nel linguaggio poetico invece ogni mutamento di termine, ogni cambiamento nell‟ordine delle parole,<br />
ogni accostamento, separazione, combinazione, ha un‟importanza rilevante perché non è essenziale tanto<br />
ciò che si intende comunicare quanto il modo particolare con cui lo si esprime. Questo modo non è<br />
necessariamente il più preciso e definito, talora neanche il più chiaro; e non rispetta neppure l‟ordine e gli<br />
accostamenti più comuni: è invece il più ricco di valori musicali e fantastici.<br />
La parola, nel linguaggio poetico, non viene ricercata per la sua capacità di comunicare ordinatamente<br />
informazioni e conoscenze, quanto per le sue possibilità di sprigionare suoni che si leghino ritmicamente<br />
agli altri suoni del testo.<br />
Allo stesso modo non si chiede alla parola di definire con precisione un oggetto distinguendolo da altri,<br />
ma piuttosto di rappresentarlo evocando tutte le possibili immagini che il significato comporta o che<br />
richiama per associazione, o che può suscitare in rapporto ad altri significati presenti nel testo poetico.<br />
Perciò la polisemia di una parola (cioè il suo essere portatrice contemporaneamente di più significati) e<br />
l‟ambiguità che ne consegue non solo non vengono evitate nel linguaggio poetico, ma sono consapevolmente<br />
sfruttate per moltiplicare i rapporti con li altri elementi nel testo poetico.<br />
E‟ come un gioco complesso e prezioso di echi e di riflessi, in cui ogni suono e ogni immagine non valgono<br />
più per se stessi, ma per tutte le possibilità che suggeriscono. Si costituisce quindi, nel linguaggio poetico,<br />
una rete fitta di rapporti così intrecciati tra di loro che non si può togliere un singolo elemento senza mettere<br />
in pericolo l‟equilibrio del risultato finale. (op. cit. pagg. 70-71)<br />
Anche grazie a quanto abbiamo appena visto cerchiamo di individuare quali sono gli elementi che<br />
caratterizzano, e quindi differenziano, un testo poetico da altri tipi di testi. Per comodità osserviamo forma e<br />
contenuto in modo distinto, anche se proprio nel testo poetico questi due elementi sono strettamente legati.<br />
Forma<br />
Gli elementi formali che caratterizzano un testo poetico sono:<br />
l’essere scritto in versi<br />
l’attenzione per le rime, le assonanze e le consonanze<br />
la scelta dei termini secondo criteri fonici<br />
2
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
sintassi che spesso non segue le regole canoniche<br />
cura particolare per il lessico<br />
Contenuto<br />
Per quanto attiene al contenuto possiamo dire che non vi sono particolari argomenti che in qualche modo<br />
caratterizzano il testo poetico. E‟ invece importante sottolineare come in esso il contenuto è strettamente<br />
legato alla forma, significato e significante sono tra loro uniti in un’unione inscindibile.<br />
Ogni poesia è l’espressione unica di un particolare poeta, cercare d’esprimere i medesimi<br />
contenuti modificando la forma è impossibile, otterremo qualcosa di completamente diverso.<br />
La complessità del testo poetico<br />
Nell‟avvicinarci ad un qualsiasi testo poetico dobbiamo ricordare che in esso nulla, o poco, è spontaneo,<br />
ogni elemento viene scelto non solo per il significato che porta con sé ma anche:<br />
per le relazioni che crea con le altre parti del testo<br />
perché è in grado di suggerire immagini<br />
sa evocare ricordi<br />
per la capacità di creare effetti musicali<br />
perché è in grado di creare associazioni d’idee<br />
2. Studiare un testo poetico<br />
Proprio per queste peculiari caratteristiche studiare un testo poetico è un‟operazione piuttosto complessa,<br />
possiamo immaginarla come un percorso suddiviso in diverse fasi o livelli di lettura. La prima parte del<br />
percorso è legata all‟analisi del testo, mentre la seconda si focalizza sull‟interpretazione dello stesso.<br />
Analisi del testo<br />
Data la natura pragmatica del presente testo proponiamo, in modo schematico, un possibile percorso<br />
per l’analisi del testo poetico, ogni lettore, con l‟esperienza, sarà in grado di crearsi un “proprio” percorso.<br />
Nello schema si noti la distinzione tra lo studio dell‟autore e del tempo in cui visse (PARTE I: analisi<br />
extratestuale), e l‟analisi del testo vero e proprio (PARTE II: analisi testuale).<br />
PERCORSO PER L’<strong>ANALISI</strong> <strong>DEL</strong> <strong>TESTO</strong> <strong>POETICO</strong><br />
PARTE I: Analisi extratestuale (o contestualizzazione)<br />
FASE DESCRIZIONE<br />
SINTETICA<br />
Prima Inquadramento storico e<br />
socio-culturale<br />
Seconda<br />
Studio della biografia<br />
dell‟autore<br />
OBIETTIVI NOTE<br />
Raccogliere quante più<br />
informazioni possibili,<br />
relative al momento storico<br />
e socio-culturale nel quale<br />
l‟autore è vissuto<br />
Conoscere la vita<br />
dell‟autore.<br />
Terza L‟autore e il suo tempo Comprendere i rapporti tra<br />
l‟autore e i contemporanei<br />
3<br />
Conoscere le coordinate storiche e socioculturali<br />
nelle quali un determinato autore è<br />
vissuto è di notevole aiuto per la<br />
comprensione dei testi poetici che questi ha<br />
prodotto<br />
(ad esempio, risulta difficile comprendere<br />
compiutamente la poesia Il cinque maggio di<br />
A. Manzoni, se non si conoscono la vita e le<br />
imprese di Napoleone).<br />
Vita e opere di un autore non possono essere<br />
considerate come due entità distinte, sarebbe<br />
un gravissimo errore, la vita si riflette nelle<br />
opere e queste ci consentono di comprendere<br />
la sua vita, in una unità inscindibile.<br />
La presenza costante di alcuni temi nella<br />
poetica di alcuni autori si comprende appieno<br />
solo conoscendo la loro vita (pensiamo ad<br />
esempio a Pascoli e al tema frequente del<br />
nido familiare come fonte di felicità, un tale<br />
tema si collega alle tragedie familiari che<br />
l‟autore ha vissuto quando era ancora<br />
ragazzo).<br />
I poeti, ma tutti gli artisti in genere,<br />
rappresentano figure del tutto particolari
Quarta<br />
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Analisi della produzione<br />
complessiva e<br />
collocazione del testo da<br />
studiare<br />
Collocare correttamente,<br />
all‟interno della<br />
produzione complessiva<br />
dell‟autore, il particolare<br />
testo poetico da studiare<br />
Quinta Studio della poetica Conoscere gli elementi<br />
essenziali che ci<br />
consentono di comprendere<br />
la poetica dell‟autore<br />
4<br />
all‟interno di un gruppo sociale, è importante<br />
comprendere quale considerazione avesse il<br />
poeta da parte dei contemporanei. Troveremo<br />
posizioni che sono lontanissime tra loro, così<br />
Manzoni ebbe una notevolissima<br />
considerazione, mentre Dino Campana<br />
venne, per tutta la vita, considerato disturbato<br />
mentalmente.<br />
Studiare il rapporto tra autore e<br />
contemporanei è importante anche perché<br />
bisogna ricordare che erano i contemporanei<br />
i reali destinatari del testo.<br />
Non bisogna poi dimenticare che il testo<br />
potrebbe essere stato scritto per una<br />
particolare occasione.<br />
E‟ importante avere una visione d‟insieme<br />
delle opere prodotte dall‟autore per<br />
comprendere il testo da analizzare. Se visto<br />
come parte di un insieme, e se collocato<br />
correttamente, diventa più facile<br />
comprendere il senso del testo.<br />
Possiamo considerare la poesia studiata come<br />
un frammento della produzione del poeta,<br />
ebbene per comprendere quel frammento è<br />
necessario conoscere le linee guida del<br />
pensiero dell‟autore, i temi più frequenti,<br />
l‟uso del lessico, ecc.<br />
PERCORSO PER L’<strong>ANALISI</strong> <strong>DEL</strong> <strong>TESTO</strong> <strong>POETICO</strong><br />
PARTE II: Analisi testuale<br />
FASE DESCRIZIONE<br />
SINTETICA<br />
OBIETTIVI NOTE<br />
Prima Prima lettura Conoscere il testo In questa prima fase si legga il testo, lettura<br />
espressiva, cercando di evidenziare le pause<br />
e gli accenti per coglierne il ritmo.<br />
Seconda Prima comprensione Comprendere il significato<br />
del testo “traducendolo” in<br />
prosa (fare la parafrasi)<br />
Nella seconda fase dobbiamo fare la<br />
parafrasi del testo. Parafrasi deriva dal<br />
greco paràphrasis e significa “frase posta<br />
vicino”. Nel fare la parafrasi dobbiamo<br />
ricordare che questa ha una propria<br />
indipendenza dal testo di riferimento, ci<br />
consente di individuare i contenuti del<br />
testo, ma da questo se ne distingue sia per<br />
la struttura, sia per il lessico. Dobbiamo<br />
inoltre ricordare che stiamo riscrivendo in<br />
prosa i contenuti del testo poetico, se in<br />
quest‟ultimo le regole sintattiche spesso sono<br />
trascurate, non altrettanto deve avvenire per<br />
il testo in prosa.<br />
Per fare la parafrasi consigliamo di:<br />
chiarire il significato di ogni singola<br />
parola o delle espressioni non<br />
immediatamente comprensibili, parole<br />
nuove, insolite, ecc;<br />
ricostruire la situazione complessiva dei<br />
fatti o delle emozioni rappresentate nel
Terza<br />
Quarta<br />
Quinta<br />
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Individuazione dei<br />
nuclei tematici<br />
Studio dell‟aspetto<br />
metrico e strutturale<br />
Studio delle figure<br />
retoriche<br />
Individuare i nuclei<br />
tematici presenti nel testo<br />
Individuare e definire gli<br />
elementi metrici e<br />
strutturali presenti<br />
Individuare le eventuali<br />
figure retoriche presenti,<br />
cercando di comprendere<br />
quale significato l‟autore<br />
intendeva attribuire alle<br />
diverse figure<br />
5<br />
testo;<br />
ricercare un‟espressione semplice e<br />
chiara, di un linguaggio comune, per ogni<br />
punto della poesia;<br />
ricercare il messaggio profondo del testo;<br />
individuare una chiave interpretativa che<br />
riveli il senso delle immagini poetiche<br />
La parafrasi ci consente di individuare quelli<br />
che possiamo definire nuclei tematici della<br />
poesia. Solo se saremmo in grado di<br />
individuare correttamente i nuclei tematici<br />
potremmo comprendere il significato<br />
complessivo del testo.<br />
In questa fase dobbiamo individuare:<br />
1. il tipo di componimento (sonetto, ballata,<br />
schema libero, ecc.)<br />
2. la natura dei versi presenti<br />
3. la posizione dell’accento ritmico, le<br />
pause, le cesure e gli enjambement<br />
In quest‟ultima fase cercheremo nel testo<br />
quelle che vengono definite “figure<br />
retoriche”, ossia quelle forme stilistiche<br />
usate dall‟autore per ottenere particolari<br />
effetti. Il nome “retoriche” deriva dal fatto<br />
che tali figure furono studiate e codificate<br />
dalla Retorica antica (ricordo che presso i<br />
Greci e i Latini la Retorica era una materia di<br />
studio, coincidente con l’arte del parlare e<br />
scrivere con efficacia persuasiva)<br />
Le figure retoriche che possiamo trovare nei<br />
testi poetici sono:<br />
1. figure di suono (rima, assonanza,<br />
consonanza, allitterazione, onomatopea)<br />
2. figure sintattiche (anafora, ellissi,<br />
enumerazione, climax, anastrofe,<br />
iperbato, chiasmo)<br />
3. figure di significato (similitudine,<br />
metafora, analogia, sinestesia, metonimia,<br />
sineddoche, ossimoro, iperbole, litote)<br />
Dall’analisi all’interpretazione<br />
Dopo l‟analisi del testo possiamo passare alla sua interpretazione. Il testo analizzato viene ora<br />
osservato secondo quattro diverse chiavi di lettura:<br />
in relazione alla produzione poetica dell’autore<br />
in relazione alla produzione poetica del tempo<br />
in relazione alla produzione poetica in generale<br />
in relazione al mio rapporto con quel particolare testo<br />
Rispetto all‟analisi è necessario sottolineare come il momento dell‟interpretazione sia più complesso, per<br />
interpretare è necessario avere una visione d‟insieme che solo uno studioso è in grado d‟avere. Quando<br />
scrivo “interpretare” intendo perciò conoscere le interpretazioni date dai critici letterari.<br />
INTERPRETAZIONE <strong>DEL</strong> <strong>TESTO</strong>
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
FASE DESCRIZIONE<br />
SINTETICA<br />
Prima Il testo nella produzione<br />
dell‟autore<br />
Seconda<br />
Terza<br />
Quarta<br />
Il testo nella produzione<br />
del suo tempo<br />
Il testo nella produzione<br />
poetica in generale<br />
Il mio rapporto con quel<br />
particolare testo<br />
(commento)<br />
OBIETTIVI NOTE<br />
Interpretare il testo<br />
nell‟ottica della<br />
produzione complessiva<br />
dell‟autore<br />
Interpretare il testo<br />
nell‟ottica della produzione<br />
poetica del suo tempo<br />
Interpretare il testo<br />
nell‟ottica della produzione<br />
poetica in generale<br />
Cogliere le emozioni, gli<br />
stati d‟animo, le riflessioni<br />
che il testo mi ha suscitato<br />
6<br />
Con l‟aiuto dei critici letterari cerchiamo di<br />
comprendere quale posto particolare abbia<br />
avuto il testo nella produzione complessiva<br />
dell‟autore.<br />
Sempre con l‟aiuto delle opinioni dei critici<br />
(ribadisco che è sempre meglio consultarne<br />
più d‟uno) cerchiamo di conoscere:<br />
la fortuna dell‟opera tra i contemporanei<br />
come si colloca l‟opera nella produzione<br />
dei contemporanei<br />
Non ci resta ora che individuare la rilevanza<br />
che all‟opera viene attribuita nella<br />
produzione poetica in generale.<br />
In quest‟ultima fase riflettiamo in merito alle<br />
emozioni, ai sentimenti, ai pensieri che la<br />
lettura del testo ha suscitato in noi.<br />
Quest‟ultimo momento mette in luce la<br />
nostra sensibilità poetica e la nostra capacità<br />
d‟ascolto.<br />
3. Studiare un testo poetico (applicazione)<br />
<strong>ANALISI</strong> EXTRATESTUALE (o contestualizzazione)<br />
Ricordo che con analisi extratestuale intendo:<br />
inquadramento storico e socio-culturale<br />
studio della biografia<br />
l’autore e il suo tempo<br />
analisi della produzione complessiva e collocazione del testo da studiare<br />
studio della poetica<br />
Nelle antologie scolastiche i testi poetici sono sempre accompagnati da informazioni che consentono l‟analisi<br />
extratestuale, certo lo spazio che viene dedicato a questo aspetto dell‟analisi del testo varia notevolmente a<br />
seconda della tipologia d‟utente a cui l‟antologia è destinata, e delle finalità per le quali la stessa è stata<br />
scritta.<br />
<strong>ANALISI</strong> TESTUALE<br />
Come abbiamo visto l‟analisi testuale può essere suddivisa nei seguenti momenti:<br />
a. prima lettura<br />
b. prima comprensione<br />
c. ricerca dei nuclei tematici<br />
d. studio dell’aspetto metrico strutturale<br />
e. studio delle figure retoriche<br />
a. Prima lettura<br />
In questa prima fase leggiamo con lettura espressiva il testo, cercando, mediante l‟intonazione della<br />
voce, di mettere in rilievo il ritmo della poesia.<br />
b. Prima comprensione
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Non è sempre facile “comprendere il significato profondo di una poesia”. Il paziente lavoro di lettura<br />
e di decodificazione di un testo poetico può, come prima tappa, materializzarsi nella parafrasi ( paraphrasis<br />
= dire con altre parole) che prevede alcune importanti operazioni:<br />
il chiarimento del significato di ogni singola parola o delle espressioni non immediatamente<br />
comprensibili, parole nuove, insolite, ecc<br />
la ricerca di un’espressione semplice e chiara, di un linguaggio comune per ogni punto della<br />
poesia;<br />
la ricerca del messaggio profondo;<br />
l’individuazione di una chiave interpretativa che riveli il senso delle immagini poetiche<br />
Come esempio vediamo la parafrasi di tre terzine 1 tratte al Canto primo della Divina commedia (versi 19-<br />
27):<br />
Allor fu la paura un poco queta<br />
che nel lago del cor m‟era durata<br />
la notte ch‟i‟ passai con tanta pièta.<br />
E come quel che con lena affannata<br />
uscito fuori dal pelago a la riva<br />
si volge a l‟acqua perigliosa e guata,<br />
così l‟animo mio, ch‟ancor fuggiva,<br />
si volse a retro a rimirar lo passo<br />
che non lasciò già mai persona viva.<br />
Parafrasi (di Natalino Spegno)<br />
Allora si calmò, almeno in parte, la paura che mi aveva ingombrato il cuore durante la notte che avevo trascorso con<br />
tanta angoscia. E come fa chi è appena giunto alla riva dopo uno scampato naufragio, che si volge col respiro ancora<br />
affannato a fissare la distesa d‟acqua che gli ha fatto correre un così grave rischio; così l‟animo mio, che ancora<br />
rifuggiva dal pericolo della selva, si volse indietro a guardare nuovamente quel passaggio che non ha mai lasciato<br />
sopravvivere nessuno.<br />
c. Ricerca dei nuclei tematici<br />
La parafrasi ci aiuta nella ricerca di quelli che abbiamo definito i nuclei tematici del testo. Per comprendere<br />
cosa sono i nuclei tematici immaginiamo di dover rispondere alla domanda: quali temi o argomenti sono<br />
affrontati, toccati, suggeriti dall’autore del testo ?<br />
Osserviamo la poesia di Salvatore Quasimodo “Alle fronde dei salici” del 1945 pubblicata nella raccolta<br />
Con il piede straniero sopra il cuore del 1946.<br />
E come potevamo noi cantare<br />
con il piede straniero sopra il cuore,<br />
tra i morti abbandonanti nelle piazze<br />
sull‟erba dura di ghiaccio, al lamento<br />
d‟agnello dei fanciulli, all‟urlo nero<br />
della madre che andava incontro al figlio<br />
crocifisso sul palo del telegrafo ?<br />
Alle fronde dei salici, per voto,<br />
anche le nostre cetre erano appese:<br />
oscillavano lievi al triste vento.<br />
Il tema centrale di questa poesia è che davanti alla violenza e alla crudeltà, di fronte a quella che possiamo<br />
definire la disumanizzazione dell‟uomo, ai poeti non rimane che il silenzio. All‟interno di questo tema<br />
centrale vi sono dei sotto temi o nuclei tematici, tra questi sottolineiamo:<br />
il tema della solidarietà tra gli esseri umani (si noti il noi del primo verso e il piede straniero sopra<br />
il cuore del secondo verso, qui il cuore è unico in una forma di compartecipazione alla sofferenza)<br />
il tema dei bambini principali vittime della violenza (al lamento d‟agnello dei fanciulli)<br />
il tema del dolore straziante provocato dalla perdita di un figlio (l‟urlo nero della madre)<br />
il tema del silenzio che si impone ai poeti nelle situazioni di violenza e di crudeltà, quasi una<br />
forma di rispetto per quanti soffrono (Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano<br />
appese)<br />
1 Strofe formate da tre versi.<br />
7
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
oltre a questi anche altri temi possono emergere da una lettura attenta.<br />
d. Studio dell’aspetto metrico-strutturale<br />
Per esperienza questo è il tipo d‟analisi meno gradito agli studenti. Analizzare l‟aspetto metrico strutturale di<br />
un testo significa:<br />
1. definire il tipo di componimento, osservando il tipo di strofe e la loro organizzazione<br />
2. trovare la lunghezza (quindi il tipo) del verso<br />
3. evidenziare la distribuzione degli accenti ritmici, delle pause e delle eventuali cesure ed<br />
enjambements<br />
1. Definire il tipo di componimento<br />
Ogni componimento poetico è costituito da una o più strofe, ma come possiamo definire la strofa e quante<br />
sono le tipologie di strofe che possono dar luogo ai testi poetici.<br />
La strofa<br />
Con strofa intendiamo l’insieme di versi che danno luogo ad un “periodo ritmico” (spesso anche logico<br />
concettuale) ben definito. E‟ piuttosto facile rilevare il numero di strofe che compongono un componimento<br />
poetico dato che ogni strofa è separata dalla successiva da una riga bianca.<br />
Le strofe vengono nominate in base al numero di versi che le costituiscono, avremo così:<br />
il distico ( strofa di due versi);<br />
la terzina (strofa di tre versi);<br />
la quartina (strofa di quattro versi)<br />
la sestina (strofa di sei versi)<br />
l’ottava (strofa di otto versi)<br />
Nella letteratura italiana, le strofe più frequenti sono la terzina ( la “Divina Commedia” è in terzine ), la<br />
quartina (usata in particolare nel sonetto ), e l‟ottava. Nella poesia moderna, a partire dalla fine<br />
dell‟Ottocento, si trovano comunemente strofe a schema libero, ossia che non seguono modelli ritmici<br />
definiti.<br />
I diversi componimenti poetici<br />
I principali tipi di componimenti della tradizione poetica italiana sono:<br />
ballata<br />
canzone<br />
sonetto<br />
ode<br />
Ballata<br />
La ballata, o canzone a ballo, è un componimento molto antico, di origine popolare, caratterizzato<br />
inizialmente dal fatto di essere accompagnato dal canto e dalla danza. La ballata è formata da una<br />
introduzione, detta ripresa o ritornello, costituita da un numero di versi variabile da uno a quattro. Dopo la<br />
ripresa vengono le stanze, composte ciascuna da due piedi ( rispettivamente detti prima mutazione e<br />
seconda mutazione ) e da una volta: l‟ultimo verso della volta, che ha sempre lo stesso numero di versi della<br />
ripresa, rima con l‟ultimo verso della ripresa.<br />
La ballata è un metro classico diffuso soprattutto in epoca medioevale, rinascimentale e barocca. Dal<br />
Settecento in avanti il suo utilizzo è andato esaurendosi.<br />
Canzone<br />
Di origine provenzale, la canzone raggiunge con Petrarca la sua struttura classica. La canzone è considerata<br />
il componimento più solenne e illustre della tradizione lirica italiana. E‟ costituita da una serie di strofe o<br />
stanze, miste di endecasillabi (versi formati da undici sillabe) e settenari (versi formati da sette sillabe).<br />
Ogni stanza è composta da due parti, la fronte, formata a sua volta da due piedi, e la sirma ( o coda ), che<br />
può essere unica o divisa in due parti uguali. La sirma è legata alla fronte da un verso che può restare o<br />
isolato o rimare con l‟ultimo verso della fronte che si chiama chiave ( o concatenazione ).<br />
Di solito la canzone è chiusa da una stanza più breve delle altre detta congedo o commiato.<br />
Sonetto<br />
Il sonetto è un componimento di antica tradizione. E‟ costituito da 14 endecasillabi, distribuiti in due<br />
quartine e due terzine. I versi sono endecasillabi e le rime possono essere di vario tipo<br />
8
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Ode<br />
Derivata dalla canzone, ne ha semplificato lo schema, orientandosi verso la scelta di strofe più brevi, con<br />
un numero variabile di versi. L‟ode più conosciuta è senz‟altro Il cinque maggio di Alessandro Manzoni.<br />
2. Trovare la lunghezza del verso<br />
Un verso è costituito dall‟insieme di parole che stanno su una stessa riga. Esso rappresenta l‟elemento<br />
caratterizzante i testi poetici, l‟elemento che ci consente, anche a colpo d‟occhio, la loro distinzione da tutti<br />
gli altri tipi di testi.<br />
I versi possono essere di lunghezza variabile, e in base alla lunghezza vengono nominati, abbiamo, così,<br />
versi:<br />
bisillabi o binari (formati da due sillabe)<br />
trisillabi o ternari (formati da tre sillabe)<br />
quadrisillabi o quaternari (formati da quattro sillabe)<br />
quinari (formati da cinque sillabe)<br />
senari (formati da sei sillabe)<br />
settenari (formati da sette sillabe)<br />
ottonari (formati da otto sillabe)<br />
novenari (formati da nove sillabe)<br />
decasillabi (formati da dieci sillabe)<br />
endecasillabi (formati da undici sillabe)<br />
dodecasillabo o doppio senario (formati da dodici sillabe)<br />
Trovare la lunghezza del verso è operazione in apparenza piuttosto semplice (basta contare le sillabe che lo<br />
compongono), tuttavia per individuare correttamente il numero di sillabe che compongono un verso è<br />
necessario tener presente alcune regole, vediamole.<br />
Versi piani, tronchi, sdruccioli e bisdruccioli<br />
1. Se il verso è piano (ossia se l‟accento tonico cade sulla penultima sillaba della parola conclusiva) il<br />
conteggio delle sillabe è regolare<br />
2. Se il verso è tronco (ossia se l‟accento tonico cade sull‟ultima sillaba della parola conclusiva) bisogna<br />
considerare una sillaba in più rispetto a quelle effettivamente computate (l‟ultima viene considerata<br />
doppia).<br />
2. Se il verso è sdrucciolo o bisdrucciolo (ossia se l‟accento tonico cade sulla terz‟ultima o quart‟ultima<br />
sillaba della parola conclusiva) bisogna considerare una sola sillaba dopo quella accentata<br />
In presenza di particolari figure metriche (sinalèfe, dialèfe, sinèresi, dièresi)<br />
Le regole della sinalèfe e della dialèfe si applicano nell‟incontro di parole, mentre quelle della sinèresi e<br />
della dièresi interessano un‟unica parola.<br />
1. La vocale finale atona di una parola si fonde con la vocale iniziale della parola che segue, formando<br />
un‟unica sillaba, si parla in questo caso di sinaléfe:<br />
di/ gen/te-in/ gen/te,/ me/ ve/drai/ se/du/to<br />
(Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni)<br />
si noti come la e di gente si fonde con la in, formando un‟unica sillaba.<br />
2. Il contrario della sinalèfe è la dialèfe, in questo caso non avviene la fusione delle vocali di parole<br />
diverse che si incontrano; generalmente la fusione non avviene perché una delle due e tonica:<br />
che/ la/ di/rit/ta/ via/ e/ra/ smar/ri/ta<br />
(Dante Alighieri)<br />
si noti come via e e di era rimangono separate.<br />
3. La regola della sinèresi si applica quando due vocali che normalmente formano uno iato (ossia si<br />
distinguono nella pronuncia) vengono unite in un’unica sillaba:<br />
Ed/ er/ra/ l‟ar/mo/nia/ per/ que/sta/ val/le<br />
(Giacomo Leopardi, Il passere solitario)<br />
lo iato presente nella sillaba nia non viene considerato, le due vocali si mantengono unite a formare<br />
un‟unica sillaba. Generalmente, nei testi poetici, si ha sinèresi con parole come mio, tuo, tua, ecc.<br />
9
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
4. La dièresi è il contrario della sinèresi, consiste nel considerare come uno iato due vocali che<br />
normalmente formano dittongo:<br />
E/ pre/go an/ch‟io/ nel/ tuo/ por/to/ qui/e/te<br />
(Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni)<br />
La dieresi nella parole quiete rende la parola trisillabica e quindi il verso endecasillabo. Graficamente una<br />
diéresi viene indicata ponendo due puntini sopra la vocale più debole.<br />
3. Individuare l’accento ritmico, le eventuali cesure ed enjambements<br />
Nello studio di una poesia spesso trascuriamo, ingiustamente, l‟analisi del ritmo e della musicalità che<br />
emergono dal testo; eppure dobbiamo pensare che il poeta considera il ritmo e la musicalità del testo<br />
come elementi fondamentali per la scelta dei termini da usare. Non bisogna dimenticare che la poesia è<br />
strettamente imparentata con il canto (la poesia antica veniva cantata con accompagnamento musicale).<br />
Ancora oggi il testo di alcune canzoni può essere considerato, a tutti gli effetti, un testo poetico.<br />
La musicalità e il ritmo di un testo si creano mediante l‟uso di accenti ritmici e di pause.<br />
Accenti ritmici<br />
Nei testi poetici accanto agli accenti tonici, caratteristici di ogni parola, esiste l’accento ritmico o ictus<br />
(ictus in latino significa percussione, e richiama il battere del tempo durante l‟esecuzione di un brano<br />
musicale) esso può essere definito come: il punto o i punti del verso, chiamati sedi, dove la voce insiste in<br />
modo particolare, con più forza.<br />
Nella poesia tradizionale le sedi dell’accento ritmico sono fissate dalla metrica in base alla lunghezza del<br />
verso, abbiamo così:<br />
Tipo di verso Accenti ritmici cadono sulle sillabe<br />
bisillabo o binario prima<br />
trisillabo o ternario Seconda<br />
quadrisillabo o quaternario prima e terza<br />
quinario prima o seconda e quarta<br />
senario seconda e quinta<br />
settenario una della prime quattro e sesta<br />
ottonario terza o quarta e settima<br />
novenario generalmente seconda, quinta e ottava<br />
decasillabo terza, sesta e nona<br />
endecasillabo obbligatorio sulla decima sillaba, gli altri sono mobili<br />
oltre l‟endecasillabo i versi si considerano, per gli accenti ritmici come versi doppi, così un dodecasillabo<br />
viene considerato un doppio senario.<br />
Pause, cesure ed enjambement<br />
La cadenza ritmica della poesia è data, oltre che dagli accenti ritmici, anche dalle pause. Una pausa è,<br />
generalmente, presente alla fine del verso; possiamo però delle pause anche all’interno di un verso, in<br />
questi casi si parla di cesura:<br />
Ei fu. (pausa di cesura) Siccome immobile<br />
(Manzoni)<br />
Nel breve verso di Manzoni proposto la funzione della cesura è di evidenziare alcune parole. Solitamente le<br />
cesure sono presenti nei versi lunghi, in concomitanza dei segni di punteggiatura, dividono il verso in<br />
due parti dette emistichi (emistichio deriva dal greco e significa mezzo verso). Nell‟endecasillabo (forse il<br />
verso più usato nella letteratura italiana) la cesura si ha dopo la settima sillaba (in alcuni casi dopo la quinta).<br />
Abbiamo visto come le pause siano generalmente presenti alla fine del verso, capita però, a volte, che il<br />
senso logico del verso si completi in quello successivo (ad esempio quando abbiamo un nome in un verso e il<br />
suo aggettivo nel verso successsivo), in questi casi la pausa di fine verso tende a svanire modificando il<br />
ritmo, questo fenomeno prende il nome di enjambement (o inarcatura):<br />
Il tramonto discendeva con sordi<br />
brontolii. Ognuno si godeva i cari<br />
ricordi, cari ma perché ricordi.<br />
(G. Pascoli)<br />
si noti l‟enjambement presente tra il primo e il secondo verso, e quello tra il secondo e il terzo.<br />
10
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
e. Studio delle figure retoriche<br />
Le più diffuse figure retoriche che possiamo trovare nei testi poetici si possono così classificare:<br />
1. figure di suono (rima, assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea)<br />
2. figure sintattiche (anafora, ellissi, enumerazione, climax, anastrofe, iperbato, chiasmo)<br />
3. figure di significato (similitudine, metafora, analogia, sinestesia, metonimia, sineddoche, ossimoro,<br />
iperbole, litote)<br />
1. Figure di suono (rima, assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea)<br />
Rima<br />
Assieme all‟accento ritmico e alle pause, la musicalità di un testo poetico si ottiene, innanzitutto, mediante le<br />
rime. La rima è da considerarsi tra le più diffuse figure di suono. Due parole si dicono in rima quando<br />
hanno un’identità di suoni a partire dalla vocale su cui cade l’accento tonico. Le parole che producono<br />
la rima si trovano, perlopiù, alla fine del verso. Attenzione perché si abbia una vera e propria rima vi deve<br />
essere l‟identità di suoni a partire dalla vocale sui cade l’accento tonico della parola, così saltare e<br />
ballare fanno rima, mentre temere e prendere non sono in rima, in prendere, infatti, l‟accento tonico cade<br />
sulla prima e.<br />
All‟interno di un testo poetico la rima svolge delle funzioni importante perché:<br />
contribuisce in maniera sostanziale a scandire il ritmo del testo<br />
stabilisce rapporti fonici tra parole diverse<br />
pone in relazione due termini che fanno riferimento a concetti che possono essere simili,<br />
diversi, opposti, potendo così trasformare una relazione di suono in una relazione di significato (ad<br />
esempio spande-grande per somiglianza, sera-capinera per diversità, sera-primavera per<br />
opposizione)<br />
Le rime si distinguono in base al loro disporsi nell‟ambito di una sequenza di versi. Per aiutarsi nel definire<br />
la sequenza, i versi contenenti rime uguali vengono indicati con una stessa lettera dell‟alfabeto, avremo così<br />
una sequenza di lettere che indicano il rapporto in rima tra i differenti versi. Vediamo le sequenze di rime più<br />
diffuse nella letteratura italiana:<br />
Rima baciata: si ha quando due versi consecutivi rimano tra loro secondo lo schema AA BB CC<br />
O cavallina, cavallina storna A<br />
che portavi colui che non ritorna A<br />
Rima alternata: unisce due versi alternativamente secondo lo schema AB AB<br />
Forse perché della fatal quiete A<br />
tu sei l‟imago, a me sì cara vieni B<br />
o sera! E quando ti corteggian liete A<br />
le nubi estive e i zefiri sereni B<br />
11<br />
(G. Pascoli, La cavalla storna)<br />
Rima incrociata: unisce il primo verso al quarto, il secondo al terzo secondo lo schema AB BA<br />
Voi ch‟ascoltate in rime sparse il suono A<br />
di quei sospiri ond‟io nudriva „l core B<br />
in sul mio primo giovenile errore B<br />
quand‟era in parte altr‟uom da quel ch‟i‟ sono A<br />
(U. Foscolo, Alla sera)<br />
(F. Petrarca, Canzoniere)<br />
Rima incatenata o terza rima (detta anche rima dantesca, perché usata da Dante nella Divina Commedia):<br />
lega assieme strofe di tre versi (terzine) in una specie di catena, il primo verso legato con il terzo, il secondo<br />
con il primo e il terzo della strofa successiva, introducendo in ogni nuova strofa un nuovo verso nel mezzo<br />
secondo lo schema ABA BCB CDC, ecc.<br />
Nel mezzo del cammin di nostra vita A<br />
mi ritrovai per una selva oscura, B<br />
che la diritta via era smarrita. A
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura B<br />
esta selva selvaggia ed aspra e forte C<br />
che nel pensier rinnova la paura ! B<br />
Rima interna<br />
Quando almeno una delle parole che formano la rima si trova all‟interno del verso all‟ora si parla di rima<br />
interna.<br />
Rima al mezzo (o rimalmezzo)<br />
Questo particolare tipo di rima si ottiene quando la rima interna cade al termine di un emistichio (metà del<br />
verso), ossia quando coincide con la cesura.<br />
Versi sciolti<br />
Quando i versi non sono legati tra loro da alcun schema di rima, allora si parla di versi sciolti; questi<br />
sono entrati in uso nella poesia dell‟Ottocento (anche i componimenti di Leopardi sono in versi sciolti) e si<br />
sono affermati nel Novecento.<br />
Assonanza e consonanza<br />
Attenzione a non confondere l‟assonanza e la consonanza con la rima, nella rima vi è una perfetta<br />
identità dei suoni dopo l’accento tonico, mentre nell‟assonanza vi è l’identità delle sole vocali, e nella<br />
consonanza l’identità delle sole consonanti.<br />
nostri-volti (assonanza)<br />
partisti-rimasta (consonanza)<br />
Allitterazione<br />
Il termine allitterazione deriva dal latino ad litterare = allineare lettere. Questa figura di suono si ottiene<br />
ripetendo uno stesso fonema (o uno simile) in una o più parole successive:<br />
E nella notte nera come il nulla<br />
(da G. Pascoli, Il tuono)<br />
Già tutta l‟aria imbruna,<br />
torna azzurro il sereno, e tornan l‟ombre<br />
(da G. Leopardi, Sabato del Villaggio)<br />
Onomatopea<br />
Detta anche armonia imitativa, l’onomatopea consiste nell’usare delle espressioni verbali che<br />
richiamano particolari suoni naturali. L‟espressione verbale che viene usata può essere foneticamente<br />
imitativa (il gre gre della rane), oppure contenere dei fonemi che suggeriscono acusticamente l’azione o<br />
l’oggetto (il fruscio delle foglie, il miagolare del gatto, ecc.).<br />
Paronomasia<br />
Viene detta anche “bisticcio”, consiste nell’accostare due parole di suono simile ma di significato<br />
completamente diverso:<br />
sedendo e mirando<br />
(G.Leopardi, L‟Infinito )<br />
2. Figure sintattiche (anafora, anastrofe, chiasmo, climax, ellissi, enumerazione, iperbato)<br />
Anafora<br />
Il termine anafora deriva dal greco anaphéro = ripeto. Consiste nella ripetizione di una o più parole<br />
all’inizio di due versi o di due periodi; è tipica delle preghiere, delle invocazioni, delle filastrocche.<br />
Per me si va nella città dolente,<br />
per me si va nell‟eterno dolore,<br />
per me si va tra la perduta gente.<br />
(Dante, Inferno, Canto III vv.1-3)<br />
Anastrofe<br />
Questo temine deriva dal greco anàstrophe = inversione. Questa figura prevede un sovvertimento,<br />
rispetto alla struttura sintattica abituale, dell’ordine degli elementi di una frase.<br />
La bocca sollevò dal fiero pasto<br />
quel peccator (Dante, Inferno)<br />
12
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
invece di: Quel peccator sollevò la bocca dal fiero pasto<br />
Chiasmo<br />
Dal greco khiasmòs = collocazione in forma di croce, secondo la lettera greca X. Si tratta di un particolare<br />
tipo di inversione che prevede la disposizione incrociata di due espressioni, il cui ordine delle parole è<br />
invertito nella seconda rispetto la prima, così da formare una X.<br />
Le donne i cavalieri<br />
l‟arme .. gli amori<br />
(Ludovico Ariosto, Orlando furioso)<br />
Si noti come Le donne richiami l‟espressione gli amori e i cavalieri l‟espressione l‟arme, a formare una X.<br />
Climax<br />
Collegata alla figura della Enumerazione, per climax si intende una progressiva successione di termini in<br />
un ordine che può essere crescente per cui si parla di climax ascendente (progressivo intensificarsi del<br />
concetto) o decrescente (progressivo attenuarsi del concetto) e si parla di climax discendente (o<br />
anticlimax).<br />
Climax ascendente<br />
Antonio quando corre è rapido, veloce, un razzo, un fulmine.<br />
Climax discendente<br />
Questo alunno è intelligente, ha buona memoria, fa quello che può.<br />
Ellissi<br />
Deriva dal greco élleipsis = mancanza. L‟ellissi prevede l’eliminazione di uno più elementi sintattici<br />
all’interno della frase al fine di ottenere una maggiore efficacia comunicativa; l‟ellissi è usata anche nei<br />
testi non poetici (si pensi alle frasi nominali, o prive di verbo, come ad esempio “Oggi pensionati in piazza”)<br />
Gèmmea [è] l‟aria, il sole [è] così chiaro,<br />
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore.<br />
(da G. Pascoli, Novembre)<br />
Enumerazione<br />
Consiste nella rapida rassegna di eventi, oggetti, qualità coordinati per asindeto (ossia senza le<br />
congiunzioni e, o, ma, ecc., in alcuni casi sostituite da segni di punteggiatura) o per polisindeto (con le<br />
consuete congiunzioni).<br />
Enumerazione per asindeto.<br />
S‟aprirà quella strada,<br />
le pietre canteranno,<br />
il cuore batterà sussultando,<br />
come l‟acqua nelle fontane.<br />
(Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna)<br />
Enumerazione per polisindeto.<br />
Benedetto sia „l giorno e „l mese, e l‟anno,<br />
e la stagione, e „l tempo, e l‟ora, e „l punto,<br />
(Petrarca, dal Canzoniere)<br />
Iperbato<br />
Indica l’alterazione dell’ordine consueto delle parole e l’inserimento di uno o più termini tra parole<br />
che sintatticamente andrebbero unite.<br />
invece di: mandano al ciel mille incensi di fiori.<br />
mille di fior al ciel mandano incensi<br />
13<br />
(Foscolo, Sepolcri)<br />
3. Figure di significato (analogia, litote, iperbole, metafora, similitudine, metonimia, ossimoro,<br />
sineddoche, sinestesia)<br />
Analogia<br />
L‟analogia non è una figura retorica vera e propria, ma una tecnica, tipica del Decadentismo, che consiste<br />
nell’accostare realtà logicamente lontanissime, scoprendo, mediante l’intuizione, relazioni e<br />
corrispondenze particolari.
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Ma nel mio cuore<br />
nessuna croce manca<br />
E‟ il mio cuore<br />
il paese più straziato.<br />
si noti l‟analogia tra il cuore sofferente e il paese distrutto dalla guerra.<br />
14<br />
(da Ungaretti, San Martino del Carso)<br />
Litote<br />
Questa figura si ha quando si afferma un concetto mediante la negazione del suo contrario.<br />
Don Abbondio non era nato con un cuor di leone<br />
(Manzoni, I promessi sposi)<br />
Non cuor di leone indica la mancanza di coraggio, una forma attenuata per dire che Don Abbondio era un<br />
vile.<br />
Iperbole<br />
L’iperbole è una esagerazione nella rappresentazione della realtà, tramite l’uso di termini o<br />
espressioni che amplificano, o riducono, oltre misura la realtà stessa.<br />
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale<br />
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino<br />
(Montale, Xenia I)<br />
Un milione di scale rappresenta un‟iperbole della realtà.<br />
Metafora<br />
Questo termine deriva dal greco metaphérein = trasferire. Indica la sostituzione di una parola con<br />
un’altra, con la quale abbia una qualche relazione di significato (aspetto in comune). La metafora è<br />
molto usata dai poeti perché, sovrapponendo due concetti, anche molto diversi tra loro, crea immagini nuove<br />
ed originali.<br />
Per esempio nell‟espressione capelli d‟oro la parola oro viene usata perché il suo colore giallo richiama il<br />
biondo dei capelli.<br />
Antonio è [coraggioso] un leone e Sandro è [pauroso] un coniglio<br />
Nella frase proposta abbiamo due metafore, nella prima usiamo il termine leone per indicare il coraggio di<br />
Antonio (l‟elemento in comune tra Antonio e il leone è il coraggio), nella seconda usiamo il termine coniglio<br />
per indicare che Sandro è pauroso (l‟elemento in comune tra Sandro e il coniglio è la paura). La metafora è<br />
una delle figure più usate, diffusa anche nel linguaggio comune: sei un somaro, ai piedi dell‟albero, ecc.<br />
Similitudine<br />
Consiste nell’evidenziare un rapporto di somiglianza tra due esseri, due azioni, due avvenimenti, ecc.<br />
La similitudine si caratterizza, rispetto alla metafora, per la presenza di nessi logici di collegamento<br />
(come, quale, quanto, ecc.).<br />
E caddi come corpo morto cade<br />
(Dante, Inferno)<br />
Metafore similitudine sono figure molto simili, per ricordarsi la differenza bisogna ricordare come nella<br />
similitudine vi sempre un nesso logico di collegamento tra gli elementi interessati, tale nesso manca nella<br />
metafora, tanto che alcuni studiosi vedono nella metafora una similitudine abbreviata.<br />
Giovanni corre veloce come una lepre (similitudine)<br />
Giovanni quando corre è una lepre (metafora)<br />
Metonimia<br />
Il termine deriva dal greco metà = cambiamento e ònyma = nome. Tale figura prevede la sostituzione di un<br />
termine con un altro. Lo scambio di termini è possibile perché i due elementi sono tra loro legati da un<br />
rapporto logico. Si parla di metonimia quando tra gli elementi scambiati vi è un rapporto:<br />
1. causa ed effetto o viceversa: “Talor lasciando le sudate carte” (da Leopardi, A Silvia);<br />
2. materia e oggetto: “sguainare il ferro” (Monti);<br />
3. contenente e contenuto: “bevve un bicchiere” (Manzoni);<br />
4. l’astratto e il concreto e viceversa: a chi piace la spada [vita militare];<br />
5. l’autore con l’opera: leggere Dante;<br />
6. il simbolo e la cosa simboleggiata: “educò un lauro.... e t‟appendea corone” (Foscolo)<br />
7. la cosa posseduta e il possessore: i colletti bianchi, le camicie rosse;<br />
8. il mezzo e la persona: “lingua mortal non dice...” (Leopardi)
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Ossimoro<br />
Consiste nell’accostamento di termini o espressioni di senso opposto, antitetico. Un tale accostamento,<br />
proprio per la sua originalità crea un effetto particolarmente intenso. L‟uso di ossimori è frequente nella<br />
poesia di Pascoli: “tacito tumulto”, “estate fredda”, ecc.<br />
Sineddoche<br />
Simile alla metonimia, questa figura prevede la sostituzione di un termine con un altro, col quale vi sia<br />
una relazione di tipo estensionale (quantitativa). Si parla di sineddoche quando tra gli elementi scambiati<br />
vi è un rapporto di:<br />
1. parte per il tutto e viceversa: “E se da lungi i miei tetti saluto” (Foscolo), ho dipinto casa;<br />
2. il singolare per il plurale e viceversa: l‟uomo è egoista, gli Augusti sono rari nella storia;<br />
3. il genere per la specie e viceversa: i mortali per gli uomini, il pane non ci manca;<br />
Sinestesia<br />
Consiste nell’associare due termini (ad esempio un sostantivo e un aggettivo) che appartengono a sfere<br />
sensoriali diverse: “pigolio di stelle” (Pascoli), “urlo nero” (Quasimodo), “fresche le mie parole nella<br />
sera” (D‟Annunzio).<br />
INTERPRETAZIONE <strong>DEL</strong> <strong>TESTO</strong><br />
Il momento dell‟interpretazione si concretizza in queste quattro fasi analitiche:<br />
1. il testo nella produzione dell’autore<br />
2. il testo nella produzione del suo tempo<br />
3. il testo nella produzione poetica in generale<br />
4. il mio rapporto con quel particolare testo (o commento)<br />
per le prime tre fasi è preferibile, come abbiamo fatto per l‟analisi extratestuale, rivolgersi ai critici letterari,<br />
magari più d‟uno, per poter comprendere quale rilevanza abbia il testo nella produzione dell‟autore, nella<br />
produzione del tempo e nella produzione poetica in generale. Discorso totalmente diverso bisogna invece<br />
fare per quanto attiene al mio rapporto con il testo letto.<br />
Il mio rapporto con quel particolare testo (o commento)<br />
Questo punto viene spesso, a torto, trascurato nello studio di un testo poetico, è il momento del mio<br />
coinvolgimento razionale ed emotivo. Adesso, dopo aver acquisito le necessarie informazioni extratestuali,<br />
dopo aver fatto una puntuale analisi testuale e dopo aver letto l‟opinione dei critici, qual è l‟idea che io mi<br />
sono fatto del testo, quali pensieri, quali emozioni e sentimenti la sua lettura ha provocato in me. Si tratta del<br />
commento al testo, questo può essere apprezzato ma anche criticato, attenzione però ogni nostro giudizio<br />
dovrà essere giustificato da valide argomentazioni, che possono nascere solo da una approfondita conoscenza<br />
dell‟opera e dl suo significato profondo. In questo caso non vi sono molti consigli che possono essere dati,<br />
ognuno cerchi di affinare la propria capacità d‟ascolto di quella tipologia testuale del tutto particolare<br />
chiamata “testo poetico”.<br />
15
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
SAGGIO BREVE<br />
Il saggio breve è una sorta di miniatura – molto maneggevole – di testo informativo/argomentativo<br />
nella sua forma più essenziale: ne comprende le sezioni fondamentali, ne simula l‟organizzazione e<br />
ne rispecchia la logica costruttiva. In quanto forma minimale – ma completa – di testo espositivo, il<br />
saggio breve può divenire un ottimo modello per la realizzazione – attraverso espansione e<br />
rielaborazione – di documenti molto più complessi (relazioni, rapporti, studi, tesi).<br />
La lezione in breve<br />
Il saggio breve in cinque capoversi è un testo informativo/argomentativo a struttura rigida che può<br />
essere impiegato quale modello per testi più complessi, anche molto lunghi. Nella sua forma tipica,<br />
è costituito da 5 segmenti (capoversi) unitari dal punto di vista linguistico, contenutistico e<br />
paratestuale collegati tra loro da frasi-transizione e raccolti in tre sezioni: Introduzione, corpo del<br />
testo e conclusione. Mentre l‟introduzione e la conclusione sono costituite da un capoverso<br />
ciascuna, il corpo del testo ne raccoglie tre.<br />
L‟introduzione ha il compito fondamentale di presentare l‟argomento oggetto di trattazione, di<br />
chiarire quale sia il fine comunicativo dello scrivente e di anticipare la struttura del testo; i tre<br />
capoversi del corpo hanno lo scopo di sviluppare l‟argomento in maniera conforme a quanto<br />
anticipato nell‟introduzione e la conclusione risponde al fine di riepilogare le considerazioni svolte<br />
nel corpo del testo.<br />
Il saggio breve in cinque capoversi: concetti di base<br />
Si può descrivere il Saggio breve in cinque capoversi come un testo a struttura rigida che risponde a<br />
fini informativi o argomentativi; nella sua versione informativa, il saggio breve ha lo scopo di<br />
offrire informazioni adeguate su un tema specifico; nella sua versione argomentativa, esso sostiene,<br />
attraverso catene di enunciati, la validità di un‟affermazione. Detto in altre parole, il saggio breve<br />
argomentativo è congegnato per sostenere la giustezza di un‟idea (più oltre faremo riferimento<br />
all‟enunciato in cui questa idea viene formulata esplicitamente con il nome di tesi). 2<br />
Come suggerisce il suo nome – e come vedremo in dettaglio nelle pagine seguenti – il saggio breve<br />
si articola in cinque segmenti (“capoversi”) ciascuno formato da più proposizioni in catena e<br />
distinto dagli altri con un a-capo. 3 I segmenti si susseguono in un ordine rigido e, nel loro insieme,<br />
compongono le tre partizioni fondamentali del saggio: l‟introduzione, il corpo del testo e la<br />
conclusione.<br />
Ognuno dei capoversi in cui si articola il saggio breve ha una configurazione ben definita, che verrà<br />
descritta in dettaglio nei prossimi paragrafi; qui occorre solo segnalare che i tre capoversi del corpo<br />
centrale condividono la medesima organizzazione e si contrappongono, in questo, all‟introduzione e<br />
alla conclusione, che presentano un impianto differente.<br />
Un‟ultima nota: nel testo – a supporto della tesi o ai fini della completezza di informazione –<br />
possono essere incluse informazioni di tipo diversissimo: ciò che conta è che esse possiedano un<br />
2 L‟enunciato è una combinazione di parole (ma può essere costituito anche da una sola parola) che rappresentano un‟unità<br />
all‟interno di un‟interazione comunicativa. In molti casi coincide con ciò che la grammatica chiama frase, ma ciò non accade sempre:<br />
un enunciato, infatti, può essere più breve di una frase, mancare di più elementi e non essere corretto da un punto di vista<br />
grammaticale. Nell‟ambito di un dialogo immaginario, per esempio, un Subito! fornito in risposta ad una domanda come Allora<br />
quando parti? costituirebbe un enunciato, ma non una frase.<br />
3 Come si è suggerito nella presentazione dell‟unità, si può tranquillamente espandere la struttura del saggio breve, facendo sì che<br />
esso sia composto di paragrafi invece che di capoversi; e si può addirittura trasformarlo in un saggio molto esteso, tanto da fare<br />
diventare i paragrafi dei capitoli. Questa è un‟evoluzione desiderabile e necessaria e il saggio breve si propone esplicitamente come<br />
modello “adattabile” a varie situazioni comunicative; in questa unità, tuttavia, presenteremo il saggio nella sua forma più semplice,<br />
che non contiene più di 500 parole. Si ricordi che il paragrafo rappresenta ciascuna delle unità in cui si articolano i capitoli, e che i<br />
capoversi sono le unità che costituiscono i paragrafi. Di solito i paragrafi sono titolati, mentre i capoversi non lo sono e si distinguono<br />
gli uni dagli altri per la presenza di un a-capo o di un rientro di prima riga.<br />
16
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
grado di formalità, di affidabilità e di completezza adeguati alla natura dell‟argomento e<br />
dell‟uditorio. Indicazioni più dettagliate verranno fornite, a questo riguardo, nelle unità dedicate al<br />
processo della scrittura; sia sufficiente, in questa sede, dire che nel saggio breve possono essere<br />
usate, a seconda delle necessità, narrazioni aneddotiche, esempi tratti da esperienze reali proprie o<br />
altrui, dati (numerici e non) acquisiti attraverso inchieste dirette o raccolti da fonti secondarie,<br />
citazioni da testi autorevoli ed altro ancora.<br />
La funzione del saggio breve<br />
Come si è ripetuto più volte, il saggio breve può avere funzione informativa o argomentativa; nel<br />
primo caso, il suo fine è quello di fornire informazioni e di offrire spiegazioni, spesso definendo<br />
concetti o descrivendo accuratamente stati di cose. Nel secondo, invece, il suo fine è quello di<br />
convincere il lettore della bontà di una determinata opinione, eventualmente spingendolo ad<br />
intraprendere comportamenti specifici.<br />
La differenza dei fini comunicativi si riflette sia sugli argomenti passibili di trattazione che sul<br />
modo in cui essi devono venire affrontati: mentre, infatti, si può informare su tutto, non si può<br />
argomentare che sul discutibile. Ciò significa che l‟oggetto di un saggio argomentativo non può che<br />
essere uno attorno al quale si possa sviluppare un dibattito. Sarebbe molto difficile, ad esempio,<br />
costruire un saggio argomentativo parlando di droghe e sostenendo che hanno effetti nocivi sulla<br />
salute umana: questa è una constatazione difficilmente confutabile, per la quale si faticherebbe a<br />
trovare un antagonista disputante; e senza un quid demonstrandum ed qualcuno cui dimostrarlo non<br />
esiste neppure un testo argomentativo.<br />
Inoltre, l‟enunciato le droghe hanno effetti nocivi sulla salute umana non solo si limita a constatare<br />
un semplice fatto, ma non mette neppure in chiaro quale sia l‟opinione dello scrivente in merito ad<br />
esso; anche questo è un requisito fondamentale del saggio argomentativo: difficilmente infatti si<br />
potrà convalidare un‟opinione se non la si dichiara. Insomma: il presupposto per un saggio<br />
argomentativo è che (a) riguardi un tema su cui sia possibile disputare e (b) spieghi chiaramente<br />
quale sia la posizione sostenuta nella potenziale controversia. 4<br />
Un testo informativo, invece, deve rispettare un numero inferiore di requisiti: è sufficiente che verta<br />
su un argomento interessante e che presenti informazioni complete ed aggiornate, utili per il proprio<br />
uditorio. Da questo punto di vista, il saggio informativo è più semplice di quello argomentativo, che<br />
richiede un supplemento di riflessione ed una più accurata organizzazione delle idee.<br />
La struttura del saggio breve<br />
Abbiamo già chiarito, nei paragrafi precedenti, che il saggio breve in cinque capoversi si articola in<br />
tre sezioni principali: l‟introduzione, il corpo del testo e la conclusione. Mentre introduzione e<br />
conclusione sono costituiti da un capoverso ciascuna, il corpo del testo ne comprende tre.<br />
Schematicamente, dunque, la struttura del saggio breve è la seguente:<br />
Introduzione (1 solo capoverso)<br />
Corpo del testo (3 capoversi)<br />
Conclusione (1 capoverso).<br />
Come è ovvio, ciascuna delle sezioni che costituiscono il saggio breve risponde ad uno scopo<br />
diverso e presenta varie specificità sia dal punto di vista della struttura che da quello del contenuto:<br />
vedremo quali nei paragrafi che seguono.<br />
4 Avrebbe tutte le carte in regola per riuscire un buon testo argomentativo in cui si sostenga che come quelle pesanti,<br />
anche le droghe leggere hanno effetti nocivi rilevanti sull‟organismo umano e conducono alla dipendenza: per questo il<br />
loro consumo non dovrebbe essere ammesso. Il suo argomento si presterebbe al dibattito e la posizione sostenuta<br />
dall‟autore del testo vi è esplicitamente dichiarata.<br />
17
L‟introduzione<br />
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
L‟introduzione risponde a più scopi, tra i quali quelli fondamentali sono:<br />
a quello di introdurre il lettore nel testo, provocandone l‟attenzione;<br />
b quello di indicargli l‟argomento di cui si tratta;<br />
c quello di chiarire, nel caso di un testo argomentativo, quale sia l‟opinione che vi viene sostenuta;<br />
d quello di fornire una sorta di essenzialissimo sunto del testo (chiamato spesso blueprint) 5 ;<br />
e quello di introdurre i paragrafi successivi, in modo da stimolare la prosecuzione della lettura.<br />
Schematicamente, dunque, il capoverso introduttivo dovrebbe articolarsi nelle sezioni che seguono:<br />
a introduzione al testo, tesa ad interessare il lettore;<br />
b presentazione dell‟argomento;<br />
c presentazione del fine comunicativo;<br />
d esposizione della tesi;<br />
e presentazione schematica della struttura del testo;<br />
f aggancio ai paragrafi successivi.<br />
Vi sarà modo di tornare sull‟argomento nella prima delle unità dedicate al processo della scrittura;<br />
ai fini della comprensione di quanto scriverà nei prossimi paragrafi, però, è necessario introdurre –<br />
anche se in forma non perfettamente rifinita – i concetti-chiave di (a) argomento, (b) tesi, (c) fine<br />
comunicativo e (d) presentazione schematica della struttura del testo.<br />
L’argomento<br />
L‟argomento è, nella sua accezione più larga, l‟oggetto del discorso 6 che si conduce nel saggio;<br />
argomento di un saggio informativo o argomentativo, ad esempio, potrebbe essere quello degli<br />
effetti nocivi delle droghe sulla salute umana.<br />
La tesi<br />
La tesi, in un testo argomentativo, è un enunciato in cui l‟autore esprime un‟opinione precisa<br />
riguardo all‟argomento che ha deciso di trattare. Nel saggio – come nella maggior parte dei testi<br />
argomentativi tecnici, scientifici e professionali – essa deve essere sempre formalizzata<br />
esplicitamente – “messa nero su bianco” – in un enunciato; in altre scritture – soprattutto in quelle<br />
non molto formali (giornalistiche ad esempio) o che abbiano qualche intento persuasivo (come<br />
quelle politiche) – essa viene talvolta sottaciuta o dissimulata.<br />
Un esempio valido di tesi argomentativa potrebbe essere il seguente: Gli strumenti finanziari ed<br />
economici messi in opera dal Governo per il contenimento del deficit pubblico non sono adeguati a<br />
fronteggiare l‟emergenza attuale. In esso, infatti, non solo è del tutto chiaro quale sia l‟argomento<br />
del discorso (vi si tratta degli strumenti finanziari ed economici messi in opera dal Governo per il<br />
contenimento del deficit pubblico), ma anche l‟opinione sostenuta, in merito ad esso, dallo scrivente<br />
(secondo cui, appunto, essi sono inadeguati a fronteggiare una congiuntura economica negativa).<br />
Il fine comunicativo<br />
5 Il termine significa „cianografia‟; la cianografia è un procedimento di stampa usato per la riproduzione su carta<br />
azzurro scuro di disegni, soprattutto tecnici, in scala; il termine blueprint, dunque indica, nel contesto cui stiamo<br />
facendo riferimento, lo “schema proporzionalmente ridotto” del testo nel suo complesso.<br />
6 Il termine discorso indica, nel contesto in cui lo stiamo usando, l‟esposizione di una serie organica di pensieri per<br />
mezzo concatenati tra loro; esso designa, quindi, non solo il contenuto di tale esposizione, ma anche il modo particolare<br />
in cui l‟autore ha deciso di presentarlo. In qualche modo il termine potrebbe essere considerato sinonimo di testo.<br />
18
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Il fine comunicativo è l‟obiettivo cui tende la scrittura: in un testo argomentativo esso consiste,<br />
come abbiamo chiarito, nel tentativo di convincere il proprio uditorio della validità della tesi che<br />
l‟autore vi sostiene. La concorrenza di più fini, naturalmente, è sempre possibile: così, l‟autore di un<br />
testo argomentativo, oltre a convincere della bontà di una determinata tesi, potrebbe anche voler<br />
indurre il proprio uditorio a certi comportamenti (per esempio: a votare sì o no ad un referendum<br />
sulle centrali nucleari; a votare o non votare i rappresentanti della maggioranza alla successiva<br />
tornata elettorale e così via).<br />
Non è detto che tutti i fini comunicativi cui risponde un testo debbano essere espliciti: in qualche<br />
caso, infatti, il celarne alcuni può essere funzionale proprio al loro raggiungimento. Si pensi, ad<br />
esempio, a testi persuasivi come quelli pubblicitari: difficilmente il loro autore vi dichiara a tutte<br />
lettere di volere convincere il suo uditorio ad acquistare un determinato bene (magari voluttuario,<br />
costoso, pericoloso o addirittura nocivo); anzi: nella maggior parte dei casi la vera abilità del<br />
pubblicitario consiste proprio nel dissimulare le proprie intenzioni reali, in modo da non mettere in<br />
allerta il destinatario del proprio messaggio suscitando in lui reazioni di rigetto.<br />
Quando però farlo ha un senso – come nella maggior parte dei testi argomentativi e informativi e, in<br />
ogni caso, nel saggio breve –, la dichiarazione dei fini ha la forma di uno o più enunciati in<br />
sequenza e assomiglia alla seguente, che possiamo immaginare collocata in apertura di un ipotetico<br />
“pezzo” dedicato a questioni economiche: questo articolo vuole convincere i propri lettori del fatto<br />
che la politica economico-finanziaria del Governo è assolutamente inadeguata a fronteggiare<br />
l‟attuale situazione di emergenza.<br />
La presentazione schematica della struttura del testo<br />
La presentazione schematica della struttura del testo (blueprint) è un semplice elenco, in formato<br />
discorsivo; in un testo argomentativo si tratta di un breve inventario delle prove (tecnicamente:<br />
argomenti 7 ) impiegate a sostegno della tesi che vi si sostiene; in uno informativo si tratta di<br />
catalogo strutturato delle informazioni fornite.<br />
Il blueprint ha la funzione di anticipare al lettore informazioni sullo sviluppo del testo e per questo<br />
gli può essere molto utile: sapere come verranno presentate le informazioni ne rende infatti più<br />
facile e piena la comprensione e permette di decidere sin dal principio in modo ragionato se un testo<br />
è utile o no.<br />
Dal momento che ha, in sostanza, la funzione di un sommario, il blueprint deve rispecchiare<br />
pienamente il testo: l‟ordine in cui vi sono presentati gli argomenti deve coincidere, quindi, con<br />
quello in cui essi vengono introdotti nel testo. In un saggio breve, dal momento che il corpo del<br />
testo prevede tre soli capoversi, la presentazione schematica del testo potrà fare riferimento a tre<br />
soli argomenti/informazioni fondamentali.<br />
Nell‟ipotetico testo di argomento economico cui abbiamo più volte fatto riferimento, un blueprint<br />
accettabile potrebbe avere questa forma: Gli interventi finanziari previsti dal Governo non possono<br />
che deprimere, in ultima analisi, l‟economia industriale, già in affanno: in primo luogo aumentano<br />
l‟indebitamento delle famiglie e provocano una contrazione del mercato interno; in secondo luogo<br />
non incidono sui fattori strutturali che hanno creato la congiuntura e, in terzo, inibiscono la<br />
crescita della piccola e media impresa, un settore tradizionalmente trainante nell‟economia<br />
italiana. Si noti come, in esso, si faccia esplicito riferimento alle tre ragioni fondamentali per cui<br />
l‟autore ritiene fallimentare la politica economica del Governo: esse – nella stessa sequenza in cui<br />
sono elencate nel blueprint – verranno riprese nei tre capoversi che costituiscono il corpo del testo,<br />
e ne costituiranno, ciascuna, il nucleo argomentativo.<br />
Non esiste un ordine preferenziale nella presentazione degli argomenti: alcuni autori consigliano di<br />
includere gli argomenti decisivi nel primo capoverso; altri ritengono che si debba procedere invece<br />
7 Un testo argomentativo non solo si svolge intorno ad un argomento („oggetto di discorso‟), ma impiega anche serie di<br />
argomenti („prove‟) per convalidare una tesi.<br />
19
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
dal più debole al più forte, secondo un crescendo di sapore retorico. La scelta non marcata 8 è la<br />
seconda: se, infatti, si presenta nel primo enunciato, il proprio argomento forte, gli altri non avranno<br />
più grande utilità: la valutazione va compiuta, in ogni caso, di volta in volta, tenendo conto, come si<br />
vedrà meglio nelle unità seguenti, dell‟uditorio e dell‟argomento, al fine di massimizzare l‟efficacia<br />
comunicativa del proprio discorso.<br />
Il corpo del testo<br />
Il corpo del testo si articola, come si è già scritto, in tre capoversi; in un testo informativo, ciascuno<br />
di essi presenta un set di informazioni collegate alla questione che si è scelto di trattare; in un testo<br />
argomentativo propone uno degli argomenti scelti a sostegno della propria tesi.<br />
Ogni capoverso ha la medesima struttura: include, di norma, (a) una frase-chiave (topic-sentence)<br />
che ne costituisce il nucleo informativo-argomentativo e che ne rappresenta, da sola, il messaggio<br />
fondamentale; (b) comprende più frasi in cui si forniscono informazioni/sub-argomenti a supporto<br />
della frase-chiave 9 ; (c) una frase di transizione che guida il lettore al capoverso successivo (nel<br />
terzo capoverso la frase di transizione conduce alla conclusione). Le frasi di transizione possono<br />
anche mancare ed essere sostituite da elementi di collegamento collocati all‟inizio del capoverso<br />
successivo (si veda, per un esempio di questa organizzazione, il saggio breve analizzato a partire da<br />
pagina 23).<br />
La conclusione<br />
In un testo informativo, la conclusione include solitamente (a) una ripresa dell‟enunciato con il<br />
quale, nell‟introduzione, si presentava l‟oggetto del discorso; (b) una ripresa dei tre set di<br />
informazioni fornite nel corpo del testo e (c) un segmento conclusivo, che indichi che la discussione<br />
è giunta al termine e si ricolleghi, se necessario, al capoverso introduttivo, in particolare a quella<br />
sua sezione iniziale in cui, con quale artificio retorico o qualche frase ad effetto si è cercato di<br />
interessare il lettore al testo che aveva sotto gli occhi. In un testo argomentativo, invece, la<br />
conclusione include: a) una riformulazione della tesi; (b) la ripresa dei tre argomenti fondamentali;<br />
(c) il segmento conclusivo.<br />
La struttura del saggio breve, in uno schema<br />
Volendo riassumere, si può dire che il saggio breve ha la struttura presentata nel box seguente.<br />
I. Introduzione<br />
1. Introduzione al testo<br />
2. Presentazione della questione/esposizione della tesi<br />
3. Presentazione schematica della struttura del testo (blueprint)<br />
4. Frase di transizione (opzionale)<br />
II. Corpo del testo<br />
a) Primo capoverso<br />
1. Frase-chiave (topic sentence)<br />
2. prima informazione/primo elemento di supporto<br />
3. seconda informazione/secondo elemento di supporto<br />
4. terza informazione/terzo elemento di supporto<br />
8 Dato un insieme di possibili opzioni, quella non marcata viene scelta per prima, in mancanza di elementi che ne<br />
facciano preferire altre. In termini informatici, si potrebbe dire che la scelta non marcata è quella di default per la<br />
maggior parte degli utenti.<br />
9In genere, per semplice amore della geometria testuale, ci si limita a tre per ciascun capoverso.<br />
20
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
5. Frase di transizione (opzionale)<br />
b) secondo capoverso<br />
1. Frase-chiave (topic sentence)<br />
2. prima informazione/primo elemento di supporto<br />
3. seconda informazione/secondo elemento di supporto<br />
4. terza informazione/terzo elemento di supporto<br />
5. Frase di transizione (opzionale)<br />
c) terzo capoverso<br />
1. Frase-chiave (topic sentence)<br />
2. prima informazione/primo elemento di supporto<br />
3. seconda informazione/secondo elemento di supporto<br />
4. terza informazione/terzo elemento di supporto<br />
5. Frase di transizione (opzionale)<br />
III. Conclusione<br />
1. Riferimento alla questione di partenza/riformulazione della tesi<br />
2. Riassunto delle informazioni fornite/degli argomenti presentati<br />
3. Chiusura, che si collega alla frase di apertura dell‟Introduzione.<br />
La struttura del capoverso<br />
Il capoverso costituisce l‟unità informativo-testuale di base nel saggio breve: la sua riconoscibilità<br />
in quanto elemento testuale autonomo è garantita sia da elementi semantico-informativi, sia da<br />
elementi testuali e paratestuali. Ciò significa, detto altrimenti, che il capoverso può essere<br />
identificato come elemento unitario del testo tanto perché presenta – pur essendo parte di un<br />
insieme più grande – un contenuto relativamente compiuto, quanto perché mostra espliciti segnali<br />
formali di apertura e di chiusura.<br />
Per la precisione, un capoverso si presenta come compiuto dal punto di vista contenutistico in<br />
quanto risponde a tre requisiti fondamentali:<br />
a quello di essere comprensibile in isolamento, ovvero di avere un senso ricostruibile anche a<br />
prescindere dai capoversi che lo precedono e lo seguono;<br />
b quello di articolarsi intorno ad un tema principale, riconoscibile e isolabile;<br />
c quello di poter essere riassunto e parafrasato.<br />
Un capoverso, invece, si qualifica come unitario dal punto di vista formale quando mostra uno o più<br />
segnali (in genere interpuntori e paratestuali) che ne segnalano i confini: nei testi scritti, per<br />
esempio, a indicare la presenza di un confine di capoverso sono di solito un punto fermo ed un acapo.<br />
Spesso tali elementi segnaletici minimali sono rafforzati da altri, come righe di bianco o<br />
rientri della prima riga di testo (si veda il box seguente).<br />
Questo capoverso costituisce un‟unità informativa perché il suo contenuto è compiuto ed unitario;<br />
può essere compreso in isolamento, si articola intorno ad un tema principale che può essere<br />
identificato, può venire riassunto e parafrasato.<br />
Il capoverso si qualifica in quanto unità testuale anche perché presenta espliciti segnali di apertura e<br />
di chiusura: a delimitarne i confini sono la riga bianca che lo precede ed il punto (con a-capo) che lo<br />
segue.<br />
21
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
L‟unitarietà di un capoverso (e, quindi, poi, del testo che ne è composto) non sorge spontaneamente:<br />
è il risultato di uno sforzo cosciente del suo autore che ne verifica costantemente l‟organicità,<br />
applicando anche, talora, specifiche tecniche compositive.<br />
Una di quelle più sfruttate nel caso di testi informativi ed argomentativi, ad esempio, è quella della<br />
costruzione a piramide rovesciata (o top-down) con frase-chiave (o frase-guida o topic sentence).<br />
Ne scriveremo più diffusamente nelle unità che seguono; per il momento sia sufficiente dire che<br />
essa prevede che si includa in ciascun capoverso, preferibilmente all‟inizio, una frase che ne<br />
racchiude il messaggio fondamentale e che la si accompagni con altre che ne sono complemento ed<br />
espansione. Ciò garantisce, tra gli altri vantaggi, quelli dell‟evidenza, della trasparenza e della<br />
memorabilità dei contenuti e offre al lettore frettoloso la possibilità di comprendere il testo anche<br />
solo scorrendolo. Si veda, per un esempio di capoverso redatto in modalità top-down con frase<br />
chiave, il Box 3.<br />
La costruzione a piramide rovesciata con frase-chiave è informativamente funzionale: lo mostra<br />
questo capoverso il quale, dal momento che il suo contenuto è in qualche modo anticipato nella<br />
frase di apertura, risulta chiaro e memorabile. Il lettore che volesse avere maggiori informazioni<br />
sull‟argomento, naturalmente, potrebbe continuare a scorrere il testo, leggendo anche le frasi che<br />
seguono – questa inclusa – per scoprire nuovi particolari. Anche quello che tuttavia non volesse<br />
farlo, per fretta o disinteresse nei confronti della trattazione, potrebbe dire di essersi fatto un‟idea<br />
sufficientemente adeguata del suo significato leggendo solo le prime tre righe di testo.<br />
Nel caso di un saggio argomentativo, la frase-guida dell‟introduzione è costituita dalla tesi; la fraseguida<br />
della conclusione è rappresentata dalla sua riformulazione; le frasi-guida di ciascuno dei<br />
capoversi del corpo del testo provengono invece dallo sviluppo e dalla ripresa delle idee che – a<br />
sostegno della propria tesi – si sono presentate sommariamente nel blueprint. Nel caso di un saggio<br />
informativo, invece, la frase-guida dell‟introduzione è costituita dell‟enunciato che presenta<br />
l‟argomento trattato nel testo; la frase-guida della conclusione è rappresentata dalla sua riscrittura;<br />
le frasi-guida di ciascuno dei capoversi del corpo del testo sono invece l‟approfondimento delle<br />
informazioni che si sono anticipate nel blueprint<br />
Ad accompagnare la frase-guida, come si è già scritto nel paragrafo intitolato La struttura del<br />
capoverso, sono, nelle sezioni che compongono il testo, enunciati diversi per funzione e struttura. In<br />
particolare:<br />
a nell‟introduzione, accompagnano la frase-guida e hanno funzione di supporto (1) l‟introduzione<br />
al testo, (2) la presentazione schematica della struttura del testo (blueprint) e (3) la frase di<br />
transizione;<br />
b nel corpo del testo, in un saggio argomentativo, hanno questo ruolo (1) ciascuno degli argomenti<br />
usati per convalidare la frase-guida (in genere in numero di tre per ciascun capoverso) e (2) le<br />
frasi di transizione. In un testo informativo, invece, a complementare la frase-guida sono<br />
altrettanti enunciati in cui si forniscono informazioni via via più ricche e dettagliate:<br />
c nella conclusione, accompagnano la frase-guida (1) il riassunto degli argomenti principali<br />
presentati e (2) il segmento conclusivo, che si collega alla frase di apertura dell‟introduzione.<br />
Presentiamo, nel paragrafo che segue, un esempio di saggio breve argomentativo, accompagnandolo<br />
con un breve commento. Di ciascun capoverso evidenziamo tipograficamente i componenti (le<br />
frasi-chiave, quelle di complemento informativo) nei loro ruoli specifici.<br />
22
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Un esempio di saggio breve<br />
Il difficile di essere un genitore moderno<br />
Introduzione<br />
Frase di<br />
introduzione<br />
Tesi<br />
Blueprint<br />
Primo capoverso<br />
di supporto<br />
Frase-guida<br />
Primo argomento<br />
di sostegno<br />
Secondo argomento<br />
di sostegno<br />
Terzo argomento<br />
di sostegno<br />
Riproposizioni di sit-com americane degli anni Cinquanta e dei primi<br />
anni Sessanta mettono in scena i problemi che i genitori di un tempo<br />
dovevano affrontare con i loro bambini ed i loro ragazzi. Allora i<br />
Cleaver rimproveravano Beaver, loro figlio, perché non si lavava le<br />
mani prima di mettersi a tavola; Gli Anderson sgridavano Bud, già<br />
dodicenne, perché non faceva i compiti; i Nelson non lasciavano<br />
uscire Ricky perché dimenticava sempre la sua camera in disordine.<br />
Ma oggi i tempi sono completamente cambiati.<br />
Essere un genitore oggi è molto più difficile di quanto non fosse una<br />
generazione fa. Oggi madri e padri devono proteggere i loro figli da<br />
un numero sempre crescente di elementi di distrazione, da materiale<br />
ad alto contenuto erotico e da situazioni potenzialmente molto<br />
pericolose.<br />
I genitori d‟oggigiorno devono cercare, prima di tutto, di controllare<br />
le fonti di distrazione che possono allontanare i ragazzi dallo studio.<br />
A casa ogni studente ha uno stereo e magari una televisione in<br />
camera. Non molti ragazzini sanno resistere alla voglia di ascoltare un<br />
Cd o di guardare un clip su Mtv – soprattutto quando si tratta di fare i<br />
compiti. Fuori di casa le tentazioni sono ancora più forti: i ragazzi<br />
non si fermano più a chiacchierare all‟angolo sotto casa, a tiro di voce<br />
da mamma e papà che li richiamano perché facciano i compiti. Si<br />
ritrovano, invece, nei grandi centri commerciali, nei vari music-store<br />
o nei fast food pieni di luci. Persino a scuola non mancano distrazioni:<br />
oggi tutti i ragazzi hanno un cellulare, con i quali possono inviare in<br />
qualsiasi momento messaggi ai loro amici o riceverne; possono<br />
persino iscriversi a mailing-lists, che li bombardano di SMS e li<br />
rendono, costantemente disattenti. I genitori ed i compiti a casa hanno<br />
ovviamente grosse difficoltà a competere con queste stimolanti<br />
23
Secondo capoverso<br />
di supporto<br />
Collegamento con il<br />
capoverso precedente<br />
Frase-guida<br />
Primo argomento<br />
di sostegno<br />
Secondo argomento<br />
di sostegno<br />
Terzo argomento<br />
di sostegno<br />
Terzo capoverso<br />
di supporto<br />
Frase-guida<br />
Collegamento con il<br />
capoverso precedente<br />
Primo argomento<br />
di sostegno<br />
Secondo argomento<br />
di sostegno<br />
Terzo argomento<br />
di sostegno<br />
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
alternative.<br />
Oltre a dover affrontare queste fonti di distrazione, i genitori devono<br />
proteggere i loro figli da un vero e proprio diluvio di materiale<br />
erotico. Oggi i ragazzi possono trovare giornali pornografici e libri a<br />
contenuto erotico nello stesso negozio all‟angolo in cui un tempo si<br />
vendevano solo fumetti e lecca-lecca. I giovani non vedono i nudi<br />
sfuocati di una generazione fa, ma l‟esplicitezza grossolana di<br />
Playboy o Penthouse, quando va bene. E c‟è di più: i film che essi<br />
guardano sono spesso incentrati su situazioni intensamente sensuali.<br />
È difficile inculcare nei ragazzi i valori tradizionali quando i film<br />
mostrano insegnanti che seducono i loro alunni e dei teenager che<br />
considerano il sesso come un‟attività del tutto paragonabile alla<br />
partita di calcio. Un problema ancora più grave è costituito dal<br />
contenuto pesantemente erotico dei programmi televisivi. Premendo<br />
un semplice tasto i nostri figli possono vedere star delle telenovelas<br />
che si rotolano nel letto o, sempre più spesso, guardare programmi via<br />
cavo dove la nudità è di casa.<br />
Il problema più difficile da affrontare per i genitori del giorno d‟oggi,<br />
in ogni caso, è l‟incremento delle situazioni pericolose, addirittura<br />
potenzialmente mortali a cui sono esposti i giovani. Quando i figli<br />
sono ancora piccoli, i genitori temono che possano essere vittime di<br />
violenza. Tutti i telegiornali parlano di omicidi che fanno le loro<br />
vittime tra le bambine, di pedofili che seppelliscono bambini in<br />
cantina, o di un‟organizzazione criminale votata alla produzione di<br />
pornografia che molesta i bambini dell‟asilo. Quando poi i figli<br />
crescono, i genitori cominciano a preoccuparsi della droga. La<br />
pressione esercitata dai coetanei perché provino ad usarla è spesso più<br />
forte degli avvertimenti del padre o della madre e può essere fatale.<br />
Infine, anche se i ragazzi riescono ad evitare i rischi associati all‟uso<br />
di droga, devono comunque riuscire a resistere all‟allettamento del<br />
bere. Per quanto l‟alcool abbia sempre costituito un‟attrattiva per i<br />
teenager, alcune ricerche indicano che oggi essi tendono a bere molto<br />
più di un tempo. Come sanno molti genitori, le conseguenze di questa<br />
passione possono essere mortali, soprattutto quando l‟abuso di<br />
alcoolici si lega alla guida.<br />
24
Conclusione<br />
Riformulazione<br />
della tesi<br />
Collegamento con<br />
l‟introduzione<br />
Commento<br />
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Nel giro di una generazione, il mondo è cambiato radicalmente. Ci si<br />
chiede se le madri ed i padri di un tempo sarebbero stati in grado di<br />
affrontare i problemi di oggi. Gli Anderson sarebbero riusciti a tenere<br />
Bud lontano da Mtv? E i Nelson avrebbero potuto proteggere Ricky<br />
dalla stampa pornografica? I Cleaver sarebbero stati in grado di<br />
allontanare Beaver da droga ed alcool? I genitori devono essere<br />
consci di queste fonti di distrazione e di questi potenziali problemi e –<br />
allo stesso tempo – devono porsi nella condizione di garantire ai<br />
ragazzi la libertà che occorre loro per farli diventare adulti<br />
responsabili. E non è facile.<br />
L‟introduzione si apre cercando di attrarre l‟interesse del lettore con il riferimento a show televisivi<br />
d‟annata, che dipingono una realtà acutamente contrastante con quella attuale; ciò consente<br />
all‟autore di introdurre la propria tesi secondo cui “Essere un genitore oggi è molto più difficile di<br />
quanto non fosse una generazione fa”. Quello di introdurre il proprio testo con materiale che<br />
contrasta con quello che segue è un artificio molto usato, soprattutto nei testi giornalistici, ma<br />
consigliabile anche in altre occasioni. Si deve notare, all‟interno dell‟introduzione, la presenza del<br />
blueprint, che ha la funzione di presentare al lettore il contenuto dei capoversi di supporto. Si noti<br />
che, per quanto utile, il blueprint deve essere riservato ai casi in cui sia realmente necessario, e cioè<br />
soprattutto ai testi argomentativi piuttosto lunghi e complessi. La sua presenza in altri casi (come in<br />
questo, in cui però esso viene introdotto su richiesta del docente) rischia di fare apparire il testo un<br />
po‟ meccanico.<br />
L‟autore sostiene la sua tesi attraverso argomenti relativamente informali, presentando, cioè, serie<br />
di esempi e rimarcando il contrasto tra i bei tempi andati e il giorno d‟oggi.<br />
Gli esempi su cui si incentra il corpo della trattazione vengono disposti a formare un climax<br />
ascendente (ordine enfatico), segnalando prima le cose meno gravi, poi quelle più preoccupanti.<br />
All‟interno di ciascun capoverso, il materiale è ordinato secondo logiche variabili: nel primo<br />
spazialmente (si citano prima le fonti di distrazione domestiche e poi quelle che i ragazzi incontrano<br />
fuori casa), nel secondo enfaticamente (si fa riferimento prima ai giornali pornografici e poi ai<br />
programmi televisivi, il cui accesso è meno controllabile ed il cui effetto è perciò più insidioso), nel<br />
terzo cronologicamente (si va dai rischi corsi dai bambini a quelli cui sono esposti i ragazzi).<br />
Ogni capoverso di supporto si apre con un periodo guida e l‟unità del testo è segnalata<br />
dall‟abbondante (a volte persino eccessiva) presenza di legamenti (elementi del testo quali, ad<br />
esempio invece, inoltre …), di sinonimi e parole semanticamente collegate tra loro (erotico …<br />
sensuale … sesso … nudità; fonti di distrazione … stimolanti alternative), di proposizioni con<br />
funzione riassuntiva (Oltre a dover affrontare queste fonti di distrazione …).<br />
Il testo appare molto strutturato; persino troppo. In effetti l‟eccessiva fissità del modello costruttivo<br />
(in tutti i capoversi un periodo guida posto all‟inizio; a chiudere l‟introduzione un blueprint che<br />
riprende troppo evidentemente il tema dei tre capoversi che seguono; un certo scrupolo eccessivo di<br />
rendere evidenti i trapassi logici tra una parte del testo e l‟altra) mettono a nudo l‟artificio<br />
architettonico. Nel caso del testo che abbiamo presentato, ciò è richiesto dall‟esercitatore, ed ha una<br />
sua giustificazione didattica. In altri documenti – come quelli professionali – l‟autore può mostrarsi<br />
25
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
meno didascalico: una solida strutturazione deve essere presente anche in quelli, naturalmente, ed il<br />
loro dettato deve essere altrettanto chiaro, ma non tutto deve essere scolasticamente esplicito: una<br />
testo troppo predicibile finisce il divenire poco stimolante e a perdere forza di impatto. Nel caso in<br />
esame a rendere meno forte l‟impressione di elementarità schematica sarebbe stato sufficiente<br />
posticipare il periodo guida in uno dei capoversi, o magari omettere del tutto il blueprint o, ancora,<br />
limare qualche congiunzione sostituendola con dei segni interpuntivi…<br />
26
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
ARTICOLO DI GIORNALE<br />
Presentazione<br />
L‟articolo di giornale ha come scopo principale quello di informare il grande pubblico, attraverso<br />
una grande varietà di tematiche, di funzioni e scopi comunicativi, di linguaggi e di stili. Basta<br />
sfogliare le pagine di un quotidiano per rendersi conto della diversità sia della struttura degli<br />
articoli, sia del punto di vista del giornalista, sia dello scopo dell‟informazione.<br />
E poi bisogna distinguere tra articoli di cronaca, articoli di fondo, interviste, inchieste, notizie,<br />
commenti, ecc. Infine, il tipo di informazione che gli articoli forniscono varia all‟infinito, perché<br />
può spaziare dall‟ambito politico a quello sociale ed economico, dall‟ambito culturale a quello<br />
scientifico, ecc…<br />
Caratteristiche dell’articolo richiesto in ambito scolastico:<br />
a) Argomento<br />
La prova scolastica, prevede la trattazione di argomenti di ampia rilevanza sociale e culturale,<br />
inoltre deve tenere ben presenti i dati forniti dal ministero.<br />
b) Tipo di articolo<br />
Tali circostanze fanno sì che l‟articolo che viene richiesto agli esami non corrisponda a qualsiasi<br />
tipo di scrittura giornalistica, ma di una in particolare, più o meno corrispondente all‟articolo di<br />
fondo, ovvero all‟articolo di opinione, o di riflessione.<br />
c) Destinatario<br />
Il carattere di prova scolastica delimita anche il cerchio del destinatario. A meno che<br />
l‟individuazione del destinatario non rientri nelle consegne della stessa prova, i candidati possono<br />
generalmente supporre un “virtuale” destinatario medio-colto, non completamente al corrente della<br />
problematica chiamata in causa, un destinatario dunque che occorre prima informare e poi semmai<br />
comunicargli, attraverso un commento, il punto di vista sostenuto.<br />
Ne consegue la necessità di una scrittura completa nelle informazioni, e razionale nelle<br />
argomentazioni.<br />
d) Collocazione<br />
La circostanza della prova scolastica può farci presupporre con una certa esattezza la collocazione<br />
dell‟articolo, cioè la sua posizione all‟interno di una possibile testata giornalistica, posizione che<br />
come è risaputo, ha delle conseguenze sul contenuto e sulle caratteristiche dell‟articolo.<br />
Gli argomenti di carattere sociale e/o culturale o scientifici previsti dall‟esame di stato, nonché le<br />
particolari finalità valutative della prova (conoscenze, competenze, capacità) possono infatti farci<br />
individuare una posizione che oscilla tra l‟editoriale (articolo di apertura di un giornale, con<br />
funzione di riflessione su un argomento di particolare rilievo nell‟attualità), l‟articolo di commento,<br />
l‟articolo di terza pagina (è la pagina culturale e letteraria), in ogni caso posizioni riservate a eventi<br />
di larga incidenza storica e contemporanea.<br />
Poiché l‟argomento può non essere collegato direttamente e immediatamente con l‟attualità, e<br />
poiché la trattazione in forma di articolo giornalistico si giustifica solo sulla base di una sua<br />
“attualità”, è necessario trovare in tali casi un riferimento (immaginario o abbastanza realistico) a<br />
circostanze vicine nel tempo (una ricorrenza, una scoperta, una mostra, un congresso e simili) che<br />
rendano verosimile la trattazione giornalistica di quell‟argomento per rivolgersi a un pubblico di<br />
lettori contemporanei.<br />
Scopo dell’articolo e differenze col saggio breve<br />
Come tutti ben sappiamo gli articoli giornalistici hanno lo scopo di informare, per raggiungere tale<br />
obiettivo devono necessariamente contenere informazioni e argomentazioni.<br />
27
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Ciò lo distingue dal saggio breve:<br />
Nel saggio breve le informazioni sono date nella stretta misura utile a condurre<br />
l‟argomentazione.<br />
Nell‟articolo, invece, le informazioni hanno un valore in quanto tali, e perciò devono essere<br />
date in misura più completa e in forma meno parziale.<br />
Nel saggio breve la dimostrazione delle tesi deve essere condotta in maniera evidente e<br />
stringente.<br />
Nell‟articolo, invece, non è strettamente necessario esporre con evidenza una tesi e condurre<br />
una rigorosa argomentazione logica a favore. Chi scrive, infatti, si può solo limitare a<br />
esporre il proprio orientamento, o può portare addirittura il discorso su strade diverse dalla<br />
dimostrazione di una personale tesi, quali per esempio un commento sulla portata e<br />
sull‟incidenza di un certo fenomeno o evento, una registrazione di opinioni altrui o delle<br />
opinioni prevalenti, una apertura alle possibili alternative interpretative, o ancora una<br />
apertura alle possibili soluzioni di una problematica.<br />
Come si collocano in un articolo le informazioni, le tesi e la opinioni<br />
Nell‟articolo di giornale è necessario separare sempre con sufficiente nettezza le informazioni dalle<br />
eventuali argomentazioni a favore di una o più tesi. Questo perché lo scopo dell‟articolo è quello di<br />
informare, e perciò è bene che la parte informativa assuma una propria rilevanza, sia per qualità,<br />
obiettività e per completezza, e non tenda ad essere limitata ad accenni funzionali alle successive<br />
argomentazioni. La parte informativa in un articolo deve essere, dunque, la più importante.<br />
Essa può assumere di volta in volta, e secondo gli argomenti, un andamento:<br />
Narrativo (cronaca degli eventi relativi all‟argomento) e in tal caso può essere ordinatamente<br />
svolta secondo una successione cronologica o causa-effettuale di sequenze.<br />
Analitico- descrittivo (ragguaglio sui particolari di circostanze, soggetti od oggetti relativi<br />
all‟argomento: è il caso, per esempio di un testo letterario).<br />
Espositivo (esposizione di nozioni e concetti obiettivi relativi all‟argomento in causa: è il<br />
caso, per esempio del ragguaglio sulle teorie politiche che caratterizzano una determinata<br />
circostanza storica).<br />
Specie se la parte informativa assume un andamento cronachistico, è utile riferirsi, in particolare<br />
nelle informazioni di apertura dell‟articolo, alle oramai celebre regola delle cinque “W” in voga nel<br />
giornalismo anglosassone secondo la quale un buon articolo deve rispondere alle seguenti cinque<br />
domande:<br />
WHO? = Chi? (di ci si parla?)<br />
WHERE? = Dove? (dove è avvenuto il fatto?)<br />
WHEN? = Quando? (in quale tempo è avvenuto il fatto?)<br />
WHAT? = Che cosa? (di quale evento si parla?)<br />
WHY? = Perché? (quali sono le cause e gli scopi dell‟evento?)<br />
La presentazione nella parte iniziale dell‟articolo di informazioni precise e complete permette di<br />
catturare l‟attenzione del lettore e di fargli cogliere gli elementi di maggiore rilievo.<br />
Nella parte informativa il linguaggio deve essere semplice, chiaro, conciso, incisivo, facilmente<br />
comprensibile e contenere:<br />
a) Ove possibile, frasi nominali (per es. “evasione-beffa dal centro accoglienza”; “A centinaia<br />
di metri di profondità frammenti dell‟Antartide tropicale”).<br />
b) Uso della paratassi, cioè frasi brevi, lineari, prive di subordinate, che utilizzano<br />
preferibilmente il modo indicativo (“poche ore prima della manifestazione contro il crimine<br />
e i clandestini, la beffa: ieri notte quattro persone sono scappate dal Centro di espulsione di<br />
via Corelli, alla periferia di Milano”).<br />
c) Uso di termini concreti e comprensibili a un largo pubblico e spiegazione di eventuali<br />
termini stranieri o di difficile comprensione.<br />
28
II ERICA / IGEA - Schema per il ripasso delle diverse tipologie di scrittura<br />
Per quanto riguarda la parte argomentativa, valgono tutte le indicazioni date per il saggio breve<br />
comprese quelle relative alla coesione e all‟uso dei connettivi, tenendo presente però che<br />
nell‟articolo è necessario essere incisivi ed essenziali, quindi le argomentazioni o i commenti<br />
devono essere più brevi di quelle presenti nel saggio. Dove possibile è opportuno anche inserire<br />
domande o esclamazioni, perché aiutano a mantenere viva l‟attenzione del lettore e a coinvolgerlo<br />
emotivamente. Per rafforzare la presentazione di un concetto, in alcuni casi, si può usare la tecnica<br />
della ripetizione.<br />
Il titolo<br />
Il titolo di un articolo è molto importante perché ha la funzione sia di attirare l‟attenzione dei lettori,<br />
sia di dare loro una chiave di lettura dell‟articolo stesso. Al titolo potrebbe rivelarsi opportuno<br />
aggiungere un sottotitolo, contenente ulteriori informazioni riguardanti l‟argomento trattato, o un<br />
sommario, contenente una sintesi del contenuto fondamentale dell‟articolo. Eventualmente è<br />
possibile aggiungere anche un occhiello, cioè una breve informazione su un concetto chiave<br />
dell‟articolo. L‟occhiello va posizionato sopra il titolo.<br />
Nell‟articolo relativo alla prova d‟esame è opportuno escludere il catenaccio, cioè l‟ulteriore<br />
informazione posizionata dopo il sottotitolo. Esempio:<br />
Un corteo pacifico, con slogan pieni di rabbia<br />
“Spazziamo via i clandestini”<br />
Centomila i partecipanti secondo gli organizzatori, trentamila per la polizia<br />
Il titolo e il sottotitolo riportati richiamano l‟attenzione sul dibattuto problema del soggiorno in<br />
Italia degli immigrati extracomunitari e orientano già il lettore verso un punto di vista che non è<br />
soltanto quello della pura informazione.<br />
Struttura dell’articolo<br />
La struttura base di un articolo può essere così riassunta:<br />
a) Introduzione<br />
Contenente l‟attacco, detto comunemente lead (in inglese = guida), che ha la funzione di apertura e<br />
mira a catturare l‟attenzione del lettore.<br />
Nell‟attacco, di lunghezza variabile, è già contenuta in sintesi tutta la notizia. L‟esposizione nel lead<br />
è molto rapida e sintetica.<br />
b) Parte centrale (suddivisa in due momenti):<br />
1°) Contenente la presentazione della notizia, che viene completata con tutte le informazioni<br />
necessarie, che si ricavano dalla regola delle cinque W. Il linguaggio usato deve essere agile,<br />
preciso e accattivante, per riuscire così a catturare l‟attenzione del lettore.<br />
2°) Contenente il blocco, cioè la parte dove la notizia viene commentata, vengono esposte le<br />
eventuali tesi e argomentazioni, vengono riportati, eventualmente anche, pareri di esperi. Il<br />
linguaggio usato deve essere chiaro, e soprattutto convincente.<br />
c) Conclusione<br />
Contenente una breve chiusa cioè una considerazione che concluda l‟argomento.<br />
Il linguaggio usato deve essere essenziale e asciutto perché contiene il succo del discorso.<br />
29