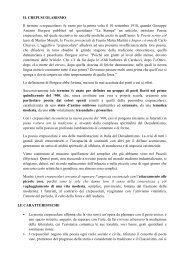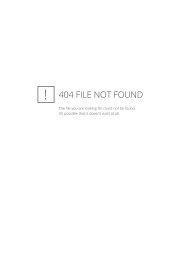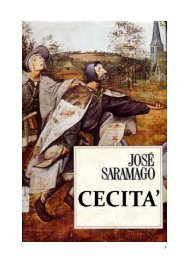Esclusione, diversità ed estraneità nella concezione della vita di ...
Esclusione, diversità ed estraneità nella concezione della vita di ...
Esclusione, diversità ed estraneità nella concezione della vita di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ARGOMENTO: <strong>Esclusione</strong>, <strong><strong>di</strong>versità</strong> <strong>ed</strong> <strong>estraneità</strong> <strong>nella</strong> <strong>concezione</strong> <strong>della</strong> <strong>vita</strong> <strong>di</strong> Pirandello<br />
DOCUMENTI<br />
Il fischio <strong>di</strong> quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria <strong>di</strong> tutte quelle sue orribili<br />
angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo<br />
che gli si spalancava enorme tutt’intorno. S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava<br />
addosso, <strong>ed</strong> era corso col pensiero <strong>di</strong>etro a quel treno che s’allontanava <strong>nella</strong> notte. C’era, ah! c’era, fuori <strong>di</strong><br />
quella casa orrenda, fuori <strong>di</strong> tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno<br />
s’avviava... Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui egli da giovine era stato e che ancora,<br />
certo, in quella notte sfavillavano <strong>di</strong> luci sulla terra. Sì, sapeva la <strong>vita</strong> che vi si viveva! La <strong>vita</strong> che un tempo<br />
vi aveva vissuto anche lui!. E seguitava, quella <strong>vita</strong>; aveva sempre seguitato, mentr’egli qua, come una bestia<br />
bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento<br />
<strong>della</strong> sua casa, nell’arida, ispida angustia <strong>della</strong> sua computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava, come per<br />
travaso violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un<br />
brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l’immaginazione d’improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva<br />
seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari... Questo stesso brivido, questo stesso palpito<br />
del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa <strong>vita</strong> “impossibile”, tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su<br />
tutta la terra, che vivevano <strong>di</strong>versamente.<br />
L. Pirandello, Il treno ha fischiato, in Novelle per un anno<br />
Non mi sono piú guardato in uno specchio, e non mi passa neppure per ll capo <strong>di</strong> voler sapere che cosa sia<br />
avvenuto <strong>della</strong> mia faccia e <strong>di</strong> tutto il mio aspetto. Quello che avevo per gli altri dovette apparir molto<br />
mutato e in un modo assai buffo, a giu<strong>di</strong>care dalla maraviglia e dalle risate con cui fui accolto. Eppure mi<br />
vollero tutti chiamare ancora Moscarda, benché il <strong>di</strong>re Moscarda avesse ormai certo per ciascuno un<br />
significato cosí <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> prima, che avrebbero potuto risparmiare a quel povero svanito là,<br />
barbuto e sorridente, con gli zoccoli e il camiciotto turchino, la pena d’obbligarlo a voltarsi ancora a quel<br />
nome, come se realmente gli appartenesse. Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome <strong>di</strong> jeri; del nome<br />
d’oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori <strong>di</strong> noi; e senza<br />
nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non <strong>di</strong>stinta e non definita; ebbene, questo che<br />
portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte <strong>di</strong> quella immagine con cui gli<br />
apparvi, e la lasci in pace non ne parli piú. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai<br />
morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La <strong>vita</strong> non conclude. E non sa <strong>di</strong> nomi, la <strong>vita</strong>.<br />
Quest’albero, respiro trèmulo <strong>di</strong> foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il<br />
libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. L’ospizio sorge in campagna, in un luogo<br />
amenissimo. Io esco ogni mattina, all’alba, perché ora voglio serbare lo spirito cosí, fresco d’alba, con tutte<br />
le cose come appena si scoprono che sanno ancora del crudo <strong>della</strong> notte, prima che il sole ne secchi il respiro<br />
umido e le abbagli. Quelle nubi d’acqua là pese plumbee ammassate sui monti livi<strong>di</strong>, che fanno parere piú<br />
larga e chiara <strong>nella</strong> grana d’ombra ancora notturna, quella verde piaga <strong>di</strong> cielo. E qua questi fili d’erba, teneri<br />
d’acqua anch’essi, freschezza viva delle prode. E quell’asinello rimasto al sereno tutta la notte, che ora<br />
guarda con occhi appannati e sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino e a mano a mano pare gli<br />
s’allontani cominciando, ma senza stupore a schiarirglisi attorno, con la luce che <strong>di</strong>laga appena sulle<br />
campagne deserte e attonite. E queste carraie qua, tra siepi nere e muricce screpolate, che su lo strazio dei<br />
loro solchi ancora stanno e non vanno. E l’aria è nuova. E tutto, attimo per attimo, è com’è, che savviva per<br />
apparire. Volto subito gli occhi per non v<strong>ed</strong>ere piú nulla fermarsi <strong>nella</strong> sua apparenza e morire. Cosí soltanto<br />
io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Imp<strong>ed</strong>ire che il pensiero sí metta in me <strong>di</strong> nuovo a<br />
lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. La città è lontana. Me ne giunge, a volte, <strong>nella</strong><br />
calma del vespro, il suono delle campane. Ma ora quelle campane le odo non piú dentro <strong>di</strong> me, ma fuori, per<br />
sé sonare, che forse ne fremono <strong>di</strong> gioja <strong>nella</strong> loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno <strong>di</strong> sole caldo<br />
tra lo stridío delle ron<strong>di</strong>ni o nel vento nuvoloso, pesanti e cosí alte sui campanili aerei. Pensa alla morte, a<br />
pregare. C’è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l’ho piú questo<br />
bisogno, perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricor<strong>di</strong>: vivo e intero, non piú in me, ma in<br />
ogni cosa fuori.<br />
L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila
Marta Ajala avrebbe occupato il posto <strong>di</strong> maestra supplente nelle prime classi preparatorie del Collegio, solo<br />
perché "protetta" del deputato Alvignani.<br />
E vi fu, nei primi giorni, una processione <strong>di</strong> padri <strong>di</strong> famiglia al Collegio: volevano parlare col Direttore. Ah,<br />
era uno scandalo! Le loro ragazze si sarebbero rifiutate d’andare a scuola. E nessun padre, in coscienza,<br />
avrebbe saputo costringerle. Bisognava trovare, a ogni costo e subito, un rim<strong>ed</strong>io.<br />
Il vecchio Direttore rimandava i padri <strong>di</strong> famiglia all’Ispettore scolastico, dopo aver <strong>di</strong>feso la futura<br />
supplente con la prova degli ottimi esami. Se qualche altra avesse fatto meglio, sarebbe stata presa a supplire<br />
in quella classe aggiunta. Nessuna ingiustizia, nessuna particolarità...<br />
- Ma sì!<br />
Il cavalier Clau<strong>di</strong>o Torchiara, ispettore scolastico, era del paese e amico intimo <strong>di</strong> Gregorio Alvignani. A lui<br />
i reclami si ritorcevano sotto altra forma e sotto altro aspetto. Voleva l’Alvignani rendersi impopolare con<br />
quella protezione scandalosa?<br />
E invano il Torchiara s’affannava a protestare che l’Alvignani non c’entrava né punto né poco, che quella<br />
<strong>della</strong> maestra Ajala non era nomina governativa. Eh via, adesso! Che sostenesse ciò il Direttore del Collegio,<br />
TRANSEAT!, ma lui, il Torchiara, ch’era del paese; eh via! Bisognava aver perduto la memoria degli<br />
scandali più recenti...<br />
Era venuta dunque così dall’aria quella nomina dell’Ajala? E in coscienza se il Torchiara avesse avuto una<br />
figliuola, sarebbe stato contento <strong>di</strong> mandarla a scuola da una donna che aveva fatto parlare così male <strong>di</strong> sé?<br />
Che fior <strong>di</strong> maestra per le ragazze!<br />
Se a Marta, ogni dì più oppressa dalla crescente miseria, mentre furtivamente, non compresa dai suoi, chiusa<br />
<strong>nella</strong> sua cameretta, si preparava a quegli esami, si fosse per un momentino affacciato il pensiero che avrebbe<br />
incontrato, sott’altro aspetto, quasi la stessa vigliacca e oltraggiosa rivolta popolare; forse le sarebbe a un<br />
tratto caduto l’animo. Ma spronavano allora la sua baldanza giovanile da un canto troppa ansia <strong>di</strong> risorgere,<br />
dall’altro la miseria in cui senza riparo ella e la sua famiglia precipitavano e la coscienza del proprio valore e<br />
la santità del suo sacrifizio per la madre e la sorella. Pensava allora soltanto a vincere la prova; sarebbe poi<br />
riuscita nel suo intento, avvalendosi <strong>della</strong> prova superata.<br />
Ora, ora intendeva lo stupore doloroso <strong>della</strong> madre e <strong>della</strong> sorella all’annunzio <strong>della</strong> sua animosa<br />
determinazione. E ancora non le era arrivata agli orecchi la calunnia <strong>di</strong> cui la gente onesta si armava per<br />
osteggiarla, per ricacciarla bene addentro nel fango da cui smaniava d’uscire!<br />
L. Pirandello, L’esclusa<br />
Per<strong>di</strong>o, l’impudenza <strong>di</strong> presentarsi qua, a me, ora col suo ganzo accanto... - E avevano l’aria <strong>di</strong> prestarsi per<br />
compassione, per non fare infuriare un poverino già fuori del mondo, fuori del tempo, fuori <strong>della</strong> <strong>vita</strong>! - Eh,<br />
altrimenti quello là, ma figuratevi se l’avrebbe subita una simile sopraffazione! - Loro sì, tutti i giorni, ogni<br />
momento, pretendono che gli altri siano come li vogliono loro; ma non è mica una sopraffazione, questa! -<br />
Che! Che! - E’ il loro modo <strong>di</strong> pensare, il loro modo <strong>di</strong> v<strong>ed</strong>ere, <strong>di</strong> sentire: ciascuno ha il suo! Avete anche voi<br />
il vostro, eh? Certo! Ma che può essere il vostro? Quello <strong>della</strong> mandra! Misero, labile, incerto...E quelli ne<br />
approfittano, vi fanno subire e accettare il loro, per modo che voi sentiate e v<strong>ed</strong>iate come loro! O almeno, si<br />
illudono! Perché poi, che riescono a imporre? Parole! parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. Eh,<br />
ma si formano pure così le così dette opinioni correnti! E guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una <strong>di</strong><br />
queste parole che tutti ripetono! Per esempio: “pazzo!” - Per esempio, che so? - “imbecille” - Ma <strong>di</strong>te un po’,<br />
si può star quieti a pensare che c’è uno che si affanna a persuadere agli altri che voi siete come vi v<strong>ed</strong>e lui, a<br />
fissarvi <strong>nella</strong> stima degli altri secondo il giu<strong>di</strong>zio che ha fatto <strong>di</strong> voi? - “Pazzo” “pazzo”! - Non <strong>di</strong>co ora che<br />
lo faccio per ischerzo! Prima, prima che battessi la testa cadendo da cavallo...<br />
L. Pirandello, Enrico IV, atto II<br />
Ahimè, che io, condannato ine<strong>vita</strong>bilmente a mentire dalla mia con<strong>di</strong>zione, non avrei potuto avere mai più un<br />
amico, un vero amico. E dunque, né casa, né amici... Amicizia vuol <strong>di</strong>re confidenza; e come avrei potuto io<br />
confidare a qualcuno il segreto <strong>di</strong> quella mia <strong>vita</strong> senza nome e senza passato, sorta come un fungo dal<br />
suici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Mattia Pascal? Io potevo aver solamente relazioni superficiali, permettermi solo co’ miei simili un<br />
breve scambio <strong>di</strong> parole aliene.<br />
Ebbene, erano gl’inconvenienti <strong>della</strong> mia fortuna. Pazienza! Mi sarei scoraggiato per questo?<br />
“Vivrò con me e <strong>di</strong> me, come ho vissuto finora!”<br />
Sì; ma ecco: per <strong>di</strong>r la verità, temevo che <strong>della</strong> mia compagnia non mi sarei tenuto né contento né pago. E<br />
poi, toccandomi la faccia e scoprendomela sbarbata, passandomi una mano su quei capelli lunghi o
assettandomi gli occhiali sul naso, provavo una strana impressione: mi pareva quasi <strong>di</strong> non esser più io, <strong>di</strong><br />
non toccare me stesso.<br />
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal<br />
Una volta tanto l’uomo sano, grosso — granitico, <strong>di</strong>rebbe Flaubert — vuol porsi <strong>nella</strong> con<strong>di</strong>zione del<br />
tribolato. Una finzione, un istrionesco gioco <strong>di</strong> contrari. Prende una sorta <strong>di</strong> vaccinazione, si immunizza una<br />
febbre leggera transitoria piacevole. E la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> aver pensato. Il popolo non conosce poeti, ma<br />
filosofi. Della poesia, anche <strong>di</strong> quella che egli stesso è capace <strong>di</strong> esprimere, non ha nozione nè rispetto. Così,<br />
basta una formula come “essere è apparire” o “conflitto tra la Vita e la Forma” a fare la popolarità <strong>di</strong> un<br />
autore. Per gente più raffinata basta un solo “ismo”. Gli “ismi” hanno tanto intorbidato le acque, alimentato<br />
tanta <strong>di</strong>ffidenza, rovinato tanta brava gente: e oggi, al posto <strong>di</strong> nitide e spaziate costruzioni, abbiamo sotto gli<br />
occhi un paesaggio <strong>di</strong> arren<strong>di</strong> alveari. Il pirandellismo, dunque. Un mondo <strong>di</strong> poesia viene consunto e<br />
calcinato fino al punto da estrarne delle filosofiche ceneri. A queste ceneri il vasto pubblico applaude; e il<br />
critico si volta dall’altra parte. Così incenerito, Pirandello <strong>di</strong>venta “l’uomo del popolo”, come <strong>di</strong>ce Ford; lo<br />
scrittore per un pubblico grosso — e, come Manfr<strong>ed</strong>i, viene a lume spento inumato <strong>di</strong> fuor dal regno <strong>della</strong><br />
critica crociana.<br />
Leonardo Sciascia, Pirandello e il pirandellismo, Palermo, 1953<br />
La storia <strong>di</strong> quest’uomo <strong>di</strong> Pirandello, dai cento nomi, dalle cento facce, dai cento comportamenti spesso<br />
sconcertanti, dai cento tic ma dall’unica pena <strong>di</strong> vivere, è raccontata in duecentocinquanta mo<strong>di</strong>, tutti<br />
riconducibili all’angoscia <strong>di</strong> chi acquista coscienza <strong>di</strong> sé, si v<strong>ed</strong>e doppiato, frastornato, ingannato, solo,<br />
sconfitto, deluso, con il cartellino <strong>di</strong> “ricercato” che la società ha attaccato sotto la sua immagine, e perciò<br />
braccato e messo al muro, mentre gli altri mangiano, bevono, dormono, piangono, ridono, fanno l’amore,<br />
defecano, allevano i figli, lavorano e muoiono, passandogli accanto insensibili e senza v<strong>ed</strong>ere la sua<br />
sofferenza <strong>di</strong> fondo, ciechi e sor<strong>di</strong> alla trag<strong>ed</strong>ia <strong>di</strong> quel personaggio soprafatto dalle incr<strong>ed</strong>ibili ipocrisie e<br />
ingiustizie sociali.<br />
Enzo Lauretta, Luigi Pirandello, storia <strong>di</strong> un personaggio ‘‘fuori <strong>di</strong> chiave’’, Milano, 1980<br />
Certamente i drammi del Pirandello appaiono a volte appesantiti da lunghi e sottili ragionamenti, paradossali<br />
e apparentemente assur<strong>di</strong>, ma <strong>nella</strong> rappresentazione dell’ “incomunicabilità” che affligge l’uomo <strong>ed</strong> è la sua<br />
tragica con<strong>di</strong>zione esistenziale, appare evidente un profondo senso <strong>di</strong> “pietà” verso l’uomo, una pietà che si<br />
fa poesia. Le opere teatrali del Pirandello contengono molte pagine belle <strong>di</strong> sincero sentimento lirico, <strong>di</strong><br />
profonda umanità, <strong>di</strong> accorata tristezza e pietà per il destino e la fragilità dell’uomo; però presentano non<br />
pochi <strong>di</strong>fetti, come l’umorismo spietato e <strong>di</strong>struttore, l’eccessiva impostazione intellettualistica delle vicende,<br />
l’uniformità dei motivi e dei problemi trattati, lo squallore <strong>di</strong> intrecci contorti e stentati, il cerebralismo <strong>di</strong><br />
personaggi che non vivono le loro azioni, ma le analizzano con <strong>di</strong>alettica sottile, quasi sofistica, e tono<br />
pr<strong>ed</strong>icatorio. Tuttavia l’arte pirandelliana, malgrado i limiti, con il suo messaggio umano ha fatto sentire il<br />
suo influsso sui drammaturghi moderni, italiani, europei e americani.<br />
Luigi De Bellis, Storia delle letteratura italiana, Bologna, 1990