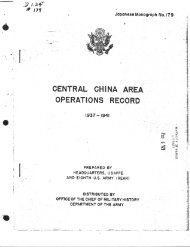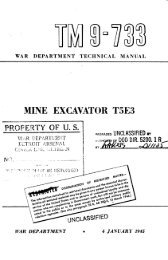Italian Bookshelf (download as PDF) - Ibiblio
Italian Bookshelf (download as PDF) - Ibiblio
Italian Bookshelf (download as PDF) - Ibiblio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
454 “<strong>Italian</strong> <strong>Bookshelf</strong>.” Annali d’italianistica 25 (2007)<br />
fitta selva di studi noti ai più esperti conoscitori di questa epoca, riuscendo a tracciare un<br />
percorso che offre spunti <strong>as</strong>sai interessanti; si tratta, infatti, della proposta di<br />
individuazione di una fonte letteraria, il poema Città di Vita di Matteo Palmieri, per il<br />
celebre affresco della Volta della Sistina, realizzato da Michelangelo all’inizio del<br />
Cinquecento su commissione del papa Giulio II.<br />
Il libro del giovane studioso argomenta in modo convincente e suggestivo la tesi<br />
secondo la quale il poema palmieriano, scritto tra il 1454 e il 1464, avrebbe ispirato<br />
alcune composizioni della volta della Sistina; attraverso una accurata esposizione della<br />
materia, Cumbo procede a illustrare la complessa rete di relazioni culturali che<br />
animavano la vita artistica di Firenze nell’ultimo quarto del XV secolo e a ripercorrere la<br />
fitta circolazione di correnti teologico-filosofiche pagane che trovavano un’insolita<br />
conciliazione con quelle cristiane, secondo un programma promosso da papa Giulio II.<br />
Alla metà del Quattrocento, infatti, erano diffusi e letti i De principiis di Origene, padre<br />
della Chiesa vissuto nel II secolo, nei quali era esposta la teoria dell’origine angelica<br />
delle anime umane cacciate dal Paradiso celeste per non aver saputo scegliere fra Dio e<br />
Satana. Attraverso una lettura attenta dell’intero poema palmieriano, diviso in cento canti<br />
e tre libri in terzine dantesche, lo studioso rintraccia nella tesi della natura angelica delle<br />
anime umane, esposta nei canti XXVI e XXVII del terzo libro del poema, la traduzione<br />
del sistema teologico origeniano, circolante negli ambienti umanistici più colti e<br />
certamente nota a Michelangelo, come nel saggio si dimostra.<br />
Ricostruendo il v<strong>as</strong>to affresco della cultura fiorentina, tra la fine del Quattrocento e<br />
le prime due decadi del secolo successivo, in cui gli echi della tradizione cl<strong>as</strong>sica<br />
nobilitavano, rendendoli più illustri, gli interessi e il gusto degli intellettuali più in vista e<br />
di una cerchia di artisti sempre più v<strong>as</strong>ta, tra cui il circolo neoplatonico di Marsilio Ficino<br />
e quello umanistico di Pico della Mirandola, Cumbo indica un itinerario di ricerca che,<br />
senza ignorare la lunga tradizione di studi letterari e artistici che l’hanno preceduto,<br />
perviene a risultati su cui occorrerà riflettere per il rigore scientifico dell’analisi e per la<br />
serietà della proposta interpretativa.<br />
Il poema palmieriano, composto in terzine sul modello dantesco, narra il viaggio di<br />
Matteo nei mondi ultraterreni sotto la guida della Sibilla Cumana; i canti decisivi,<br />
secondo lo studioso, per un confronto tra la fonte letteraria e quella iconografica, sono il<br />
XXVI e il XVII del Terzo libro, in cui la guida espone al pellegrino la teoria sull’origine<br />
angelica delle anime umane, da cui discenderebbero il loro libero arbitrio, la centralità<br />
della volontà e l’oscillazione che determina il loro percorso di vita. Il cammino di Matteo<br />
e della Sibilla è, infatti, <strong>as</strong>cendente o discendente come quello delle anime umane; gli<br />
uomini come gli angeli non sono buoni o cattivi per natura, ma per scelta. Come<br />
Lucifero, gli angeli che non parteggiarono né per Dio né per Satana degradarono alla<br />
condizione umana caratterizzata dal libero arbitrio. Fin qui la dottrina teologico-filosofica<br />
di Origene, ripresa alla metà del Quattrocento da Pico della Mirandola e dal circolo degli<br />
umanisti che favorivano una conciliazione tra le dottrine pagane e quelle cristiane. Come<br />
l’autore del saggio ricostruisce in b<strong>as</strong>e ad attente ricerche, il poema di Palmieri circolava<br />
negli ambienti colti fiorentini e romani ed è molto probabile che Michelangelo lo avesse<br />
letto e apprezzato. Alla luce di questa nuova e convincente lettura del poema palmieriano<br />
e delle puntuali osservazioni fatte su alcuni particolari della composizione del grande<br />
affresco della volta della Sistina, le conoscenze sulla civiltà di fine Quattrocento, sulla<br />
circolazione di correnti filosofiche alimentate dal platonismo ficiniano e da intermittenti<br />
risorgenze della cultura ermetica, risultano sempre meno oscure e più articolate.