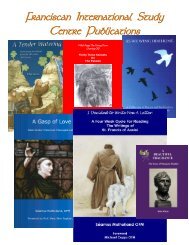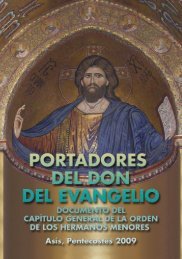Relazione di Fr. Cesare Vaiani - OFM
Relazione di Fr. Cesare Vaiani - OFM
Relazione di Fr. Cesare Vaiani - OFM
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BEATITUDINI E IDENTITÀ FRANCESCANA<br />
Intervento al Capitolo delle stuoie<br />
<strong>Fr</strong> <strong>Cesare</strong> <strong>Vaiani</strong> ofm<br />
Mi è stato chiesto <strong>di</strong> parlare <strong>di</strong> beatitu<strong>di</strong>ni e identità francescana. Mi pare giusto iniziare<br />
riascoltando quel testo evangelico che ben conosciamo, ma che oggi, qui, risuona nuovo per<br />
ciascuno <strong>di</strong> noi.<br />
1 Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi<br />
<strong>di</strong>scepoli. 2 Si mise a parlare e insegnava loro <strong>di</strong>cendo:<br />
3 "Beati i poveri in spirito, perché <strong>di</strong> essi è il regno dei cieli.<br />
4 Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.<br />
5 Beati i miti, perché avranno in ere<strong>di</strong>tà la terra.<br />
6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.<br />
7 Beati i misericor<strong>di</strong>osi, perché troveranno misericor<strong>di</strong>a.<br />
8 Beati i puri <strong>di</strong> cuore, perché vedranno Dio.<br />
9 Beati gli operatori <strong>di</strong> pace, perché saranno chiamati figli <strong>di</strong> Dio.<br />
10 Beati i perseguitati per la giustizia, perché <strong>di</strong> essi è il regno dei cieli.<br />
11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, <strong>di</strong>ranno ogni sorta <strong>di</strong><br />
male contro <strong>di</strong> voi per causa mia. 12 Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra<br />
ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima <strong>di</strong> voi.<br />
Questa parola è Vangelo. Accogliamola anzitutto così, come Vangelo, cioè buon annuncio, che ci<br />
parla <strong>di</strong> un dono, <strong>di</strong> qualcosa <strong>di</strong> buono che ci viene offerto, prima ancora <strong>di</strong> essere un invito a<br />
comportarci in un certo modo. Abbandoniamo, per un momento, la prospettiva un po’ moralistica<br />
con cui spesso ascoltiamo il Vangelo, come se fosse solo un manuale per comportarsi bene, e<br />
ritorniamo a quella essenziale prospettiva <strong>di</strong> dono, che lo rende propriamente evangelo, buon<br />
annunzio. E qual è il dono annunciato in queste parole? È l’offerta <strong>di</strong> una gioia (una beatitu<strong>di</strong>ne,<br />
appunto) che fiorisce misteriosamente anche là dove non ce lo aspetteremmo, <strong>di</strong> un bene nascosto<br />
nella povertà, nelle lacrime, nella persecuzione, negli atteggiamenti “perdenti” secondo la logica del<br />
mondo, come la mitezza o la misericor<strong>di</strong>a. Quel bene, quella gioia, è il segno del Regno <strong>di</strong> Dio,<br />
della sua presenza tra noi, della sua paterna signoria che è bene e gioia, che è beatitu<strong>di</strong>ne. In sintesi,<br />
è Dio presente tra noi, perché Dio è la beatitu<strong>di</strong>ne e il bene.<br />
Questo ha intuito <strong>Fr</strong>ancesco d’Assisi, così profondamente convinto che solo Dio è «il bene, il<br />
sommo bene, ogni bene, ed egli solo è buono» 1 , e che Egli è la sorgente <strong>di</strong> ogni bene e <strong>di</strong> ogni<br />
beatitu<strong>di</strong>ne. Il Vangelo intuito da <strong>Fr</strong>ancesco è davvero il Vangelo della beatitu<strong>di</strong>ne, perché egli, fin<br />
dall’incontro con i lebbrosi, ha scoperto che quella beatitu<strong>di</strong>ne e quel bene, che ha in Dio la sua<br />
sorgente, è accessibile ai misericor<strong>di</strong>osi, ai poveri, ai miti, agli ultimi.<br />
Come avete intuito da questo inizio, vorrei rileggere le beatitu<strong>di</strong>ni con gli occhi e il cuore <strong>di</strong><br />
<strong>Fr</strong>ancesco, percorrendo i suoi Scritti; in un secondo momento cercherò <strong>di</strong> sviluppare cosa esse<br />
suggeriscono a noi francescani oggi.<br />
A – Per capire come <strong>Fr</strong>ancesco ha accolto le beatitu<strong>di</strong>ni, propongo <strong>di</strong> rileggere alcuni suoi testi.<br />
Per almeno tre delle beatitu<strong>di</strong>ni evangeliche (poveri, puri <strong>di</strong> cuore, pacifici) abbiamo degli espliciti<br />
commenti <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco, nelle sue Ammonizioni. Per altre parole chiave del nostro testo, come<br />
misericor<strong>di</strong>a, giustizia, mitezza, persecuzione, ricompensa cercheremo in altri scritti <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco. E<br />
concluderemo chiedendoci cosa vuol <strong>di</strong>re beatitu<strong>di</strong>ne per lui. Ognuno dei testi <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco che<br />
leggerò meriterebbe una me<strong>di</strong>tazione ben più ampia <strong>di</strong> quella che propongo: ne sono ben<br />
consapevole. Io coglierò solo qualche aspetto, come delle illuminazioni per il nostro cammino.<br />
1 Am 7,4: FF 156; 8,3: FF 157; LodAl 3: FF 161; Pater 2: FF 267; Lora 11: FF 265; Rnb 17,18: FF 49; 23,9: FF 70.<br />
1
Cominciamo dalla prima beatitu<strong>di</strong>ne nella serie evangelica, che è quella dei poveri <strong>di</strong> spirito.<br />
<strong>Fr</strong>ancesco la commenta esplicitamente nell’Ammonizione 14.<br />
Beati i poveri in spirito, perché <strong>di</strong> essi è il regno dei cieli (Mt 5, 3).<br />
Ci sono molti che, applicandosi insistentemente a preghiere e occupazioni, fanno molte<br />
astinenze e mortificazioni corporali, ma per una sola parola che sembri ingiuria verso la loro<br />
persona, o per qualche cosa che venga loro tolta, scandalizzati, subito si irritano. Questi non<br />
sono poveri in spirito, poiché chi è veramente povero in spirito o<strong>di</strong>a se stesso e ama quelli che<br />
lo percuotono sulla guancia (cfr. Lc 14, 26; Mt 5, 39).<br />
In questo testo <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco, che certamente era un esperto <strong>di</strong> povertà, per spiegare chi è povero non<br />
si ricorre a esempi <strong>di</strong> uomini che cercano una povertà materiale, anzi vengono scartati tali poveri,<br />
che sono quelli «che, applicandosi insistentemente a preghiere e occupazioni, fanno molte astinenze e<br />
mortificazioni corporali». Trovo molto interessante che, per fare un esempio <strong>di</strong> povertà, <strong>Fr</strong>ancesco<br />
ricorra a situazioni <strong>di</strong> relazione fraterna: una cattiva parola detta a un fratello, o il sottrarti<br />
materialmente qualcosa che tu pensi essere tuo (a me vengono in mente confratelli molto “spirituali” ai<br />
quali togli l’immaginetta preferita!). In questi due casi, che sono casi <strong>di</strong> relazione fraterna, si vede se<br />
uno è povero. Qui una parola chiave è perturbantur (trad. si irritano), che in<strong>di</strong>ca la reazione <strong>di</strong> chi<br />
non è povero in spirito: l’ira e il turbamento sono i segnali <strong>di</strong> uno spirito <strong>di</strong> appropriazione che è<br />
l’esatto contrario della povertà. E l’ira e il turbamento sono elementi della relazione con gli altri.<br />
Insomma, la povertà è relazionale, cioè si gioca nelle relazioni con gli altri. E quando ci arrabbiamo<br />
col prossimo, si manifesta il fatto che non siamo poveri. Forse <strong>Fr</strong>ancesco parla così perché ha<br />
vissuto questi problemi: anche lui è stato tentato <strong>di</strong> rispondere male o <strong>di</strong> a<strong>di</strong>rarsi col fratello, e<br />
talvolta forse lo ha fatto. Dalla sua esperienza nasce questa maniera piuttosto anticonformista <strong>di</strong><br />
parlare <strong>di</strong> povertà, che ha molte ricadute anche per noi, che probabilmente non siamo poveri<br />
materialmente, ma che siamo comunque chiamati a una “povertà relazionale” con i fratelli. Certo,<br />
questa riflessione non deve servire da alibi per impe<strong>di</strong>rci <strong>di</strong> cercare anche una maggiore povertà<br />
materiale, però certamente in<strong>di</strong>ca nella relazione con gli altri il cuore del <strong>di</strong>scorso della povertà.<br />
Le due Ammonizioni che seguono imme<strong>di</strong>atamente la 14 sono ugualmente il commento <strong>di</strong> altre due<br />
beatitu<strong>di</strong>ni. Così, l’Ammonizione 15 è de<strong>di</strong>cata agli operatori <strong>di</strong> pace.<br />
Beati i pacifici, poiché saranno chiamati figli <strong>di</strong> Dio (Mt 5, 9). Sono veri pacifici coloro che in<br />
tutte le cose che sopportano in questo mondo, per l'amore del Signore nostro Gesù Cristo,<br />
conservano la pace nell'anima e nel corpo.<br />
In questa Ammonizione troviamo un tratto caratteristico <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco, che accosta la parola pace a<br />
sopportare o sostenere. Lo fa anche nella famosa strofa del Cantico sul perdono, in cui loda Dio per<br />
coloro che<br />
sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli ke’l sosterrano in pace, ka da te, Altissimo,<br />
sirano incoronati 2 .<br />
Troviamo l’idea del «sostenere in pace», come pure nell’esortazione Au<strong>di</strong>te poverelle, dove<br />
ugualmente le sorelle malate sono invitate a «sostenere in pace» la loro infermità. Questo<br />
collegamento tra pace e sopportare è interessante, perchè va contro le nostre idee comuni sulla<br />
pace. Noi <strong>di</strong> solito pensiamo che stiamo in pace quando non c’è niente da sopportare, e meno che<br />
mai infermità o tribolazione. <strong>Fr</strong>ancesco invece non la pensa così, e insiste nel <strong>di</strong>re che la pace<br />
fiorisce proprio nelle <strong>di</strong>fficoltà. Anche in questo caso possiamo chiederci quanto entri il vissuto<br />
personale <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco, che quando scriveva il Cantico sapeva bene cosa vuol <strong>di</strong>re «infirmitate e<br />
2 Cant 24-26.<br />
2
tribulazione». Possiamo dunque pensare che, secondo <strong>Fr</strong>ancesco, i pacifici della beatitu<strong>di</strong>ne non<br />
sono gente beata perchè non ha problemi, ma persone che riescono a godere <strong>di</strong> una misteriosa pace<br />
che nasce nelle <strong>di</strong>fficoltà.<br />
La terza Ammonizione <strong>di</strong> questa piccola serie è de<strong>di</strong>cata ai puri <strong>di</strong> cuore.<br />
Beati i puri <strong>di</strong> cuore, poiché essi vedranno Dio (Mt 5, 8). Veramente puri <strong>di</strong> cuore sono coloro<br />
che <strong>di</strong>sprezzano le cose terrene e cercano le cose celesti, e non cessano mai <strong>di</strong> adorare e vedere<br />
sempre il Signore Dio, vivo e vero, con cuore e animo puro.<br />
La purezza <strong>di</strong> cuore <strong>di</strong> cui parla <strong>Fr</strong>ancesco è, qui come altrove nei suoi scritti, qualcosa che ha a che<br />
fare con l’attenzione interiore che si rivolge a Dio. Nella Regola non bollata egli ci mette in guar<strong>di</strong>a<br />
dal «<strong>di</strong>stogliere la nostra mente e il cuore dal Signore» e prosegue esortando i frati perché<br />
allontanato ogni impe<strong>di</strong>mento e messa da parte ogni preoccupazione e ogni affanno, in<br />
qualunque modo meglio possono, si impegnino a servire, amare, adorare e onorare il<br />
Signore Id<strong>di</strong>o, con cuore mondo e con mente pura, ciò che egli stesso domanda sopra tutte le<br />
cose 3 .<br />
Per noi è un invito a ri-centrare la nostra vita, che spesso si <strong>di</strong>sperde in mille cose e in mille<br />
<strong>di</strong>rezioni. Come riuscire a vivere una vita davvero orientata verso il Signore, figli come siamo del<br />
nostro tempo, in cui siamo perennemente “connessi”, raggiunti in tempo reale da mille<br />
comunicazioni, e quin<strong>di</strong> attenti (o <strong>di</strong>stratti?) in mille <strong>di</strong>rezioni? La purezza del cuore <strong>di</strong> cui parla<br />
<strong>Fr</strong>ancesco è quella che permette <strong>di</strong> vivere tra Facebook e Twitter, tra sms e e-mail, col cuore e la<br />
mente orientati al Signore. È una bella sfida!<br />
Un’altra beatitu<strong>di</strong>ne è citata letteralmente da <strong>Fr</strong>ancesco per ben due volte nei suoi scritti, ed è quella<br />
che conclude la serie evangelica e riguarda i perseguitati: «Beati i perseguitati per la giustizia,<br />
perché <strong>di</strong> essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,<br />
<strong>di</strong>ranno ogni sorta <strong>di</strong> male contro <strong>di</strong> voi per causa mia».<br />
Queste parole del Vangelo ricorrono in due testi importanti per <strong>Fr</strong>ancesco. Anzitutto nel capitolo 10<br />
della Regola, dove dopo l’esortazione ad «avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione»,<br />
<strong>Fr</strong>ancesco ne declina gli effetti che si manifestano verso Dio, verso noi stessi e verso gli altri.<br />
Verso Dio, esorta a «pregarlo sempre con cuore puro»; verso noi stessi e verso le nostre fragilità, invita<br />
ad «avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nella infermità»; e verso il prossimo punta a quel<br />
culmine che è l’amore del nemico, citando proprio la beatitu<strong>di</strong>ne dei perseguitati, invitandoci a<br />
amare quelli che ci perseguitano e ci riprendono e ci accusano, poiché <strong>di</strong>ce il Signore: ‘Amate i<br />
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano (Mt 5, 44); beati quelli<br />
che soffrono persecuzione a causa della giustizia, poiché <strong>di</strong> essi è il regno dei cieli (Mt 5, 10).<br />
E chi persevererà sino alla fine, questi sarà salvo’ (Mt 10, 22) 4 .<br />
L’altro testo in cui <strong>Fr</strong>ancesco cita la beatitu<strong>di</strong>ne dei perseguitati è ugualmente importante: si tratta<br />
del cap. 16 della Regola non bollata, de<strong>di</strong>cato a coloro che vanno tra i saraceni e gli altri infedeli,<br />
dove descrive i due mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> comportarsi spiritualmente nei paesi non cristiani, con la testimonianza<br />
silenziosa e con l’annuncio esplicito; e poiché è ben consapevole che l’invito manifesto alla<br />
conversione, nei paesi musulmani, poteva portare alla morte (come accade ancor oggi), continua<br />
con una esortazione al martirio che è un collage <strong>di</strong> citazioni evangeliche riferite alla testimonianza<br />
3 Rnb 23,25-26.<br />
4 Rb 10, 8 -12.<br />
3
che giunge fino all’effusione del sangue. Qui, tra i testi citati, spicca la beatitu<strong>di</strong>ne dei perseguitati,<br />
che ben si inserisce in questo contesto <strong>di</strong> parole “dure” del Vangelo.<br />
E tutti i frati, dovunque sono, si ricor<strong>di</strong>no che hanno donato se stessi e hanno abbandonato i<br />
loro corpi al Signore nostro Gesù Cristo. E per il suo amore devono esporsi ai nemici sia<br />
visibili che invisibili, poiché <strong>di</strong>ce il Signore: ‘Colui che perderà l’anima sua per me, la<br />
salverà per la vita eterna’ (cfr. Lc 9, 24.; Mt 25, 46). ‘Beati quelli che soffrono persecuzione<br />
a causa della giustizia, perché <strong>di</strong> essi è il regno dei cieli (Mt 5, 10). Se hanno perseguitato<br />
me, perseguiteranno anche voi’ (Gv 15, 20). ‘Se poi vi perseguitano in una città, fuggite in<br />
un’altra (cfr. Mt 10, 23). Beati voi, quando gli uomini vi o<strong>di</strong>eranno e vi male<strong>di</strong>ranno e vi<br />
perseguiteranno e vi ban<strong>di</strong>ranno e vi insulteranno e il vostro nome sarà proscritto come<br />
infame e quando falsamente <strong>di</strong>ranno <strong>di</strong> voi ogni male per causa mia (cfr. Mt 5, 11 e 12);<br />
rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli (Lc 6,<br />
23; Mt 5, 12). E io <strong>di</strong>co a voi, miei amici: non lasciatevi spaventare da loro (cfr. Lc 12, 4) e<br />
non temete coloro che uccidono il corpo e dopo <strong>di</strong> ciò non possono far niente <strong>di</strong> più (Mt 10,<br />
28; Lc 12, 4). Guardate <strong>di</strong> non turbarvi (Mt 24, 6). Con la vostra pazienza infatti salverete le<br />
vostre anime (Lc 21, 19). E chi persevererà sino alla fine, questi sarà salvo’ (Mt 10, 22; 24,<br />
13) 5 .<br />
Il riferimento alla persecuzione ritorna anche altrove 6 negli Scritti <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco, perché si tratta <strong>di</strong><br />
un tema che ricorre frequentemente anche nel vangelo. L’atteggiamento che emerge è simile a<br />
quello che abbiamo riscontrato nella beatitu<strong>di</strong>ne dei pacifici, dove la pace fiorisce nella<br />
tribolazione: qui è annunciata una misteriosa beatitu<strong>di</strong>ne che si sperimenta nella persecuzione.<br />
Una delle beatitu<strong>di</strong>ni evangeliche <strong>di</strong>ce: “Beati i misericor<strong>di</strong>osi, perché troveranno misericor<strong>di</strong>a”.<br />
Anche se <strong>Fr</strong>ancesco non commenta <strong>di</strong>rettamente questa beatitu<strong>di</strong>ne, la parola misericor<strong>di</strong>a designa<br />
certamente un elemento importante della sua esperienza, se non altro perché il ricordo della sua<br />
conversione, nell’incontro con i lebbrosi, è contrassegnato dal «fare misericor<strong>di</strong>a» con essi. Da uno<br />
sguardo allargato a tutti gli Scritti <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco, risulta che la parola «misericor<strong>di</strong>a» ricorre nel suo<br />
vocabolario con due principali aree semantiche: in un primo senso è riferita a Dio, come attributo<br />
essenziale del suo comportamento: nell’Ufficio della passione, ad esempio, si rivolge a Dio <strong>di</strong>cendo<br />
«tu sei il Dio che mi accoglie, il mio Dio, la mia misericor<strong>di</strong>a». La misericor<strong>di</strong>a, dunque, è anzitutto<br />
attributo <strong>di</strong>vino e, in certo modo, la misericor<strong>di</strong>a è Dio stesso, se è vero che «Dio è amore».<br />
Ma in un secondo senso, la misericor<strong>di</strong>a è anche qualcosa che riguarda noi, da usare verso i fratelli,<br />
nel contesto <strong>di</strong> relazioni segnate dalla colpa (la misericor<strong>di</strong>a come perdono del fratello 7 , o il<br />
«iu<strong>di</strong>cium cum misericor<strong>di</strong>a» 8 , o la misericor<strong>di</strong>a nell’imporre la penitenza a quelli che peccano 9 ) o<br />
da altre <strong>di</strong>fficoltà non colpevoli, ma altrettanto separanti (la misericor<strong>di</strong>a con i lebbrosi 10 , che<br />
evidentemente non sono colpevoli, ma che sono per definizione i «separati» dagli uomini). Anche<br />
nella Lettera a un Ministro la parola «misericor<strong>di</strong>a» ricorre ben cinque volte, con una insistenza che<br />
non è casuale, per in<strong>di</strong>care l’atteggiamento che il Ministro deve avere verso il fratello che «ha<br />
peccato, quanto è possibile peccare». Il rapporto con gli altri, che è così fondamentale<br />
nell’esperienza <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco, risulta segnato dalla misericor<strong>di</strong>a, a partire dall’incontro coi lebbrosi,<br />
per continuare nel rapporto, spesso non meno <strong>di</strong>fficoltoso, con i fratelli frati.<br />
5 Rnb 16, 10-21.<br />
6 Amm 3,8: la persecuzione sostenuta dal frate che fa obiezione <strong>di</strong> coscienza; Amm 6, 2: la tribolazione e persecuzione che<br />
contrad<strong>di</strong>stingue le pecore del Signore nella loro sequela<br />
7 2Lf 43: FF 197.<br />
8 2Lf 28-29: FF 191.<br />
9 Rb 7,2: FF 94.<br />
10 Test 2: FF 110.<br />
4
Denso <strong>di</strong> significato questo duplice significato della parola misericor<strong>di</strong>a: forse vuol <strong>di</strong>re che la<br />
misericor<strong>di</strong>a che ci possiamo offrire tra noi non è altro che la misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Dio, la sua stessa vita:<br />
perché la carità è la vita stessa <strong>di</strong> Dio effusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo 11 .<br />
Un’altra beatitu<strong>di</strong>ne proclama: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno<br />
saziati».<br />
La giustizia <strong>di</strong> cui parla <strong>Fr</strong>ancesco nei suoi scritti è soprattutto un attributo <strong>di</strong>vino: a Dio si rivolge,<br />
nelle Lo<strong>di</strong> <strong>di</strong> Dio altissimo, <strong>di</strong>cendo «tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia e temperanza…» 12 e<br />
spesso, citando i salmi, invita Dio a giu<strong>di</strong>care e a rivelare la sua giustizia. Il maggior numero <strong>di</strong><br />
volte in cui si parla <strong>di</strong> giustizia, dunque, essa è riferita a Dio; ma la giustizia riguarda anche l’uomo.<br />
È la giustizia per la quale si soffre persecuzione nella beatitu<strong>di</strong>ne dei perseguitati, che già abbiamo<br />
citato: essi sono perseguitati per la giustizia. E, infine, la giustizia ha anche a che fare con la<br />
povertà, con la giusta o ingiusta <strong>di</strong>stribuzione dei beni, e con quella forma <strong>di</strong> restituzione dei beni ai<br />
poveri che è l’elemosina: <strong>di</strong>ce infatti <strong>Fr</strong>ancesco nella Regola non bollata che «l’elemosina è<br />
l’ere<strong>di</strong>tà e la giustizia che è dovuta ai poveri; l’ha acquistata per noi il Signore nostro Gesù<br />
Cristo» 13 . Proviamo a pensare quale effetto sociale ha questa idea <strong>di</strong> giustizia dovuta ai poveri!<br />
Un’altra beatitu<strong>di</strong>ne proclama: «Beati i miti, perché avranno in ere<strong>di</strong>tà la terra». <strong>Fr</strong>ancesco, nei suoi<br />
Scritti, usa due sole volte l’aggettivo “mite”, e come per la misericor<strong>di</strong>a o per la giustizia, egli<br />
applica questo termine sia a Dio «che solo è buono, pio, mite, soave e dolce» (Rnb 23,9), sia ai<br />
rapporti fraterni, esortando i frati che «quando vanno per il mondo, non litighino ed evitino le <strong>di</strong>spute<br />
<strong>di</strong> parole e non giu<strong>di</strong>chino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando<br />
onestamente con tutti, così come conviene» (Rb 3, 10-11).<br />
Quanto abbiamo registrato per la misericor<strong>di</strong>a, la giustizia e la mitezza mostra dunque un<br />
denominatore comune: secondo <strong>Fr</strong>ancesco, le caratteristiche <strong>di</strong> Dio sono anche gli atteggiamenti da<br />
coltivare tra noi. Perché Dio è misericor<strong>di</strong>oso, dobbiamo usare misericor<strong>di</strong>a; perché Dio è giusto,<br />
dobbiamo impegnarci per la giustizia; perché Dio è mite, dobbiamo essere miti. <strong>Fr</strong>ancesco mescola con<br />
<strong>di</strong>sinvoltura il cielo e la terra, ciò che è <strong>di</strong>vino e ciò che è umano, le caratteristiche <strong>di</strong> Dio e le nostre,<br />
nella logica <strong>di</strong> Gesù che, nel <strong>di</strong>scorso della montagna, poche frasi dopo le beatitu<strong>di</strong>ni, ci <strong>di</strong>ce «Siate<br />
perfetti come è perfetto il padre vostro celeste» (Mt 5, 48).<br />
Un altro concetto è centrale nelle beatitu<strong>di</strong>ni evangeliche: la promessa <strong>di</strong> una ricompensa. Anche se la<br />
parola ricompensa compare una sola volta, alla fine («Rallegratevi ed esultate, perché grande è la<br />
vostra ricompensa nei cieli»), tutte le beatitu<strong>di</strong>ni sono sostenute da questa convinzione <strong>di</strong> un<br />
ribaltamento della con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> povertà o <strong>di</strong> pianto, che si muterà in ricchezza e gioia. Insomma: le<br />
beatitu<strong>di</strong>ni promettono una ricompensa, che inizia fin d’ora e che si compirà nel Regno.<br />
Anche <strong>Fr</strong>ancesco usa spesso il termine ricompensa (merces), con un significato duplice: da una<br />
parte in<strong>di</strong>ca la ricompensa <strong>di</strong> cui parla il Vangelo, quella che atten<strong>di</strong>amo alla fine della vita («Gli<br />
uomini, infatti, perdono tutte le cose che lasciano in questo mondo, ma portano con sé la ricompensa<br />
della carità e le elemosine che hanno fatto, delle quali avranno dal Signore il premio e la degna<br />
ricompensa» 14 ) e che talvolta è collegata all’elemosina 15 , dall’altra mette in guar<strong>di</strong>a da un cattivo<br />
desiderio <strong>di</strong> ricompensa che può insinuarsi nell’agire umano, e che talvolta si annida anche sotto azioni<br />
apparentemente virtuose. Esemplare, a questo proposito, l’Ammonizione 21, dove la parola ricompensa<br />
ritorna ben tre volte, con una accezione sostanzialmente egoistica:<br />
11 Cfr Rom 5,5.<br />
12 LAlt 5.<br />
13 Rnb 9,8.<br />
14 2Lf 31<br />
15 «E l’elemosina è l’ere<strong>di</strong>tà e la giustizia che è dovuta ai poveri; l’ha acquistata per noi il Signore nostro Gesù Cristo. E i<br />
frati che si affaticano per procurarla avranno una grande ricompensa e la fanno guadagnare e acquistare a quelli che fanno<br />
elemosina; poiché tutte le cose che gli uomini lasceranno nel mondo, periranno, ma della carità e delle elemosine che<br />
hanno fatto riceveranno il premio dal Signore» (Rnb 9, 8-9).<br />
5
Beato il servo che, quando parla, non manifesta tutte le sue cose in vista <strong>di</strong> una ricompensa, e<br />
non è veloce a parlare, ma sapientemente valuta che cosa deve <strong>di</strong>re e rispondere. Guai a quel<br />
religioso che non custo<strong>di</strong>sce nel suo cuore i beni che il Signore gli mostra e non li manifesta<br />
agli altri attraverso le opere, ma piuttosto, con il vano pretesto <strong>di</strong> una ricompensa, preferisce<br />
manifestarli agli uomini a parole. Questi riceve già la sua ricompensa e gli ascoltatori ne<br />
riportano poco frutto 16 .<br />
Siamo dunque messi in guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> fronte all’idea <strong>di</strong> ricompensa: da una parte possiamo legittimamente<br />
attendercela, perché è promessa dal Signore stesso, ma dall’altra dobbiamo essere sicuri che si tratti<br />
della retribuzione voluta da Dio, e non <strong>di</strong> qualche genere <strong>di</strong> guadagno che appaga il nostro egoismo e<br />
che <strong>Fr</strong>ancesco riconosce essere appropriazione contraria a una vita “senza nulla <strong>di</strong> proprio”.<br />
Abbiamo cercato <strong>di</strong> cogliere il pensiero <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco a proposito delle beatitu<strong>di</strong>ni o <strong>di</strong> alcuni temi<br />
ad esse collegati; si potrebbe continuare questa indagine rileggendo quei testi che sono stati<br />
chiamati le “beatitu<strong>di</strong>ni francescane”. Si pensi a quella quin<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> volte, nelle Ammonizioni, in<br />
cui ritorna l’espressione “Beato il servo …”, con una evidente ripresa del modello evangelico delle<br />
beatitu<strong>di</strong>ni. <strong>Fr</strong>ancesco si mostra creativo nel formulare nuove beatitu<strong>di</strong>ni, mostrandoci che il<br />
Vangelo non è finito con il testo trasmessoci dalla tra<strong>di</strong>zione, ma continua a essere vivo, e va<br />
declinato nel presente. E chie<strong>di</strong>amoci: noi siamo capaci <strong>di</strong> formulare le beatitu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> oggi?<br />
Per concludere questa prima parte della nostra riflessione mi pare utile rileggere un testo riassuntivo<br />
che ci aiuta a capire cos’è beatitu<strong>di</strong>ne per <strong>Fr</strong>ancesco. È il famoso Dialogo della vera letizia.<br />
1 Lo stesso [fra Leonardo] riferì nello stesso luogo che un giorno il beato <strong>Fr</strong>ancesco, presso<br />
Santa Maria [degli Angeli], chiamò frate Leone e gli <strong>di</strong>sse: «<strong>Fr</strong>ate Leone, scrivi». 2 Questi<br />
rispose: «Ecco, sono pronto». 3 «Scrivi - <strong>di</strong>sse - quale è la vera letizia».<br />
4 «Viene un messo e <strong>di</strong>ce che tutti i maestri <strong>di</strong> Parigi sono entrati nell'Or<strong>di</strong>ne; scrivi: non è vera<br />
letizia. 5 Cosi pure che [sono entrati nell'Or<strong>di</strong>ne] tutti i prelati d'oltralpe, arcivescovi e vescovi,<br />
e anche il Re <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancia e il Re d'Inghilterra; scrivi: non è vera letizia. 6 Ancora, [si annuncia]<br />
che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, e inoltre che io ho<br />
ricevuto da Dio tanta grazia che risano gli infermi e faccio molti miracoli; io ti <strong>di</strong>co: in tutte<br />
queste cose non è vera letizia».<br />
7 «Ma quale è la vera letizia?».<br />
8 «Ecco, io torno da Perugia e a notte fonda arrivo qui, ed è tempo d’inverno fangoso e così<br />
freddo che all’estremità della tonaca si formano dei dondoli d'acqua fredda congelata, che mi<br />
percuotono continuamente le gambe, e da quelle ferite esce il sangue. 9 E io tutto nel fango e<br />
nel freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta e, dopo che ho picchiato e chiamato a lungo, viene<br />
un frate e chiede: «Chi è?». Io rispondo: «<strong>Fr</strong>ate <strong>Fr</strong>ancesco». 10 E quegli <strong>di</strong>ce: «Vattene, non è<br />
ora decente questa, <strong>di</strong> andare in giro; non entrerai». 11 E poiché io insisto ancora, l'altro<br />
risponde: «Vattene, tu sei un semplice e un i<strong>di</strong>ota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti<br />
e tali che non abbiamo bisogno <strong>di</strong> te». 12 E io resto ancora davanti alla porta e <strong>di</strong>co: «Per amor<br />
<strong>di</strong> Dio, accoglietemi per questa notte». 13 E quegli risponde: «Non lo farò. 14 Vattene al luogo<br />
dei Crociferi e chie<strong>di</strong> là».<br />
15 Ebbene, se avrò avuto pazienza e non mi sarò inquietato, in questo è vera letizia e vera virtù e<br />
la salvezza dell'anima».<br />
16 Amm 21; cfr anche altri due testi in cui la parola ricompensa è usata in accezione negativa: Rnb 23, 25 «Perciò, tutti noi<br />
frati, custo<strong>di</strong>amo attentamente noi stessi, perché, sotto pretesto <strong>di</strong> qualche ricompensa o <strong>di</strong> opera da fare o <strong>di</strong> un aiuto,<br />
non ci avvenga <strong>di</strong> perdere o <strong>di</strong> <strong>di</strong>stogliere la nostra mente e il cuore dal Signore»; Rnb 17, 11-12 «Lo spirito della carne,<br />
infatti, vuole e si preoccupa molto <strong>di</strong> possedere parole, ma poco <strong>di</strong> attuarle, e cerca non la religiosità e la santità<br />
interiore dello spirito, ma vuole e desidera una religiosità e una santità che appaia al <strong>di</strong> fuori agli uomini. È <strong>di</strong> questi che<br />
il Signore <strong>di</strong>ce: ‘In verità vi <strong>di</strong>co, hanno ricevuto la loro ricompensa’ (Mt 6, 2)».<br />
6
Quella <strong>di</strong>mensione che fin qui abbiamo chiamato «beatitu<strong>di</strong>ne» viene in<strong>di</strong>cata da <strong>Fr</strong>ancesco con il<br />
termine «vera letizia». Una letizia molto “alternativa”, perché non consiste in quello che normalmente<br />
noi consideriamo causa <strong>di</strong> gioia e che viene accuratamente descritto nella prima parte del <strong>di</strong>alogo:<br />
l’incremento numerico e qualitativo dell’Or<strong>di</strong>ne (i maestri, i prelati e i nobili che si fanno frati),<br />
l’efficacia missionaria dell’Or<strong>di</strong>ne (i frati che vanno tra gli infedeli e li convertono) o ad<strong>di</strong>rittura la<br />
conferma miracolosa della santità <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco. Per ognuno <strong>di</strong> questi nobili motivi <strong>di</strong> gioia si ripete un<br />
secco ammonimento: «non è vera letizia».<br />
Il <strong>di</strong>alogo è costruito molto bene. Dopo la prima parte in cui <strong>Fr</strong>ancesco ha <strong>di</strong>strutto i nostri pregiu<strong>di</strong>zi,<br />
segue una seconda parte in cui costruisce una immagine vera <strong>di</strong> beatitu<strong>di</strong>ne: una immagine<br />
paradossale, che è perfettamente in linea con il Vangelo che proclama beati i poveri, i piangenti, i<br />
perseguitati. L’icona della vera letizia è <strong>Fr</strong>ancesco, rifiutato dai suoi fratelli, che rimane pazientemente<br />
alla porta, una porta che sembra voler rimanere ostinatamente chiusa. Egli subisce con mitezza la<br />
violenza <strong>di</strong> quelle parole «Vattene, tu sei un semplice e un i<strong>di</strong>ota, qui non ci puoi venire ormai; noi<br />
siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno <strong>di</strong> te». Una esperienza che <strong>Fr</strong>ancesco ha fatto, nel sofferto e<br />
<strong>di</strong>fficile rapporto con i fratelli negli anni dopo le sue <strong>di</strong>missioni: beninteso, non credo che sia successo<br />
materialmente l’episo<strong>di</strong>o descritto, ma che questo racconto descriva bene il vissuto <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco per un<br />
certo periodo della sua vita. La frustrazione e il fallimento nei rapporti fraterni sono <strong>di</strong>venuti per lui il<br />
luogo <strong>di</strong> una misteriosa perfetta letizia.<br />
E troviamo condensata in questo <strong>di</strong>alogo la sostanza delle beatitu<strong>di</strong>ni che abbiamo commentato con<br />
l’aiuto degli Scritti <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco: troviamo la pace che, abbiamo detto, fiorisce nelle infermità e<br />
tribolazioni, quella pace che è la vera letizia. Troviamo quella povertà che si gioca soprattutto nei<br />
rapporti fraterni, perché la vera povertà <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco, in questo <strong>di</strong>alogo, non è tanto il fango e il freddo<br />
e il ghiaccio che lo fanno patire, ma soprattutto il rapporto con quel frate che lo rifiuta: si tratta <strong>di</strong><br />
povertà relazionale, come abbiamo detto. Troviamo la misericor<strong>di</strong>a e la mitezza, che viene da Dio e<br />
che doniamo al prossimo, e che <strong>Fr</strong>ancesco esercita pazientemente con il frate portinaio, comportandosi<br />
come il frate Ministro, invitato a donare misericor<strong>di</strong>a al fratello “che ha peccato quanto poteva<br />
peccare”. Si manifesta infine, in pienezza, la beatitu<strong>di</strong>ne nella persecuzione: una persecuzione tanto più<br />
dolorosa perché proviene dal fratello e perché <strong>Fr</strong>ancesco si trova nella situazione paradossale <strong>di</strong> vivere<br />
nella sua fraternità il culmine dell’amore, che è l’amore del nemico.<br />
B1 – Abbiamo riascoltato le beatitu<strong>di</strong>ni evangeliche e abbiamo cercato <strong>di</strong> capire cosa hanno<br />
significato per <strong>Fr</strong>ancesco d’Assisi. Ora vorrei iniziare una riflessione su quello che queste<br />
beatitu<strong>di</strong>ni possono significare per noi oggi, partendo dalla consapevolezza che esse sono Vangelo,<br />
cioè buon annuncio per noi oggi. Non si tratta <strong>di</strong> una parola morta, ma della voce <strong>di</strong> Cristo risorto<br />
che ancora oggi proclama a noi «Beati…beati…beati».<br />
Si tratta davvero <strong>di</strong> un buon annuncio perché Gesù non <strong>di</strong>ce che siamo beati nonostante la povertà,<br />
nonostante la persecuzione, nonostante le lacrime, nonostante la sete <strong>di</strong> pace e <strong>di</strong> giustizia in un<br />
mondo segnato da guerre e ingiustizie, ma proprio nella persecuzione, nella povertà, nel pianto, in<br />
questo mondo ingiusto. Mi verrebbe quasi da <strong>di</strong>re che, secondo Gesù, siamo beati a causa della<br />
povertà, del pianto, della persecuzione. Gesù ci annuncia che nel “<strong>di</strong> meno” è possibile un “<strong>di</strong> più”,<br />
che nelle situazioni che il mondo giu<strong>di</strong>ca perdenti è possibile una misteriosa gioia, che ci fa essere<br />
beati. Dopo tutto, non è altro che la realizzazione <strong>di</strong> ciò che contempliamo in maniera unica nella<br />
Pasqua, dove il “<strong>di</strong> meno” ra<strong>di</strong>cale, che è la morte, <strong>di</strong>venta il luogo in cui fiorisce la vita che non ha<br />
più limiti. Le beatitu<strong>di</strong>ni sono la declinazione della Pasqua.<br />
A questo punto possiamo interrogarci: quali sono le <strong>di</strong>fficoltà e le situazioni concrete in cui oggi si<br />
realizza la nostra evangelica beatitu<strong>di</strong>ne? Riprendo alcune delle beatitu<strong>di</strong>ni e propongo qualche<br />
domanda, come aiuto alla riflessione personale e senza pretesa <strong>di</strong> risposta imme<strong>di</strong>ata.<br />
Partiamo dalla prima beatitu<strong>di</strong>ne, che <strong>di</strong>ce «Beati i poveri in spirito», e che <strong>Fr</strong>ancesco identifica<br />
nella povertà “relazionale”; ognuno <strong>di</strong> noi può chiedersi quali sono le relazioni in cui vivere così, da<br />
vero povero e dunque da beato. Spesso saranno le relazioni fraterne, in cui siamo chiamati a<br />
espropriarci <strong>di</strong> noi stessi, in un impegno <strong>di</strong> povertà relazionale che ci riguarda tutti. Penso a tante<br />
7
nostre fraternità, ma anche alle nostre comunità cristiane, in cui spesso viviamo la beatitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
sopportare fratelli o sorelle “<strong>di</strong>fficili”.<br />
«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia» e «Beati i perseguitati per la giustizia». Qual è<br />
la giustizia della quale avere fame e sete, qual è la giustizia per la quale lottare ed essere<br />
perseguitato e dunque beato? E subito anche «Beati gli operatori <strong>di</strong> pace». Qual è l’opera <strong>di</strong> pace<br />
che oggi mi è chiesta per essere chiamato figlio <strong>di</strong> Dio? Qui si apre l’ampio spazio del nostro<br />
impegno per la giustizia e la pace, che non sono qualcosa da delegare agli “addetti ai lavori”, ma un<br />
tratto che entra nella mia identità francescana. È cosa buona avere gli incaricati <strong>di</strong> giustizia e pace<br />
nelle nostre Province, ma attenzione: che non <strong>di</strong>venti una maniera per delegare ad altri questo<br />
impegno e metterci così il cuore in pace. Ognuno <strong>di</strong> noi ha i suoi personali ambiti nei quali far<br />
crescere giustizia e pace, ad esempio nella vita fraterna o nell’impegno pastorale, e tutti siamo<br />
chiamati a intervenire, a denunciare, a lottare e forse anche a soffrire per la pace e la giustizia nella<br />
società in cui viviamo.<br />
«Beati i misericor<strong>di</strong>osi…». Quali gli spazi <strong>di</strong> misericor<strong>di</strong>a che si aprono intorno a me, già raggiunto<br />
ogni giorno dalla misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Dio e da quella dei fratelli, che mi sopportano nonostante tutto?<br />
Una misericor<strong>di</strong>a che ha convertito <strong>Fr</strong>ancesco, nel suo incontro con i lebbrosi, e che potrebbe<br />
convertire anche me. Una misericor<strong>di</strong>a che spesso assume il volto del perdono, da chiedere a da<br />
offrire, in tante relazioni segnate da durezza e lontananza.<br />
«Beati i puri <strong>di</strong> cuore…». Quale purezza <strong>di</strong> cuore coltivare per vivere una vita beata perché<br />
unificata in Dio? Qui si pone la fondamentale domanda sulla mia capacità <strong>di</strong> “stare” dentro le cose<br />
che faccio, senza <strong>di</strong>sperdermi nelle mille cose da fare e conservando quella unità interiore che nasce<br />
dal cuore rivolto al Signore. <strong>Fr</strong>atelli “under ten”, voi siete nella fascia più a rischio per questa<br />
tentazione della “<strong>di</strong>spersione” interiore: conoscete bene il fenomeno del “burnout”, cioè del<br />
bruciarsi per un lavoro esagerato. Notate: normalmente ciò non avviene per attività sbagliate, ma<br />
per un eccesso <strong>di</strong> lavoro pastorale o professionale, che rende impossibile mantenere il primato dello<br />
«spirito <strong>di</strong> orazione e devozione, cui tutte le altre cose devono servire». Voi, generazione cresciuta<br />
nella cultura informatica, credo siate ben consapevoli anche delle tentazioni dell’abuso <strong>di</strong> internet,<br />
che, da strumento utile qual è, può trasformarsi in continua navigazione senza meta o in un<br />
idolatrico pellegrinaggio a siti francamente negativi. Con queste e altre <strong>di</strong>mensioni molto attuali<br />
della nostra vita ha a che fare la purezza <strong>di</strong> cuore cui ci chiama la beatitu<strong>di</strong>ne, perché non ci<br />
scor<strong>di</strong>amo che noi abbiamo scelto <strong>di</strong> mettere Dio al primo posto.<br />
Credo che a queste domande ciascuno debba rispondere in maniera <strong>di</strong>versa, perché <strong>di</strong>verse sono le<br />
nostre situazioni <strong>di</strong> vita, i paesi da cui proveniamo, le nostre culture e le nostre fraternità, e<br />
soprattutto perché <strong>di</strong>versi siamo noi, uno dall’altro.<br />
Provo anche a suggerire una riflessione su una beatitu<strong>di</strong>ne che riguarderà molti <strong>di</strong> noi nei prossimi<br />
anni, ed è la beatitu<strong>di</strong>ne della <strong>di</strong>minuzione numerica, che attende la maggioranza delle nostre<br />
provincie e certamente il nostro Or<strong>di</strong>ne globalmente nei prossimi anni.<br />
Le statistiche, impietose, ce lo ricordano: qualche decina d’anni fa eravamo il doppio <strong>di</strong> oggi, e il<br />
trend generale continua in <strong>di</strong>scesa. Ma la parola del Signore ci assicura: «Beati voi, che calate <strong>di</strong><br />
numero…». Una nuova beatitu<strong>di</strong>ne, forse.<br />
Anche <strong>Fr</strong>ancesco ha intuito questa beatitu<strong>di</strong>ne; il <strong>di</strong>alogo della vera letizia <strong>di</strong>chiara che la<br />
beatitu<strong>di</strong>ne non sta nella crescita numerica, culturale o sociale dell’Or<strong>di</strong>ne: «non è vera letizia».<br />
Anche nelle biografie troviamo alcune tracce del modo in cui <strong>Fr</strong>ancesco considerava la crescita<br />
numerica dei frati; si tratta <strong>di</strong> accenni abbastanza fugaci, ma tanto più significativi perché vanno in<br />
una <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong>versa da quella della maggioranza dei frati e degli stessi biografi, che consideravano<br />
la crescita numerica un fatto <strong>di</strong> cui gioire e un segno della provvidenza <strong>di</strong>vina.<br />
Così Tommaso da Celano inserisce nel <strong>di</strong>scorso sulla povertà <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco una sua interessante<br />
affermazione:<br />
8
Per riguardo alla povertà, l'uomo <strong>di</strong> Dio aveva paura del gran numero <strong>di</strong> frati perché, se non in<br />
realtà almeno in apparenza, anche ciò è segno <strong>di</strong> ricchezza. Perciò <strong>di</strong>ceva: «Oh, potesse venire,<br />
<strong>di</strong>co, venga il giorno in cui il mondo, vedendo i frati minori assai <strong>di</strong> raro, ne abbia stima per il<br />
loro piccolo numero!» 17 .<br />
Noi possiamo commentare che forse è venuto il giorno invocato da <strong>Fr</strong>ancesco: oggi il mondo vede i<br />
frati assai <strong>di</strong> raro. Speriamo che, come <strong>di</strong>ce <strong>Fr</strong>ancesco, possa averne stima per il piccolo numero!<br />
E ci consola anche la parola rivolta dal Signore a <strong>Fr</strong>ancesco, secondo la Compilatio Assisiensis:<br />
Affinché tu sia convinto quanto profondamente io amo questa fraternità, anche se in tutto<br />
l'Or<strong>di</strong>ne non restassero che tre frati, non li abbandonerò in eterno 18 .<br />
Non siamo arrivati ad essere tre frati, ma possiamo riconoscere che ancor oggi il Signore, attraverso<br />
tante persone che ci amano e stimano, continua a darci segni del suo amore.<br />
Per gustare questa beatitu<strong>di</strong>ne dobbiamo forse riscoprire l’intuizione francescana della bellezza <strong>di</strong><br />
ciò che è piccolo, anzi più piccolo, cioè minore. Veniamo da una tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> presenze, <strong>di</strong><br />
gran<strong>di</strong> numeri e spesso anche <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> strutture. La vita ci sta conducendo in un’altra <strong>di</strong>rezione, e<br />
forse non sarà così <strong>di</strong>fficile camminare in questa <strong>di</strong>rezione, se incominciamo a gustare la bellezza <strong>di</strong><br />
ciò che è piccolo, con pochi mezzi materiali, ma vive <strong>di</strong> Dio. Questo ha anche a che fare con la<br />
minorità.<br />
Possiamo sognare un Or<strong>di</strong>ne fatto <strong>di</strong> fraternità spesso piccole numericamente, ma significative per<br />
la testimonianza <strong>di</strong> uomini segnati in profon<strong>di</strong>tà da Dio. Tali prospettive orienteranno anche<br />
l’investimento delle nostre forze, che stanno calando: è inutile continuare a investire energie e<br />
affetti nelle gran<strong>di</strong> strutture, perdendo la pace per sostenere le gran<strong>di</strong> opere.<br />
In questa prospettiva, ci è molto utile ritrovare l’appartenenza all’Or<strong>di</strong>ne, prima che alla Provincia.<br />
Se anche la mia Provincia può finire, ho coscienza che appartengo a un Or<strong>di</strong>ne che è più grande e<br />
che mi offre la mia vera appartenenza, che mi lega all’Or<strong>di</strong>ne dei <strong>Fr</strong>ati Minori, prima <strong>di</strong> appartenere<br />
alla mia Provincia. Questo si scontra certamente con il nostro ra<strong>di</strong>cato “provincialismo”. A questo<br />
proposito si devono ripensare gli inviti del Ministro generale a sviluppare una <strong>di</strong>mensione inter:<br />
interprovinciale, interculturale, internazionale, ecc 19 . È questa la <strong>di</strong>rezione che ci attende.<br />
In questo ci può aiutare anche l’apertura alla Famiglia <strong>Fr</strong>ancescana: al <strong>di</strong> là delle nostre rispettabili<br />
strutture <strong>OFM</strong>, alle quali sono affezionato, esiste una ispirazione comune che unisce tutti i<br />
francescani / le francescane e che permette <strong>di</strong> non restringere lo sguardo sui nostri confini.<br />
La decrescita numerica che stiamo vivendo, e che voi, fratelli più giovani, dovrete gestire nei<br />
prossimi anni in tante entità dell’Or<strong>di</strong>ne, può dunque essere luogo <strong>di</strong> beatitu<strong>di</strong>ne. E ricor<strong>di</strong>amoci<br />
che è qualcosa che riguarda tutti, anche le entità che oggi sono in crescita numerica (grazie a Dio, ce<br />
ne sono alcune). Nessuno può pensare <strong>di</strong> non essere toccato da questi <strong>di</strong>scorsi, se non altro perché il<br />
calo <strong>di</strong> presenze nelle entità “storiche” significherà anche una <strong>di</strong>minuzione economica. Molte<br />
presenze che oggi si sostengono economicamente per l’aiuto <strong>di</strong> altre entità, subiranno ugualmente la<br />
conseguenza della <strong>di</strong>minuzione e talvolta della scomparsa <strong>di</strong> tali entità. Questo per ricordarci che la<br />
questione riguarda noi tutti, ed è per tutti una occasione che ci costringerà, per amore o per forza, a<br />
essere più poveri e minori. Perché si tratta <strong>di</strong> una beatitu<strong>di</strong>ne fraterna, <strong>di</strong> qualcosa che riguarda i<br />
nostri rapporti fraterni: la nostra consistenza numerica non è una questione da “ufficio del<br />
personale”, ma è un elemento significativo del nostro essere fratelli.<br />
<strong>Fr</strong>ancesco ci aiuta, in questa nuova beatitu<strong>di</strong>ne fraterna, lui che ha patito nel suo tormentato<br />
rapporto con i fratelli, come ci è documentato storicamente dalle sue <strong>di</strong>missioni. Non si danno le<br />
<strong>di</strong>missioni se tutto fila liscio: quel gesto <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco, storicamente certo, ci rivela una crisi nel suo<br />
rapporto con i fratelli. Pure, il Dialogo della vera letizia ci fa intuire come egli è riuscito a far<br />
17 2 Cel 70.<br />
18 CAss 112<br />
19 Cfr Con autenticità e aperti al futuro. <strong>Relazione</strong> del Ministro generale al Capitolo 2009, nn 125-135.<br />
9
<strong>di</strong>ventare quella crisi un luogo <strong>di</strong> beatitu<strong>di</strong>ne. La biografia <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco in<strong>di</strong>ca nelle sue stimmate,<br />
che avvengono quattro anni dopo le <strong>di</strong>missioni e due prima della morte, una chiave per<br />
comprendere il passaggio che <strong>Fr</strong>ancesco ha compiuto per giungere ad una nuova beatitu<strong>di</strong>ne,<br />
segnata dalla esigente pace della croce. Un passaggio che è pasquale, come le stimmate fanno<br />
intuire, e che conduce <strong>Fr</strong>ancesco, alcuni mesi dopo la Verna, a comporre il Cantico <strong>di</strong> frate sole, nel<br />
suo soggiorno presso san Damiano della primavera del 1225. Il Cantico è il più alto documento <strong>di</strong><br />
un nuovo sguardo <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco sul mondo: lo sguardo del risorto, <strong>di</strong> chi ha fatto pasqua, e vede<br />
ormai i cieli nuovi e la terra nuova, gustando già le beatitu<strong>di</strong>ni promesse. E gli ultimi due anni <strong>di</strong><br />
vita <strong>di</strong> <strong>Fr</strong>ancesco appaiono segnati da questa pacificata prospettiva. Ricordando sempre che la gioia<br />
che traspare è la gioia della Pasqua, che è sempre una misteriosa unità <strong>di</strong> morte e <strong>di</strong> vita, come nelle<br />
beatitu<strong>di</strong>ni, come nelle stimmate che sono segno <strong>di</strong> morte ma che compaiono trasfigurate sul corpo<br />
del risorto. Come in Gesù, così in <strong>Fr</strong>ancesco.<br />
B2 – La parola del Vangelo è prima <strong>di</strong> tutto un dono; anche il vangelo delle beatitu<strong>di</strong>ni è anzitutto<br />
un dono, fatto a tutti noi, che ci svela la possibilità <strong>di</strong> essere beati nelle <strong>di</strong>fficoltà e nella prova. Ma<br />
sappiamo bene che, nella logica evangelica, ogni dono <strong>di</strong>venta anche un compito. I talenti ricevuti<br />
dal Signore non ci sono dati per essere nascosti sottoterra, ma per essere trafficati e restituiti a lui, il<br />
Signore, che ce ne chiederà conto al suo ritorno. Le beatitu<strong>di</strong>ni che ci sono annunciate non sono<br />
solo da tenere per noi, ma da annunciare ai fratelli. Quale beatitu<strong>di</strong>ne possiamo annunciare oggi noi,<br />
frati minori?<br />
Credo che anzitutto possiamo testimoniare ciò che sta a fondamento <strong>di</strong> tutte le beatitu<strong>di</strong>ni, cioè il<br />
primato <strong>di</strong> Dio. Solo se Dio è al primo posto <strong>di</strong>venta possibile vivere la povertà, il pianto, la fame e<br />
sete <strong>di</strong> giustizia o la persecuzione come beatitu<strong>di</strong>ne. E Dio sta al primo posto perché, come ci<br />
ricorda <strong>Fr</strong>ancesco, egli è «il bene, il sommo bene, ogni bene, ed egli solo è buono». È la sua<br />
presenza nella nostra vita la sorgente vera <strong>di</strong> ogni beatitu<strong>di</strong>ne, <strong>di</strong> ogni gioia. Egli viene prima <strong>di</strong><br />
tutto, sopra tutto e tutti, e su questa unicità <strong>di</strong> Dio, che spazza via ogni idolatria, non ci sono<br />
<strong>di</strong>scussioni; ma bisogna aggiungere che tale primato <strong>di</strong>vino non si realizza eliminando tutto il resto,<br />
bensì valorizzando tutte le altre presenze che animano la nostra vita. Dio non tiene il primo posto<br />
annullando tutto il resto, bensì donando senso e valore a ogni altra realtà, che dalla relazione con<br />
Dio trae il fondamento della sua bontà. Così è per il sole, che è «bello e ra<strong>di</strong>ante cun grande<br />
splendore» proprio perché «de Te, Altissimo, porta significazione», così per ogni altra creatura, e<br />
così per coloro che più <strong>di</strong> ogni altro ci svelano la bontà <strong>di</strong> Dio, cioè i fratelli. Testimoniare il<br />
primato <strong>di</strong> Dio, annunciato dalle beatitu<strong>di</strong>ni, significa allora annunciare la sua presenza in ogni<br />
creatura e in ogni umana relazione, e soprattutto in quel luogo <strong>di</strong> realizzazione delle beatitu<strong>di</strong>ni che<br />
è la fraternità, quella vissuta tra noi frati e quella realizzata con ogni altra persona.<br />
In due sensi la fraternità è il luogo francescano delle beatitu<strong>di</strong>ni: perché nel rapporto fraterno, che<br />
non è mai ideale o senza problemi, sperimento la povertà relazionale, conosco il pianto, incontro le<br />
situazioni in cui operare pace e cercare la giustizia, ma anche perché la fraternità è per noi il luogo<br />
della consolazione e della sazietà, in cui fin d’ora posso gustare, come in un anticipo, la presenza<br />
del Regno <strong>di</strong> Dio.<br />
L’annuncio che possiamo fare, ancora oggi, è dunque quello della beatitu<strong>di</strong>ne della fraternità: <strong>di</strong> un<br />
tale annuncio il mondo <strong>di</strong> oggi ha bisogno, e questo dono, da noi ricevuto senza meriti, siamo<br />
chiamati ad estendere al mondo intero. Perché parlare <strong>di</strong> fraternità non significa riferirsi solo ad un<br />
club per pochi intimi, ma mostrare una maniera <strong>di</strong> relazionarsi con gli altri che si estende<br />
naturalmente a ogni uomo e donna <strong>di</strong> questo mondo. Annunciare la fraternità significa non solo<br />
parlare, ma già imparare a fare e progettare insieme, sperimentare un nuovo stile <strong>di</strong> pastorale,<br />
proporre mo<strong>di</strong> nuovi <strong>di</strong> essere chiesa. Vivere e annunciare la fraternità significa mostrare, nei fatti,<br />
che il Regno è iniziato, che esso è presente tra noi, <strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> Gesù, e che il Regno <strong>di</strong> Dio è<br />
possibile. La nostra missione è questa: mostrare nelle nostre fraternità quell’inizio del Regno che è<br />
la Chiesa.<br />
10