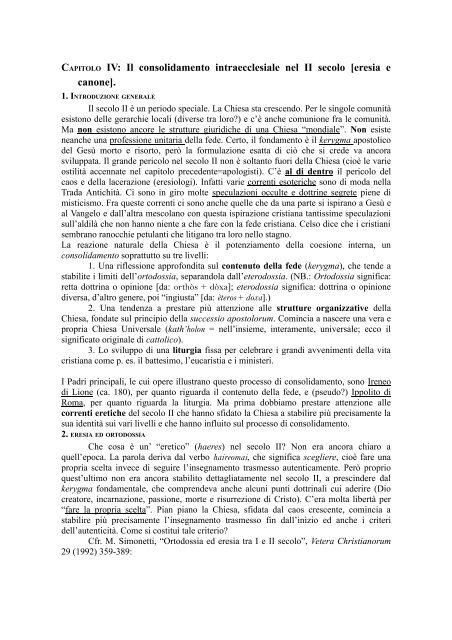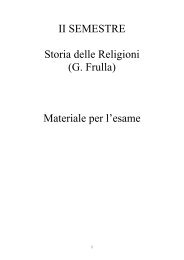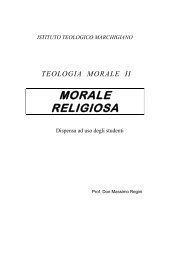Dispensa Patrologia 4
Dispensa Patrologia 4
Dispensa Patrologia 4
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPITOLO IV: Il consolidamento intraecclesiale nel II secolo [eresia e<br />
canone].<br />
1. INTRODUZIONE GENERALE<br />
Il secolo II è un periodo speciale. La Chiesa sta crescendo. Per le singole comunità<br />
esistono delle gerarchie locali (diverse tra loro?) e c’è anche comunione fra le comunità.<br />
Ma non esistono ancore le strutture giuridiche di una Chiesa “mondiale”.<br />
Non esiste<br />
neanche una professione unitaria della fede. Certo, il fondamento è il kerygma apostolico<br />
del Gesù morto e risorto, però la formulazione esatta di ciò che si crede va ancora<br />
sviluppata. Il grande pericolo nel secolo II non è soltanto fuori della Chiesa (cioè le varie<br />
ostilità accennate nel capitolo precedente=apologisti). C’è al di dentro il pericolo del<br />
caos e della lacerazione (eresiologi). Infatti varie correnti esoteriche sono di moda nella<br />
Trada Antichità. Ci sono in giro molte speculazioni occulte e dottrine segrete piene di<br />
misticismo. Fra queste correnti ci sono anche quelle che da una parte si ispirano a Gesù e<br />
al Vangelo e dall’altra mescolano con questa ispirazione cristiana tantissime speculazioni<br />
sull’aldilà che non hanno niente a che fare con la fede cristiana. Celso dice che i cristiani<br />
sembrano ranocchie petulanti che litigano tra loro nello stagno.<br />
La reazione naturale della Chiesa è il potenziamento della coesione interna, un<br />
consolidamento soprattutto su tre livelli:<br />
1. Una riflessione approfondita sul contenuto della fede (kerygma), che tende a<br />
stabilite i limiti dell’ortodossia, separandola dall’eterodossia. (NB.: Ortodossia significa:<br />
retta dottrina o opinione [da: orthòs + dòxa]; eterodossia significa: dottrina o opinione<br />
diversa, d’altro genere, poi “ingiusta” [da: èteros + doxa].)<br />
2. Una tendenza a prestare più attenzione alle strutture organizzative della<br />
Chiesa, fondate sul principio della successio apostolorum. Comincia a nascere una vera e<br />
propria Chiesa Universale (kath’holon = nell’insieme, interamente, universale; ecco il<br />
significato originale di cattolico).<br />
3. Lo sviluppo di una liturgia fissa per celebrare i grandi avvenimenti della vita<br />
cristiana come p. es. il battesimo, l’eucaristia e i ministeri.<br />
I Padri principali, le cui opere illustrano questo processo di consolidamento, sono Ireneo<br />
di Lione (ca. 180), per quanto riguarda il contenuto della fede, e (pseudo?) Ippolito di<br />
Roma, per quanto riguarda la liturgia. Ma prima dobbiamo prestare attenzione alle<br />
correnti eretiche del secolo II che hanno sfidato la Chiesa a stabilire più precisamente la<br />
sua identità sui vari livelli e che hanno influito sul processo di consolidamento.<br />
2. ERESIA ED ORTODOSSIA<br />
Che cosa è un’ “eretico” (haeres) nel secolo II? Non era ancora chiaro a<br />
quell’epoca. La parola deriva dal verbo haireomai, che significa scegliere, cioè fare una<br />
propria scelta invece di seguire l’insegnamento trasmesso autenticamente. Però proprio<br />
quest’ultimo non era ancora stabilito dettagliatamente nel secolo II, a prescindere dal<br />
kerygma fondamentale, che comprendeva anche alcuni punti dottrinali cui aderire (Dio<br />
creatore, incarnazione, passione, morte e risurrezione di Cristo). C’era molta libertà per<br />
“fare la propria scelta”. Pian piano la Chiesa, sfidata dal caos crescente, comincia a<br />
stabilire più precisamente l’insegnamento trasmesso fin dall’inizio ed anche i criteri<br />
dell’autenticità. Come si costituì tale criterio?<br />
Cfr. M. Simonetti, “Ortodossia ed eresia tra I e II secolo”, Vetera Christianorum<br />
29 (1992) 359-389:
Nel 1934 W. BAUER scrisse un’opera 1 su questo tema dando di fatto una nuova<br />
impostazione alla problematica ortodossia-eterodossia rispetto a quella che considerava<br />
l'eterodossia una deviazione dall'ortodossia. La sua idea era viziata ma l'impostazione base<br />
era giusta. Bauer sosteneva che nei primi tempi del cristianesimo ogni chiesa andasse per la<br />
sua strada, e solo con l’imporsi dell’egemonia romana, basata sulla testimonianza apostolica<br />
di Pietro e Paolo, si individuò nella conformità a questa Chiesa di Roma il concetto di<br />
ortodossia. Roma avrebbe pian piano imposto la sua interpretazione del messaggio primitivo<br />
come unica espressione della retta fede. Dunque l'eresia precede e non segue l'ortodossia.<br />
Si tratta però per Bauer di un concetto politico, sociologico: maggioritario. A prescindere<br />
dalla sua posizione (per un protestante come lui l’ortodossia è l’opinione della maggioranza)<br />
il problema posto dal Bauer è molto serio: l’eresia precede l’ortodossia? Molti credono che<br />
l’eresia sia una opinione di una minoranza, che, se diventa maggioranza, rende la sua<br />
dottrina ortodossa. [Cfr. commento Vang. Giuda, pp. 112ss.].<br />
Simonetti mostra che l’ortodossia non è una questione sociologica. Si è trattato di una<br />
progressiva presa di coscienza emergente già in Paolo. Hairesis significava originariamente<br />
scelta, divisione; anticamente vi venivano designate le scuole filosofiche. Poi con Paolo<br />
prende sempre più il significato di divisione e diventa negativo (Tit 3,10: colui che provoca<br />
dissensi). Per Ignazio significherà la vera e propria deviazione dottrinale, in senso tecnico.<br />
L'ortodossia va considearta nel divenire storico sotto due punti di vista 1. presa di coscienza<br />
del contrasto di alcune dottrine con altre che vanno respinte; 2. elaborazione di un corpus<br />
dottrinale comune.<br />
<br />
Hairesis: mondo filosofico, accezione ampia. Scelta quindi divisione, scuola filosfoica.<br />
At 5,17: sadducei e 15,5: farisei. “sètta”. Valenza non negativa.<br />
Paolo semrpe negativo: 1 Cor 11,10; Gal 5,20 la parola qui è equivalente di schisma.<br />
Cfr. hairetikos è colui che provoca dissensi e divisioni (1 Tt 3,10).<br />
Ignazio: definizione tecnica: deviazione dottrinale che comporta l'allontanamento dalla<br />
comunità Eph 6,2; Trall 6,1. Cfr. 2 Pt 2,1 qui forse senso tecnico (testo tardo).<br />
Nel primitivo cristianesimo c’erano varie correnti, le prime difficoltà si avvertirono nelle<br />
comunità paoline. I forti dissensi erano a causa dell<br />
- osservanza giudaica<br />
- opinioni su Cristo<br />
Mentre i giudei le sette facevano aprte della stessa struttura, i cristiani si pongono<br />
il problema della compatibilità della varietà di opinioni con l'appartenenza ad una<br />
comunità unica<br />
Galati 1,8-9 (54. d.C.): si tratta di due messaggi diversi, incompatibili.<br />
«se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi<br />
abbiamo predicato, sia anatema!». Anathema è la condanna solenne (=herem) con espulsione.<br />
1Cor 3,10-15 (57 d.C.): meno drastico; presenza di messaggi meno validi ma con<br />
comune fondamento in Cristo delle varie predicazioni; Forse si sentiva più diverso dai giudei<br />
che dai Corinzi? Coscienza maggiore della ramificazione del messaggio e fondate<br />
autorevolmente (esistenza di alcuni partiti che fanno dipendere la salvezza dal battezzante e<br />
non dal battesimo in sé). Tollera la diversità pro bono pacis.<br />
Fil 1,15-18: in prigione. Stesso att.to. C'è una predicazione contro Paolo ma cmq<br />
tollerata per il comune fondamento: “purchè Cristo sia predicato”. Tolleranza in materia<br />
dotrinale.<br />
1 Cor 5,1-5: in materia morale non è tollerante. Primo caso di scomunica formale<br />
(morale) per il caso di incesto. Non così sarà verso i suoi nemici (cfr. Fil 1,15-18 in materia<br />
dottrinale).<br />
Cfr. ambiente giudeocristiano Mt 5,19: non viene precluso il regno (tolleranza in materia<br />
di dottrina).<br />
Lettere pastorali: meno tolelranti a livello dottrinale; crisi organizzativa e dottrinale<br />
1Tm 1,10; 4,1. 6.13.16; 6,1.3; 1Tm 3,10.16; Tt 2,7.10; falsa dottrina<br />
(eterodidaskalein in 1Tm 1,3; 6,3). “didascalia” come insegnamento autentico o<br />
falso.<br />
1 BAUER W., Rechtgläubigkeit und Ketzerei in ältesten Christentum [BHTh 10], Tübingen 1934. Attorno a<br />
questo saggio si è concentrato l’incontro di Studiosi dell’Antichità cristiana del 1984: Eresia ed eresiologia<br />
nella Chiesa antica, in Augustinianum 25 (1985) 581-903.
Hugiainousa didaskalia: 1Tm 1,10; 2Tm 4,3; Tt 1,9; 2,1.<br />
1Tm 4,1 predicatori di dottrine errate (di origine demoniaca) che naufragano,<br />
prevaricano la verità (1Tm 1,19; 6,21; 2Tm 2,18) sono attaccati. Il vescovo deve allontanare<br />
l'airetikon anthropon (Tt 3,10). Richiamo al depositum fidei. In 1Tm 3,15, la Chiesa viene<br />
chiamata significativamente «colonna e sostegno della verità»:<br />
1 Tm 1,20: Imeneo e Alessandro “conseganti a satana” cfr 1 Cor 5,5 per fatti morali qui<br />
ora dottrinali.<br />
2Tm 2,18 ricorda i nomi di due eretici, Imeneo e Filéto, «i quali hanno già deviato dalla<br />
verità»<br />
Tito 3,10 per la prima volta si usa il termine airetikon anthopon (scomunica)<br />
Così il vocabolo passa dal significato originario (=appartenente ad una setta filosofica<br />
greca) a quello cristiano. Non c’è più tolleranza per la dottrina che non concorda con l’autore<br />
ma separazione e bisogna riprendere l’eretico o separasene (1Tm 1,20) Non si tratta ancora<br />
di una dottrina concernente la cristologia ma probabilmente le osservanze giudaiche. Non<br />
più tolleranza ma separazione. Dottine giudaizzanti o gnosticizzanti (encratismo).<br />
Ap 2 Nicolaiti che compaiono spesso nel libro (Ap 2,6.15). Contro di essi la Chiesa<br />
opera già una resistenza attiva. Ma non si capisce la natura del problema; Nicolao cfr At 6,5<br />
(uno dei sette), proselita di Antiochia.<br />
Ap 2,20-21: profetessa di Tiatira: esortazione al ravvedimento (lo scisma non è<br />
definitivo); problema degli idolotiti= osservanza.[tradizione giovannea vs tradizione paolina?]<br />
Giovanni presbitero: problema cristologico che spacca la comunità (ambito di crist.<br />
alta)<br />
cristologia bassa (nudus homo), cristologia angelica (cfr. Eb 1 e Ap 19,10; 22,8-9),<br />
cristologia alta: fino alal fine del sec le concezioni coesistono<br />
inizio di cristol. Docetista (2 Gv 1,7=> 1 Gv 4,2)<br />
Gv 6,66: «Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui»<br />
Qui si ritrovano lo stesso confronto con i docetisti:<br />
la comunità di Giovanni era tanto<br />
convinta della divinità di Cristo, da trascurarne l’umanità;<br />
separazione: 1 Gv 2,19 (scissione)<br />
1Gv 2,18-20. Compaiono dei personaggi in cui possiamo vedere degli eretici, usciti di<br />
mezzo a noi senza essere dei nostri: c’è stata scissione:<br />
«Figlioli, questa è l’ultima ora. Come avete udito che deve venire l'anticristo, di fatto ora molti anticristi sono<br />
apparsi… Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri; se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti<br />
con noi; ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete l'unzione ricevuta dal<br />
Santo e tutti avete la scienza»<br />
2Gv 1,7: «Poiché molti “anticristi”…», che sta per “eretico”<br />
3Gv 9-10. Ora lo scisma è completo: si tratta di una dottrina falsa, e non di un semplice<br />
errore; c’è perseveranza nell’errore che causa lo smembramento dalla comunità di un<br />
gruppo, dove l’errore diviene bandiera del gruppo dissidente.<br />
«Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diòtrefe, che ambisce il primo posto tra loro, non ci vuole<br />
accogliere. Per questo, se verrò, gli rinfaccerò le cose che va facendo, sparlando contro di noi con voci<br />
maligne. Non contento di questo, non riceve personalmente i fratelli e impedisce di farlo a quelli che lo<br />
vorrebbero e li scaccia dalla Chiesa».<br />
Ignazio: gnosi + usanze giudaizzanti:<br />
Smyr 1-3; Magn 8-10; Eph 7,1; 16,2; Philad 6,1<br />
hairesis: senso tecnico Trall 6,1-2<br />
eterodoxein: Smyr 6,2<br />
eterodoxia: Magn 8,1<br />
(l'uso di orthodoxein/orthodoxia inizia con Eusebio; ma prima c'è già “retta fede; dottrina,<br />
pietà”)<br />
separazione: Eph 8,1, anche liturgica (Eph 7,1)<br />
La chiesa arriva molto presto a capire la necessità di allontanare le dottrine erronee (il criterio della<br />
qualità della dottrina prevaleva sulla quantità delle persone). Clima di lotta e conflittualità<br />
interna.<br />
Impossibilità di sostenere le pluralità di opinioni=> slittamento di significato di hairesis da positivo a<br />
negativo.<br />
Contenuto consistente e accettato da tutti (?)<br />
Clemente: Cristo incarnato e funzione soteriologica (1 Clem 7,4; 36,2); pais (in<br />
36,4 huios è citazione); mai definito Theos.
Erma: Cristo = huios preesistente (Sim 9,12,2-3) ma cristologia angelica (Vis<br />
5,2; Sim 7,1; 8,12; 8,4,1; 9,1,3; distingue Figlio da Gesù (Sim. 5,5-6). Non è mai<br />
definito Theos.<br />
= tradizione giudaizzante che si disinteressa alla preesistenza (Clemente) e qundo lo fa è<br />
confusa per non mettere in discussione il monoteismo (Erma). Assenza del tema<br />
geiovanneo di Cristo-Logos (clemente potreva non consocerlo ma Erma no, perchè<br />
armonizza male tanti dati che ha).<br />
Ignazio: linea paolina e giovannea di cristologia alta. I giudaizzanti sono per lui<br />
eretici. (eph 7,2; Magn 8,2); Cristo è theos e ho theos (Smir 1,1).<br />
Mentre Clemente ed Erma considerano AT ancora normtivo Ignazio se ne disinteressa<br />
(Smyrn 5,1-2; Magn 8-9; Philad 5,2; la fede in Cristo non deve essere confermata dall'AT:<br />
Philad 8,2).<br />
Su Dio Padre: Clemente ed Erma = Dio creatore (Mand 1,1), padre del creato, di<br />
tutte le cose; pater hupsistos; Per Ignazio è soprattutto padre di Cristo (Magn 8,2; Eph<br />
17,2). Di comune hanno solo l'unicità di Dio e l'azione mediatrice di Cristo. Centri<br />
importanti della cristianità e scritti ufficiali.<br />
Non possiamo ancora parlare di ortodossia: il contenuto non è consistente e le<br />
linee divergono tra le comunità (non accettate da tutti). Ciascuna comunità identifica la<br />
retta dottrina con la propria.<br />
144: condanna di Marcione (Tertull, Marc I,19,2-3). Ruolo importante per la<br />
elaborazione e la chiarificazione dell'ortodossia cattolica. Canone scritturistico e<br />
organizzaizone ecclesiale.<br />
1. Nessuno aveva pensato a riunire queste gli scritti che sarebbero confluiti nel<br />
NT che che sileggevano nelle liturgie in un corpus unitario della stessa autorità<br />
dell'AT. In un periodo in cui i cattolici si servivano di scritti la cui diffusione era<br />
saltuaria, occasionale e la cui autorità avallata solo da qualche comunità di rilievo<br />
o dal contenuto, l'iniziativa di Marcione è genale<br />
2. Una volta rotti i rapporti, Marcione accorpa i suoi in una organizzazione vasta e<br />
capillare modellata su quella cattolica: vescovi, preti, diaconi. Un gruppo<br />
compatto. Cfr. Ireneo, Adv Haer I,27,1: “...Non ci sarà salvezza, egli dice ancora,<br />
se non per le anime che saranno state educate nella sua dottrina”.<br />
Un tale movimento di tale protata sollecitava una risposta cattolica di carattere altrettanto unitario<br />
e uno strumento analogo<br />
Anche vs gnostici (e i montanisti) la chiesa reagì: in campo teologico con una argomentazione<br />
che unisse Dio giusto e buono unico creatore;in campo antropologico vs determinismo<br />
gnostico; in campo della Rivelazione con la dottrina della progressione e storia della salvezza<br />
(tipologia; esempi di AT; AT annuncia messianicità in paolo ma nei padri Cristo approva AT).<br />
Condanna della cristologia bassa e adozionista.<br />
Alla fine del II sec si può iniziare a parlare di ortodossia. Emerge la regola della fede (compendio<br />
dottrinale di una comunità alla base del simbolo) con punti sostanziali : unicità di Dio At-Nt;<br />
divinità di Cristo, reale corporeità, trinità, soteriologia, libertà dell'uomo, retribuzione finale.<br />
Tale ortodossia è un processo come risultato ad una attività eretica di ampio<br />
raggio.
Da questa carrellata ricaviamo una “definizione” di eresia: non è solo un<br />
errore teologico, ma soprattutto l’atteggiamento di chi fa della sua opinione<br />
teologica non condivisibile una bandiera per distaccarsi dalla chiesa. C’è quindi<br />
una ribellione ed una pertinacia nell’errore. Oltre a ciò, la storia dimostra come ci<br />
siano state uscite dalla Chiesa dovute sia ad una “fuga in avanti” teologica che ad<br />
un’incapacità di accettare gli sviluppi della fede (es.: i giudeocristiani).<br />
Ignazio: hairesis, ha oramai significato tecnico; due comunità separate x<br />
motivi teologici<br />
Sull’altro versante, l’ortodossia è data dalla convergenza di vari criteri che<br />
concorrono a definire l’esistenza della koinonia. Questi criteri sono fondati nel NT e<br />
vennero usati dai Padri nel giudicare la rettitudine delle varie dottrine.<br />
conformità nel kerygma e nell’omologia;<br />
conformità al dato scritturistico;<br />
conformità nel<br />
depositum fidei;<br />
presto regula fidei e<br />
poi i Simboli<br />
prenderanno questo<br />
posto;<br />
riferimento<br />
all’autorità apostolica<br />
(poi anche i Concili).<br />
congruenza<br />
dell’appello alla<br />
ragione;<br />
congruenza con il<br />
dato della lex orandi;<br />
le confessioni di fede<br />
hanno il loro contesto<br />
nella celebrazione e nella preghiera.<br />
appello alla<br />
ragione<br />
Lex orandi<br />
kerigma<br />
appello<br />
allo Spirito<br />
Ortodossia<br />
liceità dell’appello allo Spirito (discernimento dei carismi e degli spiriti);<br />
conformità al sensus fidelium;<br />
Ireneo fece appello anche alla Chiesa di Roma, dove è stata conservata la verità<br />
da qui sunt ubique. In quella Chiesa confluivano fedeli da tutta la cristianità; quindi,<br />
anziché mendicare la verità in tutte le Chiese, basterà far riferimento a Roma, che<br />
rappresenta l’universalità. «In ipsa item catholica ecclesia magnopere curandum<br />
est, ut quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est» 2 ; così si elevano<br />
a criteri di ortodossia l’universalità, l’antichità, l’unanimità.<br />
3. MONTANISMO<br />
Risposta come fuga dal mondo.<br />
Montano, di origine Frigia, è attivo attorno al 155-160, si propone di essere l’incarnazione<br />
del Paraclito, promesso dal quarto Vangelo (Gv 14,26; 16,7). Non si è mai proposto di<br />
intaccare i criteri di interpretazione della Scrittura né certi punti della dottrina (in campo<br />
dogmatico non sono eretici ma per questo fu difficile per la chiesa attaccarlo). Si inserisce<br />
all’interno della chiesa ma esige un rinnovamento e un risveglio spirituale, soprattutto<br />
ravvivando una forte attesa escatologica che era venuta affievolendosi, predicando un<br />
rigorismo morale e un ascetismo intenso (encratismo: divieto del matrimonio, verginità<br />
obbligatoria).Viene perfino incoraggiato il martirio (sulla base di Ap 21,1.10). In questo<br />
movimento si dà grande importanza al fenomeno del profetismo estatico (“Nuova<br />
2 VINCENZO DI LÉRINS, Commonitorium II, 5: CCL LXIV, 149,24-26.<br />
appello alla<br />
Scrittura<br />
Regula fidei<br />
αυτοριτ<br />
apostolica<br />
sensus fidelium
Profezia” è il nome di questo movimento) con la glossolalia (At). Negano ogni autorità<br />
ecclesiastica perché Cristo e lo Spirito santo parlano per mezzo loro, accanto a lui vi<br />
erano della donne Priscilla e Massimilla che profetizzavano. Qui emerge il problema di<br />
una rivelazione continua (cfr. DV 8 e 13): si deve cioè considerare l’ispirazione come una<br />
nuova rivelazione o come una possessione demoniaca (glossolalia)? Montano diceva di<br />
essere superiore alle S.Scritture (ispirazione?), perché parlava con l’autorità dello Spirito<br />
chiedendo obbedienza assoluta e quindi arrivando a negare ogni autorità ecclesiastica (se<br />
lo Spirito parla tramite Montano non c’è bisogno di gerarchia). Dopo il 179 e la morte di<br />
Massimilla, si acuì l’ascetismo (le guerre sotto Marco Aurelio davano il senso della fine<br />
del mondo). Ma non arrivando la fine del mondo il movimento implode.<br />
Questo comportò la reazione della chiesa cattolica che dovette riflettere sulle sue strutture<br />
e sull’organizzazione comunitaria; ne seguì l’irrigidimento della gerarchia e<br />
dell’obbedienza (con la convocazione dei primi sinodi la scomunica e riduzione a sétta e<br />
contraccolpo sul ruolo delle donne). A fatica si riuscì a circoscrivere il fenomeno (molto<br />
popolare) alle zone di origine. (Eusebio li chiamerà catafrigi, cfr. V,14-19 e userà una<br />
terminologia tendente a sminuirli: “connette”; Tertulliano vi aderì dal 207).<br />
4. GNOSTICISMO<br />
Risposta come adattamento al mondo.<br />
Lo gnosticismo fu il fenomeno esplosivo e vario che diede maggior filo da torcere alla<br />
Chiesa del sec. II. Per questo, rispetto alle altre eresie dell’antichità (montanismo e<br />
marcionismo), ci è giunta una buona documentazione, grazie alla produzione degli<br />
gnostici stessi (che immaginiamo abbondante), e alle opere degli antichi eresiologi, che<br />
si sono dimostrate attendibili, soprattutto in quanto citano le opere degli avversari.<br />
Nel dicembre del 1945 Muhammad ‘Ali al-Samman Muhamma Khalifah scoprì,<br />
nei pressi di Nag Hammadi, una collezione di 13 codici papiracei con 53 brevi<br />
trattati in copto di cui 41 opere a noi sconosciute. Questa scoperta, pur<br />
arricchendo le nostre conoscenze, non le ha proprio rivoluzionate.<br />
Lo gnosticismo inizia ad apparire come sistema verso il 120 dC; nel giro di 60<br />
anni divenne un fenomeno universale; e si contavano infiniti sistemi. La salvezza<br />
dell'ortodossia può essere considerata un miracolo. Gnosi (qualunque conoscenza<br />
elitaria dei misteri divini) / Gnosticismo (particolare concretizzazione storica della<br />
gnosi, quella che si verificò nel corso del II e III secolo, di matrice cristiana).<br />
Per circa 50 anni la Chiesa non si accorse di questo fenomeno a causa della<br />
natura stessa di segretezza del movimento. Nella Roma di papa Vittore c’era una<br />
moltitudine di sette gnostiche di cui neppure i vescovi ne avevano perfetta<br />
coscienza; fu Ireneo a suonare l’allarme: sotto quelle dottrine c’era un’altra<br />
religione. Cercano di evitare los contro diretto, si sentono infatti la parte eletta della<br />
stessa chiesa, sono quindi più difficili da smascherare. Spesso ricchi e molto<br />
collegati tra loro.<br />
Parlando di gnosticismo ci troviamo di fronte a numerose sétte, popolari o intellettuali<br />
sempre divise tra loro<br />
La risposta cattolica ha di geniale il fatto di riuscire a mettere in evidenza il loro sfondo<br />
comune:<br />
«… un dualismo che implica all’origine una frattura verificatasi nel mondo divino.<br />
Da tale frattura, vista per lo più come divisione sessuale di un’originaria unità<br />
androgina e spiegata attraverso un mito più o meno elaborato, è derivata la<br />
creazione del mondo a opera di un Dio inferiore (il demiurgo, Dio del Vecchio<br />
Testamento) e l'imprigionamento in esso di particelle divine decadute e incorporate in<br />
alcuni uomini, che perciò risultano consustanziali alla divinità. La reintegrazione di
queste particelle nel mondo divino si ha per mezzo di una rivelazione apportata per<br />
lo più da un redentore celeste, che per questo discende nel mondo» 3 .<br />
È prevalente l’uso di un linguaggio mitico sotto il quale si trova un sistema di<br />
fortemente organizzato: nello gnosticismo possiamo ravvisare una prima<br />
sistemazione organica del dato rivelato; ad essi va riconosciuto il merito di aver<br />
iniziato lo studio sistematico della Scrittura. Gli gnostici furono i primi “maîtres à<br />
penser” del cristianesimo.<br />
“Non è solo il lavacro a liberarci ma anche la conoscenza: chi siamo e che cosa<br />
siamo diventati; dove siamo, dove siamo stati precipitati; dove tendiamo, donde<br />
siamo purificati; che cosa è la generazione, che cosa la rigenerazione”. (Excerpta ex<br />
Theodoto. 78, 2) 4<br />
Alla base c’è una concezione dualistica e negativa del mondo materiale,<br />
ridotto a sepolcro del genere umano. Lo gnostico è un uomo che si sente alienato<br />
nel mondo materiale che lo circonda, straniero in un mondo che deve trascendere.<br />
Confluisce in questo sentire il sentimento di angoscia del mondo ellenistico:<br />
l’individuo si sentiva sempre meno padrone del proprio destino, soggetto a forze<br />
(spesso astrali) ineluttabili; e quindi cerca nell’appartenenza religiosa una<br />
«salvezza».<br />
Antropologia: lo gnostico riconosce in sé una scintilla divina, separatasi dal<br />
plhrwma divino e decaduta nella materia, dove languisce in letargo. Il Salvatorerivelatore<br />
risveglia la scintilla tramite la gnwsij di questo stato di cose: tale<br />
conoscenza procura allo gnostico la salvezza, qui potenziale per divenire definitiva<br />
dopo la liberazione dal corpo.<br />
Il rivelatore viene nel mondo sotto apparenze umane: di solito autore di questo<br />
insegnamento è il Cristo Risorto che, in un periodo più lungo dei 40 gg “canonici”<br />
tra la risurrezione e l’ascensione, comunica ad alcuni discepoli questa conoscenza<br />
di tipo superiore, che poi viene trasmessa per via esoterica.<br />
Il Salvatore non è sempre Cristo: qualche volta è una voce dal cielo; altre<br />
volte la Sapienza (femminile): è comunque qualcuno o qualcosa venuto dall’aldilà<br />
per risvegliare gli uomini pneumatici, dare loro la retta conoscenza.<br />
Quanto al corpo di Cristo o si segue la linea docetista (dotato di un corpo<br />
immateriale), oppure si dice che Cristo è un essere celeste disceso su Gesù al<br />
Giordano e ritornato in cielo prima della passione. Comunque si distingue il Cristo<br />
da Gesù.<br />
Nella rivelazione si inserisce la spiegazione mitica della caduta: nel plhrwma si<br />
ha una ricca generazione di entità che si “decentrano”, fino alla crisi, ad una<br />
frattura dell’originaria unità androgina di cui è generalmente responsabile<br />
un’entità femminile.<br />
A questo punto subentra una sostanza intermedia, un Dio ribelle, un<br />
demiurgo, comunemente identificato con il Dio dell’AT.<br />
La pienezza dell’essere compete al Dio sommo. Nel plhrwma si hanno però<br />
delle emanazioni: gli eoni (maschio e femmina) che potrebbero essere da noi riletti<br />
come personificazioni degli attributi di Dio. Man mano che ci si allontana dalla<br />
coppia primigenia gli eoni perdono in forza di essere e in potenza di intelligenza:<br />
per cui il peccato di Sofia avviene in uno stato di ignoranza (anche questo<br />
concetto è tipicamente greco).<br />
In quasi tutti i sistemi gnostici non si ammette una creazione immediata da<br />
parte di Dio, ma questa viene deputata al demiurgo (considerato un “aborto” del<br />
plhrwma) o agli angeli. Comunque così viene salvata la trascendenza del Dio<br />
3 SIMONETTI M., Testi gnostici…, cit., p. XXIV.<br />
4 M. Simonetti, Testi gnostici, pp. 390-393.
sommo, come pure viene data ragione della presenza del male nel mondo, dovuto<br />
all’incompetenza del demiurgo.<br />
Il “peccato originale” non è imputato all’uomo, così totalmente<br />
deresponsabilizzato, ma ad una ribellione avvenuta nel plhrwma. Anche la<br />
punizione per il peccato viene scontata da Sofia che viene frantumata e le<br />
scintille della sua luce disperse nella materia. La «grande Chiesa» contestò proprio<br />
questa deresponsabilizzazione etica, che scaricava il problema del male nelle mani<br />
del demiurgo; inoltre la divisione dell’umanità in gruppi di cui alcuni predestinati alla<br />
salvezza (con una condizione non-morale: la gnwsij) e altri alla dannazione.<br />
Prevalentemente la salvezza è un fatto elitario: pochi uomini sono in<br />
possesso della scintilla del divino (il pneuma); alcuni altri uomini (gli yuxikoi\,<br />
assimilabili ai cristiani comuni) sono in possesso di un seme divino di secondo<br />
ordine e per loro è riservato un ricupero di grado inferiore; per la maggioranza degli<br />
uomini però l’esito finale sarà la dissoluzione nella morte (sono gli ulikoi\).<br />
Gli uomini sono divisi in tre categorie: gli ilici (materiali), gli psichici (la psyché<br />
è la potenza che trattiene il pneuma nel corpo), i pneumatici (gli gnostici stessi, che<br />
possiedono in sé un frammento del pneuma). La rottura dell’unità androgina e<br />
l’intervento del demiurgo hanno racchiuso in questi ultimi una scintilla di luce<br />
divina; essi non appartengono al mondo, ma vi sono stati gettati: in particolar modo<br />
gli gnostici hanno un pneuma divino, sono anime in esilio che tendono a ritornare<br />
nel plhrwma: la salvezza è il ritorno nel plhrwma, la liberazione dalla materia.<br />
Bene e male sono solo categorie corrispondenti alla conoscenza o<br />
all’ignoranza.<br />
Il disprezzo della materia porta ad alcuni estremismi di licenziosità<br />
(presunta? la materia non influisce sulla vita spirituale e quindi non è una categoria<br />
morale) o di encratismo, soprattutto per quanto riguarda il matrimonio.<br />
Usano una sfrenata allegoria nella lettura del NT e anche dell’AT. Sono di fatto<br />
i primi esegeti cristiani. Rifiuto dell’AT o parziale accettazione con lettura allegorica.<br />
Per quanto riguarda il NT, si fondano sulla solita distinzione tra Gesù (che ha<br />
annunciato le poche dottrine esoteriche note a tutti i cristiani) e il Cristo risorto, i<br />
cui numerosi dialoghi con gli apostoli vengono riportati nei vangeli (“apocrifi”:<br />
Vangelo di Verità, Vangelo di Filippo…), dove sono rivelati i misteri nascosti. Questi<br />
avrebbero quindi predicato due dottrine: una essoterica per la «grande Chiesa» e<br />
una esoterica per gli gnostici.<br />
A questo si aggrappa la confutazione di Ireneo: esiste una sola tradizione<br />
nella Chiesa, quella pubblica, quale è accertata nella successione episcopale<br />
Gli gnostici non conoscono una Chiesa (spesso il nome ekklhsia è solo il<br />
nome di un eone), ma soltanto dei gruppi: la Chiesa in terra è al massimo la S dei<br />
pneumatikoi\, che essi chiamano anche «casa del Padre».<br />
Differenze col cristianesimo<br />
Ma quali sono le differenze con le correnti gnostiche a questo proposito?<br />
Passiamo in rassegna le caratteristiche comuni dei vari sistemi gnostici che sono<br />
incompatibili con il vero e proprio messaggio cristiano.<br />
1. Gli gnostici rivendicano una conoscenza “segreta”, che sarebbe stata trasmessa<br />
da Gesù oralmente, accanto al messaggio pubblico del Vangelo scritto, in un secondo<br />
momento, quando i discepoli avrebbero ricevuto un’ulteriore rivelazione più esclusiva,<br />
che sarebbe riservata a un piccolo gruppo di “eletti”. Il cristianesimo invece non conosce<br />
tale esclusivismo: l’annunzio evangelico, fondamentalmente completo, è per tutti.
2. Le speculazioni gnostiche si caratterizzano da un disprezzo assoluto del mondo<br />
materiale incluso il nostro corpo. Infatti una dualità fra il mondo invisibile spirituale e il<br />
mondo visibile materiale viene assunta da tutta la tradizione filosofica ellenistica, e la<br />
troviamo, fino ad una certa misura, anche nel NT e nel pensiero dei Padri della Chiesa.<br />
Però nelle correnti gnostiche questa dualità (cioè distinzione) diventa un dualismo<br />
assoluto (cioè spaccatura). Il mondo materiale è un male, corruttibile e solo apparenza e<br />
vanità; è il mondo delle tenebre destinato a perire. L’uomo caduto è incarcerato nel corpo<br />
e se non si liberi da queste catene tramite la conoscenza segreta, perirà con esso. Il mondo<br />
spirituale invece è incorruttibile e l’unica verità; è il mondo della luce, origine e<br />
destinazione degli eletti che verranno salvati. Risposta ortodossa: Unità dell’essere<br />
umano. Da questa visione seguono altre incompatibilità con la fede cristiana, per quanto<br />
riguarda la concezione di Dio e la creazione, e quella dell’umanità e la salvezza.<br />
3. Se il mondo materiale è un male, la sua esistenza è la conseguenza di un errore.<br />
Il Dio perfetto, inaccessibile e immutabile secondo il pensiero filosofico ellenistico, non<br />
può aver creato quel mondo materiale. E’ l’opera di un dio inferiore e molto imperfetto, se<br />
non cattivo: il demiurgo (dhmiourgovς = creatore). Secondo la prima pagina dell’AT<br />
invece, Dio stesso ha creato il cielo e la terra e ha visto che tutto era buono.<br />
4. Gli gnostici però staccano il Dio dell’AT (cioè il YWHW degli ebrei) dal sommo<br />
Dio, Padre di tutti gli intelligibili che sta all’origine del mondo luminoso; sarebbe quello<br />
che Gesù ha chiamato “Abbà”, rivelando agli “iniziati” un’unico e vero Dio totalmente<br />
nuovo. Con questo gli gnostici rifiutano l’AT e non accettano, come fanno i cristiani, la<br />
fondamentale unità e continuità fra l’AT e il NT. (Questo punto gli gnostici hanno in<br />
comune con i seguaci di Marcione, un’altro eretico del secolo II).<br />
5. Per quanto riguarda l’umanità e la salvezza, l’ideale gnostico della realtà<br />
escatologica è un mondo completamente immateriale. All’inizio siamo stati degli esseri<br />
razionali senza corpi, ma solo una mente (nous). Poi, a causa di una caduta primordiale,<br />
siamo stati incarcerati nei corpi materiali; ogni corpo contiene una piccola scintilla del<br />
mondo luminoso che va liberata. Il corpo però non parteciperà nella salvezza: sparirà con<br />
il mondo materiale. Il cristianesimo invece confessa la risurrezione del corpo.<br />
6. La liberazione della particella luminosa si realizza tramite la vera conoscenza<br />
che, come abbiamo visto, è segreta e riservata ai pochi “eletti”. Essi sono predestinati a<br />
salvarsi, la stragrande maggioranza dell’umanità invece è predestinata alla perdizione.<br />
Anche questo determinismo è incompatibile con il messaggio cristiano, secondo il quale<br />
la salvezza, principalmente aperta a tutti, viene realizzata tramite la giusta cooperazione<br />
della libera volontà umana con la grazia divina.<br />
NB. Abbiamo dovuto semplificare un po’ in questo breve sommario. La popolarità delle<br />
correnti gnostiche va spiegata da tutto il contesto religioso-culturale dell’epoca e si<br />
potrebbe paragonarla a quella del New Age nel nostro tempo.<br />
5. MARCIONISMO<br />
Risposta come fuga dal mondo.<br />
Marcione passa alla storia per aver provocato il primo scisma nella storia del<br />
Cristianesimo nel 144: la sua chiesa dei marcioniti (basata come vedremo proprio su una<br />
accettazione diversa, non canonica dei vangeli) organizzata e strutturata, ebbe il suo<br />
massimo splendore durante il papato di Aniceto (155-166), e continuò, con una certa<br />
risonanza, fino al VI secolo, soprattutto nella parte orientale dell'impero.<br />
Le fonti degli oppositori, dicono Marcione originario di Sinope (Turchia).<br />
Scomunicato dal padre, vescovo di quella comunità, dopo aver fatto fortuna come<br />
armatore, sarebbe stato accolto dalla comunità di Roma che omaggiò di un
consistente donativo. Ma nel 144 venne nuovamente scomunicato e il dono gli<br />
venne restituito. Unico tra gli gnostici, fondò una chiesa (parallela) modellata su<br />
quella cattolica (con delle sacerdotesse), che si espanse molto fino al 190 e<br />
resistette fino alla fine del III sec.: poi la sua istanza sembra assorbita nel<br />
manicheismo.<br />
Voleva riportare la Chiesa al messaggio di Cristo che riteneva ormai travisato<br />
dalla Chiesa: la redenzione che Dio ha realizzato per pura misericordia. È questo<br />
il Dio Padre di Gesù buono rivelato da Cristo nel NT, Salvatore, che si esprime nel<br />
vangelo; distinto dal dio creatore dell’AT, vendicativo che si esprime nella Legge,<br />
Giudice,<br />
Di qui il rifiuto dell’AT, in un’impostazione di base diteista: da una parte pone il Dio<br />
giusto, il Dio dei Giudei, il protagonista e l’autore dell’AT; è necessario liberarsi dal<br />
potere di questo demiurgo.<br />
Compose anche un particolare canone neotestamentario (il primo!) (l’euaggelion e<br />
l’apostolikon), che comprendeva brani scelti del vangelo di Luca e di 10 lettere paoline<br />
(Gal, 1-2Cor, Rm, 1-2Ts, Ef = Laod, Col, Fil, Fm). Su questi testi fa un enorme lavoro di<br />
epurazione (nessuna aggiunta!) per espungere le interpolazioni «giudaizzanti». tutte<br />
quelle parti delle Lettere Paoline, o dei Vangeli in cui vi erano troppi riferimenti all'Antico<br />
Testamento.<br />
Tali libri correvano tra i cristiani da tempo ma nessuno mai li aveva riuniti<br />
ancora in un corpus. (cfr. Simonetti, Ortodossia ed eresia, 376) E’ il primo critico<br />
biblico e concorre alla chiarificazione interna della chiesa. Giustificò il suo canone<br />
nelle cd. Antitesi che sono la sua opera più indicativa.<br />
La sua cristologia sembra essere vicino al docetismo: Cristo muore<br />
veramente, ma non nel suo vero corpo. Il suo sangue non redime dal peccato,<br />
quanto dalla potenza del demiurgo. La morte gli ha dato l’opportunità di scendere<br />
ad annunciare la misericordia del Dio buono anche agli inferi.<br />
Chi crede viene liberato dalle angustie del legalismo.<br />
Quanto all’etica esigeva una rigorosa ascesi che comportava perfino<br />
l’astensione dal matrimonio, al fine di non far continuare il mondo decaduto del<br />
demiurgo.<br />
Ha in comune collo gnosticismo un dualismo esasperato, ma mentre lo<br />
gnosticismo è antistorico, il marcionismo è storico-biblico. Marcione è uomo<br />
d’azione che organizza una chiesa visibile in contrapposizione a quella cattolica,<br />
mentre la gnosi resta invisibile anche all’interno della chiesa ufficiale.<br />
<br />
6. IL CANONE: QUALE ?<br />
Come si è formato il Canone dei quattro vangeli che conosciamo? Chi ha scelto proprio<br />
quelli, a scapito degli altri che oggi definiamo 'apocrifi', tra cui il tanto reclamizzato<br />
'Vangelo di Giuda'? Come si è scelto? In base a quali criteri? Siamo sicuri che i Vangeli<br />
'canonici' corrispondono proprio alle vere parole di Gesù ?<br />
Sia i 4 vangeli che le lettere paoline hanno goduto di autorità di scritti ispirati fin da molto<br />
presto già tra gli gnostici.<br />
Il canone è attestato alla fine del II sec. Per i libri fondamentali. Ce lo testimoniano Ireneo<br />
e il frammento muratoriano e poi Clemente e Tertulliano.<br />
In questo grande calderone, NON con un solo gesto autoritario, come si crede, ma certo<br />
con una gestazione laboriosa nel tempo si è andato formando il limite di questo Canone,<br />
che oscillava su alcuni scritti più marginali (epistole cattoliche, Apocalissi Ebrei), da<br />
comunità a comunità fermo restando un nucleo che si è venuto a consolidare molto presto<br />
(fine II sec.) .
Nel II sec. circolavano molti Vangeli, Atti, Epistole, Apocalissi; solo 27 furono inclusi<br />
nel Canone del NT, assumendo la stessa autorità dell’AT. Di fronte al problema,<br />
bisognò riflettere a quali testi veicolavano la fede anche coscienti che era nella<br />
tradizione viva che bisognava leggere le stesse Sacre Scritture. Siamo all'oscuro<br />
sui criteri di selezione, le sedi e i personaggi intererssati a quest'opera. I criteri di<br />
scelta che possiamo reperire sono:<br />
Apostolicità (antichità). Non è un criterio teologico, ma un theologoumenon.<br />
Non chiede che uno scritto sia materialmente opera di un Apostolo, ma che<br />
provenga dalla sua cerchia. Anche degli scritti pseudoepigrafici furono accettati<br />
(es: 2Pt) perché provenienti dall'entourage di un Apostolo. Sono chiarissimi i casi di<br />
Marco e Luca. Il criterio dell’autorità apostolica appare anche in alcuni episodi<br />
dell’età patristica:<br />
Clemente di Roma parla di una trasmissione della verità da Gesù agli apostoli<br />
e da questi a «noi» (i presbiteri della comunità cristiana): essi sono eredi<br />
dell’autorità apostolica e predicano il Vangelo; usano con autorità le parole di Gesù.<br />
Ignazio, che cita qualche passo neotestamentario, valuta molto il ruolo del<br />
vescovo proprio perché depositario dell’autorità degli apostoli.<br />
La Didaché sottolinea molto l’autorità degli apostoli e dei profeti<br />
neotestamentari.<br />
Barnaba offre una lista di testimonia del NT<br />
Gli gnostici stessi pongono i loro insegnamenti sotto il nome di un apostolo,<br />
pur in tradizione segreta.<br />
Lettura pubblica liturgica. Non furono accolti libri destinati alla lettura privata<br />
o segreta.<br />
Viene rifiutata però la pseudoepigrafia degli scritti “segreti” (cfr. i vangeli<br />
gnostici).<br />
Lettura pubblica liturgica universale (universalità). Significa che gli scritti<br />
venivano letti o nelle Chiese maggiori (Roma, Alessandria, Gerusalemme,<br />
Cartagine...) o in un ampio numero di Chiese, rilevante geograficamente. La<br />
diffusione degli scritti avveniva a partire dalle comunità che li avevano generati o,<br />
nel caso delle lettere, alle quali erano stati destinati. La forte mobilità dei cristiani<br />
faceva sì che uno scritto autentico venisse poi diffuso anche in altre Chiese.<br />
Vi furono scritti sui quali la discussione fu più lunga e complessa<br />
(“deuterocanonici del NT”): Gc, 2Pt, Ebrei, 2-3Gv, Ap. L’autorità di Agostino e<br />
Atanasio li ha assicurati alla venerazione di tutte le Chiese.<br />
Il grande assertore di questo criterio fu Agostino:<br />
«Riguardo pertanto alle Scritture canoniche si comporterà così: quelle che sono<br />
accettate da tutte le Chiese cattoliche le preferirà a quelle che da alcune Chiese<br />
non sono accettate; in quelle che non sono accettate da tutte preferirà quelle che<br />
sono accettate dalle Chiese più numerose e autorevoli a quelle che sono accettate<br />
dalle Chiese di numero inferiore e di minore autorità. Se poi succedesse che<br />
alcune sono ritenute autentiche da più Chiese mentre altre da Chiese più<br />
autorevoli, sebbene questo caso non si possa risolvere con facilità, io riterrei che le<br />
si debba considerare tutte di pari autorità» (De doct. Chr. II,8,12).<br />
E Girolamo: «Bisogna dire che questa lettera indirizzata agli Ebrei, è attribuita<br />
all’apostolo Paolo non solo dalle Chiese di Oriente, ma da tutti gli scrittori<br />
ecclesiastici di lingua greca finora vissuti, benché non siano pochi quelli che la<br />
ritengono di Barnaba o di Clemente. Del resto la questione dell’autore non ha<br />
importanza, dal momento che si tratta di una lettera di un uomo di Chiesa, usata<br />
ogni giorno per la lettura pubblica nelle Chiese» (Lettera a Dardano = Ep. 119)<br />
Dottrina (unanimità): non devono contraddire la regula fidei (i punti sommari<br />
da credere, redatti per il catecumenato), che precede il NT e costituisce il criterio di<br />
giudizio. Anche nell’AT il messaggio di un profeta era vagliato dal verificarsi delle
sue predizioni, ma soprattutto dalla continuità del suo messaggio con la fede<br />
jahwista. Ci furono dunque difficoltà ad accettare l’Apocalisse (sospettata di<br />
millenarismo), 2-3Gv (brevi e poco diffuse nelle Chiese) e Gd (perché citava un<br />
apocrifo).<br />
Dobbiamo però ammettere anche altre motivazioni a noi forse non note.<br />
Quando alle sedi forse Roma, Asia, Alessandria;<br />
Tra i personaggi, Ireneo che è il primo testimone forse potrebbe aver avuto<br />
aprte (tra Asia, Roma e Gallia).
IRENEO DI LIONE (CA. 130/140-200 ?)<br />
Vita<br />
Nato probabilmente intorno al 135-140 vicino a Smirne, in Oriente, Ireneo ebbe come<br />
maestro il vescovo di questa città, Policarpo, il quale vantava di essere stato discepolo<br />
proprio di Giovanni l'Evangelista. Il collegamento con la tradizione orale e apostolica<br />
(soprattutto Paolo e Giovanni) rimase in lui molto forte. [testo 1] Comunque esiste un<br />
legame stretto con l’ambiente giovanneo e l’intervallo che separa Ireneo dall’Apostolo è<br />
relativamente breve.<br />
Verso il 170 Ireneo – non si sa bene perché – è a Lione, lungo il fiume Rodano nella<br />
Gallia, dove si trovava già una comunità cristiana, anzitutto di emigranti provenienti<br />
dall’Asia Minore e di lingua greca. Probabilmente è passato per Roma perché ricorda e<br />
consoce varie cose lì accadute.<br />
Nel 177 (unica data certa) va a Roma per portare al papa Eleuterio una lettera dei martiri<br />
di Lione sulla questione montanista [testo] [cfr. testo]; in quel periodo si scatena una<br />
persecuzione e tornato a Lione, dopo il martirio e la morte del vescovo Potino [testo],<br />
Ireneo gli succede alla giuda di quella comunità.<br />
Sotto papa Vittore (189-198) è attivo per la questione della pasqua. Vittore aveva<br />
scomunicato i quartodecimani; Ireneo interviene come uomo-di-pace [testo Eusebio V].<br />
Non sappiamo la data della sua morte. Secondo Gregorio di Tours, storiografo alla fine<br />
del secolo VI, Ireneo sarebbe morto martire (202/203?), ma non ci sono prove: la liturgia<br />
lo festeggia come tale. Pur essendo un padre molto amato, le sue opere in lingua originale<br />
sono andate perdute.<br />
Opere<br />
Ci sono rimasti due grandi testi di Ireneo.<br />
Adversus haereses<br />
(Contro gli eretici, o anche: Smascheramento e confutazione della falsa gnosi), scritta in<br />
greco ma giuntaci solo in traduzione latina. In cinque libri; ripreso in più volte, risente<br />
nella stesura di questa inorganicità: prolissità e ripetizioni.<br />
Nell’Adversus haereses Ireneo presenta le dottrine dei vari sistemi gnostici e le confuta.<br />
Prima della scoperta degli scritti di Nag Hammadi nel 1945-7 in Egitto, Ireneo è stato la<br />
fonte principale, anche se in polemica, per la nostra conoscenza dello gnosticismo del suo<br />
tempo.<br />
Prima parte<br />
I: analisi e storia dello gnosticismo [testo p.15]<br />
Rovesciamento<br />
II: confutazione della gnosi con argomenti di ragione<br />
III: chiesa, Dio e cristologia<br />
IV: logia di Gesù<br />
V: risurrezione della carne e millennio (escatologia)
Epideixis<br />
Demonstratio (oppure: Esposizione della predicazione apostolica), un’opera molto più<br />
piccola della precedente, conservataci in traduzione armena. Dimostrazione positiva della<br />
vera dottrina. Una sorta di apologia o meglio di catechesi per adulti, cioè non una “prima”<br />
catechesi. E’ il primo autore che esprime in termini dogmatici l’insieme delle dottrine<br />
cristiane.<br />
- 1-3 introduzione<br />
- 4-42 contenuto della fede battesimale cristiana, insiste su Cristo (sintesi di catechesi;<br />
Trinità, creazione e caduta, incarnazione e redenzione)<br />
- 42-97 (rivolta ai giudei) dimostra con le profezie dell’AT che la dottrina cristiana è vera<br />
Aspetti della teologia<br />
Si merita il nome di fondatore della teologia cattolica perché è il primo che esprime in<br />
termini dogmatici l’insieme della teologia cristiana, dovendo difendere gli articoli di fede<br />
negati dagli gnostici. Costituisce la prima sintesi della teologia del II secolo. La sua<br />
diffidenza per la cultura greca e la sua polemica gli impedisce forse di cogliere il<br />
significato profondo e positivo della dottrina degli avversari.<br />
Unità della storia della salvezza<br />
Nel contesto della sua polemica antignostica Ireneo sviluppa una concezione generale di<br />
ciò che oggi chiamiamo “storia della salvezza”. Questo termine (in tedesco<br />
Heilsgeschichte) è nato soltanto nel secolo XIX, però l’idea è già presente nell’opera di<br />
Ireneo. Per Ireneo AT e NT costituiscono una continuità ascendente nella rivelazione di<br />
una stessa salvezza. L’unità della rivelazione gli fa affermare la connessione tra AT e NT,<br />
secondo un’ottica di rivelazione progressiva e continua. Ireneo è il primo che parla di due<br />
testamenti (non nel senso dei libri ma nel senso dei due momenti dell’alleanza). L’AT ha<br />
autorità come profezia di Cristo. I testi del NT confermano il VT.<br />
Cfr. Vat II DV 7-9:<br />
“Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito<br />
Santo: cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la<br />
contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19 e 51), sia con la<br />
intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di<br />
coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. Così la<br />
Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa<br />
vengano a compimento le parole di Dio.” DV 8<br />
EXCURSUS. Detto in termini moderni: la Bibbia è scritta in parole umane perché Dio si adatta all’umanità,<br />
al modo umano di comprendere. Egli non può rivelarsi così com’è perché ci distruggerebbe. Deve quindi<br />
adattarsi all’uomo e chiamarlo ad un cammino progressivo di comprensione.<br />
Ma si può intendere il concetto di Rivelazione in due modi:<br />
1. La Scrittura preesiste, cade dal cielo. Anzi Dio parla in … ebraico o greco o in arabo e gli uomini<br />
devono ricevere questa rivelazione in modo del tutto passivo senza cambiare nulla, pur cambiando<br />
le loro condizioni storiche e culturali. Questo modo di intendere la rivelazione è tipica di ogni<br />
forma di fondamentalismo.<br />
2. C’è un concetto secondo il quale la rivelazione avviene storicamente, cioè nella storia, nel contesto<br />
storico e culturale degli uomini ai quali Dio vuole rivolgersi, per cui, come diceva Origene (“…il<br />
Logos di Dio sembra avere disposto le scritture, commisurando ciò che conviene nell’esposizione<br />
alla capacità degli ascoltatori ed al loro vantaggio”, CC IV,71,9-11), e come ripete il Vaticano II ,<br />
Dio ha parlato «per mezzo di uomini e alla maniera umana... Le parole di Dio, espresse in lingue
umane, si sono fatte simili al parlare dell´uomo, come già la Parola dell´Eterno Padre, avendo<br />
assunto le debolezze dell´umana natura, si fece simile all´uomo». Dio parla agli uomini in modo<br />
che essi lo comprendano e adattandosi al loro modo di comprendere. In questo caso la rivelazione è<br />
condizionata dalle categorie storiche e permette di inserire le nuove problematiche che ogni cultura<br />
porta con sè. Certo, per il cristiano Gesù Cristo è la rivelazione totale e definitiva della volontà di<br />
Dio, tuttavia egli stesso ha annunciato che lo Spirito avrebbe condotto alla verità tutta intera (Gv<br />
16,13).<br />
E’ anche questo il senso dell’idea cattolica della doppia fonte della rivelazione: Scrittura e Tradizione.<br />
Non riceviamo e non comprendiamo le Scritture se non all’interno di una Chiesa che ce le trasmette<br />
(tradizione), quindi in qualche modo attraverso il loro processo di inculturazione.<br />
Bibbia e tradizione<br />
L’esatta interpretazione delle Scritture esige una regola della verità, il simbolo, che è<br />
l’espressione della fede stessa. Si oppone alle tradizioni private.<br />
Contro gli gnostici che parlano di una tradizione segreta afferma che c’è una unica<br />
tradizione pubblica che non trasmette segreti ma la fede in un solo Dio e in una sola<br />
storia della salvezza. Contro gli gnostici Ireneo sottolinea che la predicazione degli<br />
apostoli è la rivelazione unica e completa di Dio, destinata a tutti i credenti. Non esiste<br />
nessuna “trasmissione segreta” per i pochi “iniziati”, come se ci fosse un supplemento<br />
“superiore” accanto al Vangelo.<br />
Unità di Dio<br />
Unità tra il Dio della creazione e Dio della redenzione (AT+NT): “facciamo l’uomo”, è la<br />
Trinità; Logos e lo Spirito sono le “due mani di Dio”.<br />
Cristologia<br />
Concetto di economia divina che copre tutto l’arco che va dalla creazione fino alla fine<br />
dei tempi e l’evento centrale è l’Incarnazione del Verbo di Dio. Tutto viene ricostituito e<br />
compiuto in Cristo (anakephalaiosis o recapitulatio; vedi anche Ef 1,10). Tutta la storia<br />
dell’AT ne è stata una preparazione progressiva tramite le prefigurazioni. C’è quindi una<br />
azione pedagogica del Logos e una fondamentale continuità fra l’AT e il NT.<br />
Adamo-Cristo / Eva- Maria<br />
Ireneo inizia la tipologia Adamo-Cristo e anche Eva-Maria/Chiesa.<br />
In questo schema però è in azione l'asimmetria di genere nell'ordine della salvezza. Cosa vuol dire?<br />
Vuol dire che quando la Bibbia usa il simbolismo matrimoniale o di coppia - come qui, per cui<br />
Adamo-Eva sono la coppia primitiva e Cristo-Maria(Chiesa) sono la coppia redentivi - usa un<br />
modello di matrimonio in cui la donna è subordinata. Infatti la metafora matrimoniale nell’antichità<br />
- così anche nella Bibbia - deriva da uno schema sociale in cui i due non sono affatto (come oggi)<br />
sullo stesso piano, ma la donna è considerata inferiore. Per questo del resto tale simbolo può essere<br />
applicato a Dio e all’umanità, perchè la sposa è considerata di livello inferiore, altrimenti Dio non<br />
potrebbe essere lo sposo, che invece resta il Signore e il Creatore. L'umanità quindi assume davanti a<br />
Dio le caratteristiche di una donna nel matrimonio, cioè chiamata ad un rapporto di amore e fedeltà,<br />
sì, ma subordinata (qui i testi chiave sono quelli di Gen 2,21-23; Rm 5,14; Ef 5,32; qui Paolo infatti<br />
parla di Cristo come capo della donna; ma anche Gv 19,26-27; 2 Cor 11,23). 5<br />
5 Ef 5,32-33: “Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Quindi anche voi,<br />
ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito”; Rom<br />
5,12-21: “Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte,<br />
così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge infatti c'era<br />
peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da
Unità dell’uomo<br />
Adamo come tutti gli uomini e tutto l’uomo come essere unitario, creato da Dio a tre<br />
dimensioni (spirito, anima corpo) e non solo lo spirito come volevano gli gnostici.<br />
Immagine e somiglianza<br />
Per Ireneo si tratta di due momenti distinti: la somiglianza è ricostituita col progresso<br />
spirituale.<br />
Legge del progresso:<br />
La perfezione umana non è all’origine ma alla fine della storia (cfr, GS 22: “solamente nel<br />
mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo”). L’uomo è un essere in<br />
divenire, che deve maturare, svilupparsi fino alla pienezza. Adamo era un bambino, non<br />
ancora completo. Il tempo tempo e la storia non sono come per gli gnostici un luogo di<br />
alienazione, ma di maturazione e crescita per l’uomo.<br />
Libertà e responsabilità<br />
L’uomo è libero ma non raggiungerà la sua perfezione senza la sua adesione a Dio che è<br />
Pedagogo. Nella libertà c’è rischio del peccato. Cristo ha riaperto le possibilità chiuse dal<br />
peccato.<br />
Chiesa<br />
L’insegnamento degli apostoli vive nella chiesa (successione episcopale) cfr testi.<br />
Bisogna quindi inserirsi in una linea di tradizione autentica che si colleghi con quella<br />
dell’età apostolica, capace di indirizzare la comunità a cogliere il significato esatto della<br />
parola di Dio. Contro le interpretazioni degli gnostici oppone il puntello dell’autorità<br />
episcopale. Cfr. Testo sul primato romano.<br />
Esegesi<br />
Oltre al senso letterale esiste un senso più profondo. Il testo dell Bibbia è inesauribile ma<br />
non bisogna spiegare testi oscuri con altri testi ancora più oscuri (come fanno gli gnostici)<br />
C’è un progresso nella Bibbia: sono immagini diverse ma di una sola parola.<br />
Ireneo è il primo esegeta del NT. Nessuno prima di lui utilizza in questo modo il NT.<br />
E’ il primo a dare anche una teoria dell’esegesi tradizionale della Bibbia: la Bibbia va letta<br />
nella chiesa. Inizia l’esegesi cristiana secondo la filologia classica.<br />
Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di<br />
Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per<br />
la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo<br />
uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto per il dono di<br />
grazia come per il peccato di uno solo: il giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia<br />
invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa<br />
di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia<br />
regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su<br />
tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la<br />
giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti<br />
peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopraggiunse a<br />
dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché<br />
come il peccato aveva regnato con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per<br />
mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.”
Regula fidei – il simbolo<br />
In alcuni passi Ireneo riassume i dati fondamentali della fede cristiana. Ritroviamo in quei<br />
passi già gli elementi del nostro Credo, cioè il Simbolo della fede, diremo in forma<br />
embrionale e con delle formulazioni non ancora fissate. Il contenuto della fede cristiana,<br />
così riassunto in forma trinitaria combinata con delle affermazioni cristologiche,<br />
chiamiamo la Regula fidei.<br />
Nella Demonstratio troviamo una formula più sistematica della Regula fidei in tre articoli,<br />
secondo le tre Persone della Santa Trinità. Qui alla fine troviamo una delle prime<br />
testimonianze del fatto che tale professione di fede faceva parte della liturgia battesimale,<br />
cioè la celebrazione della “rinascita in Dio Padre, per il suo Figlio e con lo Spirito Santo”,<br />
secondo il comandamento dato dal Signore Risorto in Mt 28,19.<br />
Escatologia<br />
Ireneo struttura gli eventi ultimi in modo cronologico convinto che tutto l’uomo deve<br />
partecipare al destino di gloria, tutta l’unità psico-fisica (plasis). La carne però deve<br />
esercitarsi all’incorruttibilità dello Spirito. Ireneo presenta un millenarismo particolare:<br />
questo periodo è come una sorta di scuola in cui la carne si prepara e si abitua ad<br />
accogliere e portare Dio (Adv. Haer. V,8,1) a comprenderlo (V,32,1). Tale periodo<br />
costituisce quindi una preparazione, un’iniziazione al mondo definitivo e maturo dello<br />
Spirito, iniziato con la creazione (IV,38,1-2, l’uomo infante; cfr. Adv. Haer. IV,37,7; V,31).<br />
Si tratta di uno stato dinamico. Per Ireneo la fede in questo millennio è fondamentale per<br />
l’ortodossia contro le idee gnostiche. Infatti esso dimostra l’unità dell’uomo, l’unicità di<br />
Dio e l’unità della storia della salvezza, cioè che il Dio dell’AT che ha plasmato l’uomo e<br />
che ha promesso la terra (Is; Ger, Ez) è lo stesso che anche la darà alla risurrezione ai<br />
giusti (V,34.36,3; Ap). Reso così capace di accogliere la gloria del Padre, l’uomo nuovo<br />
potrà conversare con Dio in una maniera sempre nuova (V,36,1).