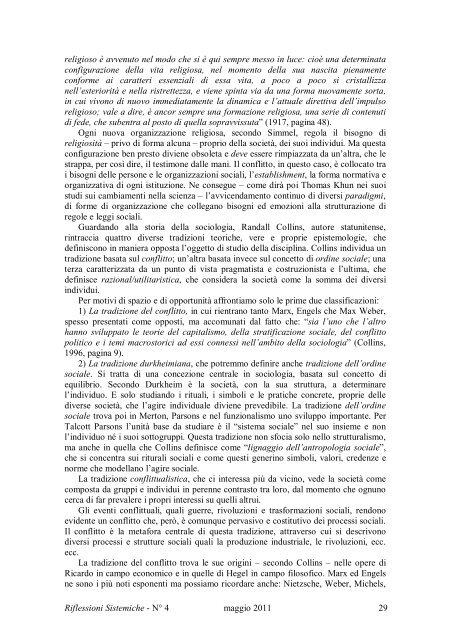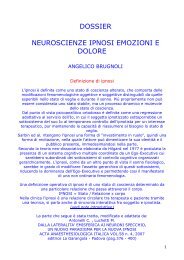Il luogo del conflitto - In-Formazione-Psicologia
Il luogo del conflitto - In-Formazione-Psicologia
Il luogo del conflitto - In-Formazione-Psicologia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
eligioso è avvenuto nel modo che si è qui sempre messo in luce: cioè una determinata<br />
configurazione <strong>del</strong>la vita religiosa, nel momento <strong>del</strong>la sua nascita pienamente<br />
conforme ai caratteri essenziali di essa vita, a poco a poco si cristallizza<br />
nell’esteriorità e nella ristrettezza, e viene spinta via da una forma nuovamente sorta,<br />
in cui vivono di nuovo immediatamente la dinamica e l’attuale direttiva <strong>del</strong>l’impulso<br />
religioso; vale a dire, è ancor sempre una formazione religiosa, una serie di contenuti<br />
di fede, che subentra al posto di quella sopravvissuta” (1917, pagina 48).<br />
Ogni nuova organizzazione religiosa, secondo Simmel, regola il bisogno di<br />
religiosità – privo di forma alcuna – proprio <strong>del</strong>la società, dei suoi individui. Ma questa<br />
configurazione ben presto diviene obsoleta e deve essere rimpiazzata da un’altra, che le<br />
strappa, per così dire, il testimone dalle mani. <strong>Il</strong> <strong>conflitto</strong>, in questo caso, è collocato tra<br />
i bisogni <strong>del</strong>le persone e le organizzazioni sociali, l’establishment, la forma normativa e<br />
organizzativa di ogni istituzione. Ne consegue – come dirà poi Thomas Khun nei suoi<br />
studi sui cambiamenti nella scienza – l’avvicendamento continuo di diversi paradigmi,<br />
di forme di organizzazione che collegano bisogni ed emozioni alla strutturazione di<br />
regole e leggi sociali.<br />
Guardando alla storia <strong>del</strong>la sociologia, Randall Collins, autore statunitense,<br />
rintraccia quattro diverse tradizioni teoriche, vere e proprie epistemologie, che<br />
definiscono in maniera opposta l’oggetto di studio <strong>del</strong>la disciplina. Collins individua un<br />
tradizione basata sul <strong>conflitto</strong>; un’altra basata invece sul concetto di ordine sociale; una<br />
terza caratterizzata da un punto di vista pragmatista e costruzionista e l’ultima, che<br />
definisce razional/utilitaristica, che considera la società come la somma dei diversi<br />
individui.<br />
Per motivi di spazio e di opportunità affrontiamo solo le prime due classificazioni:<br />
1) La tradizione <strong>del</strong> <strong>conflitto</strong>, in cui rientrano tanto Marx, Engels che Max Weber,<br />
spesso presentati come opposti, ma accomunati dal fatto che: “sia l’uno che l’altro<br />
hanno sviluppato le teorie <strong>del</strong> capitalismo, <strong>del</strong>la stratificazione sociale, <strong>del</strong> <strong>conflitto</strong><br />
politico e i temi macrostorici ad essi connessi nell’ambito <strong>del</strong>la sociologia” (Collins,<br />
1996, pagina 9).<br />
2) La tradizione durkheimiana, che potremmo definire anche tradizione <strong>del</strong>l’ordine<br />
sociale. Si tratta di una concezione centrale in sociologia, basata sul concetto di<br />
equilibrio. Secondo Durkheim è la società, con la sua struttura, a determinare<br />
l’individuo. E solo studiando i rituali, i simboli e le pratiche concrete, proprie <strong>del</strong>le<br />
diverse società, che l’agire individuale diviene prevedibile. La tradizione <strong>del</strong>l’ordine<br />
sociale trova poi in Merton, Parsons e nel funzionalismo uno sviluppo importante. Per<br />
Talcott Parsons l’unità base da studiare è il “sistema sociale” nel suo insieme e non<br />
l’individuo né i suoi sottogruppi. Questa tradizione non sfocia solo nello strutturalismo,<br />
ma anche in quella che Collins definisce come “lignaggio <strong>del</strong>l’antropologia sociale”,<br />
che si concentra sui riturali sociali e come questi generino simboli, valori, credenze e<br />
norme che mo<strong>del</strong>lano l’agire sociale.<br />
La tradizione conflittualistica, che ci interessa più da vicino, vede la società come<br />
composta da gruppi e individui in perenne contrasto tra loro, dal momento che ognuno<br />
cerca di far prevalere i propri interessi su quelli altrui.<br />
Gli eventi conflittuali, quali guerre, rivoluzioni e trasformazioni sociali, rendono<br />
evidente un <strong>conflitto</strong> che, però, è comunque pervasivo e costitutivo dei processi sociali.<br />
<strong>Il</strong> <strong>conflitto</strong> è la metafora centrale di questa tradizione, attraverso cui si descrivono<br />
diversi processi e strutture sociali quali la produzione industriale, le rivoluzioni, ecc.<br />
ecc.<br />
La tradizione <strong>del</strong> <strong>conflitto</strong> trova le sue origini – secondo Collins – nelle opere di<br />
Ricardo in campo economico e in quelle di Hegel in campo filosofico. Marx ed Engels<br />
ne sono i più noti esponenti ma possiamo ricordare anche: Nietzsche, Weber, Michels,<br />
Riflessioni Sistemiche - N° 4 maggio 2011 29