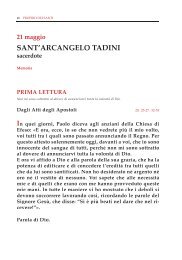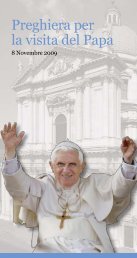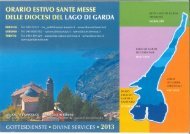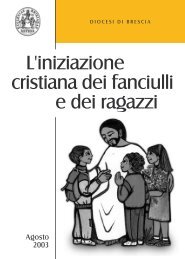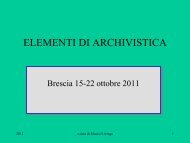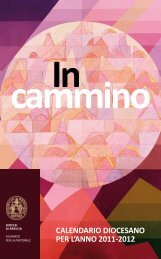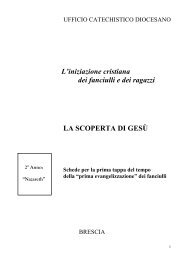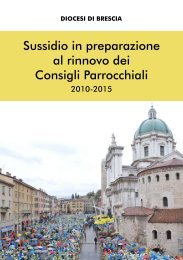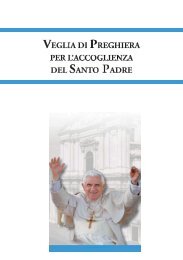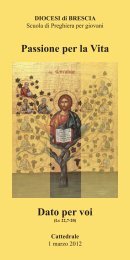scarica il documento in formato PDF - Diocesi di Brescia
scarica il documento in formato PDF - Diocesi di Brescia
scarica il documento in formato PDF - Diocesi di Brescia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’EUCARISTIA CULMINE DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA<br />
E FONTE DI OGNI ATTIVITA’ PASTORALE<br />
<strong>Brescia</strong>, 4 settembre 2006<br />
don Pierpaolo Caspani<br />
Nello svolgere <strong>il</strong> tema che mi è affidato, rivolgo la mia attenzione <strong>in</strong> particolare ai sacramenti<br />
dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana (d’ora <strong>in</strong> poi: IC): battesimo, confermazione/cresima ed eucaristia 1 .<br />
Le riflessioni che propongo priv<strong>il</strong>egiano qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>il</strong> punto <strong>di</strong> vista della teologia sacramentaria<br />
e, pertanto, avrebbero bisogno <strong>di</strong> essere <strong>in</strong>tegrate sul versante catechetico e pastorale: ciò<br />
spiega perché la seconda parte del titolo (l’eucaristia come fonte <strong>di</strong> ogni attività pastorale) sarà<br />
forse un po’ sacrificata. Credo però che <strong>il</strong> fatto <strong>di</strong> chiarire <strong>in</strong> partenza <strong>il</strong> taglio del <strong>di</strong>scorso<br />
possa renderne più sopportab<strong>il</strong>i gli <strong>in</strong>evitab<strong>il</strong>i limiti. Proce<strong>di</strong>amo anzitutto ricostruendo alcune<br />
l<strong>in</strong>ee <strong>di</strong> sv<strong>il</strong>uppo storico dell’IC <strong>in</strong> Occidente (I.), per presentare poi alcune riflessioni <strong>di</strong> carattere<br />
teologico-sistematico (II.) e concludere valutando alcune possib<strong>il</strong>i ricadute sul piano<br />
pratico-pastorale (III.).<br />
I. LINEE DI SVILUPPO STORICO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA IN OCCIDENTE<br />
1. La prassi dei primi secoli<br />
Nei primi secoli del cristianesimo (le testimonianze sono relative soprattutto ai secoli III-V), i<br />
can<strong>di</strong>dati al battesimo erano <strong>in</strong> maggioranza adulti, che venivano battezzati dopo aver compiuto<br />
un camm<strong>in</strong>o <strong>di</strong> preparazione, detto catecumenato. Di solito <strong>il</strong> battesimo aveva luogo nel<br />
corso della Veglia pasquale, <strong>in</strong> una celebrazione presieduta dal vescovo, coa<strong>di</strong>uvato da presbiteri<br />
e <strong>di</strong>aconi e attorniato da tutta la comunità cristiana. La celebrazione era piuttosto complessa,<br />
ma al suo <strong>in</strong>terno erano riconoscib<strong>il</strong>i tre momenti-chiave: <strong>il</strong> gesto battesimale <strong>in</strong> senso<br />
stretto, una serie <strong>di</strong> riti postbattesimali (imposizione delle mani, unzione, segno <strong>di</strong> croce sulla<br />
fronte, <strong>in</strong> un ord<strong>in</strong>e e con un’importanza che variava da Chiesa a Chiesa), quella che noi<br />
chiameremmo la «liturgia eucaristica», cui i neobattezzati partecipavano per la prima volta,<br />
accostandosi alla comunione, qualunque fosse la loro età. Il vertice <strong>di</strong> questa celebrazione è<br />
chiaramente rappresentato dall’eucaristia, la cui presenza nell’ambito dell’IC è attestata <strong>in</strong><br />
maniera cont<strong>in</strong>ua e generale, al punto che qualche stu<strong>di</strong>oso si domanda se non siamo <strong>di</strong> fronte<br />
ad una prassi <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e apostolica 2 . Significativa l’affermazione <strong>di</strong> Teodoro <strong>di</strong> Mopsuestia,<br />
secondo <strong>il</strong> quale l’eucaristia è <strong>il</strong> cibo appropriato alla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vita generata dal battesimo:<br />
per suo mezzo siamo «nutriti dalla stessa sorgente da cui siamo nati»: la morte <strong>di</strong> Cristo,<br />
1<br />
Introduciamo anche un cenno alla questione della presenza della penitenza sacramentale nell’it<strong>in</strong>erario<br />
dell’ICFR.<br />
2<br />
È Saxer a porre la domanda, senza però proporre una risposta: V. SAXER, Les rites de l’<strong>in</strong>itiation chrétienne du<br />
II au VI siècle. Esquisse historique et signification d’après leurs pr<strong>in</strong>cipaux témo<strong>in</strong>s (= Centro Italiano <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong><br />
sull’Alto Me<strong>di</strong>oevo 7), Spoleto 1988, 423. Altri storici sono <strong>in</strong>vece più cauti: «L’Eucaristia era con<strong>di</strong>visa solo tra<br />
i battezzati, ma non c’è alcuna documentazione che la comunione fosse <strong>in</strong>clusa nei rituali battesimali della<br />
Chiesa apostolica»: P. TURNER, Ages of Initiation. The First Two Christian M<strong>il</strong>lennia. With CD-ROM of Source<br />
Excerpts, The Liturgical Press, Collegev<strong>il</strong>le (M<strong>in</strong>nesota) 2000, 2.<br />
1
dalla quale «abbiamo ricevuto una nascita sacramentale» ed ora «riceviamo <strong>il</strong> cibo del sacramento<br />
d’immortalità» 3 .<br />
Consideriamo ora <strong>in</strong> s<strong>in</strong>tesi i fenomeni che hanno <strong>in</strong>trodotto significativi mutamenti <strong>in</strong> questa<br />
struttura <strong>di</strong> <strong>in</strong>iziazione 4 .<br />
2. Il battesimo dei bamb<strong>in</strong>i <strong>di</strong>venta la prassi generale<br />
Se nei primi secoli la maggior parte dei can<strong>di</strong>dati al battesimo erano adulti, è molto probab<strong>il</strong>e<br />
che, f<strong>in</strong> dall’<strong>in</strong>izio, costoro si facessero battezzare <strong>in</strong>sieme ai loro figli, anche neonati. Anche i<br />
neonati, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, erano battezzati (cresimati ed «eucaristizzati») <strong>in</strong>sieme con i loro famigliari<br />
che si convertivano. Con la <strong>di</strong>ffusione del cristianesimo si <strong>di</strong>ffonde pure l’uso <strong>di</strong> far battezzare<br />
i figli che nascono all’<strong>in</strong>terno delle famiglie cristiane: attorno al sec. VI, questa è ormai la<br />
prassi generale, sia <strong>in</strong> Oriente che <strong>in</strong> Occidente. Anche quando <strong>il</strong> battesimo degli <strong>in</strong>fanti <strong>di</strong>venta<br />
la prassi generale, le Chiese d’Oriente cont<strong>in</strong>uano a battezzare, cresimare e comunicare<br />
sia gli adulti (sempre più rari) che gli <strong>in</strong>fanti; <strong>in</strong> Oriente questo è l’uso <strong>in</strong> vigore ancora oggi.<br />
Le Chiese dell’Occidente, <strong>in</strong>vece, si sono comportate <strong>di</strong>versamente.<br />
3. La separazione della confermazione dal battesimo<br />
In Occidente, <strong>il</strong> <strong>di</strong>stacco della confermazione dal battesimo (i primi segni si registrano nel IV<br />
secolo <strong>in</strong> Gallia) è dovuto sostanzialmente alla scelta <strong>di</strong> riservare al vescovo i riti che si collocano<br />
tra battesimo ed eucaristia. Quando, soprattutto nelle campagne, <strong>il</strong> vescovo non può essere<br />
presente alla celebrazione battesimale, <strong>il</strong> prete battezza <strong>il</strong> can<strong>di</strong>dato e gli dà la comunione<br />
eucaristica, anche se si tratta <strong>di</strong> un <strong>in</strong>fante; <strong>il</strong> battezzato sarà confermato successivamente,<br />
quando <strong>il</strong> vescovo verrà a visitare le comunità cristiane rurali. Quando però <strong>il</strong> vescovo è presente<br />
alla celebrazione battesimale, <strong>il</strong> neofita viene subito confermato e poi riceve l’eucaristia;<br />
almeno idealmente, <strong>in</strong>fatti, l’unità dei tre sacramenti dell’IC è mantenuta f<strong>in</strong>o ai secoli<br />
XII/XIII. In questo periodo, un po’ sulla scia <strong>di</strong> quanto avviene per la comunione (cf <strong>il</strong> paragrafo<br />
seguente), l’età della confermazione viene quasi ovunque spostata attorno ai sette anni.<br />
In ogni caso, <strong>di</strong> fatto, un bamb<strong>in</strong>o (o un ragazzo) riceve la cresima quando ha modo <strong>di</strong> <strong>in</strong>contrare<br />
<strong>il</strong> vescovo, <strong>il</strong> che <strong>di</strong> solito avviene <strong>in</strong> occasione della visita pastorale.<br />
4. L’eucaristia separata dal battesimo e preceduta dalla confessione<br />
La prassi antica – La tra<strong>di</strong>zione più antica, comune a tutta la Chiesa, riteneva che ogni battezzato,<br />
a partire dal momento <strong>in</strong> cui aveva ricevuto <strong>il</strong> battesimo, potesse ricevere la confermazione<br />
e l’eucaristia nel corso della stessa celebrazione 5 . Anche se la cresima è rimandata perché<br />
non c’è <strong>il</strong> vescovo, <strong>il</strong> neobattezzato, benché <strong>in</strong>fante, riceve comunque la comunione eucaristica;<br />
se la sua con<strong>di</strong>zione gli impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> comunicarsi sotto la specie del pane, <strong>il</strong> sacerdote<br />
provvederà alla comunione con la sola specie del v<strong>in</strong>o. Alcune testimonianze – non molto<br />
numerose, ma significative – fanno presumere che la comunione venisse data agli <strong>in</strong>fanti non<br />
3 TEODORO DI MOPSUESTIA, Hom. XV,6.<br />
4 Cf P. CASPANI, «Alle orig<strong>in</strong>i della prassi attuale», Rivista <strong>di</strong> Pastorale Liturgica 231 (2002/2) 3-11.<br />
5 Cf A. VALSECCHI, «La storia della comunione ai fanciulli», <strong>in</strong> M. COLOMBO (ed.), L’Eucaristia ai fanciulli.<br />
Stu<strong>di</strong>o storico, giuri<strong>di</strong>co, pedagogico, pastorale e ascetico, Ancora, M<strong>il</strong>ano 1958, 15-69. B. KLEINHEYER, Sakramentliche<br />
Feiern I. Die Feiern der E<strong>in</strong>gliederung <strong>in</strong> <strong>di</strong>e Kirche (= Gottes<strong>di</strong>enst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft<br />
7,1), Pustet, Regensburg 1989, 237-245.<br />
2
solo <strong>in</strong> occasione del loro battesimo, ma anche ogni volta che essi partecipavano alla celebrazione<br />
eucaristica; anch’essi, <strong>in</strong>oltre, potevano sempre riceverla come viatico.<br />
Le motivazioni teologiche <strong>di</strong> questa prassi sono riconducib<strong>il</strong>i alla necessità della comunione eucaristica<br />
<strong>in</strong> vista della salvezza eterna; questa posizione è fatta valere soprattutto da Agost<strong>in</strong>o,<br />
sulla base del riferimento a Gv 6,53. Nel sec. IX com<strong>in</strong>cia a prof<strong>il</strong>arsi un orientamento <strong>di</strong>verso,<br />
sostenuto <strong>in</strong> particolare da Floro <strong>di</strong> Lione (+ 860): nella sua raccolta dei commenti <strong>di</strong> Agost<strong>in</strong>o<br />
alle lettere <strong>di</strong> Paolo, Floro riporta l’op<strong>in</strong>ione secondo cui chi è <strong>di</strong>ventato membro del corpo <strong>di</strong><br />
Cristo grazie al battesimo, anche se muore senza aver ricevuto <strong>il</strong> corpo e sangue <strong>di</strong> Cristo, non<br />
sarà escluso dalla comunione eterna con Lui. Questa affermazione non è certamente <strong>di</strong> Agost<strong>in</strong>o,<br />
ma viene erroneamente attribuita a lui e, come tale, sarà accolta nelle Summae canonistiche<br />
e teologiche del periodo scolastico. L’esistenza, nel IX sec., <strong>di</strong> un <strong>di</strong>battito attorno alla salvezza<br />
eterna dei battezzati che muoiono senza la comunione rivela che, <strong>in</strong> alcuni casi, <strong>il</strong> battesimo non<br />
è imme<strong>di</strong>atamente seguito dall’eucaristia. Presumib<strong>il</strong>mente ciò avviene quando <strong>il</strong> battesimo è<br />
amm<strong>in</strong>istrato (anche da un laico) <strong>in</strong> situazioni <strong>di</strong> emergenza, nelle quali non sempre è possib<strong>il</strong>e<br />
avere a <strong>di</strong>sposizione le specie eucaristiche 6 . È proprio a partire da questo periodo che l’uso <strong>di</strong><br />
dare la comunione ai neofiti conosce un progressivo decl<strong>in</strong>o.<br />
Il Conc<strong>il</strong>io Lateranense IV (1215) – L’abbandono della comunione agli <strong>in</strong>fanti si percepisce<br />
soprattutto nel passaggio dal XII al XIII secolo: <strong>in</strong> effetti, negli anni che precedono e seguono<br />
<strong>il</strong> 1200, <strong>di</strong>versi decreti vietano <strong>di</strong> dare la comunione ai bamb<strong>in</strong>i piccoli. L’elemento che fa da<br />
catalizzatore <strong>di</strong> questa evoluzione è <strong>il</strong> cap. 21 del Conc<strong>il</strong>io Lateranense IV (1215 – DH 812):<br />
reagendo alla progressiva <strong>di</strong>saffezione nei confronti della comunione eucaristica, <strong>il</strong> Conc<strong>il</strong>io<br />
prescrive che ogni fedele, «giunto all’età della <strong>di</strong>screzione», confessi i propri peccati una volta<br />
l’anno al suo sacerdote e si accosti reverenter alla comunione eucaristica almeno a Pasqua.<br />
Per sé, la comunione prima dell’età della <strong>di</strong>screzione non è proibita; tuttavia, poiché l’obbligo<br />
<strong>di</strong> comunicarsi vale a partire da quell’età, <strong>in</strong><strong>di</strong>rettamente si fa capire che, per quanti non l’hanno<br />
raggiunta, l’obbligo non sussiste. In tal modo è sancito <strong>il</strong> <strong>di</strong>stacco dell’eucaristia dal battesimo:<br />
<strong>il</strong> neonato, <strong>in</strong>fatti, è battezzato nei primi giorni <strong>di</strong> vita, ma si accosta all’eucaristia a partire<br />
dall’età della <strong>di</strong>screzione. Inoltre, raccomandando che la comunione venga ricevuta «con<br />
riverenza», <strong>il</strong> Lateranense IV sp<strong>in</strong>ge a considerare l’atteggiamento devoto come requisito necessario<br />
per potersi accostare alla mensa eucaristica. Coerente con questa <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione è la<br />
prassi <strong>di</strong> far precedere alla prima comunione la prima confessione: per sé <strong>il</strong> conc<strong>il</strong>io non affronta<br />
<strong>di</strong>rettamente <strong>il</strong> problema; tuttavia, <strong>il</strong> modo <strong>in</strong> cui è formulato <strong>il</strong> precetto lascia <strong>in</strong>tendere<br />
che prima ci si accosta alla confessione, poi alla comunione. A partire dal Lateranense IV,<br />
questa sarà la prassi seguita <strong>in</strong> tutta la Chiesa occidentale 7 .<br />
I motivi della svolta – Non è semplice ricostruire con precisione i motivi <strong>di</strong> questa svolta, legata<br />
ad una complessiva evoluzione della sensib<strong>il</strong>ità nei confronti dell’eucaristia 8 : a partire<br />
dai secc. VIII-IX, essa è sempre più <strong>di</strong>ffusamente vista come mysterium tremendum, che su-<br />
6 Che la morte <strong>di</strong> un battezzato senza la comunione rappresenti una questione r<strong>il</strong>evante è documentato dall’<strong>in</strong>vito<br />
ricorrente nella legislazione canonica del periodo a far sì che le specie eucaristiche siano reperib<strong>il</strong>i anche <strong>in</strong><br />
situazioni <strong>di</strong> emergenza.<br />
7 «È <strong>di</strong>ffic<strong>il</strong>e precisare, prima del IV conc<strong>il</strong>io lateranense e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> prima del XIII secolo, quale prassi fosse<br />
seguita quanto alla sequenza prima confessione-prima comunione. Si può tuttavia presumere che per tutto <strong>il</strong><br />
tempo <strong>in</strong> cui <strong>il</strong> bamb<strong>in</strong>o riceveva la comunione prima <strong>di</strong> aver raggiunto l’età della ragione, egli lo facesse senza<br />
ricorrere alla penitenza sacramentale»: C. BLANCHETTE, Pénitence et eucharistie. Dossier d’une question controversée,<br />
Bellarm<strong>in</strong> – Cerf, Montréal – Paris 1989, 89-90: cit. <strong>in</strong> R. TONONI, «L’<strong>in</strong>iziazione cristiana e <strong>il</strong><br />
sacramento della riconc<strong>il</strong>iazione. Una collocazione problematica», <strong>in</strong> Iniziazione cristiana (= Quaderni Teologici<br />
del Sem<strong>in</strong>ario <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> 12), Morcelliana, <strong>Brescia</strong> 2002, 147-176: 164, n. 49.<br />
8 N. LEMAITRE, «Avant la communion solennelle», <strong>in</strong> J. DELUMEAU (éd.), La première Communion. Quatre<br />
siècles d’histoire, Desclée de Brouwer, Paris 1987, 15-32, 19-21.<br />
3
scita un timore reverenziale esagerato, dal quale deriva un senso <strong>di</strong> <strong>in</strong>degnità nei confronti<br />
della comunione eucaristica, cui i fedeli si accostano sempre più raramente. Evidentemente<br />
questa situazione si riflette anche sulla prassi eucaristica dei bamb<strong>in</strong>i: la comunione nel corso<br />
dell’<strong>in</strong>fanzia <strong>di</strong>venta sempre meno frequente, mentre la comunione battesimale tende a scomparire<br />
9 . Su questo sfondo complessivo, due fattori (che peraltro riguardano solo l’Occidente)<br />
sono decisivi per comprendere l’abbandono della comunione agli <strong>in</strong>fanti: anzitutto la scomparsa<br />
della comunione dei laici al calice, che rende «tecnicamente» impossib<strong>il</strong>e la comunione<br />
dei neonati; <strong>in</strong> secondo luogo, l’accresciuto senso del rispetto necessario per accostarsi alle<br />
specie eucaristiche, con la richiesta che chi accede alla comunione manifesti qualche sia pur<br />
piccolo segno <strong>di</strong> devozione e con la preoccupazione <strong>di</strong> evitare ogni possib<strong>il</strong>e irriverenza nei<br />
confronti delle specie eucaristiche: evidentemente, nel caso <strong>di</strong> un neonato, nessuna <strong>di</strong> queste<br />
esigenze può essere sod<strong>di</strong>sfatta. Si <strong>in</strong>tuiscono qu<strong>in</strong><strong>di</strong> i fattori che, <strong>in</strong>teragendo fra loro, hanno<br />
fatto sì che la recezione dell’eucaristia fosse rimandata all’età della <strong>di</strong>screzione.<br />
L’età della <strong>di</strong>screzione – Non precisando quale sia l’età della <strong>di</strong>screzione, <strong>il</strong> Lateranense IV<br />
lascia aperta la possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> <strong>in</strong>terpretazioni <strong>di</strong>verse: le norme ecclesiastiche, come pure le <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni<br />
dei canonisti e dei teologi, osc<strong>il</strong>lano tra i sette e i quattor<strong>di</strong>ci anni, variando secondo<br />
i tempi e i luoghi 10 . L’età della <strong>di</strong>screzione viene generalmente identificata con quella <strong>in</strong> cui<br />
un soggetto <strong>di</strong>venta capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guere <strong>il</strong> bene dal male e, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, com<strong>in</strong>cia ad essere <strong>in</strong><br />
grado <strong>di</strong> peccare anche mortalmente; <strong>in</strong> genere si ritiene che ciò avvenga attorno ai sette anni.<br />
Abbastanza presto com<strong>in</strong>cia ad <strong>in</strong>trodursi un criterio ulteriore, legato alla capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guere<br />
<strong>il</strong> pane eucaristico dal pane comune. Così, mentre l’obbligo <strong>di</strong> confessarsi annualmente<br />
com<strong>in</strong>cia attorno ai sette anni, l’età compresa tra i <strong>di</strong>eci e i do<strong>di</strong>ci anni è quella <strong>in</strong><strong>di</strong>cata con<br />
maggiore frequenza per la prima comunione, anche se non manca chi la riceve a partire dai<br />
sette anni. All’<strong>in</strong>domani del Conc<strong>il</strong>io <strong>di</strong> Trento 11 , i S<strong>in</strong>o<strong>di</strong> locali generalmente fissano l’età<br />
della prima comunione tra i <strong>di</strong>eci e i quattor<strong>di</strong>ci anni; nei secoli successivi la situazione non<br />
cambia sostanzialmente. Queste norme trovano riscontro nelle dottr<strong>in</strong>e dei canonisti e dei teologi.<br />
Le feste della prima comunione – Tra la f<strong>in</strong>e del 1500 e l’<strong>in</strong>izio del 1600, <strong>in</strong> Francia, si com<strong>in</strong>ciano<br />
ad organizzare le «feste della prima comunione»: i fanciulli tra i do<strong>di</strong>ci ed i quattor<strong>di</strong>ci<br />
anni ricevono tutti <strong>in</strong>sieme la prima comunione con un rituale solenne: processione <strong>in</strong><br />
Chiesa, abbigliamento apposito, canti, immag<strong>in</strong>i-ricordo, menù per <strong>il</strong> pranzo… Si tratta <strong>di</strong> un<br />
vero e proprio avvenimento nella vita <strong>di</strong> una parrocchia e, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, <strong>di</strong> tutto <strong>il</strong> paese. Un avvenimento<br />
preparato <strong>in</strong>tensamente dalla catechesi, preceduto da un ritiro e dalla confessione generale.<br />
L’uso si <strong>di</strong>ffonde anche <strong>in</strong> Belgio e Germania e non manca <strong>di</strong> <strong>in</strong>fluenzare anche altri<br />
paesi. In Italia e Spagna, però, l’età della prima comunione rimane un po’ più bassa rispetto ai<br />
paesi dell’Europa centrale e settentrionale. Il contesto <strong>in</strong> cui si sv<strong>il</strong>uppa e si <strong>di</strong>ffonde la prima<br />
comunione è caratterizzato da una visione fortemente devozionale, <strong>in</strong><strong>di</strong>vidualista ed <strong>in</strong>timista<br />
della comunione, considerata essenzialmente come la visita <strong>in</strong><strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> Gesù, che «viene<br />
9 La cosa non stupisce: «poiché sovente i bamb<strong>in</strong>i venivano battezzati quando ne capitava l’occasione, non era<br />
sempre possib<strong>il</strong>e o fac<strong>il</strong>e comunicarli (con la specie del v<strong>in</strong>o), e del resto le <strong>di</strong>sposizioni <strong>in</strong> materia – riguardando<br />
per sé <strong>il</strong> solo Battesimo solenne <strong>di</strong> Pasqua o <strong>di</strong> Pentecoste – potevano fac<strong>il</strong>mente essere eluse e cadere <strong>in</strong> desuetud<strong>in</strong>e»:<br />
A. VALSECCHI, «La storia della comunione ai fanciulli», 36.<br />
10 Cf A. VALSECCHI, «La storia della comunione ai fanciulli», 38-47.<br />
11 Il Conc<strong>il</strong>io <strong>di</strong> Trento, nella sessione XIII dell’11 ottobre 1551, ripropone l’<strong>in</strong>segnamento del Lateranense IV<br />
(DH 1659), ma non precisa quale sia l’età della <strong>di</strong>screzione. Nelle <strong>di</strong>scussioni precedenti la sessione XXI (16<br />
luglio 1562), affiora la questione sull’età precisa <strong>in</strong> cui ammettere i fanciulli alla comunione, ma <strong>il</strong> testo f<strong>in</strong>ale<br />
approvato dai Padri non conserva traccia degli <strong>in</strong>terventi <strong>in</strong> proposito (DH 1730): A. VALSECCHI, «La storia della<br />
comunione ai fanciulli», 47-51.<br />
4
nel cuore» del s<strong>in</strong>golo fedele. In questo contesto, non solo si presc<strong>in</strong>de dalla stretta relazione<br />
dell’eucaristia con gli altri due sacramenti dell’IC, ma la comunione eucaristica è considerata<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>pendentemente dalla stessa celebrazione della messa 12 .<br />
5. Sv<strong>il</strong>uppi nel XX secolo<br />
5.1. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> Pio X sulla comunione a sette anni – Nel 1910, con <strong>il</strong> decreto Quam<br />
s<strong>in</strong>gulari, Pio X chiarisce che «l’età della <strong>di</strong>screzione, tanto per la confessione quanto per la<br />
comunione, è quella <strong>in</strong> cui <strong>il</strong> bamb<strong>in</strong>o com<strong>in</strong>cia a ragionare, cioè verso <strong>il</strong> settimo anno, o più<br />
tar<strong>di</strong> o anche prima»; a partire da questa età, pertanto, «<strong>in</strong>com<strong>in</strong>cia l’obbligo <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare ad<br />
ambedue i precetti della confessione e della comunione» 13 . Al bamb<strong>in</strong>o che per la prima volta<br />
si accosta all’eucaristia non è richiesta una conoscenza completa e dettagliata della dottr<strong>in</strong>a<br />
cristiana; è sufficiente che, proporzionatamente all’età, sia <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> comprendere i fondamentali<br />
misteri della fede e sappia <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guere <strong>il</strong> pane eucaristico da quello ord<strong>in</strong>ario; tuttavia,<br />
dopo aver ricevuto la prima comunione, <strong>il</strong> bamb<strong>in</strong>o è tenuto a cont<strong>in</strong>uare ad apprendere gradualmente<br />
tutto <strong>il</strong> catechismo. L’<strong>in</strong>tervento <strong>di</strong> Pio X si <strong>in</strong>serisce <strong>in</strong> tutta un’azione pastorale,<br />
volta ad avvic<strong>in</strong>are i fedeli all’eucaristia, reagendo alla visione ispirata dai giansenisti, secondo<br />
cui la comunione sarebbe «un premio e non un rime<strong>di</strong>o alla frag<strong>il</strong>ità umana» 14 . Mentre<br />
vanno riconosciuti gli <strong>in</strong>dubbi meriti <strong>di</strong> un’azione <strong>di</strong> questo genere, non si possono tacere i<br />
due fondamentali limiti <strong>di</strong> cui <strong>il</strong> decreto soffre. Anzitutto esso risente della prospettiva ere<strong>di</strong>tata<br />
dal Me<strong>di</strong>oevo, che vede nella comunione eucaristica sostanzialmente un reme<strong>di</strong>um peccati:<br />
<strong>in</strong> effetti, <strong>il</strong> dovere <strong>di</strong> accostarsi alla comunione viene fatto co<strong>in</strong>cidere con l’età <strong>in</strong> cui un<br />
fanciullo, com<strong>in</strong>ciando ad essere <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> peccare, può perdere la grazia battesimale. In secondo<br />
luogo, la questione della prima comunione è affrontata senza che venga rivisto<br />
l’<strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> quella che noi chiamiamo l’IC dei fanciulli: «riportare la prima eucaristia ad<br />
un’età precoce senza <strong>in</strong>terrogarsi sulla confermazione significa entrare <strong>in</strong> una situazione <strong>in</strong>stab<strong>il</strong>e,<br />
almeno nei paesi <strong>in</strong> cui la confermazione viene celebrata all’<strong>in</strong>izio dell’adolescenza»<br />
15 . Neppure la questione del rapporto con la prima confessione è trattata con<br />
ampiezza; <strong>in</strong> proposito, <strong>il</strong> <strong>documento</strong> si limita a denunciare <strong>il</strong> fatto che la proibizione della<br />
confessione sacramentale per i bamb<strong>in</strong>i non ancora ammessi alla comunione eucaristica rischia<br />
<strong>di</strong> lasciarli <strong>in</strong> balia del peccato mortale 16 .<br />
5.2. Sv<strong>il</strong>uppi relativi alla confermazione – Limitandoci a registrare la prassi italiana all’<strong>in</strong>izio<br />
del XX secolo, r<strong>il</strong>eviamo che normalmente essa rispetta l’<strong>in</strong><strong>di</strong>cazione del CJC del 1917,<br />
che domanda la confermazione attorno ai sette anni: l’estensione limitata delle <strong>di</strong>ocesi e<br />
l’elevato numero <strong>di</strong> vescovi ne consentono <strong>in</strong> generale la collocazione <strong>in</strong> un momento <strong>di</strong> poco<br />
anteriore alla prima comunione 17 . Negli anni imme<strong>di</strong>atamente precedenti <strong>il</strong> Vaticano II, però,<br />
12<br />
S. SIRBONI, «Festa della prima comunione o prima partecipazione all’eucaristia?», Rivista <strong>di</strong> Pastorale Liturgica<br />
231 (2002/2) 25-31: 28-29.<br />
13<br />
Acta Apostolicae Se<strong>di</strong>s 2 (1910) 577-583, 582. Cf A. VALSECCHI, «La storia della comunione ai fanciulli», 59-<br />
63; A. HAQUIN, «Les décrets eucharistiques de Pie X», La Maison-Dieu 203 (1995) 61-82.<br />
14<br />
Acta Apostolicae Se<strong>di</strong>s 2 (1910), 579. Dove si era <strong>di</strong>ffuso <strong>il</strong> giansenismo (<strong>in</strong> Francia soprattutto), «si giunse a<br />
procast<strong>in</strong>are la Comunione f<strong>in</strong>o ai 19-20 anni: pers<strong>in</strong>o a 27-28 anni molti non venivano stimati ancora pronti per<br />
accedere all’Eucaristia, ed altri, già comunicati, dovevano attendere qualche anno prima <strong>di</strong> farlo nuovamente»:<br />
A. VALSECCHI, «La storia della comunione ai fanciulli», 55. Nella stessa l<strong>in</strong>ea antigiansenista va letto <strong>il</strong> decreto<br />
Sacra Trident<strong>in</strong>a Synodus (20 <strong>di</strong>cembre 1905), che <strong>in</strong>coraggia la comunione frequente e quoti<strong>di</strong>ana dei fedeli:<br />
Acta Sanctae Se<strong>di</strong>s, 38 (1905) 400-406.<br />
15<br />
A. HAQUIN, «Les décrets eucharistiques», 77.<br />
16<br />
Acta Apostolicae Se<strong>di</strong>s 2 (1910), 579.<br />
17<br />
Cf G. RIGGIO, «L’età della Confermazione <strong>in</strong> Italia. Stu<strong>di</strong>o storico», Rivista Liturgica 59 (1972) 402-414.<br />
5
i vescovi italiani propongono <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanziare più nettamente la celebrazione dei due sacramenti,<br />
rimandando la confermazione ad un’età più avanzata: <strong>in</strong> tal modo, <strong>di</strong>venterebbe possib<strong>il</strong>e assicurare<br />
una più compiuta educazione cristiana dei can<strong>di</strong>dati. La richiesta <strong>di</strong> una più accurata<br />
preparazione si collega generalmente ad una considerazione della confermazione come «sacramento<br />
della m<strong>il</strong>izia cristiana», che rende «perfetto cristiano» colui che la riceve e che,<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, comporta da parte del soggetto una particolare assunzione <strong>di</strong> responsab<strong>il</strong>ità. La questione<br />
dell’età della confermazione accompagna anche <strong>il</strong> lungo e sofferto iter della riforma<br />
dell’Ordo: mentre <strong>il</strong> gruppo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o specificamente <strong>in</strong>caricato <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re <strong>il</strong> problema si<br />
mostra piuttosto contrario all’<strong>in</strong>nalzamento dell’età rispetto ai sette anni, Paolo VI chiede a C.<br />
Vagagg<strong>in</strong>i <strong>di</strong> stendere l’abbozzo <strong>di</strong> un motu proprio, nel quale la confermazione sia considerata<br />
«sacramento dell’adolescenza», da conferirsi preferib<strong>il</strong>mente quando <strong>il</strong> ragazzo ha term<strong>in</strong>ato<br />
la «scuola dell’obbligo». La posizione contraria del Sant’Uffizio sp<strong>in</strong>ge a lasciar cadere<br />
l’idea <strong>di</strong> un <strong>documento</strong> pontificio sull’età della confermazione, per riconoscere <strong>in</strong>vece alle<br />
conferenze episcopali la facoltà <strong>di</strong> «stab<strong>il</strong>ire un’età più matura» rispetto ai sette anni, se ritengono<br />
che ciò favorisca «una congrua preparazione» alla recezione del sacramento (Ordo Confiramtionis<br />
– Praenotanda, n° 11). La CEI, da parte sua, ha deliberato che «l’età da richiedere<br />
per <strong>il</strong> conferimento della cresima è quella dei 12 anni circa» (decreto del 23.12.1983) 18 . Poiché<br />
all’<strong>in</strong>nalzamento dell’età della confermazione non si collega alcuna decisione relativa ad<br />
un’eventuale mo<strong>di</strong>fica dell’età della prima comunione, è evidente – anche se generalmente<br />
non viene esplicitato – che la confermazione debba essere ord<strong>in</strong>ariamente posticipata rispetto<br />
alla prima comunione.<br />
5.3. I <strong>di</strong>battiti attorno alla sequenza prima confessione-prima comunione – All’<strong>in</strong>izio degli<br />
anni ’70, <strong>in</strong> alcune <strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Germania, Olanda, Canada e Stati Uniti, si concede <strong>il</strong> permesso<br />
<strong>di</strong> posticipare la prima confessione dei fanciulli un anno o due dopo la prima comunione, celebrata<br />
verso i 7/8 anni. A favore <strong>di</strong> questa <strong>in</strong>novazione vengono portate motivazioni <strong>di</strong> carattere<br />
teologico e pedagogico. Sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o teologico, si ritiene più logico fare <strong>in</strong> modo che<br />
un fanciullo si accosti al sacramento della penitenza, dopo aver completato l’IC, attraverso la<br />
partecipazione alla mensa eucaristica. Infatti, come può essere sacramentalmente riaccolto<br />
nella Chiesa con la penitenza colui che, non avendo ancora ricevuto l’eucaristia, non è stato<br />
ancora pienamente accolto nella Chiesa? Dal punto <strong>di</strong> vista pedagogico, si sostiene che nel<br />
corso della maturazione spirituale <strong>di</strong> un fanciullo, la capacità <strong>di</strong> ricevere l’eucaristia si presenta<br />
prima della capacità <strong>di</strong> compiere <strong>il</strong> peccato mortale; <strong>di</strong> conseguenza, <strong>in</strong> un fanciullo <strong>di</strong> 7/8<br />
anni, non è necessario che <strong>il</strong> sacramento della penitenza preceda la recezione dell’eucaristia,<br />
perché <strong>il</strong> fanciullo <strong>di</strong>ffic<strong>il</strong>mente viene a trovarsi <strong>in</strong> quella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> peccato grave consapevole,<br />
che rende strettamente obbligatorio <strong>il</strong> ricorso alla confessione prima dell’eucaristia.<br />
Sempre dal punto <strong>di</strong> vista pedagogico, la nuova prassi avrebbe altri due vantaggi: evita i<br />
traumi psicologici che possono provenire da un uso troppo anticipato ed affrettato della confessione;<br />
favorisce una migliore preparazione catechetica al sacramento della penitenza.<br />
Nel 1973 la S. Sede chiede <strong>di</strong> concludere gli esperimenti avviati e nel 1977 <strong>di</strong>chiara <strong>il</strong>lecita<br />
l’ammissione dei fanciulli alla comunione senza previa ammissione alla confessione. Il testo<br />
che maggiormente aiuta a comprendere <strong>il</strong> senso <strong>di</strong> tali norme è la lettera che J. Ratz<strong>in</strong>ger, allora<br />
arcivescovo <strong>di</strong> München e Freis<strong>in</strong>g, scrive alla sua <strong>di</strong>ocesi nel novembre del 1977, proprio<br />
per spiegare <strong>il</strong> senso delle <strong>di</strong>rettive venute da Roma. Anche nello scritto <strong>di</strong> Ratz<strong>in</strong>ger<br />
18 Un <strong>in</strong>quadramento <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione si trova <strong>in</strong> A. LAMERI, «Il sacramento della confermazione. Evoluzione<br />
storica della prassi sacramentale dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana e criteri teologico-pastorali circa la scelta dell’età<br />
del conferimento», Rivista Liturgica 91/1 (2004) 83-105: 98-100.<br />
6
possiamo <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guere alcune osservazioni <strong>di</strong> tipo teologico ed altre <strong>di</strong> tipo pedagogico. Dal<br />
punto <strong>di</strong> vista teologico, «la preparazione alla comunione <strong>in</strong>clude per natura sua la preparazione<br />
alla confessione (già nella sua piena forma sacramentale) e <strong>in</strong> ogni caso senza <strong>di</strong> essa si<br />
perderebbe una sua <strong>di</strong>mensione essenziale» 19 . La stessa struttura della Messa, che prevede<br />
momenti quali l’atto penitenziale e la richiesta <strong>di</strong> perdono prima della comunione, mostra che<br />
«l’eucaristia non è pensab<strong>il</strong>e senza la componente della conversione, della confessione e del<br />
perdono» 20 ; <strong>in</strong> questa l<strong>in</strong>ea, la confessione personale sacramentale contribuisce a dare verità<br />
alle <strong>in</strong>vocazioni <strong>di</strong> perdono proposte dalla liturgia eucaristica. Dal punto <strong>di</strong> vista pedagogico,<br />
Ratz<strong>in</strong>ger ritiene che una preparazione adeguata alla confessione possa contribuire positivamente<br />
alla maturazione organica e serena del fanciullo. Queste osservazioni non sono però <strong>in</strong><br />
grado <strong>di</strong> sciogliere tutte le perplessità, soprattutto sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o teologico 21 .<br />
5.4. La pubblicazione ed <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ievo dell’OICA – In tema <strong>di</strong> IC, <strong>il</strong> fatto più significativo del<br />
sec. XX è stato certamente la promulgazione dell’Ordo Initiationis Christianae Adultorum<br />
(1972 – traduzione italiana 1978), con le due fondamentali acquisizioni che esso comporta: la<br />
riscoperta dell’unità dei sacramenti dell’IC e la re<strong>in</strong>troduzione del catecumenato. Queste due<br />
acquisizioni sono <strong>il</strong> frutto della convergenza <strong>di</strong> due fattori: lo stu<strong>di</strong>o della tra<strong>di</strong>zione liturgicopastorale<br />
della Chiesa antica e la necessità <strong>di</strong> rispondere ad esigenze pastorali attuali: la presenza<br />
cioè <strong>di</strong> adulti che chiedono <strong>il</strong> battesimo <strong>in</strong> contesti che – anche <strong>in</strong> Europa – sono sempre<br />
più secolarizzati. Il r<strong>il</strong>ievo dell’OICA va al <strong>di</strong> là del suo ut<strong>il</strong>izzo effettivo e si colloca sia a livello<br />
teologico che a livello pastorale. A livello teologico, a partire dagli anni ’70, è ricorrente<br />
l’affermazione secondo cui quella proposta dall’OICA è la figura “normale”/normativa del<br />
battesimo: ciò significa che, per comprendere adeguatamente <strong>il</strong> senso teologico del battesimo,<br />
bisogna assumere come riferimento <strong>il</strong> caso <strong>di</strong> una persona adulta, che viene battezzzata sulla<br />
base <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> fede personale, dopo avere compiuto l’iter catecumenale. Nella figura <strong>di</strong> IC<br />
che la Chiesa propone <strong>in</strong> questo caso, <strong>in</strong>fatti, è possib<strong>il</strong>e cogliere nel modo più nitido gli elementi<br />
che strutturano l’IC. In maniera analogica e con i dovuti adattamenti, questi elementi<br />
strutturanti si possono ritrovare poi nel battesimo dei bamb<strong>in</strong>i. In questo quadro, la proposta<br />
della celebrazione unitaria <strong>di</strong> battesimo, cresima ed eucaristia ha contribuito a <strong>di</strong>ffondere la<br />
conv<strong>in</strong>zione secondo cui lo sguardo a questi sacramenti nella loro globalità ed ai rapporti che<br />
li legano l’uno all’altro debba precedere l’analisi specifica <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi e ne favorisca<br />
una più adeguata comprensione. È <strong>in</strong> questa l<strong>in</strong>ea che si colloca la riflessione teologicosistematica<br />
che segue.<br />
19<br />
J. RATZINGER, Prima comunione e prima confessione dei fanciulli, LDC, Leumann (To) 1978, 6.<br />
20<br />
J. RATZINGER, Prima comunione, 8.<br />
21<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista teologico, la questione è stata riproposta tra gli altri da R. Tononi, secondo <strong>il</strong> quale la prassi<br />
consueta (prima confessione e prima comunione) «contrad<strong>di</strong>ce <strong>il</strong> pieno senso teologico del sacramento della<br />
riconc<strong>il</strong>iazione, <strong>in</strong> quanto impone la necessità della celebrazione sacramentale della penitenza a chi non è ancora<br />
pienamente cristiano»: R. TONONI, «L’<strong>in</strong>iziazione cristiana»: 176. «Infatti, se <strong>il</strong> sacramento della penitenza è <strong>il</strong><br />
sacramento del perdono per chi è già <strong>di</strong>ventato cristiano, la logica esige <strong>di</strong> riconoscere che esso è pienamente<br />
sensato solo quando viene dato a un fedele che è pienamente cristiano, cioè che è già completamente <strong>in</strong>serito nel<br />
mistero <strong>di</strong> Cristo e della Chiesa attraverso la ricezione <strong>di</strong> tutti i sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana»: R. TONONI,<br />
«L’<strong>in</strong>iziazione cristiana», 170.<br />
7
II. RIFLESSIONE TEOLOGICO-SISTEMATICA<br />
1. L’“architettura” globale dei sacramenti d’<strong>in</strong>iziazione<br />
Nel presentare i sacramenti dell’IC, è necessario anzitutto <strong>il</strong>lum<strong>in</strong>are la logica che li collega.<br />
Tale logica fa perno non tanto sul sacramento che cronologicamente «apre la serie», cioè <strong>il</strong><br />
battesimo, quanto piuttosto su quello che rappresenta <strong>il</strong> punto d’arrivo dell’IC, cioè l’eucaristia.<br />
Seguendo la proposta <strong>di</strong> A. Caprioli, possiamo <strong>in</strong><strong>di</strong>care l’<strong>in</strong>serimento pieno e def<strong>in</strong>itivo<br />
nella Chiesa come la f<strong>in</strong>alità dell’IC; <strong>di</strong> conseguenza, dal punto <strong>di</strong> vista sacramentale, tale f<strong>in</strong>alità<br />
può <strong>di</strong>rsi raggiunta quando <strong>il</strong> credente viene <strong>in</strong>trodotto all’eucaristia, <strong>il</strong> sacramento che<br />
«e<strong>di</strong>fica la Chiesa nella sua fase storica e terrena» 22 . L’eucaristia appare dunque come <strong>il</strong><br />
«term<strong>in</strong>e» cui l’IC è orientata, la realtà <strong>in</strong> cui essa «sfocia»: <strong>in</strong> sostanza, «si tratta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare<br />
pienamente le membra del corpo ecclesiale <strong>di</strong> Cristo partecipando al suo corpo eucaristico» 23 .<br />
La collocazione dell’eucaristia come «term<strong>in</strong>e» dell’<strong>in</strong>iziazione <strong>in</strong>troduce una sorta <strong>di</strong> «asimmetria»<br />
tra l’eucaristia stessa e gli altri due sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione. Una asimmetria che<br />
trova riscontro <strong>in</strong> un dato <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata ed <strong>in</strong>controvertib<strong>il</strong>e evidenza: battesimo e confermazione<br />
sono gesti irripetib<strong>il</strong>i, che segnano una volta per sempre chi li riceve; l’eucaristia, <strong>in</strong>vece,<br />
viene regolarmente ripetuta e scan<strong>di</strong>sce <strong>il</strong> ritmo della vita delle comunità cristiane. Tale<br />
asimmetria che può essere rigorosamente espressa <strong>in</strong> questi term<strong>in</strong>i:<br />
Battesimo e confermazione sarebbero solo sacramenti <strong>di</strong> <strong>in</strong>iziazione o aggregazione<br />
alla comunità ecclesiale, non [propriamente] <strong>di</strong> costituzione della comunità ecclesiale<br />
[…]. Sacramento <strong>di</strong> costituzione della Chiesa <strong>in</strong> quanto tale sarebbe piuttosto<br />
l’eucaristia […]; battesimo e confermazione <strong>in</strong>vece aggregherebbero nuovi fedeli alla<br />
Chiesa già costituita dall’eucaristia e come tale già celebrante l’eucaristia […]. In<br />
questo senso si dovrebbe parlare <strong>di</strong> battesimo e confermazione come sacramenti <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>iziazione all’eucaristia 24 .<br />
In quanto «sacramenti <strong>di</strong> <strong>in</strong>iziazione all’eucaristia», battesimo e confermazione – considerati<br />
anzitutto nella loro reciproca connessione – hanno lo scopo <strong>di</strong> far partecipare <strong>il</strong> credente alla<br />
mensa eucaristica, realizzando quella «r<strong>in</strong>ascita dall’acqua e dallo Spirito» che è presupposto<br />
necessario <strong>di</strong> tale partecipazione. Di questa r<strong>in</strong>ascita, ciascuno dei due sacramenti esplicita un<br />
aspetto: <strong>il</strong> battesimo si presenta soprattutto come momento <strong>di</strong> svolta esistenziale, che segna <strong>il</strong><br />
passaggio da un’esistenza <strong>di</strong> peccato alla realizzazione <strong>di</strong> una vita nuova (<strong>il</strong> che implica già<br />
l’azione dello Spirito); la confermazione, da parte sua, appare orientata proprio allo sv<strong>il</strong>uppo<br />
positivo della vita nuova, me<strong>di</strong>ante la comunicazione del dono dello Spirito. Cerchiamo ora <strong>di</strong><br />
svolgere queste affermazioni, qui del<strong>in</strong>eate <strong>in</strong> maniera molto s<strong>in</strong>tetica.<br />
22<br />
A. CAPRIOLI, Vi laverò con acqua pura. Catechesi sui sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana, Ancora, M<strong>il</strong>ano<br />
1981, 29.<br />
23<br />
L.-M. CHAUVET, «I sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana», <strong>in</strong> Assemblea Santa. Manuale <strong>di</strong> liturgia pastorale,<br />
EDB, Bologna 1990, 207-224: 208. È quanto si ricava da Presbyterorum Ord<strong>in</strong>is 5: «Fideles, iam sacro baptismate<br />
et confirmatione signati, plene per receptionem Eucharistiae Corpori Christi <strong>in</strong>seruntur». È l’eucaristia che<br />
attua pienamente l’<strong>in</strong>corporazione alla Chiesa, cui l’<strong>in</strong>corporazione battesimale è strutturalmente orientata: cf P.<br />
CASPANI, La pert<strong>in</strong>enza teologica della nozione <strong>di</strong> <strong>in</strong>iziazione cristiana, Glossa, M<strong>il</strong>ano 1999, 816-817.<br />
24<br />
A. CAPRIOLI, «L’<strong>in</strong>iziazione cristiana: aspetti generali, battesimo e confermazione», <strong>in</strong> Celebrare <strong>il</strong> mistero <strong>di</strong><br />
Cristo. Manuale <strong>di</strong> liturgia a cura dell’Associazione Professori <strong>di</strong> Liturgia, 2. La celebrazione dei sacramenti,<br />
CLV - E<strong>di</strong>zioni Liturgiche, Roma 1996, 53-124: 96. «L’Eucaristia è al vertice dei sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione,<br />
ma non si identifica con quelli né <strong>in</strong> essi si appiattisce; non può essere equiparata a quelli: l’Eucaristia è al<br />
term<strong>in</strong>e dell’<strong>in</strong>iziazione, […] quella realtà <strong>in</strong> cui sfocia l’<strong>in</strong>iziazione»: G. MAZZANTI, I sacramenti simbolo e<br />
teologia, 2. Eucaristia, Battesimo e Confermazione, EDB, Bologna 1998, 260.<br />
8
2. L’eucaristia pr<strong>in</strong>ceps analogatum dei sacramenti e sacramento che «fa la Chiesa»<br />
Nell’eucaristia la realtà del sacramento si realizza pienamente, perché l’eucaristia è per eccellenza<br />
<strong>il</strong> sacramento della Pasqua <strong>di</strong> Cristo; è quanto la scolastica <strong>in</strong>tendeva affermare, parlando<br />
dell’eucaristia come pr<strong>in</strong>ceps analogatum <strong>in</strong> rapporto agli altri sacramenti: <strong>in</strong> essa la realtà<br />
del sacramento trova compiuta attuazione, mentre negli altri sacramenti si dà <strong>in</strong> maniera analogica,<br />
come per partecipazione 25 .<br />
L’em<strong>in</strong>enza dell’eucaristia nell’ord<strong>in</strong>e sacramentale è un dato che la tra<strong>di</strong>zione teologica non ha<br />
mai messo <strong>in</strong> <strong>di</strong>scussione. A questo proposito, Tommaso def<strong>in</strong>isce l’eucaristia f<strong>in</strong>is et consummatio<br />
omnium sacramentorum (Summa Theologiae, III, q. 63, a. 3): <strong>in</strong> quanto è f<strong>in</strong>is, tutti i sacramenti<br />
tendono ad essa, come verso ciò per cui sono fatti; <strong>in</strong> quanto è consummatio, <strong>in</strong> essa<br />
tutti i sacramenti trovano <strong>il</strong> loro pieno compimento. Questo ruolo centrale dell’eucaristia le deriva<br />
dal fatto che <strong>in</strong> essa «è contenuto tutto <strong>il</strong> mistero della nostra salvezza» (q. 83, a. 4). In questa<br />
prospettiva, i sette sacramenti non si configurano come «entità» autonome e fra loro irrelate,<br />
bensì come esplicitazioni <strong>di</strong>verse dell’unico mistero, «onde concentriche, scaturenti da un unico<br />
punto d<strong>in</strong>amico, che è l’eucaristia» 26 . Il Conc<strong>il</strong>io <strong>di</strong> Trento, da parte sua, esprime la «pr<strong>in</strong>cipalità»<br />
dell’eucaristia, affermando che, mentre gli altri sacramenti contengono l’efficacia santificatrice,<br />
nell’eucaristia è presente substantialiter «lo stesso autore della santità», dal quale proviene<br />
ogni efficacia santificatrice (DH 1636, 1639).<br />
Nella prospettiva della teologia eucaristica contemporanea, <strong>in</strong>fluenzata dalla riflessione <strong>di</strong> O.<br />
Casel, l’affermazione del primato dell’eucaristia può essere riespressa <strong>in</strong> questi term<strong>in</strong>i: quella<br />
presenza dell’evento pasquale, cui tutti i sacramenti si riferiscono, trova nell’eucaristia una<br />
realizzazione <strong>in</strong>superab<strong>il</strong>e. Grazie alla transustanziazione del pane e del v<strong>in</strong>o, <strong>in</strong>fatti, la partecipazione<br />
all’evento salvifico assume ad<strong>di</strong>rittura la forma dell’<strong>in</strong>contro sacramentale con <strong>il</strong><br />
corpo e <strong>il</strong> sangue del Signore, che solo nelle specie eucaristiche sono «contenuti» <strong>in</strong> forma<br />
permanente e sostanziale. In nessun altro sacramento, al <strong>di</strong> fuori dell’eucaristia, la presenza<br />
della Pasqua si dà <strong>in</strong> un modo così «<strong>in</strong>tenso» da toccare la realtà profonda degli elementi sacramentali,<br />
che – <strong>in</strong> questo caso e solo <strong>in</strong> questo – <strong>di</strong>ventano vere realiter et substantialiter <strong>il</strong><br />
corpo dato e <strong>il</strong> sangue versato del Signore. A questo aspetto fondamentale, va aggiunto un dato<br />
ulteriore. Mentre gli altri sacramenti fanno memoria della Pasqua <strong>in</strong> riferimento <strong>di</strong>retto a<br />
specifiche situazioni del s<strong>in</strong>golo cristiano (<strong>il</strong> cristiano peccatore, <strong>il</strong> cristiano malato…), l’eucaristia,<br />
tanto nel suo modo <strong>di</strong> realizzarsi quanto nelle sua oggettiva dest<strong>in</strong>azione, è più chiaramente<br />
f<strong>in</strong>alizzata alla comunione ecclesiale. Certo tutti i sacramenti «fanno la Chiesa», ma<br />
questa f<strong>in</strong>alità acquista particolare risalto nel caso dell’eucaristia, proprio perché essa ripropone<br />
la memoria della Pasqua <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i generali e globali, senza particolari riferimenti a situazioni<br />
specifiche dell’esistenza cristiana.<br />
In questa l<strong>in</strong>ea, ci proponiamo <strong>di</strong> svolgere la tesi seguente: la f<strong>in</strong>alità propria dell’eucaristia,<br />
la sua ragion d’essere, è la comunione degli uom<strong>in</strong>i con <strong>il</strong> sacrificio <strong>di</strong> Gesù Cristo. In altri<br />
25 «Questo carattere primario dell’eucaristia comporta che gli altri sacramenti trov<strong>in</strong>o <strong>il</strong> loro senso ultimo proprio<br />
<strong>in</strong> rapporto all’eucaristia. In altri term<strong>in</strong>i: la parola “sacramento” è una parola analogica, <strong>il</strong> vuol <strong>di</strong>re che si<br />
applica a ciascun sacramento <strong>in</strong> modo identico e <strong>di</strong>verso, non trovando la sua piena realizzazione che nell’eucaristia»:<br />
G. LAFONT, «Presentazione», <strong>in</strong> A. GRILLO - M. PERRONI - P. R. TRAGAN (edd.), Corso <strong>di</strong> teologia sacramentaria,<br />
1. Meto<strong>di</strong> e prospettive, <strong>Brescia</strong>, Quer<strong>in</strong>iana, 2000, 7-20: 16. Questa prospettiva è sv<strong>il</strong>uppata da A.<br />
GRILLO, «L’eucaristia al centro del settenario sacramentale. Decl<strong>in</strong>o e ripresa <strong>di</strong> un assioma sistematico», <strong>in</strong><br />
Corso <strong>di</strong> teologia sacramentaria, 2. I sacramenti della salvezza, <strong>Brescia</strong>, Quer<strong>in</strong>iana, 2000, 65-92.<br />
26 J.M.R. TILLARD, «Le “votum Eucharistiae”: l’Eucharistie dans le rencontre des chrétiens», <strong>in</strong> Miscellanea<br />
liturgica <strong>in</strong> onore <strong>di</strong> Sua Em<strong>in</strong>enza <strong>il</strong> Card<strong>in</strong>ale Giacomo Lercaro, Desclée & Co., Roma 1967, II, 143-194: 156.<br />
9
term<strong>in</strong>i: la f<strong>in</strong>alità dell’eucaristia è l’esserci della Chiesa, def<strong>in</strong>ib<strong>il</strong>e come l’umanità associata<br />
al sacrificio <strong>di</strong> Cristo.<br />
Quando parliamo <strong>di</strong> «sacrificio <strong>di</strong> Cristo», ci riferiamo non solo alla passione e alla croce, bensì<br />
all’unità salvifica del mistero pasquale, nel suo duplice aspetto <strong>di</strong> morte e risurrezione; nell’eucaristia<br />
<strong>il</strong> Signore risorto – <strong>in</strong> virtù dello Spirito –ci rende partecipi della sua autodonazione, ci<br />
pone <strong>in</strong> comunione con sé, nell’atto del suo consegnarsi sulla croce; la comunione con la croce<br />
<strong>di</strong> Cristo è, <strong>in</strong>fatti, per noi passaggio obbligato e con<strong>di</strong>zione impresc<strong>in</strong><strong>di</strong>b<strong>il</strong>e per partecipare alla<br />
sua risurrezione gloriosa.<br />
Sulla scia della riflessione <strong>di</strong> Casel, la teologia contemporanea riconosce nella celebrazione<br />
eucaristica la presenza reale sacramentale del sacrificio <strong>di</strong> Cristo: l’eucaristia celebra, ripropone,<br />
rende sacramentalmente presente <strong>il</strong> sacrificio della croce 27 . Questa acquisizione fondamentale<br />
permette <strong>di</strong> r<strong>il</strong>eggere <strong>in</strong> maniera unitaria <strong>il</strong> tema degli effetti/f<strong>in</strong>alità dell’eucaristia,<br />
che la teologia dei manuali aveva trattato <strong>in</strong> due capitoli <strong>di</strong>st<strong>in</strong>ti ed irrelati: uno relativo agli<br />
effetti della comunione eucaristica, l’altro relativo agli effetti del sacrificio della messa. Se <strong>il</strong><br />
«contenuto» della celebrazione eucaristica/messa è <strong>il</strong> sacrificio <strong>di</strong> Cristo, reso presente <strong>in</strong> maniera<br />
sacramentale, l’effetto della celebrazione è precisamente la partecipazione sacramentale<br />
al sacrificio <strong>di</strong> Cristo, che si realizza <strong>in</strong> pienezza per quanti si accostano alla comunione sacramentale.<br />
SC 55 designa come «più perfetta» (perfectior) la partecipazione alla messa comprensiva della<br />
comunione; con ciò non si vuole <strong>in</strong>s<strong>in</strong>uare l’idea che la comunione eucaristica sia un «<strong>di</strong> più»,<br />
che si aggiunge estr<strong>in</strong>secamente ad una partecipazione già <strong>in</strong> se stessa perfetta; si vuole <strong>in</strong>vece<br />
affermare che la partecipazione alla Messa trova <strong>il</strong> suo naturale e logico sbocco nella comunione<br />
sacramentale.<br />
Da un lato, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, la partecipazione piena e reale al sacrificio <strong>di</strong> Cristo si attua me<strong>di</strong>ante la<br />
comunione sacramentale; dall’altro, la comunione sacramentale con Cristo implica/comporta<br />
la comunione col suo sacrificio: andare alla comunione significa qu<strong>in</strong><strong>di</strong> lasciarsi co<strong>in</strong>volgerenel<br />
sacrificio <strong>di</strong> Cristo. La comunione eucaristica (a partire dalla «prima comunione») non va<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong> pensata anzitutto come l’esperienza <strong>di</strong> una visita <strong>in</strong><strong>di</strong>viduale del Signore, quanto piuttosto<br />
come la partecipazione al sacrificio <strong>di</strong> Cristo e la con<strong>di</strong>visione della sua de<strong>di</strong>zione. In<br />
quanto l’eucaristia ci <strong>in</strong>corpora a Cristo e ci rende partecipi del suo sacrificio, essa genera la<br />
Chiesa, <strong>in</strong>tesa come <strong>il</strong> popolo <strong>di</strong> coloro che, partecipando al sacrificio <strong>di</strong> Cristo, sono sollecitati<br />
a vivere la sua stessa carità. Incorporazione a Cristo e costituzione della Chiesa non sono<br />
due azioni giustapposte o successive; <strong>in</strong> realtà, proprio mentre ci pone <strong>in</strong> comunione con Cristo,<br />
l’eucaristia realizza la comunione tra tutti coloro che vivono la medesima relazione con<br />
Lui, rendendoci <strong>in</strong> Lui «un solo corpo e un solo spirito».<br />
Per esprimere l’<strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca relazione esistente fra la Chiesa e l’eucaristia, si usa spesso ripetere<br />
l’affermazione <strong>di</strong> De Lubac, secondo cui tra la Chiesa e l’eucaristia esiste una «reciproca causalità»:<br />
«È la Chiesa che fa l’eucaristia, ma è anche l’eucaristia che fa la Chiesa» 28 . Va precisato<br />
che la reciprocità fra le due azioni è «asimmetrica»: la «causalità» dell’eucaristia nei confronti<br />
della Chiesa non può essere messa sullo stesso piano della causalità che la Chiesa esercita nei<br />
27 Mi riferisco <strong>in</strong> particolare alla riflessione sv<strong>il</strong>uppata da G. Colombo (1923-2005) e che si ritrova nei saggi<br />
pubblicati <strong>in</strong> G. COLOMBO, Teologia sacramentaria (= Quaestio 6), Glossa, M<strong>il</strong>ano 1997.<br />
28 H. DE LUBAC, Me<strong>di</strong>tazione sulla Chiesa, Jaca Book, M<strong>il</strong>ano 1979, 82.<br />
10
confronti dell’eucaristia 29 . Certamente la Chiesa fa l’eucaristia, poiché non c’è eucaristia senza<br />
l’azione dei <strong>di</strong>scepoli che, <strong>in</strong> obbe<strong>di</strong>enza al comando <strong>di</strong> Cristo, ne celebrano la memoria. Più<br />
profondamente, però, è l’eucaristia che fa la Chiesa: è Gesù Cristo che, col suo sacrificio reso<br />
presente nell’eucaristia, fa la Chiesa. Il gesto celebrativo con cui la Chiesa fa l’eucaristia, <strong>in</strong><br />
fondo, è un fare spazio all’azione <strong>di</strong> Colui che, operando nell’azione della Chiesa, associa gli<br />
uom<strong>in</strong>i al suo sacrificio, e<strong>di</strong>ficando così la Chiesa stessa. La Chiesa, dunque, fa l’eucaristia (la<br />
celebra) per essere fatta dall’eucaristia, per ritrovare cont<strong>in</strong>uamente se stessa, nella sua realtà <strong>di</strong><br />
popolo che ha la propria orig<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Gesù Cristo e vive animato dalla carità <strong>di</strong> Gesù Cristo.<br />
Rispolverando <strong>il</strong> l<strong>in</strong>guaggio scolastico, potremmo <strong>di</strong>re che l’eucaristia fa la Chiesa, perché ne<br />
costituisce la causa efficiente e formale: è ciò che ontologicamente fa essere la Chiesa (causa<br />
efficiente), dandole forma e struttura (causa formale), la forma e la struttura della de<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
Cristo 30 . In questa l<strong>in</strong>ea, Presbyterorum Ord<strong>in</strong>is 5 estende anche all’apostolato le affermazioni<br />
<strong>di</strong> Tommaso sull’ord<strong>in</strong>amento <strong>di</strong> tutti i sacramenti all’eucaristia: «Tutti i sacramenti,<br />
come pure tutti i m<strong>in</strong>isteri ecclesiastici e le opere <strong>di</strong> apostolato, sono strettamente uniti (cohaerent)<br />
alla sacra eucaristia e ad essa sono ord<strong>in</strong>ati» 31 . In altri term<strong>in</strong>i, ogni azione pastorale –<br />
<strong>in</strong> quanto tende all’e<strong>di</strong>ficazione della Chiesa – è autentica nella misura <strong>in</strong> cui è coerente con la<br />
logica <strong>in</strong>scritta nell’eucaristia e trova <strong>in</strong> essa <strong>il</strong> proprio pr<strong>in</strong>cipio ispiratore. Un pr<strong>in</strong>cipio che<br />
evidentemente determ<strong>in</strong>a <strong>il</strong> f<strong>in</strong>e dell’azione pastorale: realizzare la conformità dei credenti a<br />
Gesù Cristo nel donare <strong>il</strong> proprio corpo e sangue – cioè la propria vita. Il problema fondamentale,<br />
qui, è fare <strong>in</strong> modo che la conformità ontologica a Cristo operata dal sacramento trovi effettiva<br />
espressione sia nel modo <strong>di</strong> attuare la celebrazione, sia oltre la celebrazione, traducendosi<br />
nella pratica personale e comunitaria della carità come scelta ra<strong>di</strong>cale <strong>di</strong> vita e «segno <strong>di</strong>st<strong>in</strong>tivo»<br />
dell’esistenza cristiana 32 . Perseguendo questa f<strong>in</strong>alità, la Chiesa adempie la propria<br />
missione <strong>di</strong> annunciare Gesù Cristo: dove l’annuncio <strong>di</strong> Cristo non si riduce ad una comunicazione<br />
verbale su <strong>di</strong> Lui, ma si esprime nell’esistenza umana vissuta secondo Gesù Cristo. A<br />
questo proposito risultano pert<strong>in</strong>enti alcune osservazioni <strong>di</strong> don P<strong>in</strong>o Colombo:<br />
La qualifica <strong>di</strong> «corpo <strong>di</strong> Cristo» [riferita alla Chiesa] è sempre da comprendere più<br />
come un comandamento o una vocazione a <strong>di</strong>ventare <strong>il</strong> «corpo <strong>di</strong> Cristo» che non<br />
come <strong>il</strong> riconoscimento <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione acquisita. La con<strong>di</strong>zione è acquisita solo<br />
quando lo Spirito <strong>di</strong> Gesù Cristo [quello Spirito che <strong>in</strong> ogni celebrazione <strong>in</strong>vochiamo<br />
<strong>in</strong> pienezza su coloro che si comunicano] s’impossessa realmente del nostro spirito,<br />
lo purifica dall’amore egoistico <strong>di</strong> sé e lo trasforma ispirandogli <strong>il</strong> vero amore,<br />
l’amore per gli altri, pr<strong>in</strong>cipio <strong>di</strong> nuovi rapporti: <strong>di</strong> servizio, <strong>in</strong>vece che <strong>di</strong> sfruttamento,<br />
<strong>di</strong> pace <strong>in</strong>vece che d’<strong>in</strong>imicizia, <strong>di</strong> fiducia <strong>in</strong>vece che <strong>di</strong> sospetto 33 .<br />
La necessità <strong>di</strong> ripetere regolarmente la celebrazione eucaristica è dunque legata alla necessità<br />
che la comunità cristiana – ed <strong>in</strong> essa <strong>il</strong> s<strong>in</strong>golo credente – si lasci cont<strong>in</strong>uamente riplasmare<br />
dallo Spirito per rispondere alla sua vocazione a <strong>di</strong>ventare «<strong>il</strong> corpo <strong>di</strong> Cristo».<br />
29 «È anzitutto l’eucaristia che fa la Chiesa. Si può veramente <strong>di</strong>re che fra la Chiesa e l’eucaristia c’è una<br />
“causalità reciproca”? Non lo pensiamo. La formula non è reversib<strong>il</strong>e»: H. BLOCK, «L’eucharistie fait-elle<br />
toujours l’Église?», La Maison-Dieu 223 (2000/3) 73-92: 84 [trad. nostra].<br />
30 Per uno sv<strong>il</strong>uppo del tema, cf D. AMATO, «Eucaristia e forma ecclesiae», Odegitria 11 (2004) 29-70.<br />
31 La nota 15 <strong>di</strong> Presbyterorum Ord<strong>in</strong>is riporta l’affermazione <strong>di</strong> Tommaso, secondo cui l’eucaristia è «quasi<br />
consummatio spiritualis vitae et omnium sacramentorum f<strong>in</strong>is» (Summa Theologiae, III, q. 63, a. 3; cf III, q. 65,<br />
a. 3).<br />
32 Cf T. CITRINI, «L’Eucaristia epifania della Chiesa», <strong>in</strong> Eucaristia genesi della comunità. Celebrazione domenicale<br />
e camm<strong>in</strong>o della Chiesa, Ancora, M<strong>il</strong>ano 1999, 7-23, 11-19.<br />
33 G. COLOMBO, L’ord<strong>in</strong>e cristiano, Glossa, M<strong>il</strong>ano 1993, 60.<br />
11
In coerenza con l’architettura dei sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione del<strong>in</strong>eata all’<strong>in</strong>izio, a questo<br />
punto cerchiamo <strong>di</strong> r<strong>il</strong>eggere <strong>il</strong> senso del battesimo e della confermazione nella loro comune<br />
f<strong>in</strong>alità <strong>di</strong> <strong>in</strong>trodurre alla comunione eucaristica, ma – più ra<strong>di</strong>calmente – alla celebrazione<br />
eucaristica.<br />
3. Il battesimo, «porta» dell’eucaristia<br />
Anzitutto <strong>il</strong> battesimo non va semplicemente giustapposto all’eucaristia, ma va ripensato nella<br />
sua funzione <strong>di</strong> <strong>in</strong>trodurre all’eucaristia, <strong>di</strong> cui costituisce <strong>il</strong> necessario «portale d’accesso»<br />
34 . La necessità <strong>di</strong> essere battezzati per poter accedere alla mensa eucaristica (e, per sé, alla<br />
stessa celebrazione eucaristica) è un dato costante nella tra<strong>di</strong>zione cristiana, che può essere<br />
giustificato anzitutto dal punto <strong>di</strong> vista ecclesiologico: per poter celebrare l’eucaristia – e, a<br />
maggior ragione, per potervi partecipare nel modo più pieno grazie alla comunione sacramentale<br />
– occorre essere aggregati «alla Chiesa già costituita dall’eucaristia e come tale già celebrante<br />
l’eucaristia» 35 . In una prospettiva <strong>di</strong> antropologia teologica, la necessità del battesimo<br />
<strong>in</strong> vista dell’eucaristia si chiarisce osservando che l’uomo non può entrare <strong>in</strong> relazione all’evento<br />
nel quale si dà sacramentalmente la Pasqua <strong>di</strong> Cristo, se non perché Cristo stesso gli dà<br />
<strong>di</strong> accedervi; l’uomo non può accedere all’eucaristia senza esservi <strong>in</strong>iziato me<strong>di</strong>ante un atto<br />
nel quale – attraverso l’azione rituale della Chiesa – è Cristo stesso che lo <strong>in</strong>troduce nella ripresentazione<br />
sacramentale della sua Pasqua. Ciò rivela l’uomo come colui che – da sé – non<br />
può <strong>di</strong>sporre del rapporto a quell’evento nel quale pure sta <strong>il</strong> senso della sua esistenza; <strong>il</strong> rapporto<br />
dell’uomo all’evento della Pasqua – sacramentalmente me<strong>di</strong>ato nell’eucaristia – non è<br />
possib<strong>il</strong>e se non grazie ad un atto <strong>di</strong> Gesù Cristo, che, nella forza dello Spirito, una volta per<br />
sempre ed <strong>in</strong> maniera irreversib<strong>il</strong>e, ab<strong>il</strong>ita l’uomo ad entrare <strong>in</strong> tale rapporto: questo atto è,<br />
appunto, <strong>il</strong> battesimo.<br />
4. La collocazione ed <strong>il</strong> senso della confermazione<br />
Quanto alla confermazione, teologi, storici e liturgisti sono concor<strong>di</strong> nel ritenere che la sua<br />
collocazione all’<strong>in</strong>terno dei sacramenti dell’IC sia quella più adeguata per ritrovare <strong>il</strong> senso<br />
proprio <strong>di</strong> questo sacramento. Ciò implica anzitutto che si rifletta sul suo rapporto col battesimo:<br />
anche quando la confermazione è legittimamente celebrata con un rito <strong>di</strong>st<strong>in</strong>to dal battesimo,<br />
<strong>il</strong> suo senso può essere colto, mettendo <strong>in</strong> luce più ciò che la raccorda al battesimo che<br />
ciò che da esso la <strong>di</strong>st<strong>in</strong>gue. Su questo sfondo, molti Autori ricercano <strong>il</strong> significato specifico<br />
della confermazione, riferendosi al legame tra questo sacramento e lo Spirito santo. Quanto al<br />
modo <strong>in</strong> cui tale rapporto viene determ<strong>in</strong>ato, si possono fondamentalmente <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guere due l<strong>in</strong>ee<br />
36 . Un primo orientamento accomuna quegli Autori che, pur riconoscendo lo stretto rapporto<br />
tra battesimo e confermazione, si preoccupano comunque <strong>di</strong> cercare nella confermazione<br />
effetti <strong>di</strong>versi rispetto a quelli del battesimo. Se dunque nel battesimo lo Spirito santo fa ri-<br />
34 «Nella sacramentalità cristiana <strong>il</strong> battesimo e l’Eucaristia non si collocano <strong>in</strong> giustapposizione, e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> non<br />
suggeriscono due simbolismi <strong>di</strong>versi; ma collocandosi secondo <strong>il</strong> rapporto della f<strong>in</strong>alità rispettiva, nel senso che<br />
<strong>il</strong> battesimo è f<strong>in</strong>alizzato all’Eucaristia, esprimono oggettivamente un unico simbolismo, precisamente quello<br />
def<strong>in</strong>ito dall’Eucaristia, che coerentemente esercita sul battesimo un’azione <strong>di</strong> appropriazione, specificandone <strong>il</strong><br />
senso». G. COLOMBO, «Problematica della “celebrazione dell’Eucaristia”», <strong>in</strong> Celebrare l’Eucaristia. Significato<br />
e problemi della <strong>di</strong>mensione rituale, LDC, Leumann (Tor<strong>in</strong>o) 1983, 7-26: 24.<br />
35 A. CAPRIOLI, «L’<strong>in</strong>iziazione cristiana», 96.<br />
36 Cf A. CECCHINATO, Celebrare la confermazione. Rassegna critica dell’attuale <strong>di</strong>battito teologico sul sacramento,<br />
Padova, Messaggero – Abbazia <strong>di</strong> Santa Giust<strong>in</strong>a 1987, 42-46.<br />
12
nascere alla vita cristiana, nella confermazione ci sarebbe «una nuova effusione dello Spirito<br />
Santo che, perfezionando i doni del battesimo e/o portandone <strong>di</strong> nuovi, qualifica la vita del<br />
s<strong>in</strong>golo cristiano rendendolo membro attivo nella Chiesa» 37 , corresponsab<strong>il</strong>e della sua missione<br />
nel mondo 38 .<br />
Un secondo orientamento, <strong>in</strong>vece, idealmente raggruppa quegli Autori che relativizzano la<br />
questione del proprium della confermazione, per valorizzarne <strong>il</strong> legame col battesimo sullo<br />
sfondo dell’unità dell’economia salvifica 39 . In quest’ottica, la relazione tra battesimo e confermazione<br />
viene letta alla luce dell’unità articolata del mistero pasquale-pentecostale. «La<br />
pentecoste […] non è un evento isolato e a sé stante, accaduto cronologicamente dopo la pasqua,<br />
ma è esattamente <strong>il</strong> compiersi della pasqua» 40 , che rivela e costituisce <strong>il</strong> Signore morto<br />
e risorto come colui che fa dono del suo Spirito. Analogamente la confermazione rappresenta<br />
<strong>il</strong> complemento <strong>di</strong> un processo che, avviatosi con la r<strong>in</strong>ascita battesimale, è dest<strong>in</strong>ato a sfociare<br />
nella partecipazione alla mensa eucaristica. In questo quadro,<br />
ciò che la confermazione conferisce è <strong>il</strong> dono dello Spirito, o meglio, lo Spirito come<br />
dono che sig<strong>il</strong>la la novità <strong>di</strong> vita <strong>in</strong>augurata nel battesimo. Tale dono non si aggiunge<br />
né si somma semplicemente a quello del battesimo, ma si compone armonicamente<br />
con esso. La sua <strong>di</strong>st<strong>in</strong>zione può sussistere proprio perché è <strong>in</strong><strong>di</strong>ssolub<strong>il</strong>e <strong>il</strong><br />
suo rimando all’unica realtà battesimale dentro <strong>il</strong> processo <strong>di</strong> <strong>in</strong>iziazione 41 .<br />
In s<strong>in</strong>tesi, la confermazione costituirebbe l’esplicitazione della <strong>di</strong>mensione pneumatologica<br />
dell’IC; essa cioè mostrerebbe che la r<strong>in</strong>ascita battesimale non è completa senza un rito che<br />
esplicitamente esprima e realizzi l’effusione dello Spirito. Il riferimento allo Spirito, dunque,<br />
non è da riconoscere «<strong>in</strong> esclusiva» alla confermazione. In essa, <strong>in</strong>vece, tale riferimento acquista<br />
r<strong>il</strong>ievo primario: come una melo<strong>di</strong>a che già risuona nella liturgia del battesimo, ma che<br />
nella confermazione viene ripresa e svolta come «tema» dom<strong>in</strong>ante della s<strong>in</strong>fonia 42 .<br />
37 A. CECCHINATO, Celebrare la confermazione, 46.<br />
38 Limitandoci agli Autori italiani, ricor<strong>di</strong>amo A. CAPRIOLI, «L’<strong>in</strong>iziazione cristiana»; G. MAZZANTI, I sacramenti<br />
simbolo e teologia, 2. In questa l<strong>in</strong>ea, è collocab<strong>il</strong>e anche la posizione che fa riferimento alla confermazione<br />
come «sacramento delle vocazioni cristiane», che specifica a livello personale la generale chiamata<br />
battesimale alla f<strong>il</strong>iazione <strong>di</strong>v<strong>in</strong>a, come pure quella che vede nella confermazione la fonte del sacerdozio regale<br />
dei fedeli: <strong>il</strong> primo orientamento si ritrova <strong>in</strong> E. RUFFINI, Il Battesimo nello Spirito, Marietti, Tor<strong>in</strong>o 1975; V.<br />
CROCE, Cristo nel tempo della Chiesa, Elle<strong>di</strong>ci, Leumann (Tor<strong>in</strong>o) 1992, 127-156; C. ROCCHETTA, I sacramenti<br />
della fede, 2. Sacramentaria biblica speciale, EDB, Bologna 1997, 59-88; <strong>il</strong> secondo orientamento è sostenuto<br />
da A. NOCENT, «La confirmation. Questions posées aux théologiens et aux pasteurs», Gregorianum 72 (1991)<br />
689-704; A. ELBERTI, «Accipe signaculum doni Spiritus Sancti. La confermazione: fonte del sacerdozio regale<br />
dei fedeli?», Gregorianum 72 (1991) 491-513; A. ELBERTI, La Confermazione nella tra<strong>di</strong>zione della Chiesa<br />
lat<strong>in</strong>a, San Paolo, C<strong>in</strong>isello Balsamo (M<strong>il</strong>ano) 2003.<br />
39 Particolarmente rigoroso <strong>in</strong> questa l<strong>in</strong>ea è L. GIRARDI, «Battesimo e confermazione», <strong>in</strong> Corso <strong>di</strong> teologia<br />
sacramentaria, 2. I sacramenti della salvezza, Quer<strong>in</strong>iana, <strong>Brescia</strong> 2000, 95-187. Posizioni analoghe, sia pure<br />
con sottol<strong>in</strong>eature ed accenti <strong>di</strong>versi, si trovano <strong>in</strong> S. REGLI, «Il sacramento della confermazione e lo sv<strong>il</strong>uppo<br />
cristiano», <strong>in</strong> Mysterium Salutis, vol. V/1, <strong>Brescia</strong>, Quer<strong>in</strong>iana 1978, 349-410: 389; P. CODA, Uno <strong>in</strong> Cristo<br />
Gesù. Il battesimo come evento tr<strong>in</strong>itario, Città Nuova, Roma 1996, 128-129; R. FALSINI, «Cresima e <strong>in</strong>iziazione<br />
cristiana: l’attuale <strong>di</strong>battito nella chiesa cattolica», Stu<strong>di</strong> Ecumenici 13 (1995) 73-90; P. DE CLERCK,<br />
«L’<strong>in</strong>itiation et l’ordre des sacrements», Catéchèse 147 (1997) 33-42; G. GÄDE, Battesimo e confermazione.<br />
Teologia dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana, Facoltà Teologica <strong>di</strong> Sic<strong>il</strong>ia – E<strong>di</strong>zioni Lussografica, Palermo – Caltanissetta<br />
2002.<br />
40 L. GIRARDI, «Battesimo e confermazione», 178.<br />
41 L. GIRARDI, «Battesimo e confermazione», 181.<br />
42 Il paragone <strong>di</strong> tipo musicale è ripreso da S. REGLI, «Il sacramento della confermazione», 389.<br />
13
III. POSSIBILI RICADUTE SUL PIANO PRATICO-PASTORALE<br />
1. Evidenziare <strong>il</strong> carattere ecclesiale della «prima partecipazione all’eucaristia»<br />
In primo luogo, occorre mostrare che anche la «prima comunione» si <strong>in</strong>scrive all’<strong>in</strong>terno della<br />
f<strong>in</strong>alità propria dell’eucaristia che consiste nell’e<strong>di</strong>ficazione della Chiesa. Accostarsi alla<br />
mensa eucaristica, <strong>in</strong>fatti, non significa semplicemente «ricevere Gesù» (benché questa affermazione<br />
conservi una qualche pert<strong>in</strong>enza), bensì <strong>di</strong>ventare compiutamente parte del corpo<br />
<strong>di</strong> Cristo che è la Chiesa, attraverso la comunione al suo corpo eucaristico. In questo senso la<br />
term<strong>in</strong>ologia stessa andrebbe rivista, prendendo ispirazione dal RICA, che volutamente evita<br />
l’espressione «prima comunione» e parla <strong>di</strong> «prima partecipazione all’eucaristia» (RICA, n°<br />
36). Il fatto stesso che nel Messale romano non esista un rito particolare per la messa <strong>di</strong> prima<br />
comunione suggerisce che <strong>il</strong> contesto adeguato per la prima partecipazione all’eucaristia è la<br />
normale assemblea eucaristica domenicale.<br />
Proprio per questo non è <strong>il</strong> caso «<strong>di</strong> stravolgere questo contesto allestendo un ‘altare’ <strong>di</strong>verso<br />
nella navata centrale, sim<strong>il</strong>e a un tavolo <strong>di</strong> nozze, per mimare <strong>in</strong> qualche modo l’ultima cena!»<br />
43 . La mensa dove l’IC trova compimento dev’essere la stessa alla quale ogni domenica<br />
l’«<strong>in</strong>iziato» alimenterà la relazione con Cristo e con la Chiesa cui è stato <strong>in</strong>trodotto. Ancora più<br />
improvvide risultano alcune soluzioni escogitate da pastori e catechisti, con l’<strong>in</strong>tento <strong>di</strong> sottrarre<br />
la celebrazione ad un clima <strong>di</strong> «festaiola banalità»; mi riferisco all’<strong>in</strong>serimento della prima comunione<br />
nella messa <strong>in</strong> coena Dom<strong>in</strong>i e, ancor più, all’<strong>in</strong>troduzione <strong>di</strong> una duplice celebrazione:<br />
«la prima a porte chiuse (!), <strong>in</strong> un giorno feriale […], riservata ai fanciulli e ai loro genitori. La<br />
‘seconda’ (?) prima comunione nella domenica successiva, secondo la ‘tra<strong>di</strong>zione’» 44 . Più sensata<br />
pare <strong>in</strong>vece l’ammissione dei neo-comunican<strong>di</strong> all’eucaristia <strong>in</strong> piccoli gruppi, nel contesto<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>verse messe domenicali.<br />
2. Riprist<strong>in</strong>are l’ord<strong>in</strong>e teologico dei sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana<br />
Rispetto al <strong>di</strong>scorso teolgogico-sacramentale svolto, la prassi correntemente messa <strong>in</strong> atto per<br />
fanciulli e ragazzi suscita due questioni. Quella più ra<strong>di</strong>cale è legata al fatto che i tre sacramenti<br />
dell’IC vengono celebrati <strong>in</strong> tempi separati. La nostra corsa nella storia ci ha mostrato –<br />
almeno <strong>in</strong> parte – le ragioni <strong>di</strong> questa separazione, che – va ricordato – riguarda solo la Chiesa<br />
occidentale. In proposito, va detto chiaramente che, dal punto <strong>di</strong> vista strettamente teologico,<br />
la celebrazione unitaria dei sacramenti dell’IC non rappresenterebbe un problema, neppure nel<br />
caso dei neonati: è ciò che <strong>di</strong>mostra la prassi ancora oggi <strong>in</strong> atto nelle Chiese Orientali, prassi<br />
che l’Occidente ha def<strong>in</strong>itivamente abbandonato solo nel XII/XIII secolo. Nell’attuale contesto<br />
ecclesiale, però, non mi sembra opportuno proporre una celebrazione unitaria <strong>di</strong> battesimo,<br />
cresima ed eucaristia anche per gli <strong>in</strong>fanti 45 . Tra l’altro, la <strong>di</strong>stanza cronologica <strong>di</strong> cresima ed<br />
eucaristia rispetto al battesimo offre l’opportunità aff<strong>in</strong>ché, nell’IC <strong>di</strong> quanti sono stati battezzati<br />
da <strong>in</strong>fanti, si <strong>di</strong>a spazio ad un certo camm<strong>in</strong>o <strong>di</strong> adesione personale alla fede. Senza dunque<br />
ri<strong>di</strong>scutere la separazione cronologica fra i tre sacramenti, bisogna comunque riconoscere<br />
che <strong>il</strong> ritrovato legame teologico tra battesimo, confermazione ed eucaristia fa percepire <strong>in</strong><br />
43 S. SIRBONI, «Festa della prima comunione», 30.<br />
44 S. SIRBONI, «Festa della prima comunione», 26-27.<br />
45 La proposta è avanzata, ad esempio, da P. TURNER, Ages of Initiation, 63-64. Essa però richiederebbe la<br />
mo<strong>di</strong>fica dell’attuale normativa canonica, a proposito della quale cf G. TREVISAN (ed.), Quando si <strong>di</strong>venta cristiani.<br />
I sacramenti dell'<strong>in</strong>iziazione: <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni canoniche e pastorali, Ancora, M<strong>il</strong>ano 2003.<br />
14
maniera più stridente una sorta <strong>di</strong> «schizofrenia» della pastorale corrente: da un lato, <strong>in</strong>fatti, <strong>il</strong><br />
battesimo degli <strong>in</strong>fanti viene fondamentalmente dato a tutti coloro che lo chiedono, senza particolari<br />
con<strong>di</strong>zioni; d’altro lato, poi, si tende a far confluire sulla confermazione tutto l’<strong>in</strong>sieme<br />
<strong>di</strong> valori legati ad una scelta <strong>di</strong> fede libera, personale e consapevole, enfatizzando la presentazione<br />
della cresima come sacramento della «maturità», del «cristiano adulto», della<br />
«conferma personale della fede»… Mi parrebbe opportuno qu<strong>in</strong><strong>di</strong> riequ<strong>il</strong>ibrare un po’ la situazione,<br />
<strong>in</strong>vestendo <strong>di</strong> più sulla pastorale del battesimo dei bamb<strong>in</strong>i, dato che <strong>il</strong> battesimo costituisce<br />
<strong>il</strong> pr<strong>in</strong>cipio della vita cristiana e, pertanto, <strong>il</strong> modo <strong>in</strong> cui esso viene celebrato non<br />
può non con<strong>di</strong>zionare tutto ciò che viene <strong>in</strong> seguito.<br />
La seconda questione è legata al fatto che, <strong>in</strong> concreto, <strong>il</strong> sacramento posto al term<strong>in</strong>e dell’it<strong>in</strong>erario<br />
<strong>di</strong> <strong>in</strong>iziazione è la cresima, non l’eucaristia: ciò obiettivamente <strong>in</strong>troduce un elemento<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo, che rende poco percepib<strong>il</strong>e la logica <strong>in</strong>terna dei sacramenti <strong>di</strong> <strong>in</strong>iziazione:<br />
Anche solo da un punto <strong>di</strong> vista psicologico, collocare la comunione al term<strong>in</strong>e del<br />
processo <strong>in</strong>iziatico permette al s<strong>in</strong>golo fedele <strong>di</strong> cont<strong>in</strong>uare l’esperienza del primo<br />
<strong>in</strong>contro con Cristo. La cresima, poiché non reiterab<strong>il</strong>e, dà più <strong>il</strong> senso della conclusione<br />
<strong>di</strong> un percorso 46 .<br />
A questo proposito la Nota Pastorale 2006-2007 – Iniziazione cristiana ed Eucaristia – afferma:<br />
Per esprimere maggiormente questo <strong>in</strong>timo rapporto tra i sacramenti dell’IC e la f<strong>in</strong>alizzazione<br />
dei primi due all’Eucaristia, la CEI ha dato la possib<strong>il</strong>ità – che la nostra<br />
<strong>Diocesi</strong> ha fatto propria – <strong>di</strong> riprist<strong>in</strong>are, anche per l’ICFR, l’ord<strong>in</strong>e più antico, e teologicamente<br />
più corretto, dei tre sacramenti e <strong>di</strong> unire nella medesima celebrazione <strong>il</strong><br />
dono della Cresima e dell’Eucaristia 47 .<br />
In effetti, per completare sacramentalmente l’IC <strong>di</strong> chi ha ricevuto <strong>il</strong> battesimo da <strong>in</strong>fante, la<br />
celebrazione unitaria <strong>di</strong> cresima ed eucaristia sembra – al momento – la soluzione più capace<br />
<strong>di</strong> comporre <strong>in</strong>sieme le <strong>di</strong>verse esigenze <strong>in</strong> gioco. Se la proposta <strong>di</strong> celebrare <strong>in</strong>sieme cresima<br />
ed eucaristia suscita qualche perplessità, perplessità ancora maggiori suscita <strong>il</strong> fatto che un<br />
cresimato non venga ammesso alla comunione eucaristica nel corso della messa durante la<br />
quale ha ricevuto la confermazione 48 .<br />
46 F. MARINI, «Il problema dell’età della cresima», <strong>in</strong> Iniziazione cristiana, Morcelliana, <strong>Brescia</strong> 2002, 199-220:<br />
219. Analoga osservazione è stata avanzata dall’Arcivescovo <strong>di</strong> M<strong>il</strong>ano: «Un’altra <strong>in</strong>iziativa è quella <strong>di</strong> riprendere<br />
e attuare, nella <strong>in</strong>iziazione cristiana, la successione teologica dei sacramenti Battesimo-Cresima-Eucaristia e<br />
<strong>di</strong> proporre un camm<strong>in</strong>o <strong>di</strong> fede nel quale nel quale la Cresima “conferma” <strong>il</strong> Battesimo e l’Eucaristia costituisce<br />
<strong>il</strong> vero “compimento” dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana. Oggi, la Cresima, sacramento non reiterab<strong>il</strong>e, provoca <strong>in</strong>evitab<strong>il</strong>mente<br />
l’impressione che <strong>il</strong> camm<strong>in</strong>o <strong>di</strong> fede si concluda con la sua celebrazione. Mentre, con l’Eucaristia, che è<br />
<strong>il</strong> sacramento più reiterab<strong>il</strong>e <strong>di</strong> tutti, <strong>il</strong> camm<strong>in</strong>o sfocia sulla vita cristiana»: D. TETTAMANZI, Mi sarete testimoni.<br />
Il volto missionario della Chiesa <strong>di</strong> M<strong>il</strong>ano. Percorso pastorale <strong>di</strong>ocesano per <strong>il</strong> triennio 2003-2006, ITL,<br />
M<strong>il</strong>ano 2003, n° 64.<br />
47 G. SANGUINETI, Iniziazione cristiana ed Eucaristia. Nota Pastorale. Anno 2006-2007, 7. Il testo cui si fa<br />
riferimento è <strong>il</strong> n° 54 della Nota del Consiglio Permanente della CEI sull’IC <strong>di</strong> fanciulli e ragazzi dai 7 ai 14 anni<br />
(1999): «Intorno agli un<strong>di</strong>ci anni, possib<strong>il</strong>mente nella veglia pasquale, i [ragazzi] catecumeni celebrano i tre<br />
sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana, mentre i coetanei già battezzati celebrano la Confermazione e la prima<br />
Eucaristia (RICA, 310)»: «L’<strong>in</strong>iziazione cristiana, 2. Orientamenti per l’<strong>in</strong>iziazione cristiana dei fanciulli e dei<br />
ragazzi dai 7 ai 14 anni», Il Regno Documenti 44 (1999) 437-445. Le tre note della CEI de<strong>di</strong>cate all’IC nel 1997,<br />
1999 e 2003 sono raccolte nel volume UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE - SERVIZIO NAZIONALE PER IL CATE-<br />
CUMENATO (ed.), L’<strong>in</strong>iziazione cristiana. Documenti e orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana. 1 -<br />
Catecumenato degli adulti. 2 – Catecumenato dei fanciulli e dei ragazzi. 3 - It<strong>in</strong>erari per <strong>il</strong> risveglio della fede<br />
cristiana, Elle<strong>di</strong>ci, Leumann (Tor<strong>in</strong>o) 2004.<br />
48 A meno <strong>di</strong> non prevedere la celebrazione della confermazione senza la messa, secondo le <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni del cap.<br />
II del Rito della Confermazione. Una scelta del genere, per quanto legittima, stride con ciò che afferma <strong>il</strong> n° 13<br />
dei Praenotanda: «La Confermazione si conferisce normalmente durante la Messa, perché risalti meglio l’<strong>in</strong>timo<br />
15
3. La questione dell’età<br />
La questione dell’età <strong>in</strong> cui completare sacramentalmente l’IC è certamente più <strong>di</strong>scutib<strong>il</strong>e, <strong>in</strong><br />
quanto gli elementi che <strong>in</strong> essa entrano <strong>in</strong> gioco sono prevalentemente <strong>di</strong> carattere pedagogico-pastorale.<br />
Il Piano <strong>di</strong> lavoro per l’ICFR (PLIC 2003) prevede la celebrazione unitaria <strong>di</strong><br />
cresima ed eucaristia dopo circa c<strong>in</strong>que anni <strong>di</strong> camm<strong>in</strong>o, qu<strong>in</strong><strong>di</strong> per lo più verso gli 11/12 anni.<br />
Questa scelta – peraltro <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea con le <strong>in</strong><strong>di</strong>cazioni della Nota del Consiglio permanente<br />
della CEI sull’IC <strong>di</strong> fanciulli e ragazzi 49 – risponde all’esigenza <strong>di</strong> recuperare <strong>in</strong> tutti gli it<strong>in</strong>erari<br />
<strong>di</strong> IC l’«ispirazione catecumenale» 50 . In concreto, si tratta <strong>di</strong> strutturare l’<strong>in</strong>iziazione come<br />
un camm<strong>in</strong>o progressivo <strong>di</strong> evangelizzazione e <strong>di</strong> maturazione della fede, scan<strong>di</strong>to da tappe<br />
graduali e da verifiche, che comportano un <strong>di</strong>scernimento del camm<strong>in</strong>o del ragazzo; la celebrazione<br />
dell’eucaristia viene collocata al culm<strong>in</strong>e <strong>di</strong> questo it<strong>in</strong>erario che, evidentemente,<br />
presuppone una certa <strong>di</strong>stensione temporale. Non è <strong>di</strong>ffic<strong>il</strong>e <strong>in</strong>tuire la sensatezza <strong>di</strong> questa impostazione,<br />
a fronte <strong>di</strong> un contesto socio-culturale come quello <strong>in</strong> cui siamo <strong>in</strong>seriti.<br />
Tuttavia, alla scelta <strong>di</strong> celebrare la cresima/eucaristia attorno agli 11/12 anni vengono mosse<br />
obiezioni su due versanti opposti. Alcuni preti, catechisti e genitori (e, <strong>in</strong> qualche caso, i <strong>di</strong>retti<br />
<strong>in</strong>teressati, cioè i bamb<strong>in</strong>i) preferirebbero che la celebrazione fosse collocata <strong>in</strong> un’età più<br />
vic<strong>in</strong>a ai sette anni; attendere f<strong>in</strong>o ai do<strong>di</strong>ci anni, <strong>in</strong>fatti, significherebbe privare troppo a lungo<br />
i bamb<strong>in</strong>i della grazia che deriva dalla comunione eucaristica. A questo proposito, non bisogna<br />
<strong>di</strong>menticare che la grazia dei sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione non agisce solo alla f<strong>in</strong>e del<br />
camm<strong>in</strong>o; «anche l’it<strong>in</strong>erario che ad essi conduce partecipa <strong>di</strong> quella grazia preparandola, anticipandola,<br />
favorendola» 51 . Ritengo comunque che la preoccupazione <strong>di</strong> non ritardare troppo<br />
la conclusione sacramentale dell’IC abbia una sua pert<strong>in</strong>enza. Nella maggior parte dei casi,<br />
<strong>in</strong>fatti, l’IC riguarda ragazzi battezzati; è vero che spesso anch’essi e i loro genitori hanno bisogno<br />
<strong>di</strong> un camm<strong>in</strong>o <strong>di</strong> riscoperta della fede; d’altra parte, però, se esiste un collegamento tra<br />
i sacramenti dell’<strong>in</strong>iziazione cristiana, una volta che si è scelto <strong>di</strong> battezzare un neonato, i<br />
term<strong>in</strong>i per la celebrazione degli altri sacramenti non vanno troppo prolungati 52 . Questa osservazione,<br />
<strong>in</strong> qualche modo, entra <strong>in</strong> tensione con l’ispirazione catecumenale; ma si tratta <strong>di</strong><br />
una tensione che va mantenuta: ci ispiriamo all’it<strong>in</strong>erario catecumenale, ben sapendo però che<br />
abbiamo a che fare con ragazzi già battezzati, la cui con<strong>di</strong>zione può solo <strong>in</strong> maniera analogica<br />
essere qualificata come catecumenale. Tenendo conto <strong>di</strong> ciò, mi pare sensato che – <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea<br />
generale – chi è stato battezzato da neonato concluda sacramentalmente l’<strong>in</strong>iziazione nella<br />
fanciullezza, prima dell’<strong>in</strong>izio dell’età adolescenziale – <strong>in</strong> ogni caso, non oltre i 12 anni. I 12<br />
anni vanno cioè considerati come <strong>il</strong> term<strong>in</strong>e oltre <strong>il</strong> quale non andare (se non <strong>in</strong> casi del tutto<br />
eccezionali); personalmente, però, non vedo negativamente la possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> abbassare questo<br />
term<strong>in</strong>e, qualora ve ne siano le con<strong>di</strong>zioni. Del resto, proprio <strong>il</strong> richiamo ad un <strong>di</strong>scernimento<br />
nesso <strong>di</strong> questo sacramento con tutta l’<strong>in</strong>iziazione cristiana, che raggiunge <strong>il</strong> suo culm<strong>in</strong>e nella partecipazione<br />
conviviale al sacrificio del corpo e del sangue <strong>di</strong> Cristo».<br />
49<br />
Cf <strong>il</strong> già citato n° 54 della Nota del Consiglio Permanente della CEI sull’IC <strong>di</strong> fanciulli e ragazzi dai 7 ai 14<br />
anni.<br />
50<br />
L’affermazione più esplicita <strong>in</strong> proposito si trova nel n° 41 della prima Nota del Consiglio Permanente della<br />
CEI sull’IC (1997): «Il catecumenato degli adulti costituisce <strong>il</strong> modello <strong>di</strong> ogni processo <strong>di</strong> <strong>in</strong>iziazione cristiana.<br />
Anche la prassi tra<strong>di</strong>zionale dell’<strong>in</strong>iziazione per coloro che hanno ricevuto <strong>il</strong> Battesimo da bamb<strong>in</strong>i va ripensata<br />
e r<strong>in</strong>novata alla luce del modello catecumenale»: «L’<strong>in</strong>iziazione cristiana, 1. Orientamenti per <strong>il</strong> catecumenato<br />
degli adulti», Il Regno Documenti 42 (1997) 343-359. Cosa si <strong>in</strong>tende per «ispirazione catecumenale» è chiarito<br />
dal n° 36 del PLIC 2003.<br />
51<br />
«L’<strong>in</strong>iziazione cristiana, 2», n° 22.<br />
52<br />
Cf F. MARINI, «Il problema dell’età della cresima», 218.<br />
16
che tenga conto della maturazione del ragazzo <strong>in</strong>troduce la possib<strong>il</strong>ità che un can<strong>di</strong>dato venga<br />
ammesso alla celebrazione sacramentale prima dei tempi generalmente fissati.<br />
Quanto detto risponde già <strong>in</strong> parte all’obiezione <strong>di</strong> quanti ritengono che <strong>il</strong> camm<strong>in</strong>o <strong>di</strong> ICFR<br />
dovrebbe essere prolungato f<strong>in</strong> verso i 18 anni, così da coprire <strong>il</strong> tempo dell’adolescenza, <strong>in</strong><br />
modo da avere più occasioni <strong>di</strong> contatto con ragazzi che, senza lo “stimolo” del sacramento,<br />
<strong>di</strong>ffic<strong>il</strong>mente cont<strong>in</strong>uerebbero a frequentare <strong>il</strong> catechismo. Un’impostazione <strong>di</strong> questo tipo mi<br />
pare tra<strong>di</strong>sca un modo <strong>di</strong> vedere <strong>il</strong> sacramento che lo riduce ad «occasione» per tener legati i<br />
ragazzi alla catechesi con una modalità che – sia pur velatamente – rischia <strong>di</strong> assumere la<br />
forma del ricatto.<br />
4. Per una prospettiva più ampia<br />
La questione dell’età <strong>in</strong> cui concludere sacramentalmente l’IC deve essere <strong>in</strong>quadrata <strong>in</strong> una<br />
serie <strong>di</strong> considerazioni <strong>di</strong> più ampio respiro: ne propongo tre – più una che può servire come<br />
conclusione <strong>di</strong> tutto <strong>il</strong> <strong>di</strong>scorso.<br />
4.1. La celebrazione della cresima e la prima partecipazione all’eucaristia non segnano la<br />
f<strong>in</strong>e dell’attenzione educativa che la Chiesa rivolge a ragazzi, adolescenti e giovani. L’<strong>in</strong>troduzione<br />
<strong>di</strong> un tempo <strong>di</strong> mistagogia, successivo alla celebrazione sacramentale, ha proprio lo<br />
scopo <strong>di</strong> favorire la personale appropriazione del dono ricevuto nei sacramenti 53 . Una volta<br />
completata l’<strong>in</strong>iziazione sacramentale nell’età <strong>in</strong>fant<strong>il</strong>e, c’è dunque spazio per l’elaborazione<br />
<strong>di</strong> it<strong>in</strong>erari educativi, attenti alle specifiche esigenze <strong>di</strong> adolescenti e giovani. La permanenza<br />
<strong>di</strong> costoro negli ambienti ecclesiali <strong>di</strong>penderà <strong>in</strong> parte dalla qualità delle proposte loro rivolte,<br />
<strong>in</strong> parte dal clima complessivo della comunità cristiana, ma anche da tutta una serie <strong>di</strong> fattori<br />
che non <strong>di</strong>pendono da noi: l’ambito fam<strong>il</strong>iare <strong>di</strong> provenienza, <strong>il</strong> tipo <strong>di</strong> educazione globale che<br />
i ragazzi stanno ricevendo, <strong>il</strong> contesto culturale generale, che certo non favorisce una vita cristiana<br />
coerente…<br />
4.2. La celebrazione unitaria <strong>di</strong> cresima ed eucaristia non è un’<strong>in</strong>iziativa isolata. Essa si<br />
colloca come compimento sacramentale <strong>di</strong> un it<strong>in</strong>erario costruito secondo un’ispirazione catecumenale.<br />
La celebrazione, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, ha luogo <strong>in</strong> un contesto che – se attivato <strong>in</strong> modo coerente<br />
– dovrebbe contribuire a ri<strong>di</strong>mensionare certe situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio che si riscontrano attualmente.<br />
4.3. Il Piano <strong>di</strong> Lavoro <strong>in</strong>vita ad «operare un più attento <strong>di</strong>scernimento circa <strong>il</strong> Battesimo<br />
dei bamb<strong>in</strong>i», <strong>in</strong> modo da garantire «che <strong>il</strong> bamb<strong>in</strong>o che viene battezzato sia sostenuto da un<br />
contesto <strong>di</strong> fede» (n° 35). Più ra<strong>di</strong>calmente andrebbe chiarito che la pastorale dell’IC non com<strong>in</strong>cia<br />
quando un bamb<strong>in</strong>o raggiunge i 6 anni, ma quando i genitori <strong>di</strong> un bamb<strong>in</strong>o <strong>di</strong> poche<br />
settimane/mesi <strong>di</strong> vita chiedono <strong>il</strong> battesimo per <strong>il</strong> loro figlio. Non va <strong>di</strong>menticato <strong>in</strong>fatti che è<br />
<strong>il</strong> battesimo <strong>il</strong> primo sacramento dell’IC. In questa l<strong>in</strong>ea, una pastorale battesimale – vista<br />
come primo momento della pastorale dell’IC – potrebbe perseguire due obiettivi: <strong>il</strong> primo –<br />
che emerge con chiarezza dai documenti del Magistero – è quello <strong>di</strong> far sì che <strong>il</strong> battesimo <strong>di</strong><br />
un neonato sia accompagnato dalla fondata speranza che <strong>il</strong> bamb<strong>in</strong>o sarà educato nella fede; <strong>il</strong><br />
secondo – forse un po’ più ambizioso – è quello <strong>di</strong> fare <strong>in</strong> modo che <strong>il</strong> battesimo <strong>di</strong> un bamb<strong>in</strong>o<br />
sia accompagnato da una più precisa scelta <strong>di</strong> fede e <strong>di</strong> appartenenza ecclesiale da parte dei<br />
genitori. La realizzazione <strong>di</strong> questi obiettivi richiede <strong>il</strong> co<strong>in</strong>volgimento della comunità cristiana<br />
– soprattutto delle coppie e delle famiglie <strong>in</strong> essa attive – nel compito <strong>di</strong> accompagnare chi<br />
53 Il PLIC 2003 propone un tempo della mistagogia <strong>di</strong> circa un anno, con lo scopo <strong>di</strong> aiutare i ragazzi a «cogliere<br />
<strong>in</strong> profon<strong>di</strong>tà e a tradurre nella vita i sacramenti che hanno ricevuto» (n° 51).<br />
17
chiede <strong>il</strong> battesimo per i propri figli, sia nella fase che precede <strong>il</strong> battesimo, sia <strong>in</strong> quella che<br />
segue la celebrazione. Non si tratta <strong>di</strong> proporre lunghe serie <strong>di</strong> <strong>in</strong>contri, che risulterebbero<br />
sopportati prima del battesimo e <strong>di</strong>sertati dopo; si tratta <strong>in</strong>vece <strong>di</strong> favorire occasioni ag<strong>il</strong>i <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>contro, <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> dar vita a relazioni non puramente formali con le famiglie dei battezzan<strong>di</strong>.<br />
In conclusione: vale la pena <strong>di</strong> <strong>in</strong>vestire più <strong>di</strong> quanto non si faccia attualmente sulla pastorale<br />
battesimale, lasciando cadere l’<strong>il</strong>lusione che si possa recuperare <strong>in</strong> seguito quanto non si è<br />
fatto prima e dopo <strong>il</strong> battesimo.<br />
CONCLUSIONE<br />
La questione dell’ord<strong>in</strong>e dei sacramenti non è certo la chiave risolutiva <strong>di</strong> tutti i problemi legati<br />
all’IC; d’altra parte, però, se si riconosce <strong>il</strong> valore strutturante dei sacramenti nell’it<strong>in</strong>erario<br />
<strong>di</strong> IC, è sensato fare <strong>in</strong> modo che la logica che lega i sacramenti dell’IC traspaia con più<br />
evidenza nella concreta organizzazione dell’it<strong>in</strong>erario stesso. Più <strong>in</strong> generale, l’elaborazione<br />
<strong>di</strong> nuovi it<strong>in</strong>erari <strong>di</strong> IC va <strong>in</strong>serita dentro un quoti<strong>di</strong>ano e paziente impegno <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novamento<br />
del volto concreto delle nostre comunità. Si tratta <strong>di</strong> costruire <strong>in</strong> esse una rete <strong>di</strong> rapporti, segnata<br />
dalla novità del vangelo e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> accogliere effettivamente coloro che cont<strong>in</strong>uano<br />
a bussare alla nostra porta. A questo proposito, più che preoccuparci <strong>di</strong> restr<strong>in</strong>gere la<br />
porta d’accesso alla Chiesa, dovremmo preoccuparci <strong>di</strong> offrire a chi varca quella porta <strong>il</strong> volto<br />
concreto <strong>di</strong> una comunità che, e<strong>di</strong>ficata dall’eucaristia, cerca <strong>di</strong> vivere secondo Gesù Cristo.<br />
18