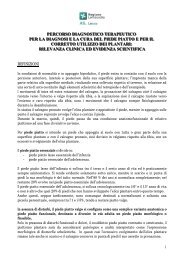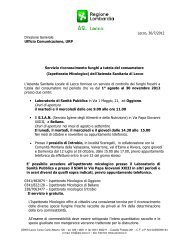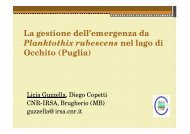Patto territoriale - ASL Lecco
Patto territoriale - ASL Lecco
Patto territoriale - ASL Lecco
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ORGANISMO DI COORDINAMENTO PER<br />
LA SALUTE MENTALE<br />
DELLA PROVINCIA DI LECCO<br />
GIUGNO 2007
INDICE<br />
INTRODUZIONE<br />
I PARTE<br />
Rilevamento dati; Obiettivi strategici del triennio; priorità di intervento; Azioni di sistema<br />
Cap. 1 Valutazione clinico epidemiologica febbraio 2006<br />
Dr. Limonta – Direttore Dipartimento Programmazione Acquisto Controllo <strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong><br />
Cap. 2 DSM – Rapporti annuali 2005-2006<br />
Dr. Ssa Pinciara – Direttore DSM Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong><br />
Cap. 3 DSM - Obiettivi, priorità e azioni triennio 2006-2008<br />
Dr. Ssa Pinciara – Direttore DSM Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong><br />
Cap. 4 OCSM – Obiettivi, priorità e azioni 2006-2007<br />
Dr. Scaccabarozzi – Direttore Dipartimento Fragilità <strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> – Coordinatore OCSM<br />
II PARTE<br />
Intese distrettuali di programma<br />
Cap. 1 Atto d’intesa <strong>ASL</strong>/AO LECCO/COMUNI/PROVINCIA<br />
Cap. 2 Protocollo Residenzialità<br />
Cap. 3 Protocollo Territorialità<br />
Cap. 4 Protocollo DSM-MMG<br />
Cap. 5 Protocollo DSM-Ser.D. e NOA per doppia diagnosi<br />
Cap. 6 Protocollo <strong>ASL</strong> – AO per patologie alcool correlate<br />
Cap. 7 Protocollo DSM-UONPIA<br />
Cap. 8 Protocollo per le urgenze psichiatriche in adolescenza<br />
Cap. 9 Protocollo Lavoro DSM - CONSOLIDA<br />
Cap. 10 Programma Innovativo “Una rete per il lavoro”<br />
Cap. 11 Programma Innovativo “Prevenzione e trattamento precoce per i disturbi psichici gravi”<br />
Cap. 12 Programma Innovativo “Il Castello Solidale”<br />
Cap. 1 Provincia e Comuni per la Salute Mentale<br />
Cap. 2 DSM organigramma e unità d’offerta<br />
Cap. 3 <strong>ASL</strong> per la Salute Mentale<br />
Cap. 4 Strutture residenziali accreditate<br />
III PARTE<br />
Gli attori<br />
Cap. 5 Associazioni per la Salute Mentale sul territorio della Provincia <strong>Lecco</strong><br />
Cap. 6 Consorzio CONSOLIDA
INTRODUZIONE<br />
Il Piano Regionale Triennale per la Salute Mentale, emanato con D.g.r. 7/17513/2004, nelle Linee<br />
di Sviluppo e in ottemperanza a quanto indicato dal PSSR 2202-2004, prevede che “una volta<br />
definito l’assetto organizzativo dei servizi per la salute mentale, diviene rilevante dedicarsi ai<br />
programmi di trattamento, ai percorsi di diagnosi e terapia, ai processi clinici, alla relazione con la<br />
persona malata e con la sua famiglia, tutelandone i diritti di cittadino. Primo obiettivo da perseguire<br />
è lo sviluppo di una Psichiatria di Comunità che operi in un contesto ricco di risorse e di offerte,<br />
con programmi di cura improntati a modelli di efficacia e valutabili, in un territorio concepito come<br />
un insieme funzionale ampio, non rigidamente delimitato, con la possibilità di integrare diversi<br />
servizi, sanitari e sociali, pubblici, privati e non – profit, e di collaborare con la rete informale<br />
presente, in una reale apertura alla società civile. In tale prospettiva è necessario mettere in primo<br />
piano il problema dell’integrazione e del collegamento tra diversi soggetti istituzionali e diversi<br />
soggetti erogatori nel campo della salute mentale e prevedere il ruolo di un Organismo di<br />
Coordinamento ove il DSM si apra alla collaborazione con <strong>ASL</strong>, MMG, Enti locali, altri soggetti<br />
erogatori, agenzie della rete naturale, associazioni, mondo del lavoro.”<br />
Tra i compiti che il Piano assegna all’Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale vi è<br />
quello di predisporre un <strong>Patto</strong> Territoriale per la Salute Mentale, coerente con il Piano stesso e da<br />
rinnovare ogni tre anni ed aggiornare annualmente.<br />
A partire dalle indicazioni di cui sopra, l’Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale della<br />
Provincia di <strong>Lecco</strong> - OCSM ha sostenuto il DSM dell’Azienda Ospedaliera nell’avviare e<br />
diffondere la rete di scambi, confronti, collaborazioni con le altre Agenzie del sociale, dai Medici di<br />
Medicina Generale ai rapporti con gli operatori dei Comuni, con il Servizio per i Minori, il Servizio<br />
Dipendenze, la UONPIA ed altri, dando così spazio e realizzazione nell’affrontare un concetto di<br />
Salute Mentale, inteso come il benessere psichico dei cittadini di un territorio e l’integrazione dei<br />
vari momenti terapeutici all’interno della struttura sociale.<br />
La vera prevenzione, infatti, passa dal creare dei percorsi consolidati e condivisi, per cui il disagio<br />
venga colto al suo emergere con risposte qualificate e precoci.<br />
L’integrazione, infine, si completa nell’affrontare le problematiche tra mente e corpo, con il<br />
concetto di una Medicina Olistica, che prevede protocolli di intesa e rapporti di scambio con gli altri<br />
Dipartimenti dell’Azienda Ospedaliera, non solo per il trattamento comune delle cosiddette<br />
patologie delle Aree di confine, ma anche per una visione più completa dell’essere umano, che<br />
partendo dagli aspetti di scissione patologica, arrivi ad un insieme più armonico e completo, da cui<br />
origina il benessere.<br />
Il presente documento ha lo scopo di “raccontare” quanto avvenuto dal settembre 2005 con<br />
l’approvazione dell’”Atto d’intesa per la realizzazione e l’attivazione di un sistema locale di<br />
interventi nell’area della Salute Mentale”, tenuto conto che per alcuni protocolli scaturiti da tale<br />
Atto all’interno dei Gruppi di Lavoro dell’OCSM si sta già lavorando alla prima revisione.<br />
Vuole, inoltre, essere strumento di lavoro a disposizione di tutti gli attori coinvolti in problematiche<br />
inerenti la Salute Mentale nel territorio della Provincia di <strong>Lecco</strong> e pertanto si è scelta la versione in<br />
formato elettronico e non la pubblicazione di un documento cartaceo.
I PARTE<br />
Rilevamento dati; Obiettivi strategici del triennio; Priorità d’intervento; Azioni<br />
di Sistema<br />
CAP. 1<br />
Percorsi riabilitativi assistenziali nella rete delle strutture residenziali<br />
psichiatriche<br />
Valutazione clinico epidemiologica<br />
Documenti di riferimento<br />
(In collaborazione con Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong>)<br />
- Piano Regionale Salute Mentale 2003-2005<br />
- Circolare R.L. 28/SAN 2004, Circolare R.L. 49/SAN 2005<br />
- Protocollo di intesa area tematica residenzialità, Documento tecnico, Prime indicazioni<br />
operative per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi riabilitativi di pazienti inseriti in<br />
strutture residenziali (documenti approvati dall’OCSM)<br />
- Le prestazioni psichiatriche in Lombardia, rapporto economico 2004.<br />
Premessa<br />
Il PRSM e le circolari regionali 28/SAN 2004 e 49/SAN 2005 contenenti le indicazioni<br />
attuative emanate dalla Regione Lombardia, definiscono gli indirizzi operativi per la<br />
riqualificazione delle Strutture Residenziali psichiatriche (SR) attraverso:<br />
1) la differenziazione in nuove tipologie strutturali, organizzative e funzionali delle SR<br />
2) la definizione dei programmi residenziali<br />
3) l’introduzione di una nuova modalità di finanziamento.<br />
L’OCSM della provincia di <strong>Lecco</strong>, nel recepire le indicazioni del PRSM, ha promosso la<br />
formulazione di un protocollo d’intesa per l’area della residenzialità che è stato sottoscritto<br />
dall’<strong>ASL</strong>, dall’AO e dai Comuni. Il protocollo d’intesa contiene le specifiche funzioni e<br />
competenze in capo ai diversi soggetti coinvolti nella pianificazione, erogazione, monitoraggio e<br />
valutazione delle prestazioni riabilitative in regime residenziale rivolte ai pazienti affetti da<br />
patologie psichiatriche ed in particolare al DSM, alle Strutture Accreditate, all’ <strong>ASL</strong> e ai Comuni.<br />
Nel presente documento, alla luce delle indicazioni regionali e dei riferimenti sopra riportati,<br />
viene presentata in primo luogo una valutazione clinico-epidemiologica riferita alla realtà locale<br />
sviluppata sia attraverso l’analisi degli indicatori di domanda e offerta di prestazioni sia mediante<br />
l’esame della casistica degli utenti seguiti dal DSM aggiornata al mese di gennaio 2006. Gli<br />
indicatori di domanda / offerta sono stati elaborati attraverso l’analisi dei dati pubblicati nel<br />
rapporto “Le prestazioni psichiatriche anno 2004” pubblicato dalla Regione Lombardia, mentre la<br />
valutazione della casistica clinica è stata condotta, nell’ambito dell’equipe multidisciplinare<br />
dell’OCSM costituita da componenti dell’<strong>ASL</strong> (Dipartimento PAC) e dell’A.O. (Dipartimento di<br />
Salute Mentale), esaminando i piani di trattamento individuali relativi ai singoli pazienti.<br />
Questo lavoro ha consentito di acquisire in modo sistematico le informazioni necessarie per<br />
formulare una proposta di riqualificazione del sistema di offerta delle SR coerente con i bisogni<br />
assistenziali presenti nel territorio, compatibile con le indicazioni programmatorie regionali,<br />
finalizzata e definire i tempi di realizzazione, le indicazioni operative, le modalità di monitoraggio e<br />
valutazione del sistema di offerta.<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 1
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 2
Il quadro epidemiologico e l’analisi della domanda / offerta di prestazioni<br />
Nella presente analisi sono utilizzati principalmente i dati relativi ai consumi di prestazioni<br />
psichiatriche pubblicati nel rapporto della Regione Lombardia relativo all’anno 2004 e che<br />
rappresentano indubbiamente una fonte informativa di riferimento sia per la valutazione del<br />
contesto assistenziale locale sia per analisi di confronto con la realtà regionale. Per il calcolo dei<br />
tassi sono stati utilizzati i dati pubblicati dall’ISTAT per quanto concerne il territorio regionale<br />
mentre per il calcolo degli stessi a livello locale sono stati utilizzati i dati rilevati dal Servizio<br />
Sistema Informativo aziendale attraverso gli uffici anagrafe dei Comuni. Gli indicatori relativi ai<br />
ricoveri ospedalieri sono stati elaborati utilizzando i dati delle SDO e la banca dati dinamica<br />
ALEEAO.<br />
L’incidenza delle patologie psichiatriche nell’<strong>ASL</strong> risulta sostanzialmente sovrapponibile a<br />
quella regionale; il tasso<br />
di pazienti residenti<br />
ricoverati in SPDC<br />
presenta un valore<br />
lievemente inferiore<br />
nell’<strong>ASL</strong> pari a 1,57 casi<br />
x 1.000 abitanti rispetto<br />
alla regione (1,70 x<br />
1.000).<br />
Il tasso di prestazioni psichiatriche<br />
extraospedaliere complessive<br />
(territoriali, semiresidenziali,<br />
residenziali e domiciliari) fruite dai<br />
cittadini residenti è sensibilmente<br />
inferiori per il 2004 nel territorio<br />
provinciale rispetto all’ambito regionale<br />
mentre la distribuzione relativa tra<br />
maschi e femmine risulta<br />
sovrapponibile.<br />
Anche la distribuzione per fasce di età<br />
nell’<strong>ASL</strong> risulta coerente con i valori<br />
riscontrati in ambito regionale sia per i<br />
maschi che per le femmine con un picco<br />
nella fascia 35/44 per i maschi e nella<br />
fascia 45/54 per le femmine.<br />
Tasso x 1.000 resdidenti<br />
500,00<br />
450,00<br />
400,00<br />
350,00<br />
300,00<br />
250,00<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
-<br />
Tassi prestazioni psichiatriche per età<br />
(maschi)<br />
65<br />
<strong>ASL</strong> Regione<br />
Incidenza ricoveri patologie psichiatriche<br />
anno 2004<br />
tassi per 1.000 residenti<br />
N° pazienti<br />
ricoverati<br />
<strong>ASL</strong> <strong>Lecco</strong> 496<br />
Lombardia 15.441<br />
Prestazioni psichiatriche extraospedaliere<br />
(anno 2004)<br />
300,00<br />
250,00<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
-<br />
Tasso x 1.000 resdidenti<br />
350,00<br />
300,00<br />
250,00<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
-<br />
Popolazione<br />
315.183<br />
9.108.645<br />
maschi femmine<br />
Tasso di incidenza<br />
x 1.000<br />
Tassi prestazioni psichiatriche per età<br />
(femmine)<br />
65<br />
<strong>ASL</strong> Regione<br />
1,57<br />
1,70<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 3<br />
asl<br />
regione
Nella figura successiva viene rappresentata la distribuzione delle prestazioni totali, in<br />
termini di tasso per 1.000 residenti maschi e femmine, in relazione alla diagnosi formulata; il<br />
profilo diagnostico rilevato nell’<strong>ASL</strong>, pur con i valori inferiori già evidenziati risulta decisamente<br />
sovrapponibile a quello regionale con una maggiore incidenza di prestazioni con diagnosi di<br />
schizofrenia e sindromi deliranti e di disturbi della personalità nell’adulto.<br />
N° prestazioni per 1.000 residenti<br />
Il ricorso alle strutture riabilitative ed assistenziali, sia in termini di numerosità che di<br />
valorizzazione economica, presenta nell’<strong>ASL</strong>, rispetto alla regione, le seguenti caratteristiche:<br />
minore ricorso alle strutture residenziali ed alle prestazioni territoriali e maggiore utilizzo di<br />
prestazioni semiresidenziali e domiciliari.<br />
Si evidenzia come la quota prevalente di risorse (oltre il 60%) sia nell’<strong>ASL</strong> che in regione sia<br />
destinata alle attività residenziali mentre decisamente inferiore è l’entità della valorizzazione totale<br />
per prestazioni territoriali e domiciliari.<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
180,00<br />
160,00<br />
140,00<br />
120,00<br />
100,00<br />
80,00<br />
60,00<br />
40,00<br />
20,00<br />
-<br />
territoriali<br />
Prestazioni per diagnosi<br />
(per 1.000 residenti - maschi)<br />
Diagnosi mancante<br />
Sindromi di natura organica<br />
Sindromi da sostanze psicoattive<br />
Schizofrenia e sindromi deliranti<br />
Sindromi affettive<br />
Sindromi nevrotiche, somatoformi<br />
Sindromi associate a fattori somatici<br />
Prestazioni per tipologia (%)<br />
anno 2004<br />
semiresidenziali<br />
residenziali<br />
<strong>ASL</strong> Regione<br />
<strong>ASL</strong><br />
Regione<br />
Ritardo mentale<br />
Sindromi da alterato sviluppo psicologico<br />
Sindromi ad esordio nell'infanzia e adole...<br />
Nulla di psicopatologico<br />
domiciliari<br />
N. prestazioni per 1.000 residenti<br />
70,0%<br />
60,0%<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
100,00<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
-<br />
Valorizzazione prestazioni per tipologia (%)<br />
anno 2004<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 4<br />
territoriali<br />
Prestazioni per diagnosi<br />
(per 1.000 residenti - femmine)<br />
Diagnosi mancante<br />
Sindromi di natura organica<br />
Sindromi da sostanze psicoattive<br />
Schizofrenia e sindromi deliranti<br />
Sindromi affettive<br />
Sindromi nevrotiche, somatoformi<br />
Sindromi associate a fattori somatici<br />
semiresidenziali<br />
Ritardo mentale<br />
Sindromi da alterato sviluppo psicologico<br />
Sindromi ad esordio nell'infanzia e adole...<br />
Nulla di psicopatologico<br />
residenziali<br />
<strong>ASL</strong> Regione<br />
<strong>ASL</strong><br />
Regione<br />
domiciliari
La mobilità verso strutture a contratto extraprovincia risulta complessivamente contenuta e<br />
limitata essenzialmente alle prestazioni residenziali; la percentuale di prestazioni fruite presso<br />
strutture extra <strong>ASL</strong> risulta infatti pari al 22% del totale sia in termini di numerosità delle stesse che<br />
di valorizzazione economica.<br />
20.000<br />
16.000<br />
12.000<br />
8.000<br />
4.000<br />
-<br />
territoriali<br />
Mobilità extraprovincia<br />
(numero prestazioni)<br />
semiresidenziali<br />
residenziali<br />
entroprovincia extraprovincia<br />
Il ricorso alle strutture non a<br />
contratto appare in progressiva<br />
riduzione nel triennio 2003 – 2005<br />
sia come numero di pazienti (-24%)<br />
sia come giornate di residenzialità<br />
(-12%); contestualmente si<br />
evidenzia un maggiore ricorso alle<br />
strutture accreditate a contratto per<br />
le quali risulta un aumento del<br />
numero di pazienti nel triennio pari<br />
al 7,5% mentre le giornate di<br />
residenzialità presentano un<br />
incremento del 30%.<br />
Questa evidenza è certamente<br />
domiciliari<br />
3.000.000<br />
2.500.000<br />
2.000.000<br />
1.500.000<br />
1.000.000<br />
500.000<br />
riconducibile al potenziamento dell’offerta presente nel territorio avvenuto nel 2004 con<br />
l’accreditamento e la messa a contratto della nuova comunità protetta del DSM che ha consentito<br />
anche il recupero di pazienti ospiti presso strutture extraregionali.<br />
Analisi dei percorsi riabilitativi e assistenziali: utenti attuali<br />
Mobilità extraprovincia<br />
(valorizzazione prestazioni)<br />
Nelle tabelle seguenti è riportata la casistica attuale dei pazienti residenti nel territorio<br />
dell’<strong>ASL</strong> e ospiti presso strutture riabilitative e assistenziali. Per ciascuna tipologia di struttura è<br />
indicato il numero di pazienti in carico al mese di gennaio 2006, il numero di casi che risultano<br />
coerenti con i criteri di appropriatezza previsti dal PRSM ed il numero di pazienti per i quali è<br />
prevista una rimodulazione del percorso riabilitativo assistenziale o una proroga dello stesso per<br />
particolare complessità del quadro clinico o per l’attuale indisponibilità di strutture adeguate nel<br />
territorio.<br />
-<br />
territoriali<br />
semiresidenziali<br />
residenziali<br />
domiciliari<br />
entroprovincia extraprovincia<br />
Strutture non a contratto<br />
n. pa zie nti gg re side nzia lità ta sso<br />
ANNO 2003 37 10.258 32,45<br />
ANNO 2004 33 9.074 28,45<br />
ANNO 2005 28 8.929 27,68<br />
Strutture a contratto<br />
n. pazienti gg residenzialità tasso<br />
ANNO 2003 80 16.943 53,61<br />
ANNO 2004 83 17.165 53,81<br />
ANNO 2005 86 22.075 68,44<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 5
Strutture Riabilitative / Assistenziali a contratto (in provincia – extraprovincia)<br />
Tipo di struttura N. Pazienti Criteri SI Criteri NO Note<br />
CRT (in <strong>ASL</strong>) 27 20 7 a1 – a2 – a3<br />
CPA (extra<strong>ASL</strong>) 6 5 1 a4<br />
CPM (in <strong>ASL</strong>) 25 20 5 a5 – a6<br />
CPM (extra <strong>ASL</strong>) 5 3 2 a7<br />
CA (in <strong>ASL</strong>) 2 2 0 -<br />
Strutture Riabilitative / Assistenziali non a contratto (in provincia – extraprovincia – extraregione)<br />
Tipo di struttura N. Pazienti Criteri SI Criteri NO Note<br />
CPA (1 in <strong>ASL</strong>, 1 extra <strong>ASL</strong>) 2 2 0 -<br />
CPM (1 in <strong>ASL</strong>, 1 extra <strong>ASL</strong>) 2 1 1 b1<br />
CA (in <strong>ASL</strong>) 2 2 0 -<br />
Altro 2 2 0 CODIC<br />
Strutture Socio Sanitarie<br />
Tipo di struttura N. Pazienti Criteri SI Criteri NO Note<br />
RSA 3 3 0 -<br />
RSD 1 1 0 -<br />
IDR 7 3 4 c1<br />
Strutture Sociali<br />
Tipo di struttura N. Pazienti Criteri SI Criteri NO Note<br />
Appartamenti 10 10 0 -<br />
Note relative ai soggetti che non rispondono ai criteri (criteri NO) di inserimento in SR come<br />
previsto dal PRSM:<br />
a1 – per 3 pazienti è indicato ed in corso di attuazione il passaggio a SR area assistenziale (CPM)<br />
a2 – per 2 pazienti è proponibile il rientro in famiglia<br />
a3 – 2 pazienti presentano condizioni cliniche che richiedono una proroga<br />
a4 – 6 pazienti ospiti di CPA extraprovincia: richiedere valutazione clinica per 1 caso extra soglia<br />
a5 - 4 pazienti presentano condizioni cliniche che richiedono una proroga<br />
a6 – per 1 paziente è previsto l’inserimento in RSA<br />
a7 – 5 pazienti ospiti in CPM extraprovincia: richiedere valutazione clinica per 2 casi extra soglia<br />
b1 – Richiedere valutazione clinica aggiornata<br />
c1 – Richiedere valutazione clinica aggiornata<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 6
Valutazione clinica e ipotesi di revisione dei percorsi riabilitativi / assistenziali per “gruppi”<br />
omogenei di pazienti.<br />
Per la valutazione clinica e il monitoraggio dei bisogni di residenzialità, riabilitazione,<br />
assistenza e risocializzazione si propone di effettuare una classificazione dell’utenza psichiatrica in<br />
carico, in gruppi omogenei sulla base di criteri clinici di diagnosi, di decorso, di bisogni terapeuticoriabilitativi<br />
e assistenziali, di età e durata, correlati con la sede appropriata per l’erogazione del<br />
servizio, secondo il seguente schema:<br />
1. Gruppo 1: SOGGETTI CON QUADRO PSICOPATOLOGICO IN FASE DI POST-<br />
ACUZIE. Soggetti che presentano una condizione psicopatologica di recente esordio e/o<br />
riacutizzazione, con sintomatologia positiva e negativa non ancora stabilizzata ed una disabilità<br />
secondaria e funzionale significative, bisogni assistenziali elevati che necessitano di interventi<br />
psichiatrici complessi e protratti. I limiti di età per l’inserimento in questo programma è di 65<br />
anni. Programma presso CRA<br />
2. Gruppo 2: SOGGETTI INSERIBILI IN SR DELL’AREA RIABILITATIVA PER<br />
PROGRAMMA RIABILITATIVO AD ALTA INTENSITÀ RIABILITATIVA. Soggetti<br />
che presentano una condizione psicopatologica di recente esordio e/o con decorso naturale<br />
difettuale, con sintomatologia positiva e negativa non ancora stabilizzata, che presentano una<br />
disabilità secondaria e funzionale significative che possono trarre beneficio da interventi<br />
riabilitativi intensivi. I limiti di età per l’inserimento in questo programma è di 50 anni. I<br />
soggetti possono provenire oltre che dall’area <strong>territoriale</strong> anche da altri programmi riabilitativi.<br />
Programma presso CRA/CRM<br />
3. Gruppo 3: SOGGETTI INSERIBILI IN SR DELL’AREA RIABILITATIVA PER<br />
PROGRAMMA RIABILITATIVO A MEDIA INTENSITÀ RIABILITATIVA. Soggetti<br />
che presentano una condizione psicopatologica con decorso naturale difettuale, presentanti una<br />
disabilità secondaria e funzionale non ancora sufficientemente stabilizzata che necessitano di<br />
ulteriori interventi riabilitativi intensivi. I limiti di età per l’inserimento in questo programma è<br />
di 50 anni. Soggetti provenienti prevalentemente da programmi di riabilitazione intensiva presso<br />
le CRA. Programma presso CRA/CRM<br />
4. Gruppo 4: SOGGETTI INSERIBILI IN SR DELL’AREA ASSISTENZIALE PER<br />
PROGRAMMA RIABILITATIVO ESTENSIVO IN CONDIZIONE DI ALTA<br />
PROTEZIONE. Soggetti che non presentano una condizione psicopatologica sufficientemente<br />
stabilizzata, con disabilità residuale che non necessitano di ulteriori interventi riabilitativi<br />
intensivi, ma presentano bisogni assistenziali di grado elevato. I limiti di età per l’inserimento in<br />
questo programma è di 65 anni. Programma presso CPA.<br />
5. Gruppo 5: SOGGETTI INSERIBILI IN SR DELL’AREA ASSISTENZIALE PER<br />
PROGRAMMA RIABILITATIVO ESTENSIVO IN CONDIZIONE DI MEDIA<br />
PROTEZIONE. Soggetti che presentano una condizione psicopatologica stabilizzata, con<br />
disabilità residuale e decorso cronico, con bisogni assistenziali di grado medio. I limiti di età per<br />
l’inserimento in questo programma è di 65 anni. Programma presso CPA/CPM.<br />
6. Gruppo 6: SOGGETTI INSERIBILI IN SR DELL’AREA SOCIALE PER PROGRAMMA<br />
RIABILITATIVO “RESIDENZIALITÀ LEGGERA” IN CONDIZIONE DI<br />
MEDIA/BASSA PROTEZIONE. Soggetti che presentano una condizione psicopatologica<br />
sufficientemente stabilizzata, con disabilità residuale che necessitano di programmi di<br />
reinserimento sociale protetto e sostegno nella risocializzazione. Non ci sono limiti di età.<br />
Programma presso SR dell’area sociale<br />
7. Gruppo 7: SOGGETTI INSERIBILI IN SR SOCIO-ASSISTENZIALE. Soggetti che<br />
presentano una condizione psicopatologica sufficientemente stabilizzata, con disabilità residuale<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 7
che non necessitano di programmi di reinserimento sociale protetto e sostegno nella<br />
risocializzazione. Non ci sono limiti di età. Programma presso SR dell’area socio-assistenziale.<br />
8. Gruppo 8: SOGGETTI INSERIBILI IN RSA. Soggetti che presentano una condizione<br />
psicopatologica sufficientemente stabilizzata, con disabilità residuale che hanno raggiunto il<br />
limite di età di 65 anni, con bisogni di tipo socio-sanitario e per i quali non è possibile un<br />
programma di reinserimento sociale protetto. Programma presso RSA<br />
9. Gruppo 9: SOGGETTI DIMISSIBILI A DOMICILIO. Soggetti che hanno concluso il<br />
programma riabilitativo e assistenziale psichiatrico con residue esigenze assistenziali che<br />
possono essere saturate con le risorse territoriali del DSM e con l’attivazione di una rete di<br />
sostegno sociale. Questo gruppo potrebbe necessitare, per un periodo limitato di tempo, di un<br />
programma di “residenzialità leggera”.<br />
In seguito alla distribuzione in gruppi omogenei è possibile stabilire l’offerta adeguata del servizio<br />
ed individuare le azioni correttive da intraprendere come illustrato nella seguente tabella:<br />
Tabella: Distribuzione dei soggetti inseriti in SR alla data del 1° gennaio 2006.<br />
Gruppo N° soggetti<br />
Residenza e<br />
programma<br />
adeguati<br />
N° soggetti<br />
Residenza e<br />
programma non<br />
rispondenti ai criteri<br />
N° soggetti<br />
da rivalutare<br />
N° soggetti<br />
da monitorare<br />
1 5 0 0 0<br />
2 10 0 0 0<br />
3 5 0 0 0<br />
4 7 8 4 4<br />
5 24 2 1 1<br />
6 10*+2** 2 2 0<br />
7 8 1 1 0<br />
8 3 5 4 1<br />
9 0 2 0 2<br />
Tot 74 20 12 8<br />
*) Comprendono “Appartamenti”<br />
**) Comprendono “Altro”<br />
Considerazioni complessive<br />
Dalla tabella soprariportata si evince che le criticità sono prevalentemente concentrate nel<br />
gruppo di pazienti con bisogni assistenziali e socio-assistenziali, in particolare:<br />
1. Per alcuni pazienti (gruppo 4) sono necessari percorsi assistenziali ad alta protezione<br />
realizzabili in strutture attualmente non disponibili nel territorio provinciale (CPA/CRM),<br />
per i quali è stata richiesta una proroga al programma di residenzialità in CRA o che sono<br />
inseriti in CP oltre i termini della durata prevista.<br />
2. Un soggetto del gruppo 5 è in fase di inserimento in CPM come correttamente previsto dal<br />
progetto personale, un altro soggetto andrà rivalutato per ridefinire un percorso coerente con<br />
le nuove indicazioni e linee guida<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 8
3. Un gruppo di soggetti (Gruppi 6-7, noti anche come “casi storici”) risiedono in strutture<br />
socio-sanitarie e necessitano di una rivalutazione da parte dell’inviante per ridefinire un<br />
percorso coerente con le nuove indicazioni e linee guida<br />
4. Per i soggetti (gruppo 8) che hanno superato l’età di 65 anni resta comunque piuttosto<br />
difficile l’inserimento in RSA. Per facilitare l’inserimento in RSA l’OCSM ha già avviato<br />
un apposito gruppo tecnico per la definizione di un protocollo finalizzato alla rielaborazione<br />
di criteri e modalità di gestione dei casi, tenuto conto anche della presenza di Strutture che<br />
intendono sviluppare programmi assistenziali specifici.<br />
5. Per due soggetti (gruppo 9) è previsto un programma di rientro in famiglia: è stata richiesta<br />
proroga per completare il progetto.<br />
6. Occorre infine tener in considerazione che un gruppo di soggetti completeranno il percorso<br />
riabilitativo assistenziale nell’arco dei prossimi due anni; per costoro è necessario favorire<br />
un ulteriore sviluppo della rete delle strutture sociali in collaborazione con i Comuni e<br />
l’avvio di programmi di residenzialità leggera.<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 9
Quadro delle Strutture riqualificate accreditate a contratto e non a contratto<br />
Nelle tabelle di seguito riportate sono indicate le Strutture Residenziali (SR) accreditate<br />
riqualificate, a contratto e non, presenti nel territorio dell’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> con la relativa dotazione di<br />
posti letto.<br />
Strutture di area riabilitativa<br />
Denominazione struttura Tipologia riqualificata Posti letto<br />
C.R.T. di Cernusco Lombardone C.R.A. 12<br />
C.R.T. di Bosisio Parini C.R.A. 16<br />
Strutture di area assistenziale<br />
Denominazione struttura Tipologia riqualificata Posti letto<br />
C.P. elevata intensità assistenziale “Il Poggio” C.P.A. 6<br />
C.P. di media intensità assistenziale di Garlate C.P.M. 10<br />
C.P. di media intensità assistenziale di Casatenovo C.P.M. 16<br />
Casa Sara (C.P. a bassa intensità assistenziale) C.P.M. fascia B 2<br />
Strutture di area sociale<br />
Progetti innovativi Tipologia riqualificata Posti letto<br />
Castello Solidale Residenzialità leggera 6<br />
Via Pergola Residenzialità leggera 4<br />
Strutture non a contratto<br />
Denominazione struttura Tipologia riqualificata Posti letto<br />
C.P.A. “Il volo” di Monticello Br. C.P.A. 20<br />
C.P.M. “Antropos” di Esino C.P.M. 20<br />
Criticità e proposte<br />
Dal quadro presentato si evidenziano alcune criticità principalmente legate alla carente<br />
diversificazione delle strutture d’offerta a contratto, alla mancanza di alcune tipologie di strutture ed<br />
alla difficoltà di modulare gli interventi riabilitativi-assistenziali attraverso l’erogazione dell’intera<br />
gamma di programmi previsti dal PRSM.<br />
Nella tabella sottoriportata viene quindi presentata la proposta di riqualificazione delle strutture a<br />
contratto elaborata d’intesa con il DSM, approvata nell’ambito dell’OCSM e finalizzata a:<br />
- completare o adeguare la rete di offerta delle strutture residenziali presenti nel territorio<br />
ridefinendo la dotazione di posti letto riabilitativi di alta intensità, prevedendo la dotazione di<br />
una struttura riabilitativa di media intensità, ridistribuendo la dotazione di posti letto di<br />
assistenza ad alta e media intensità;<br />
- consentire l’implementazione ed il potenziamento di programmi di residenzialità leggera in<br />
raccordo ed in continuità con i progetti innovativi già attivati o in via di attivazione;<br />
- garantire una struttura d’offerta complessiva compatibile con la dotazione programmata e<br />
coerente con le indicazioni del PRSM.<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 10
Strutture di area riabilitativa<br />
Denominazione struttura Riqualificazione proposta Posti letto<br />
C.R.T. di Cernusco Lombardone C.R.A. 14<br />
C.R.T. di Bosisio Parini C.R.M. 14<br />
Strutture di area assistenziale<br />
Denominazione struttura Riqualificazione proposta Posti letto<br />
C.P. elevata intensità assistenziale “Il Poggio” C.P.A. 6<br />
C.P. di media intensità assistenziale di Garlate C.P.M. 10<br />
C.P. di media intensità assistenziale di Casatenovo C.P.A. 16<br />
Casa Sara (C.P. a bassa intensità assistenziale) C.P.M. fascia B 2<br />
Strutture/progetti di area sociale<br />
Strutture o progetti Riqualificazione proposta Posti letto<br />
Castello Solidale (programma innovativo) Residenzialità leggera 6<br />
Via Pergola (progetto quadriennale – appartamento protetto) Residenzialità leggera 4<br />
Posti di residenzialità leggera gestiti da CRM (Bosisio) Residenzialità leggera 4<br />
Posti di residenzialità leggera gestiti da CRA (Cernusco) Residenzialità leggera 2<br />
Il percorso di riqualificazione delle strutture<br />
Nella fase transitoria, come indicato dalle disposizioni regionali, le SR riqualificate<br />
mantengono i requisiti di autorizzazione e accreditamento validi per le attuali SR secondo la<br />
normativa vigente (DGR 38133 del 6.08.1998; Decreto DGS 19791 del 8.08.2000) con le ulteriori<br />
indicazioni e precisazioni che vengono definite nelle tabelle 1 e 2 allegate alla circolare 49/SAN. Le<br />
SR riqualificate devono recepire le linee guida e gli indicatori di attività che vengono presentati nel<br />
Piano Regionale Salute Mentale (DGR 17513 del 17.05.2004) come “protocolli di accoglimento,<br />
trattamento, dimissione” per le SR psichiatriche. A tal fine il Servizio PAV ha già avviato la<br />
verifica in merito all’adozione da parte delle Strutture accreditate a contratto dei suddetti protocolli<br />
richiedendo la presentazione degli stessi per le successive valutazioni nell’ambito delle attività di<br />
controllo.<br />
Al fine della completa attuazione del percorso di riqualificazione secondo i nuovi requisiti<br />
previsti, le Strutture Residenziali Accreditate a contratto dovranno:<br />
- garantire, a partire dal 1° gennaio 2006, l’applicazione dei protocolli di accoglienza,<br />
trattamento e dimissione previsti dal PRSM;<br />
- assicurare, a partire dal 1° gennaio 2006, il rispetto dei criteri di ammissione per i nuovi<br />
accoglimenti, ovvero per l’accoglimento di utenti che non hanno avuto precedenti trattamenti in<br />
ambito psichiatrico, come previsto dalla circolare 49/SAN.<br />
Caratterizzazione dei programmi residenziali<br />
Sulla base di quanto definito nel PRSM l’intensità dei programmi riabilitativi si basa su<br />
tre criteri: a) la numerosità e l’intensità degli interventi erogati, b) il mix di tipologie diverse di<br />
interventi (individuali, di gruppo, terapeutici, riabilitativi, in sede, fuori sede), c) la numerosità e<br />
l’intensità di interventi che riguardano la rete sociale (famiglia, lavoro, socialità).<br />
Fermi restando i criteri riguardanti la numerosità e l’intensità degli interventi definiti nella<br />
circolare 28/SAN del 21/7/2004, l’OCSM, attraverso un apposito gruppo di lavoro ha definito ed<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 11
approvato un “Documento Tecnico” che stabilisce gli ulteriori criteri qualitativi (interventi) che<br />
caratterizzano i programmi riabilitativi riportati nella seguente tabella.<br />
PROGRAMMI INTERVENTI<br />
Bassa intensità riabilitativa<br />
Media intensità riabilitativa<br />
Alta intensità riabilitativa<br />
Programmi post - acuzie<br />
• Interventi sulle abilità di base con affiancamenti individuali<br />
per l’igiene, la pulizia, la lavanderia<br />
• Coinvolgimento in minime mansioni della vita quotidiana di<br />
comunità: riordino di spazi di comunità, turnazioni nelle<br />
attività di colazione, pranzo, cena<br />
• Interventi di intrattenimento: attività ludiche interne alla<br />
comunità<br />
• Coinvolgimento del volontario per sostegno di programmi<br />
personalizzati<br />
• I precedenti punti della bassa intensità<br />
• Interventi di risocializzazione: attività di gruppo in sede o<br />
fuori sede (gite, viaggi)<br />
• Partecipazione ad un momento di gruppo comunitario e<br />
programmatico<br />
• Partecipazione ad attività di gruppo: espressive,<br />
psicomotorie, musicali, gruppi discussione<br />
• Coinvolgimento di volontari nelle attività riabilitative in<br />
sede e fuori sede<br />
• I precedenti punti della bassa e della media intensità<br />
• Gruppi psicoterapici: psicodramma, musicoterapica, ecc.<br />
• Psicoterapia e/o colloqui strutturati specialistici individuali e<br />
della famiglia<br />
• Corresponsabilità nella gestione di momenti comunitari<br />
• Interventi di riabilitazione psicosociale<br />
• Partecipazione ad attività pre-lavorative<br />
• Inserimento in progetti di avviamento al lavoro<br />
• Partecipazione ad attività eterocentrate e promosse sul<br />
territorio come segno di corresponsabilità nella cura:<br />
incontri con associazioni locali, promozione di attività<br />
preventive territoriali, promozione e partecipazione ad<br />
attività esterne alla comunità e autonome<br />
• Partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto<br />
• Interventi per la valutazione clinico-diagnostica<br />
• Interventi con i familiari<br />
• Interventi di risocializzazione: attività individuali e di<br />
gruppo in sede<br />
• Interventi sulle abilità di base interpersonali e sociali<br />
• Somministrazione di farmaci<br />
I criteri sopra descritti saranno applicati, anche ai fini della valorizzazione economica dei<br />
programmi riabilitativi erogati, a partire dalla scadenza dei termini per la riqualificazione delle<br />
strutture e secondo le modalità che saranno definito in ambito regionale. Resta inteso che i<br />
programmi definiti nel Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR) elaborato dalle SR dovranno<br />
comunque essere coerenti con le indicazioni espresse dal DSM inviante che definisce nel PTI le<br />
caratteristiche del programma che dovrà essere realizzato.<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 12
Per quanto riguarda la valutazione dell’appropriatezza dei programmi riabilitativi di pazienti<br />
residenti e già ospiti di SR, il Servizio PAV, in accordo con l’OCSM, ha avviato un percorso di<br />
verifica finalizzato a definire il quadro della domanda attraverso l’esame dei PTI dei singoli pazienti<br />
ed a formulare le eventuali proposte di soluzioni assistenziali adeguate rispetti ai bisogni dei<br />
pazienti e coerenti con i criteri di appropriatezza previsti dal PRSM. A tale fine è stata costituita,<br />
nell’ambito dell’OCSM, un equipe di valutazione multidisciplinare che prevede la partecipazione di<br />
figure professionali designate dall’<strong>ASL</strong> e dall’A.O..<br />
Per l’individuazione delle soluzioni assistenziali più adeguate rispetto alle esigenze dei<br />
singoli pazienti in conformità con i criteri sopracitati, l’OCSM si propone di promuovere lo<br />
sviluppo della rete delle strutture di area sociale attraverso il raccordo con i progetti innovativi<br />
proposti sia da Enti locali che da Soggetti del terzo settore finalizzati all’ampliamento della<br />
“residenzialità leggera” (affido eterofamiliare, gruppi famiglia, assistenza domiciliare psichiatrica);<br />
l’OCSM promuoverà inoltre la definizione di protocolli condivisi per l’eventuale inserimento in<br />
RSA di pazienti che hanno superato i 65 anni d’età e di soggetti che presentano sindromi residuali<br />
deficitarie oltre i 55 anni d’età (equiparabili per le condizioni psicofisiche alle caratteristiche della<br />
popolazione più anziana). In tale ambito sarà garantito il tempestivo coinvolgimento dei Comuni<br />
per tutte quelle situazioni in cui si rivela prevalente la valenza socio-assistenziale della residenza in<br />
SR.<br />
Modalità operative<br />
∗ Gli psichiatri prescrittori del CPS di residenza del soggetto, per cui è stato avviato il percorso<br />
“presa in carico”, sono tenuti ad indicare nel PTI il tipo di programma riabilitativo richiesto<br />
secondo le seguenti tipologie:<br />
- Programma post acuzie<br />
- Programma ad alta intensità riabilitativa<br />
- Programma a media intensità riabilitativa<br />
- Programma a bassa intensità riabilitativa<br />
∗ Il medico prescrittore del DSM dovrà altresì indicare nel PTI le prestazioni necessarie per<br />
l’attuazione dello stesso (precisandone la numerosità, il mix degli interventi e la valenza<br />
sociale degli stessi) ed i precedenti periodi trascorsi in SR indicandone durata, tipo di struttura<br />
ed esito.<br />
∗ La domanda di inserimento in SR verrà vagliata dal NVISR del DSM al fine di garantire una<br />
corretta gestione degli invii e delle risorse, nel rispetto delle indicazioni cliniche e della scelta<br />
degli utenti. Tutti gli inserimenti in SR andranno segnalati all’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong>.<br />
∗ Le SR sono tenute a rispettare i protocolli di accoglienza, trattamento e dimissione elaborati<br />
secondo i criteri previsti dal PRSM e dall’allegato alle “Indicazioni operative per il<br />
monitoraggio e la valutazione dei percorsi riabilitativi di pazienti inseriti in strutture<br />
residenziali” approvate dall’OCSM.<br />
∗ Entro 60 giorni dall’ingresso in SR l’equipe curante dovrà predisporre il PTR sulla base delle<br />
indicazioni fornite dal PTI e dalle osservazioni cliniche emerse nel corso del periodo di<br />
accoglimento. Se sarà necessario modificare o integrare il programma richiesto dal PTI<br />
occorrerà effettuare un incontro con gli invianti per ridefinire la coerenza tra PTI e PTR. Per i<br />
programmi post-acuzie la stesura del PTR andrà effettuata entro quindici giorni dall’ingresso.<br />
∗ Gli psichiatri invianti del CPS e le equipes delle SR sono tenuti ad effettuare verifiche<br />
periodiche sull’andamento del progetto perseguendo una coerenza tra PTI e PTR; la cadenza<br />
delle verifiche è variabile sulla base del tipo di programma (almeno 3 incontri per il<br />
programma post-acuzie, 1 incontro ogni 4 mesi per l’alta intensità riabilitativa, 1 incontro ogni<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 13
6 mesi per la media intensità riabilitativa, 1 incontro all’anno per la bassa intensità<br />
riabilitativa).<br />
∗ L’equipe della SR, sulla base degli obiettivi proposti, rispetterà i limiti temporali del progetto,<br />
considerando fin dalle prime verifiche gli esiti attesi e le criticità connesse con le dimissioni,<br />
adoperandosi affinchè il soggetto possa attuare un percorso di cura coerente e adeguato.<br />
(verranno controllati gli eventi sentinella: dimissione dalla SR in regime di ricovero in SPDC,<br />
passaggio in cura al CPS non concordato, follow-up …)<br />
∗ Per i casi in cui il processo riabilitativo si considera in fase di conclusione e per i quali il<br />
bisogno socio-assistenziale appare ancora prevalente, occorrerà darne comunicazione ai<br />
Servizi sociali del Comune di residenza da parte del CPS e concordare con gli stessi il<br />
programma personalizzato ricorrendo, se ritenuto adeguato, ai programmi riabilitativi di<br />
“residenzialità leggera”.<br />
Valorizzazione dei percorsi riabilitativi<br />
A decorrere dai termini di adeguamento delle strutture ai requisiti autorizzativi e di<br />
accreditamento e fatte salve le ulteriori indicazioni regionali in merito al finanziamento della<br />
residenzialità psichiatrica secondo i criteri già definiti nella circolare 49/SAN, saranno attivate le<br />
procedure per il riconoscimento alle strutture delle quote fisse e delle quote variabili in funzione<br />
delle caratteristiche dei programmi riabilitativi come più sopra definiti.<br />
Le SR, come previsto dalla normativa, sono tenute a garantire la corretta rendicontazione delle<br />
prestazioni rese attraverso il sistema Psiche della Regione Lombardia al fine di agevolare le<br />
funzioni di controllo e di governo delle risorse.<br />
Il “Protocollo di intesa area tematica residenzialità” approvato dall’OCSM prevede<br />
l’eventuale ed eccezionale ricorso alle SR socio-assistenziali per ricoveri a valenza anche<br />
riabilitativa o alle SR accreditate non a contratto; tale soluzione dovrà comunque essere<br />
subordinata al rispetto dei seguenti criteri:<br />
− il ricovero deve avere caratteristiche riabilitative e per l’inserimento deve comunque esserci<br />
coerenza tra il PTI, di responsabilità del CPS inviante e PTR attuato nella struttura;<br />
− i soggetti devono rispondere ai requisiti previsti per l’inserimento nelle SR, come stabilito dal<br />
PRSM, dalla circolare 28 San del luglio 04 e come vengono esplicitati nel documento tecnico<br />
approvato dall’OCSM;<br />
− la valutazione iniziale del bisogno, la presenza di patologia di interesse psichiatrico e la<br />
valenza riabilitativa del ricovero sono di pertinenza del DSM;<br />
− per tali SR si applicherà il criterio di pagamento previsto dall’ “Atto di indirizzo e<br />
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” (D.P.C.M. 14.02.2001) e la<br />
successiva normativa relativa ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) - Gazzetta Ufficiale<br />
del 08.02.02 - che prevede per le SR a bassa intensità assistenziale una quota a carico del<br />
Comune “non inferiore al 30% e non superiore al 70%, fatta salva la eventuale<br />
compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale”.<br />
In base a tale definizione si stabilisce pertanto a carico del fondo sanitario dell’<strong>ASL</strong>:<br />
- una quota pari al 40% per strutture a bassa protezione (comunità alloggio e strutture<br />
accreditate non psichiatriche o a bassa protezione accreditate non a contratto);<br />
- una quota pari al 60% per comunità protette psichiatriche a media protezione accreditate non a<br />
contratto;<br />
- una quota pari all’80% per comunità protette psichiatriche ad alta protezione accreditate non a<br />
contratto.<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 14
La restante quota socio-assistenziale è a carico dei Comuni che possono rivalersi sull’utente<br />
stesso o sui loro familiari secondo i propri regolamenti. La valutazione sulla situazione economica<br />
del soggetto e del suo nucleo familiare per la determinazione della quota da recuperare è di<br />
pertinenza del Comune di residenza del soggetto.<br />
In situazioni assolutamente eccezionali che richiedono interventi riabilitativi altamente<br />
specifici non reperibili nella rete provinciale delle strutture a contratto, su proposta del DSM,<br />
l’OCSM può prevedere il riconoscimento dell’intera quota prevista ai sensi della circolare 49/SAN<br />
fatti salvi i criteri di appropriatezza prevista dalla circolare stessa.<br />
<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 15
Rapporto annuale 2005<br />
I PARTE<br />
Cap. 2<br />
DSM - Rapporti annuali 2005-2006<br />
Nel 2005 è stato istituito l’Organismo di Coordinamento (OCSM), che con i Protocolli sulla<br />
Residenzialità e sulla Territorialità, recepiti dalla Conferenza dei Sindaci e deliberati dai singoli<br />
Comuni, ha dato avvio ai Patti per la Salute Mentale ed alla Psichiatria di Comunità, previsti dal<br />
Piano Regionale. Tali Protocolli sono il frutto del lavoro di due Tavoli Tecnici: il Tavolo Tecnico<br />
del Territorio con la partecipazione per l’AO della Dr.ssa Puccia, e quello della Residenzialità con<br />
la partecipazione del Dr. Rossi e della Dr.ssa Puccia. Recentemente sono stati istituiti i Tavoli<br />
Tecnici definiti “Equipe multiprofessionale” per la valutazione ed il monitoraggio del sistema della<br />
residenzialità, “Inserimenti Lavorativi” ed, infine, “Coordinamento delle Associazioni di<br />
Volontariato”, con la partecipazione della Dr.ssa Puccia e della Dr.ssa Martini, che detiene l’Alta<br />
Professionalità denominata “ Riabilitazione e Risocializzazione”.<br />
La Conferenza Territoriale per la Salute Mentale, che ha presentato il lavoro e l’attività svolta si è<br />
tenuta nell’ottobre 2005.<br />
Il Comitato di Dipartimento, che si è riunito regolarmente una volta al mese ed ha organizzato<br />
l’Assemblea di Dipartimento in data 12.05.2005, ha prodotto il Documento Organizzativo con la<br />
riorganizzazione del DSM. Accanto alle SS già esistenti, è stato istituito la SS Funzionale “ Il Servizio<br />
di Psicologia” ed in staff al Direttore del DSM la Posizione Organizzativa dell’Area Sociale.<br />
Inoltre, sono state rivisitate le Alte Professionalità a valenza dipartimentale, che, prima collegate a<br />
Responsabilità di Presidio, sono state ora collegate, più propriamente, a cinque Funzioni.<br />
La Job Rotation e la valutazione dei Dirigenti, con l’assegnazione degli obbiettivi, ha impiegato<br />
molte energie e si prevede un grosso lavoro anche per il 2006, nella misura in cui il DSM, che non<br />
si serve di tecnologie avanzate, ma di risorse umane, deve investire molto sulla motivazione, il<br />
coinvolgimento e la responsabilizzazione dei Dirigenti”.<br />
Dal punto di vista delle strutture c’è stato l’avviamento fino alla saturazione dei posti della CPM di<br />
Casatenovo, l’apertura a fine anno del CD di <strong>Lecco</strong>, in corrispondenza con la trasformazione del<br />
CPS di Oggiono ad Ambulatorio e lo spostamento dei pazienti che erano in semiresidenzialità.<br />
Si è, inoltre, realizzato il Progetto di Residenzialità leggera, con l’apertura di un appartamento<br />
protetto soprannominato il Pergolino, che ha permesso la dimissione di 4 ospiti della CRA di<br />
Garbagnate Rota, completando così il circuito residenziale, previsto dal Piano Regionale.<br />
Per quel che riguarda l’Area della Residenzialità si è dato avvio al processo di riqualificazione con<br />
l’applicazione degli indirizzi contenuti nella Circolare Regionale 28/SAN 2005, relativi alla<br />
definizione dei percorsi riabilitativi, dei criteri di appropriatezza e dei programmi riabilitativi, (<br />
coerenza tra PTI e PTR). Per il governo e la gestione dell’intero sistema della Residenzialità è stato<br />
istituito il “ Nucleo di Valutazione ed Inserimento in Struttura Residenziale” (NVISR), che si<br />
riunisce mensilmente.<br />
In seguito a questa attività è stato possibile far rientrare sul territorio di origine gran parte dei<br />
soggetti, che erano ospiti presso strutture fuori Regione e fuori Provincia, limitando l’inserimento in<br />
altre strutture extra DSM a quei pazienti, che necessitavano di ricovero in Comunità ad Alta<br />
Protezione, non esistente nel DSM.<br />
I tre Programmi Innovativi triennali finanziati con fondo vincolato dalla Regione, che ci hanno visto<br />
coinvolti come DSM, approvati in Luglio, ci hanno impegnato nel 2005 per l’attività<br />
programmatoria e a partire da Ottobre per la fase di avviamento.<br />
Per quanto riguarda la realizzazione dei percorsi di cura territoriali, si evidenza che per la semplice<br />
Consulenza, riservata alle patologie minori, è stata mantenuta una tensione ed un parziale
aggiungimento dell’obbiettivo; a proposito sono stati effettuati Corsi di aggiornamento per i MMG,<br />
che sono i gestori della patologia, ma l’attivazione di ambulatori dedicati in collaborazione con la<br />
Fondazione Idea non è stata realizzata, per mancanza di finanziamenti da parte della Fondazione<br />
stessa.<br />
Sempre per quanto riguarda i percorsi di cura, si è privilegiata la Presa in Carico dei pazienti gravi,<br />
come previsto dalla Mission del DSM, focalizzando l’attenzione sulla corretta formulazione dei<br />
PTI, individuando come obbiettivi di budget dell’area Professionale e come item di miglioramento,<br />
la raccolta anamnestica ed i colloqui con i famigliari.<br />
Per quanto riguarda le patologie delle aree di confine sono stati regolarmente effettuati gli incontri<br />
previsti dei Nuclei Stabili di Collegamento con la UONPIA e con il SERD, sia per il Servizio<br />
Alcologia che per quello delle Tossico Dipendenze.<br />
In riferimento al Piano di Formazione, il DSM ha attuato i seguenti progetti formativi:<br />
- Corso di formazione su “La doppia diagnosi”, in collaborazione con il SERD (<strong>ASL</strong>) e la<br />
Provincia di <strong>Lecco</strong>,<br />
- Corso di formazione per i Medici di Medicina Generale sui percorsi di cura ed il trattamento<br />
dei disturbi dell’umore e d’ansia e di disadattamento,<br />
- corso per gli E.P. del DSM sulla riabilitazione secondo il metodo “Cunningham”,<br />
- 5 Moduli formativi per gli operatori del DSM (IP, EP, Ass. Soc., TRP): 1) Disturbi<br />
alimentari; 2) Gruppo analisi: dinamiche; 3) Il paziente psichiatrico e la legge; 4) Modelli<br />
relazionali; 5) Volontariato nel Servizio Sociale.<br />
- 2 Corsi su “Case management” presso ISERDIP e IREF per IP, EP e Ass. Soc.<br />
- Supervisioni d’equipe sui casi clinici.<br />
- Corso di formazione presso la SDA Bocconi “Valutazione dei Dirigenti delle Aziende<br />
Sanitarie” per i 2 Responsabili delle SS delle Aree di <strong>Lecco</strong> e di Merate.<br />
Proposte:<br />
Protocollo RSA. Si propone di aprire una trattativa tra gli Enti Istituzionali e le RSA per il problema<br />
relativo alla gestione dei casi psicogeriatrici, con l’auspicabile risultato di formalizzare un<br />
Protocollo di intesa.<br />
Una delle tematiche ancora da affrontare in modo organico è quella legata alle gestione Handicap<br />
Adulti, all’interno del OCSM si è attivato un Tavolo Tecnico per lo studio del problema, che ha<br />
come capo fila il Dr. Molteni, Direttore Sanitario della Nostra Famiglia di Bosisio Parini e come<br />
rappresentante della Psichiatria la Dr.ssa Caparrelli. Nell’attualità il nodo da sciogliere è legato al<br />
fatto che la UONPIA gestisce direttamente l’Handicap Minori, mentre per la Psichiatria degli adulti<br />
non è prevista la competenza e la relativa presa in carico, né tanto meno un sistema di<br />
finanziamento.<br />
L’altro problema è che la Nostra Famiglia gestisce un ambulatorio di Psichiatria per l’Handicap<br />
Adulti, accreditato sulla 28/ SAN, ma non sulla 46/SAN, per cui non sono fatturabili le prestazioni e<br />
gli interventi di tipo psico-sociale ed i colloqui con i famigliari.<br />
E’ recentemente stato istituito il gruppo di coordinamento delle Associazioni di Volontari e di<br />
Famigliari con l’obbiettivo di migliorare l’integrazione tra le attività a carattere risocializzante e di<br />
intrattenimento, di promozione primaria della Salute Mentale ( gruppi di Auto Mutuo Aiuto,<br />
interventi nelle scuole), di lotta allo Stigma e di organizzazione delle celebrazioni per la Giornata<br />
nazionale della Salute Mentale.<br />
Per le proposte interne inerenti l’attività del DSM, si ritiene in linea generale di consolidare gli<br />
obbiettivi professionali degli anni precedenti, ovvero il miglioramento nella stesura dei PTI e<br />
l’estensione a tutti i casi di Presa in Carico, il miglioramento nella stesura dei PTR,<br />
l’approfondimento degli Strumenti di Valutazione Diagnostica (Anamnesi, utilizzo di Scale di<br />
Valutazione secondo l’EBM…).
Alla luce delle indicazioni previste dal nuovo contratto, ci sembra assolutamente prioritario<br />
investire le energie nel 2006 sulla Valutazione dei Dirigenti, in considerazione che all’interno del<br />
DSM non avviene da tempo il necessario ricambio di Dirigenti, con la conseguenza di una sorta di<br />
fissità tendente alla cronicità, che non favorisce la necessaria flessibilità e la disponibilità al<br />
cambiamento. E’ noto che in Psichiatria la tendenza alla cronicità, insita nel paziente psicotico<br />
grave, si ripercuota pesantemente sugli operatori, sono professionalità così dette usuranti, con il<br />
risultato del Burn Out, della strutturazione delle così dette Relazioni di manutenzione con l’utente e<br />
della perdita di motivazione, elementi che innescano, in cortocircuito, ulteriore cronicità.<br />
L’obbiettivo è di cercare di favorire il processo di adeguamento al procedere per Obbiettivi,<br />
uscendo dall’inerzia dell’auto-referenzialità e del dovuto non per impegno e capacità, ma per<br />
anzianità. Le resistenze al cambiamento, l’eccessiva e limitante identificazione con il proprio<br />
gruppo sono meccanismi, che favoriscono la sottocultura della scissione ed un’ ingannevole<br />
valorizzazione, fonte di conflittualità e di separazione, incompatibili con il modello dipartimentale,<br />
che privilegia l’integrazione di ruoli e funzioni e la sinergia degli interventi.<br />
Prosegue il Miglioramento Continuo in Qualità, che prevede per l’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong><br />
ben due sistemi di certificazione, Vision 2000 e Joint Commission, più un terzo, strutturato solo per<br />
il DSM, di Certificazione tra Pari, proposto all’interno di uno dei Programmi Innovativi della<br />
Regione, si è provveduto a rendere omogenee, su tutto il territorio, procedure ed istruzioni<br />
operative. Trattasi di un nuovo modello certificativo dell’Accreditamento Professionale tra pari<br />
secondo l’EBM, che vede impegnati ben 15 DSM e che per il 2006 prevede ancora il<br />
completamento della fase formativa del gruppo dei rilevatori e dei facilitatori per poi dare inizio alla<br />
certificazione vera e propria con il 2007. Questo progetto vede come referente per il nostro DSM il<br />
Dr. Chianese, al quale è stata assegnata l’Alta Professionalità denominata Qualità ed<br />
Epidemiologia. Collaborano con lui la Dr.ssa Allevi, il Dr. Giunta, l’IP Laura Bruschi, l’EP Barbara<br />
Galbusera e l’Ass.Soc. Lieta Romeri.<br />
Il Piano Formativo 2006 prevede una serie di corsi, seminari e supervisioni, incentrati sul<br />
trattamento dei gravi Disturbi di Personalità e per quanto riguarda l’interazione con le agenzie di<br />
confine, allo scopo di favorire lo sviluppo della rete e l’interfaccia con il sociale, è previsto in<br />
collaborazione con la Provincia un Corso di formazione sui percorsi riabilitativi, la risocializzazione<br />
e il lavoro di rete. Inoltre, gli operatori che nel corso del 2005 si sono formati al Case Management<br />
saranno docenti del Corso esteso all’interno del DSM per il restante personale. Sarà poi istituito per<br />
gli operatori dell’Area Residenzialità un Corso per l’addestramento all’elaborazione dei Piani di<br />
Trattamento Riabilitativo ( PTR); per gli Ass. Soc. e gli EP è previsto un corso di formazione,<br />
centrato sulle problematiche inerenti gli inserimenti lavorativi dei giovani pazienti gravi, come<br />
previsto dal Programma Innovativo. Così come per il Programma Innovativo sui giovani psicotici è<br />
previsto un Corso di formazione dedicato ed una serie di supervisioni cliniche.<br />
Infine, per tutti gli operatori del DSM sarà tenuto un Corso su argomenti di Psichiatria Forense e<br />
Medicina Legale.<br />
Come continuazione di quanto intrapreso nel 2005 e da sviluppare per il 2006 sono il Gruppo di<br />
Coordinamento delle Associazioni, appena istituito, il Progetto Salute Mentale in Ospedale.<br />
Stiamo attendendo delucidazione da parte della Regione, dopo la Circolare 49/SAN e la sua<br />
successiva rivisitazione per concretizzare il lavoro di monitoraggio e riqualificazione delle strutture<br />
residenziali.
Rapporto annuale 2006<br />
Il Comitato di Dipartimento si è riunito regolarmente con periodicità mensile, ha organizzato<br />
l’Assemblea di Dipartimento in data 18 Maggio 2006 ed ha effettuato con l’Organismo di<br />
Coordinamento la Conferenza Territoriale per la Salute Mentale in data 21 Novembre 2006. Tutto<br />
ciò al fine di promuovere coerenza e condivisione nella realizzazione della Mission e degli obbiettivi<br />
concordati.<br />
Nonostante questo sforzo, la comunicazione e l’adesione partecipativa restano da migliorare per un<br />
maggior coinvolgimento di tutto il Personale.<br />
In considerazione della Job Rotation, effettuata nel 2005, del completamento delle strutture previste<br />
dal Piano Regionale (vedi apertura CD di <strong>Lecco</strong> in autunno 2005), dell’attivazione dei percorsi di<br />
cura, di nuove prassi e strumenti di valutazione, il DSM nel 2006 si era dato come obbiettivo più<br />
generale di consolidare quanto avviato negli anni precedenti, al fine di garantire che l’adesione<br />
formale al Piano di miglioramento diventasse pratica clinica quotidiana, con un reale orientamento<br />
al miglioramento della qualità delle prestazioni.<br />
Per quanto riguarda le strutture previste dal Piano per la Salute Mentale, restano da attivare i 2<br />
letti di DH presso l’SPDC del Manzoni di <strong>Lecco</strong>: è già stato richiesto il relativo personale, occorre<br />
ancora predisporre gli spazi dedicati all’attività (individuazione dell’area e completamento degli<br />
arredi). Si richiama agli elementi già in precedenza forniti per una maggior definizione della richiesta<br />
stessa.<br />
Come è ben noto si è in attesa di lumi da parte della Regione rispetto all’applicazione della Circolare<br />
49/San, che prevede la riqualificazione delle strutture e dovrebbe fornire, come da relazione inviata,<br />
tutta la gamma della tipologia di strutture e dei gradi di protezione previsti dal Piano, anche sul<br />
territorio della Provincia di <strong>Lecco</strong>. Al proposito è comunque in corso una valutazione dei bisogni<br />
reali della popolazione assistita e una valutazione critica del fabbisogno di S.R e della tipologia delle<br />
medesime.<br />
Secondo i criteri già citati dell’accreditamento si è provveduto ad incrementare gli orari di apertura<br />
del CPS di <strong>Lecco</strong>, mentre resta da definire la situazione del CPS di Bellano e del relativo bacino di<br />
utenza.<br />
I tre Programmi Innovativi Regionali si sono ormai avviati, raggiungendo gli obbiettivi previsti.<br />
Particolare attenzione è stata posta nell’anno alla gestione dei percorsi di cura, in particolare alla<br />
coerenza tra PTI/PTR.<br />
Abbiamo anche aderito alle indicazioni di Budget con l’individuazione di indicatori clinici di esito<br />
(Revolving door, scala Honos per la riabilitazione, scala VGF per CPS e SR), mantenendo comunque
un’attenzione costante sugli indicatori di processo (Appropriatezza nella compilazione cartelle cliniche,<br />
Partnership con MMG, Tempi attesa prime visite, Colloqui con i famigliari, Interruzione del<br />
rapporto di cura con CPS, Appropriatezza inserimenti in SR, monitoraggio eventi sentinella).<br />
Commento Indicatori di esito<br />
A partire dal secondo semestre del 2006 si è iniziata la rilevazione di tutti gli indicatori di esito, che<br />
essendo a scadenza annuale saranno valutabili nel secondo semestre 2007, fatta eccezione per la<br />
scheda Honos che viene ormai applicata da più di tre anni.<br />
Indicatore VGF area SR<br />
L’applicazione dell’indicatore di esito VGF è iniziato nel mese di luglio 2006 per tutti i pazienti<br />
presenti nelle strutture residenziali e semiresidenziali in quel mese.<br />
Alla data del 31 dicembre 2006, essendo la compilazione della scala VGF collegata alla<br />
compilazione del PTR ed alle revisioni dello stesso, (la periodicità di rilevazione è “variabile per<br />
ciascun paziente in quanto legata allo specifico programma” e nelle comunità protette e nelle<br />
strutture semiresidenziali i tempi di verifica di alcuni programmi hanno scadenze semestrali) non è<br />
stato possibile avere i dati relativi all’indicatore, in quanto mancante della seconda<br />
somministrazione in tutte le strutture.<br />
Per questo motivo il dato percentuale di tutta l’area residenziale che risulta al 31 dicembre 2006 del<br />
66%, quindi inferiore allo standard individuato del 70%, non appare in questo momento utilizzabile<br />
per considerazioni significative, in quanto la valutazione è stata applicata adeguatamente solo in un<br />
numero di programmi ridotto rispetto al totale della popolazione degente.<br />
È tuttavia interessante rilevare che soprattutto nelle strutture con programmi di semiresidenzialità<br />
vengano espressi valori al di sotto dello standard dichiarato. Le équipe dei CD ed il gruppo di<br />
coordinamento sono stati investiti della criticità. A partire da gennaio 2007, a seguito della stesura<br />
di nuovi PTR, si potranno avere i dati di tutte le strutture e sarà quindi possibile, al 31 dicembre<br />
2007 ricavare il dato reale di tale indicatore per poter poi esprimere le valutazioni e lo standard<br />
conseguito.<br />
Indicatore HONOS area SR<br />
I dati relativi alla scala HONOS sono stati raccolti secondo le procedure e la metodologia di<br />
rilevazione stabilita nel piano di attuazione dell’anno 2006.<br />
L’obiettivo dell’indicatore era la valutazione dell’esito dell’intervento terapeutico-riabilitativoassistenziale<br />
sia nelle sue componenti cliniche che psicosociali. Attraverso la compilazione della<br />
Scala Honos, si sono misurate le medie annue dei miglioramenti globali ottenuti dai singoli soggetti<br />
inseriti nelle diverse strutture residenziali o semiresidenziali, ad intervalli di tempo definiti e<br />
diversi a seconda del percorso terapeutico individuato, come stabilito dal piano di attuazione<br />
dell’indicatore.<br />
I risultati mettono in luce che tutte le strutture, con diversa percentuale, hanno raggiunto l’obiettivo<br />
proposto che era stato fissato al 63% di miglioramenti /mantenimenti (se dichiarati) dei valori<br />
globali delle scale messe a confronto nelle singole rilevazioni. Le due strutture residenziali, CRA di<br />
Garbagnate e Cernusco L., si comportano in modo piuttosto omogeneo, cosi’ come nel complesso<br />
tutte le semiresidenzialità. Si nota invece un andamento diverso da parte delle due CPM :<br />
Casatenovo presenta la percentuale più bassa anche se ha raggiunto il valore standard previsto ;<br />
viceversa la CPM di Garlate ha una percentuale di miglioramenti molto elevata. Questo dato può<br />
essere interpretato come il frutto di un’attività, che si sta svolgendo ormai in modo consolidato da<br />
parecchio tempo da parte della comunità di Garlate. La CPM di Casatenovo, viceversa, nel
confronto mette in luce possibili difficoltà di assestamento, dovute alla recente apertura della<br />
Comunità e al recente inserimento di pazienti su cui gli obiettivi sono ancora in continua<br />
riformulazione, dato che gli ospiti sono ancora soggetti di osservazione ed inquadramento. Il dato<br />
comunque lascia ampio spazio a possibilità di ulteriori miglioramenti, una volta maggiormente<br />
consolidato il progetto riabilitativo-assistenziale personalizzato. Ci proponiamo in questo anno di<br />
approfondire il tema della valutazione dell’esito in merito all’intervento terapeutico-riabilitativo ed<br />
eventualmente di reperire nuovi strumenti.<br />
Indicatore VGF area CPS<br />
Sono state compilate le scale VGF per i pazienti in carico da cinque anni nei tre CPS del DSM<br />
( Merate, <strong>Lecco</strong>, Bellano), entro il mese di settembre 2006, come stabilito nella scheda indicatore. Nel<br />
mese di settembre 2007 verrà effettuata la seconda rilevazione, in modo da verificare le modificazioni<br />
nel Funzionamento Globale dei pazienti in carico a distanza di un anno e, quindi, l’esito delle cure e<br />
degli interventi messi in atto.<br />
Indicatore Revolving Door<br />
La prima fase di rilevazione dell’indicatore è stata completata e si riferisce alla rilevazione media sui<br />
tre anni di soggetti che abbiano avuto più di tre ricoveri l’anno. Il dato medio sui tre anni è stato<br />
pari al 4,65% per i paziente dell’Area di <strong>Lecco</strong> e del 3,90% per quelli dell’Area di Merate. Il dato è<br />
ampiamente al di sotto dello standard medio nazionale ( pari al 9%) e lo eguaglia se si considerano<br />
pazienti revolving quelli che abbiano effettuato fino a 3 ricoveri / anno ( abbassando il limite di<br />
definizione a = 3 ricoveri). La seconda rilevazione verrà effettuata a Giugno 2007 e prenderà in<br />
considerazione i pazienti che hanno effettuato più di 3 ricoveri l’anno nel periodo Giugno 2006 /<br />
Giugno 2007.<br />
Commento Indicatori di processo<br />
Appropriatezza inserimenti in SR.<br />
La rilevazione costante dell’indicatore nel corso degli ultimi due anni, associata ad un continuo<br />
monitoraggio dei criteri di inserimento e dimissione, ha contribuito a far sì che i criteri stabiliti dal<br />
PRSM per le presenze nelle SR del DSM fossero rispettati, così come risulta dai dati complessivi<br />
nelle due aree riabilitativa (CRA) e assistenziale (CPM).<br />
Da considerazioni più analitiche relative alle singole strutture emerge che: nella CRA di Bosisio P.<br />
e nella CPM di Casatenovo lo standard di riferimento dell’indicatore è pienamente soddisfatto nel<br />
corso di tutto l’anno; nella CRA di Cernusco L. il criterio non è stato soddisfatto nei mesi di giugno<br />
e settembre per fattori di ordine esterno (reperimento di una abitazione, difficoltà di reinserimento<br />
in famiglia), tuttavia va sottolineato lo sforzo compiuto dalla SR per rientrare nei criteri in<br />
considerazione del fatto che in questa SR vi era in partenza un numero superiore di ospiti impropri;<br />
nella CPM di Garlate resta costante il rispetto del criterio del 50% in considerazione del fatto che<br />
cinque ospiti sono stati inseriti in questa struttura con un contratto terapeutico, che non prevedeva<br />
una dimissione e che queste persone hanno sviluppato un processo di recupero, che difficilmente<br />
potrà essere ulteriormente incrementato, a meno che non si creino delle condizioni ambientali tali<br />
da poter supportare e tollerare un funzionamento comunque compromesso.<br />
In una prospettiva a medio termine (fine 2007 inizio 2008), anche per la CPM di Casatenovo<br />
verranno a scadere i 36 mesi dei programmi assistenziali per alcuni dei primi ospiti inseriti, per i<br />
quali non appare al momento realistico un programma di dimissione in una condizione di maggior<br />
autonomia.
Appropriatezza compilazione cartelle cliniche<br />
La valutazione della compilazione delle cartelle cliniche attraverso una check list formata da items<br />
predefiniti, ha rilevato l’appropriatezza della compilazione nel 92,8% delle cartelle dei tre CPS del<br />
Dipartimento, con un risultato che va oltre lo standard che ci si era dati del 70% . Nelle CRA si è<br />
raggiunto il 100%. Sono però state rilevate alcune criticità che potrebbero essere superate nel<br />
prossimo futuro e che sono:<br />
- Per i Presidi CPS<br />
1. Le anamnesi prossima e remota sono spesso descritte in modo eccessivamente<br />
sommario, o mancanti del tutto. Il dato, peraltro, si riferisce in particolare alle cartelle di<br />
maggiore “anzianità”, quando lo stile di lavoro era piuttosto diverso da quello attuale.<br />
2. Un commento simile può essere fatto sull’esplicitazione dei motivi dell’invio in CPS.<br />
3. Raramente sono riportati gli esiti delle discussioni d’équipe, tanto che il punteggio più<br />
frequente è n/a, cioè impossibilità a dare un punteggio. Le équipe dovrebbero pertanto<br />
controllare che venga regolarmente redatta una nota in cartella, eventualmente<br />
rimandando al verbale della discussione, se questo esiste. Da valutare, data<br />
l’eterogeneità della difficoltà clinica dei singoli casi e quindi dell’effettiva necessità di<br />
una discussione di gruppo, di aggiungere un’apposita voce sul PTI, tale da far prevedere<br />
la decisione del terapeuta in merito.<br />
4. I PTI sono presenti nel 90% dei casi previsti, ma l’articolazione in obiettivi specifici è<br />
pienamente soddisfacente solo nel 66% e la descrizione delle modalità di<br />
raggiungimento degli obiettivi ha ottenuto il punteggio pieno solo nel 59% (parziale<br />
24%, non soddisfacente 17%).<br />
- Per i Presidi CRA<br />
1. La criticità più frequente è analoga al punto 3) del paragrafo precedente, riguardando la<br />
questione della rintracciabilità delle riunioni d’équipe. Valgono le stesse considerazioni.<br />
2. Per quanto i PTR siano in questo caso riccamente articolati in obiettivi personalizzati, i<br />
tempi per la verifica del loro raggiungimento sono raramente rispettati (punteggio pieno<br />
solo nel 33%).<br />
3. Sul diario clinico raramente compaiono le terapie farmacologiche in atto e le ragioni di<br />
eventuali modifiche. Vero è che le terapie vengono decise dai Curanti del CPS, tuttavia<br />
questo stato di cose impedisce una chiara visione dell’evoluzione dei trattamenti<br />
farmacologici.<br />
Partnership con i Medici di Medicina Generale (MMG)<br />
L’indicatore riguardava il monitoraggio dei pazienti con diagnosi F4 al fine di verificare se, dopo un<br />
percorso di consulenza, potessero essere rinviati ai propri MMG, come da indicazione del PRSM.<br />
Il risultato appare disomogeneo tra i CPS di <strong>Lecco</strong> e Bellano da un lato e quello di Merate dall’altro.<br />
A fronte dello standard che ci si era dati, del 70% di pazienti dimessi fra coloro che avevano avuto
un primo accesso nel 2006, la media dei dimessi per i CPS di <strong>Lecco</strong> e Bellano è risultata pari al<br />
79,5%, mentre la media per il CPS di Merate è risultata pari al 41,2%. Il dato non è di immediata<br />
comprensione, anche se si è rilevato che tra i pazienti dimessi dai CPS di <strong>Lecco</strong> e Bellano sono stati<br />
conteggiati anche coloro che, sempre appartenenti alla categoria F4, si sono autodimessi. Ripetendo<br />
il conteggio è possibile che le percentuali si avvicinino.<br />
Tempi di attesa prime visite<br />
L’obiettivo in questo caso è stato raggiunto da tutti i presidi CPS al 100%<br />
Colloqui con i famigliari<br />
L’indicatore, con un valore del 42%, ha mostrato che il rapporto ed il coinvolgimento dei famigliari<br />
nei percorsi di cura deve essere migliorato, risultando piuttosto al di sotto del 60% di valore standard<br />
che ci si era proposti. Devono pertanto essere studiate modalità diverse di partnership con i<br />
famigliari che possono comprendere gruppi di incontro o pacchetti socio educativi, che<br />
incrementino il coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di “ presa in carico” dei pazienti.<br />
Percentuale di pazienti che interrompono il rapporto di cura con il CPS (drop –out)<br />
L’indicatore segnala che il 2,65 di pazienti in carico ha interrotto il rapporto con il CPS senza averlo<br />
concordato con i curanti. Non è stato indicato uno standard cui fare riferimento, ma il dato rilevato<br />
potrebbe, dopo uno studio della casistica, che ha abbandonato le cure, diventare lo standard sotto il<br />
quale stare se si vorrà mantenere attivo l’indicatore. Sembra comunque opportuno mantenere<br />
l’indicatore, limitatamente ai percorsi di “presa in carico” e di “ assunzione in cura”, per i gravi<br />
disturbi psicotici e affettivi.<br />
Eventi aggressivi e contenzioni fisiche negli SPDC<br />
Per quanto attiene agli eventi aggressivi ( N° episodi aggressivi / N° ricoveri), l’SPDC di <strong>Lecco</strong> ha<br />
avuto un esito pari al 47,4% contro il 40% dell’SPDC di Merate.<br />
Per quanto attiene alle contenzioni fisiche queste si rivelano maggiori presso l’SPDC di <strong>Lecco</strong> rispetto<br />
a quello di Merate.<br />
I dati potrebbero trovare più elementi di interpretazione che sono al momento in corso di disamina.<br />
Un’innovazione importante è stata l’attivazione del Servizio Civile, che ci ha permesso di<br />
immettere nuove e fresche risorse umane per la gestione del paziente. In riferimento al Piano di<br />
formazione, il DSM ha attuato molteplici progetti formativi centrati su tre aree tematiche: gestione<br />
di casi complessi, integrazione dell’équipe e omogenizzazione dei linguaggi nel lavoro di rete ( vedi<br />
piano formativo Aziendale per il DSM del 2006).
Un obiettivo strategico per il DSM resta la partecipazione attiva e propositiva all’Organismo di<br />
Coordinamento per la Salute Mentale, strumento individuato dalla Regione per realizzare il<br />
coordinamento tra <strong>ASL</strong>, DSM dell’ Azienda Ospedaliera, Erogatori accreditati, Comuni, Associazioni<br />
del Terzo Settore, finalizzato a definire e attuare in modo integrato strategie, obiettivi, azioni per il<br />
fine comune della promozione e della tutela della salute mentale. Costituitosi nel 2005, nel corso del<br />
2006 l’Organismo ed il DSM hanno organizzato la propria attività in gruppi di lavoro finalizzati alla<br />
necessità di assicurare sedi di analisi, confronto ed elaborazione di proposte operative sui diversi<br />
ambiti di intervento, aperte al contributo di tutte le componenti coinvolte.<br />
Operativamente l’organismo ha attivato 3 tavoli tecnici:<br />
- un gruppo di lavoro sulla Residenzialità.<br />
- un gruppo di lavoro Territorialità che si occupa sia dell’integrazione socio-sanitaria che<br />
dell’area lavoro<br />
- un gruppo di lavoro sull’ area handicap adulti<br />
Accanto a tali gruppi è stato costituito un gruppo ristretto avente la funzione di organizzare la<br />
Conferenza Territoriale che si è tenuta il 21 novembre 2006.<br />
Proposte:<br />
Obiettivi strategici e azioni di miglioramento per il 2007.<br />
Gli impegni che il DSM ha condiviso con l’Organismo per il biennio 2007/2008, e che vengono<br />
quindi assunti quali obiettivi strategici, sono i seguenti:<br />
1. Riconversione delle strutture residenziali secondo le indicazioni regionali e sulla base della<br />
proposta di riqualificazione presentata d’intesa con l’<strong>ASL</strong>.<br />
2. Protocollo con le R.S.A. per le situazioni di pazienti psichiatrici anziani, che necessitano di<br />
assistenza in ambito socio – assistenziale.<br />
3. Dare continuità ai Tavoli tecnici.<br />
4. Incrementare gli spazi di residenzialità leggera.<br />
5. Attivare il progetto ritardo mentale in collaborazione con l’Istituto Medea di Bosisio Parini.<br />
Inoltre ci proponiamo le seguenti azioni di miglioramento:<br />
1. Promuovere l’attivazione di due letti di D.H. presso l’Ospedale Manzoni di <strong>Lecco</strong><br />
2. Attivare il MCQ attraverso il nuovo modello della certificazione fra pari (progetto innovativo<br />
regionale per la psichiatria), che si aggiunge ai già esistenti ISO 9000 e Joint Commission.<br />
3. Attivare un protocollo d’intesa con la Procura, la Questura i Carabinieri ed i Comuni<br />
4. Promuovere iniziative informative / formative per diffondere una cultura sulla salute mentale<br />
( vedi piano Formativo Aziendale per il DSM)
I PARTE<br />
Cap. 3<br />
DSM – Obiettivi, priorità e azioni triennio 2006 – 2008<br />
Il DSM, in sintonia con il Piano Regionale per la Salute Mentale e con la rilevazione dei bisogni<br />
emergenti dal nostro territorio, si è dato, per il triennio 2006 – 2008, i seguenti obiettivi:<br />
Riconversione delle strutture residenziali secondo le nuove disposizioni regionali<br />
Protocollo con RSA per l’assistenza ai soggetti anziani portatori di disturbi psichiatrici e<br />
rilevazione del bisogno all’interno della popolazione in cura<br />
Dare continuità ai tavoli tecnici che si sono costituiti all’interno dell’Organismo di<br />
Coordinamento<br />
Incrementare gli spazi di Residenzialità Leggera, rilevandone il bisogno nella popolazione in<br />
cura e fornendo ipotesi previsionali a tre anni<br />
Attivare il Progetto Ritardo Mentale in collaborazione con l’Istituto Medea di Bosisio Parini<br />
Promuovere l’attivazione, all’interno dell’Ospedale Manzoni di <strong>Lecco</strong>, di due posti di Day<br />
Hospital<br />
Attivare il MCQ ( Miglioramento Continuo Qualità) secondo il nuovo modello di<br />
certificazione fra pari<br />
Attivare il Protocollo di Intesa con Procura, Questura, Carabinieri, Provincia e Comuni, per<br />
le situazioni nelle quali il disturbo psichico sfocia in stati di delinquenza<br />
Promuovere iniziative informative / formative per diffondere la cultura della salute mentale
I PARTE<br />
Cap. 4<br />
OCSM - Obiettivi, priorità e azioni 2006 2007<br />
Premessa<br />
In coerenza con gli indirizzi del “Piano Regionale triennale per la salute mentale” (DGR 7/17513<br />
del 17/5/04) l’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong>, d’intesa con l’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong>, gli altri erogatori<br />
accreditati, i Comuni, la Provincia e il Terzo Settore, ha istituito con deliberazione n. 710 del<br />
22.12.2004 l’Organismo di Coordinamento per la salute mentale.<br />
La finalità dell’organismo di coordinamento è di assicurare un coordinamento e una sinergia fra gli<br />
interventi proposti dai diversi soggetti coinvolti nella tutela della salute mentale al fine di assicurare<br />
la promozione della salute mentale e la tutela dei diritti di cittadinanza delle persone affette da<br />
disturbi psichici, anche in età evolutiva.<br />
Obiettivi dell’Organismo di Coordinamento sono:<br />
• La rilevazione dei bisogni e delle risorse dell’intero territorio;<br />
• Il monitoraggio dei bisogni di residenzialità secondo criteri epidemiologici e nell’ambito di<br />
una lettura complessiva dei bisogni del territorio;<br />
• Il controllo e la verifica delle attività erogate;<br />
• La proposta di linee strategiche di sviluppo e di riorganizzazione di servizi e unità d’offerta,<br />
anche nell’ambito di progetti innovativi che favoriscano l’uso razionale delle risorse e gli<br />
interventi di buona pratica clinica;<br />
• La proposta di iniziative di integrazione della rete socio-sanitaria, con particolare attenzione<br />
agli interventi di prevenzione (anche proposti dalla UONPIA) e di lotta allo stigma;<br />
• La definizione di indicatori per la verifica di qualità e di appropriatezza delle prestazioni<br />
erogate;<br />
• Il coordinamento dei protocolli operativi, degli accordi di programma ed atti di intesa,<br />
elaborati a livello distrettuale;<br />
• La predisposizione di una proposta di budget annuale di spesa;<br />
• Organizzare annualmente una Conferenza <strong>territoriale</strong> per la salute mentale, coinvolgendo le<br />
diverse realtà territoriali ed i diversi soggetti che si occupano di tutela della salute mentale;<br />
• Predisporre, sulla base delle indicazioni Piano Regionale per la salute mentale, un <strong>Patto</strong><br />
<strong>territoriale</strong> per la salute mentale;<br />
• Garantire la valutazione dell’appropriatezza di programmi residenziali anche riferiti a singoli<br />
pazienti secondo quanto previsto dalla normativa;<br />
• Dare indicazioni per la partecipazione ai tavoli tecnici d’area – con riferimento al tema della<br />
salute mentale – attivati dagli Uffici di Piano dei tre Distretti dell’<strong>ASL</strong>;<br />
• Predisporre relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei diversi progetti, da inviare sia al<br />
“Tavolo di confronto istituzionale” che alla Regione.
Obiettivi specifici per gli anni 2006-2007<br />
Secondo quanto contenuto nella Circolare n. 49/SAN/2005 e successive note integrative, al fine di<br />
procedere alla riqualificazione delle Strutture Residenziali psichiatriche, l’<strong>ASL</strong> prevede le seguenti<br />
azioni:<br />
• ricognizione clinico epidemiologica della struttura d’offerta e dei bisogni clinico-assistenziali<br />
del territorio;<br />
• analisi delle attività erogate dalle strutture accreditate a contratto attraverso l’elaborazione dei<br />
dati derivanti dal flusso di cui alla Circ. 46/SAN validati dalla Regione;<br />
• analisi periodica dei flussi informativi provenienti dalle Strutture secondo le procedure definite<br />
nell’ambito dell’OCSM al fine della valutazione delle prestazioni erogate secondo i criteri di<br />
appropriatezza;<br />
• monitoraggio dei consumi di ricoveri in Strutture Residenziali non a contratto con il SSR e fuori<br />
Regione.<br />
Le linee di ulteriore sviluppo delle attività dell’OCSM per il biennio 2006/2007 sono<br />
rappresentate da:<br />
- partecipazione al percorso di riqualificazione delle strutture residenziali psichiatriche<br />
finalizzato al completamento della rete di offerta ed alla caratterizzazione dei programmi<br />
riabilitativi in funzione dell’intensità assistenziale e dei bisogni clinici;<br />
- promozione di iniziative di integrazione degli interventi sanitari, socio-sanitari e sociali<br />
attraverso l’implementazione ed il potenziamento di programmi di residenzialità leggera (con<br />
obiettivo specifico per il 2007 di attivare almeno una struttura di residenzialità leggera) ed il<br />
raccordo con le strutture socio-sanitarie (con obiettivo specifico per il 2007 di definire e<br />
attuare un percorso di accoglienza nelle RSA di pazienti anziani garantendo il raccordo e la<br />
continuità delle cure anche attraverso eventuali convenzioni del DSM);<br />
- individuazione linee di indirizzo per rispondere adeguatamente ai bisogni di pazienti giovani e<br />
adulti con psicopatologia e ritardo mentale (doppia diagnosi) al fine di avviare un percorso<br />
ambulatoriale a sostegno della persona e dalla sua famiglia, anche con la collaborazione del<br />
privato accreditato.
II PARTE<br />
Intese distrettuali di programma<br />
Cap. 1<br />
ATTO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI UN<br />
SISTEMA LOCALE DI INTERVENTI NELL’AREA DELLA SALUTE<br />
MENTALE IN PROVINCIA DI LECCO<br />
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCO<br />
AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO<br />
COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO<br />
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO<br />
Premessa<br />
Con il Piano di zona 2002/2004 (prorogato al 31 dicembre 2005), in ottemperanza alle indicazioni<br />
della L.328/2000, i Comuni della Provincia di <strong>Lecco</strong> hanno avviato un processo teso a garantire a<br />
tutti i cittadini una risposta compiuta, integrata e unitaria ai bisogni socio assistenziali del territorio,<br />
avviando un processo di confronto volto al superamento della frammentazione e della<br />
frammentarietà proprie di un territorio costituito in larga parte da Comuni molto piccoli, ma anche<br />
di un sistema di servizi erogati da Enti istituzionali diversi, per caratteristiche e competenze.<br />
Il lavoro avviato ha rappresentato di fatto un atto di programmazione partecipata che ( pur<br />
scontando la necessità di ridefinire scenari progettuali e operativi ormai consolidati nei loro aspetti<br />
positivi ma anche critici e la fatica di promuovere una riappropriazione di funzioni e responsabilità)<br />
ha costruito le premesse per ulteriori evoluzioni in vista della elaborazione del nuovo piano di zona.<br />
In linea dunque con le finalità e gli obiettivi propri del piano di zona - soprattutto per quanto<br />
riguarda la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari<br />
e flessibili, la qualificazione della spesa (attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme<br />
di concertazione), la definizione delle modalità organizzative, finanziarie, strutturali e professionali<br />
dei servizi, le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni, le modalità per garantire<br />
il coordinamento, le forme di rilevazione dei dati e la lettura partecipata dei fenomeni e dei<br />
problemi - a partire dal febbraio 2004 sono stati attivati tavoli di lavoro tematici con il<br />
coinvolgimento di tutti i soggetti previsti dalla legge.<br />
In tale contesto, mentre da un lato veniva costituito all’interno del gruppo disabilità e disagio<br />
mentale il sottogruppo “psichiatria” che ha visto la rappresentanza di tecnici dei Comuni,<br />
dell’Azienda Ospedaliera, di operatori della Cooperazione sociale e dell’Associazionismo familiare<br />
e di settore, il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci ha promosso la costituzione di un gruppo<br />
tecnico e tecnico/politico per lavorare, anche sulla base delle indicazioni emerse dai gruppi 328, alla<br />
stesura di un accordo istituzionale sull’area della Psichiatria.<br />
Nella prima parte dell’anno pertanto, una pluralità di attori del sistema di erogazione dei servizi al<br />
cittadino con disagio psichico, hanno condiviso analisi dei problemi, ipotesi di intervento,<br />
metodologie di lavoro, in significativa sintonia con le indicazioni del “ Piano regionale triennale per<br />
la salute mentale” approvato, nel frattempo, dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta<br />
n. 7/17513 del 17 maggio 2004.<br />
1
Fin dalle premesse si è pertanto operato per una costruzione partecipata dell’ipotesi, riconoscendo<br />
che il tema della salute mentale investe, per aspetti diversi ma complementari, i ruoli dei diversi<br />
Enti istituzionali ma anche la comunità locale e le sue forme aggregative.<br />
L’atto di Intesa tra gli Enti richiamati in premessa conclude a questo punto un percorso di lavoro<br />
ma ne apre immediatamente un altro, certamente non meno complesso. L’Atto di Intesa infatti è<br />
uno strumento di definizione delle interazioni, delle prassi operative e collaborative tra i soggetti<br />
firmatari, ma riconosce il ruolo svolto dalle realtà cooperative, associative, aziendali che<br />
concorrono alla costruzione dei processi di integrazione dei soggetti destinatari degli interventi.<br />
Uno strumento che le Istituzioni locali si danno per governare con efficacia l’erogazione, lo<br />
sviluppo, la costante ridefinizione dei bisogni e conseguentemente dei servizi, per superare il rischio<br />
di autoreferenzialità e frammentazione delle risposte, ma che deve necessariamente tradursi in uno<br />
strumento di dialogo con la realtà, di rapporto con i cittadini e la comunità, riconoscendo dietro i<br />
bisogni la storia delle persone, soggettiva e familiare, il disagio che investe non solo la sfera del<br />
privato ma sempre più quella del contesto primario e dell’ambiente sociale in cui vivono le persone.<br />
L’Atto di intesa assume, anche culturalmente, l’obiettivo che le Istituzioni locali indicano, di una<br />
ricomposizione della risposta di fronte a problemi complessi che richiedono un approccio<br />
multidisciplinare e pluriarticolato, sia sul versante sanitario e della cura sia su quello sociale e<br />
dell’integrazione, per evitare che la frammentazione dell’individuo venga esasperata da<br />
un’altrettanta frammentazione della risposta da parte dei soggetti che sono chiamati ad operare.<br />
In questo senso risultano estremamente attuali e pertinenti le indicazioni del Piano regionale che,<br />
ponendo al centro del sistema il cittadino, ribadiscono l’importanza fondamentale dell’integrazione<br />
e collaborazione fra i diversi soggetti istituzionali che concorrono alla progettazione e realizzazione<br />
dei programmi di assistenza per la salute mentale (servizi <strong>ASL</strong>, Enti Locali, DSM, soggetti<br />
erogatori accreditati coinvolgendo competenze e responsabilità di tutti gli attori, anche non<br />
istituzionali) in un’ottica di community care .<br />
L’organismo di coordinamento per la salute mentale, previsto dal Piano regionale quale momento<br />
di integrazione e collaborazione fra i diversi soggetti, alla sua costituzione, potrà trovare nell’Atto<br />
di Intesa e nello spirito che ha caratterizzato il lavoro preparatorio, un punto di riferimento utile e<br />
importante, sul piano metodologico e per la rete di relazioni che ha prodotto.<br />
Pertanto, con l’intento di concorrere con eguale responsabilità alla realizzazione di interventi socio-<br />
sanitari per la prevenzione della salute mentale e la tutela delle persone con patologia psichiatrica, i<br />
soggetti istituzionali firmatari assumono il compito di sviluppare un lavoro costante indirizzato<br />
all’integrazione e alla gestione <strong>territoriale</strong> delle competenze di ciascun soggetto.<br />
In particolare:<br />
L’Azienda Sanitaria Locale di <strong>Lecco</strong> con le sue funzioni di lettura e analisi della domanda socio-<br />
sanitaria, per la sua conoscenza dei fenomeni di salute/malattia/cronicità che consente di valutare<br />
la migliore risposta ai bisogni dei cittadini in termini di efficacia e appropriatezza e di monitorare<br />
e verificare il corretto funzionamento del sistema. L’<strong>ASL</strong> svolge inoltre un ruolo fondamentale nel<br />
rapporto con la medicina generale, considerato il ruolo centrale che assume il medico di medicina<br />
generale nel rapporto con il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) a tutela della salute del proprio<br />
assistito.<br />
2
Inoltre e in particolare l’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> è portatrice del patrimonio di lavoro svolto negli anni per<br />
conto dei Comuni, garantendo a tutto il territorio provinciale una pari distribuzione di risorse e<br />
interventi;<br />
L’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong>, che attraverso le specifiche funzioni del Dipartimento di Salute<br />
Mentale ha il compito di dare risposte adeguate ai bisogni di salute in ambito diagnostico e<br />
terapeutico, anche per il necessario coordinamento e raccordo con le altre strutture dipartimentali<br />
che intercettano direttamente e/o indirettamente l’utenza in oggetto;<br />
I Comuni della Provincia di <strong>Lecco</strong> nell’esercizio del ruolo di governo del sistema integrato degli<br />
interventi e servizi sociali, realizzato in forma associata ai sensi della Legge 328/2000 attraverso i<br />
piani di zona, con il fine di promuovere i diritti di cittadinanza, eliminare o ridurre le condizioni di<br />
bisogno e di disagio individuale e familiare, con particolare riferimento ai soggetti con<br />
problematiche di tipo psichiatrico;<br />
La Provincia di <strong>Lecco</strong> per il ruolo centrale affidatole dalla normativa e riconosciutole dai Comuni<br />
in materia di formazione e di collocamento al lavoro, di governo dei servizi all’impiego anche per<br />
l’area della disabilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro. La stretta relazione e integrazione<br />
progettuale e operativa fra i servizi socio- sanitari e i servizi per l’impiego rappresenta una risorsa<br />
fondamentale per la riuscita dei progetti di integrazione socio- lavorativa e per l’emancipazione dei<br />
soggetti con problematiche psichiatriche dal circuito assistenziale.<br />
La Provincia ha inoltre assunto un ruolo fondamentale nel favorire una progettazione partecipata fra<br />
i diversi soggetti, istituzionali e non, promuovendo una crescita della sensibilità collettiva sui temi<br />
sociali e del disagio.<br />
ART. 1 - FINALITA’<br />
Le finalità del presente Atto di Intesa trovano riferimento nelle indicazioni:<br />
- nella Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e<br />
servizi sociali ” che sancisce il ruolo di governo dei Comuni del sistema di interventi e servizi<br />
sociali, da realizzarsi in forma associata;<br />
- nella legge regionale n.31/1997 “Norme per il riordino del servizio regionale e sua<br />
integrazione con le attività dei servizi sociale” che riconosce alle <strong>ASL</strong> una funzione di governo<br />
della domanda;<br />
- nel Decreto Ministeriale n.469/1999 e nella Legge n.68/1999 che attribuiscono alle Regioni e<br />
in particolare alle Province varie competenze in materia di mercato del lavoro, anche per ciò<br />
che attiene al collocamento dei disabili e delle fasce deboli;<br />
- nelle indicazioni del “Piano regionale triennale per la salute mentale” (deliberazione della<br />
Giunta Regionale n. 7/17513 del 17 maggio 2004 in attuazione del Piano Socio Sanitario<br />
Regionale 2002-2004, in particolare per quanto riguarda la definizione dei ruoli e delle<br />
competenze istituzionali e il coordinamento degli interventi a tutela della salute mentale dei<br />
cittadini.<br />
ART. 2 - OBIETTIVI<br />
- Promuovere la salute mentale del soggetto adulto attraverso l’integrazione tra servizi<br />
sanitari e sociali, pubblici e del privato sociale, per garantire ai cittadini certezza di<br />
riferimenti e chiarezza nelle prassi di funzionamento dei servizi;<br />
- Investire in termini organizzativi e gestionali su percorsi territoriali per promuovere una<br />
psichiatria di comunità integrando i diversi servizi e soggetti presenti.<br />
- Individuare il ruolo di <strong>ASL</strong>, Enti Locali e di tutti i soggetti che concorrono alla tutela della<br />
salute mentale sul nostro territorio, con il fine di attivare un Organismo di coordinamento<br />
3
che assicuri le sinergie tra i servizi promuovendo interventi a tutela dei diritti dei cittadini<br />
affetti da disturbi psichici relativamente a : l’analisi dei bisogni, anche di rilievo sociale;<br />
l’integrazione della rete socio- sanitaria; l’ottimizzazione delle risorse del territorio; le<br />
iniziative di prevenzione e di contrasto ai processi di stigmatizzazione e isolamento sociale.<br />
- Garantire un ruolo di riferimento del DSM nei percorsi di integrazione socio sanitaria inter-<br />
dipartimentale, per i soggetti con problematiche psichiche.<br />
ART. 3 - DESTINATARI<br />
Destinatari diretti e indiretti degli interventi previsti dall’Atto di Intesa e dai protocolli attuativi<br />
sono :<br />
- Gli utenti dei servizi di psichiatria che presentano bisogni di carattere socio- assistenziale e<br />
sanitario<br />
- Gli operatori dei diversi enti istituzionali per la facilitazione dei compiti di analisi, ipotesi,<br />
intervento e verifica<br />
- Gli operatori del privato sociale e del volontariato che interagiscono con i servizi<br />
- Le famiglie degli utenti dei servizi di psichiatria<br />
ART. 4 - METODOLOGIA<br />
La tutela della salute mentale è da considerarsi un intervento complesso che richiede l’adozione di<br />
strategie territoriali orientate allo sviluppo delle diverse competenze delle risorse istituzionali e alla<br />
loro integrazione e al collegamento sinergico con le realtà del privato sociale e del volontariato,<br />
ponendo un’attenzione specifica ai bisogni e alle risorse dei soggetti e dei loro nuclei familiari. In<br />
tale logica d’intervento il presente Atto di Intesa è frutto del lavoro di confronto avviato,<br />
nell’ambito dell’elaborazione dei piani di zona, tra i soggetti istituzionali firmatari e le realtà della<br />
cooperazione sociale e del volontariato familiare e di settore, con l’obiettivo di garantire una<br />
modalità partecipativa nell’analisi e nell’affronto dei problemi.<br />
La programmazione partecipata viene considerata infatti lo strumento privilegiato per garantire<br />
corrette modalità di impostazione, erogazione e verifica degli interventi e verrà garantita attraverso<br />
l’istituzione dell’ “Organismo di Coordinamento per la salute mentale” prevedendo al suo interno<br />
una corretta rappresentanza dei soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato che operano<br />
nel campo, e attraverso la “Conferenza annuale per la salute mentale” e i “Tavoli di lavoro a<br />
livello di distretto socio- sanitario” previsti dal Piano Regionale triennale per la salute mentale.<br />
Le prassi operative tra i servizi, i livelli e le procedure di collaborazione tra i diversi soggetti<br />
avvengono secondo le modalità indicate nei protocolli operativi di cui all’Art.5<br />
ART. 5 - PROTOCOLLI OPERATIVI<br />
Gli interventi a tutela della salute mentale, garantiti dal presente Atto di Intesa, vengono attuati<br />
secondo le modalità previste dai seguenti protocolli operativi:<br />
Area tematica della territorialità:<br />
Protocollo tra i soggetti firmatari dell’Atto di Intesa per gli interventi di natura socio-<br />
assistenziale e di integrazione sociale e lavorativa (ALL. 2A)<br />
Area tematica della residenzialità:<br />
Protocollo con linee guida rispetto agli interventi di tipo residenziale. (ALL. 3)<br />
Area tematica delle problematiche di confine:<br />
- Protocollo tra D.S.M. dell’Azienda Ospedale di <strong>Lecco</strong> e l’Area Dipendenze dell’<strong>ASL</strong> per la<br />
gestione dei soggetti che presentano doppia diagnosi (psichiatrica e dipendenza da sostanze)<br />
- Protocollo interdipartimentale per il trattamento delle patologie alcool- correlate;<br />
- Protocollo fra UOP e UONPIA;<br />
4
- Progetto di servizio per disabili adulti con scompenso psicopatologico (in corso di<br />
definizione).<br />
Gli enti titolari dell’Atto di Intesa si impegnano ad assolvere i compiti previsti nei diversi<br />
protocolli operative, concorrendo all’obiettivo di garantire una ricomposizione dell’offerta di<br />
servizi in favore del cittadino.<br />
ART. 6 - FINANZIAMENTI E RISORSE<br />
Il piano economico e la copertura finanziaria degli interventi previsti dall’Atto di Intesa saranno<br />
annualmente definiti dai diversi Enti e raccordati, ai fini della definizione del budget di spesa, in<br />
sede di Organismo di Coordinamento per la salute mentale.<br />
ART. 7 - DURATA DELL’ACCORDO<br />
La durata dell’Atto di intesa è fissata in anni 3 con decorrenza dalla data della stipula. Ognuno dei<br />
soggetti contraenti potrà recedere dall’Atto previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno<br />
3 mesi dalla scadenza di ogni annualità.<br />
ART. 8 - VERIFICHE<br />
Il primo anno di attuazione dell’Atto di Intesa assume carattere sperimentale, di avvio e messa a<br />
punto dell’attività gestionale prevista, anche con il fine di verificare i protocolli operativi. Entro 15<br />
mesi dall’approvazione, l’Organismo di coordinamento dovrà formulare agli Enti le eventuali<br />
proposte di modifica dell’Atto e/o dei protocolli attuativi, ovvero le proposte di integrazione.<br />
Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, allargato alle Direzioni Generali dell’<strong>ASL</strong> e<br />
dell’Azienda Ospedaliera, nonché al Presidente della Provincia e ai Presidenti delle Assemblee<br />
Distrettuali, assumono il compito di vigilanza e di verifica dello stato di attuazione del presente Atto<br />
di Intesa.<br />
5
II PARTE<br />
Cap. 2<br />
PROTOCOLLO D’INTESA AREA TEMATICA DELLA RESIDENZIALITA’<br />
FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, L’AZIENDA<br />
OSPEDALIERA DI LECCO, L’<strong>ASL</strong> DI LECCO, L’AMMINISTRAZIONE<br />
PROVINCIALE DI LECCO<br />
FINALITA’<br />
Il presente protocollo, recependo le indicazioni del Piano Regionale Salute Mentale del 17/05/2004<br />
(PRSM), e sulla base della sintesi operata dal gruppo di lavoro interistituzionale, si propone di<br />
fornire gli elementi atti a definire il sistema “residenzialità” nell’ambito dell’“Atto di Intesa per la<br />
realizzazione e attuazione di un sistema locale di interventi nell’area della salute mentale in<br />
Provincia di <strong>Lecco</strong>”, e di definire e regolare le modalità di collaborazione tra i soggetti firmatari, nel<br />
rispetto delle rispettive competenze. L’obiettivo condiviso è quello di integrare le analisi, le letture,<br />
le culture operative e le modalità di intervento, per garantire la coerenza e la continuità dei percorsi<br />
di cura all’interno del sistema, favorire l’integrazione fra i diversi soggetti istituzionali coinvolti<br />
(<strong>ASL</strong>, Enti Locali, AO, Soggetti gestori accreditati), definire gli elementi di gestione e governo<br />
delle risorse nell’ambito della residenzialità psichiatrica.<br />
Il documento tecnico allegato recepisce le indicazioni del PRSM e delle circolari integrative ed<br />
esplicative contenenti i criteri proposti dalla Regione Lombardia integrandoli con le esigenze della<br />
realtà locale. Nel documento, dopo aver rilevato la situazione esistente nell’ambito provinciale<br />
rispetto alle strutture residenziali e agli utenti, si definisce il nuovo modello del sistema della<br />
residenzialità e le azioni necessarie per implementarlo.<br />
PREMESSA<br />
La “funzione residenzialità” integra esigenze di tipo riabilitativo ed esigenze di tipo socioassistenziale.<br />
E’ necessario differenziare questi due aspetti, pur considerandoli entrambi importanti.<br />
Allo stato attuale, il progressivo allungamento dei tempi di degenza, con un ridotto turn-over dei<br />
pazienti, ha determinato per la residenzialità psichiatrica una prevalenza della funzione “abitativa”<br />
sulla funzione “progettuale” terapeutico-riabilitativa.<br />
Ciò comporta il rischio, più o meno palese, di una nuova forma di istituzionalizzazione dei soggetti<br />
con una conseguente riduzione del diritto “di cittadinanza”.<br />
D’altra parte, occorre considerare che i bisogni di accoglimento residenziale e di abitazione in<br />
ambiente comunitario, per un gruppo di utenti psichiatrici, sono elementi essenziali all’interno del<br />
percorso terapeutico riabilitativo.<br />
Le risposte a tali bisogni necessitano di un’ampia articolazione di soluzioni che considerino il<br />
concorso attivo di diversi interlocutori istituzionali e non, che possano offrire risorse anche diverse<br />
dalle strutture residenziali (SR) predefinite, alfine di favorire, laddove è possibile per gli aspetti<br />
evolutivi del paziente, un reale percorso di cura con un suo specifico percorso evolutivo e un<br />
autentico inserimento nella realtà del territorio di appartenenza.<br />
.<br />
1
Tra i fattori cruciali per il funzionamento del “sistema residenzialità” in psichiatria si riconoscono:<br />
la centralità del progetto terapeutico riabilitativo basato sui bisogni e le caratteristiche<br />
specifiche del paziente;<br />
la variabilità dei progetti personali, che rende spesso difficile standardizzare dei percorsi<br />
proprio per la complessità delle diverse specificità esistenziali in gioco, che non permettono<br />
la semplificazione del programma solo sul dato diagnostico o su “pacchetti di prestazioni”<br />
rigidamente predefiniti;<br />
l’individuazione di forme diversificate e flessibili di residenzialità sia in ambito sanitario<br />
che non sanitario, con la partecipazione, il coinvolgimento e la collaborazione di diversi<br />
soggetti del territorio (<strong>ASL</strong>, Enti Locali, altri soggetti erogatori).<br />
Al fine di favorire lo sviluppo di una psichiatria di comunità occorre concepire l’ambito <strong>territoriale</strong><br />
come un sistema funzionale ampio, non rigidamente delimitato, con la possibilità di integrare i<br />
diversi servizi sanitari e sociali, pubblici, privati e non-profit, e di collaborare con la rete informale<br />
presente. Tutti i soggetti erogatori accreditati a contratto devono concorrere alla migliore offerta di<br />
servizi per i soggetti affetti da disturbi psichici.<br />
QUADRO D’OFFERTA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI NELLA PROVINCIA DI<br />
LECCO<br />
STRUTTURE ACCREDITATE A CONTRATTO<br />
Ad alta assistenza:<br />
CRA di Cernusco L. - 12 p.l. (DSM AO <strong>Lecco</strong>)<br />
CRA di Bosisio P. – 16 p.l. (DSM AO <strong>Lecco</strong>)<br />
CPA “Il Poggio” di Calolziocorte – 6 p.l (Struttura privata) + 4 p.l. (in fase di accreditamento non a<br />
contratto)<br />
A media assistenza:<br />
C.P.M di Garlate - 10 p.l. (DSM AO <strong>Lecco</strong>)<br />
C.P.M di Casatenovo -16 p.l. (DSM AO <strong>Lecco</strong>)<br />
A bassa assistenza<br />
C.P. Casa Sara – 2 p.l. (struttura privata)<br />
STRUTTURE ACCREDITATE NON A CONTRATTO<br />
CPA “Il volo” di Monticello – 20 p.l. . (struttura privata )<br />
CPM “Antropos” di Esino – 20 p.l. (struttura privata )<br />
STRUTTURE AREA SOCIALE<br />
Progetto innovativo regionale “Castello solidale” di Cesana B. – 6 p.l. (in collegamento con un<br />
CDI)<br />
Progetto sperimentale DSM “La Casetta in città” 4 p.l. (in fase di realizzazione)<br />
2
DEFINIZIONE DEI COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI:<br />
L’<strong>ASL</strong>, attraverso l’Organismo di Coordinamento per la salute mentale, riguardo alle esigenze<br />
di tipo residenziale, ha il compito di:<br />
a. monitorare i bisogni di residenzialità secondo criteri epidemiologici nell’ambito<br />
dei più vasti bisogni sociali di un territorio;<br />
b. governare l’uso corretto delle risorse attraverso la definizione di previsioni di spesa,<br />
il controllo e la verifica delle attività erogate;<br />
c. promuovere, in collaborazione con il DSM, l’attuazione di programmi innovativi<br />
che favoriscano l’uso razionale delle risorse e insieme interventi di buona pratica<br />
clinica;<br />
d. definire i criteri generali nell’utilizzo delle diverse SR (intra ed extra DSM);<br />
e. coordinare e controllare i nuovi inserimenti e le dimissioni per i pazienti residenti.<br />
Al fine di attuare i punti sopra riportati all’interno dell’Organismo di Coordinamento per la Salute<br />
Mentale (OCSM) è prevista la costituzione di Gruppi di Lavoro tecnici e di un’equipe<br />
multidisciplinare per la valutazione anche di casi singoli così come previsto dal regolamento dello<br />
stesso OCSM.<br />
Il DSM ha il compito di:<br />
a. definire i Piani di Trattamento Individuali (PTI), attraverso la presa in carico<br />
multidisciplinare ed integrata, in accordo con il paziente e la sua famiglia;<br />
b. definire e attuare i Progetti Terapeutico Riabilitativi (PTR) nelle SR intra DSM<br />
dando opportuna comunicazione ai Comuni di residenza;<br />
c. monitorare attraverso verifiche periodiche l’attuazione dei PTR sia nelle SR del<br />
DSM che in quelle extra DSM in cui sono ospitati i pazienti in carico, garantendo la<br />
coerenza tra PTI e PTR;<br />
d. attuare programmi innovativi che favoriscano l’uso razionale delle risorse e<br />
interventi di buona pratica clinica;<br />
e. favorire quanto più possibile la permanenza dei pazienti nel territorio di<br />
appartenenza ed utilizzare SR accreditate fuori provincia solo nel caso non siano<br />
disponibili posti nelle SR del DSM o vi siano problemi di incompatibilità.<br />
I Comuni in collaborazione con il DSM e Soggetti gestori di SR accreditate i hanno il compito di:<br />
a. partecipare alla definizione e alla valutazione dei progetti individuali finalizzati ad<br />
attuare percorsi riabilitativi all’interno di SR;<br />
b. concorrere al reperimento di risorse per favorire le dimissioni dei pazienti dalle SR<br />
nei tempi previsti dalle norme di riferimento, attivando anche i propri servizi per<br />
realizzare percorsi di reinserimento <strong>territoriale</strong>;<br />
c. attivarsi perché possa essere mantenuta al paziente, durante la permanenza in SR, la<br />
residenza anagrafica nel proprio comune, anche in caso di prolungata assenza, per<br />
garantire allo stesso a tutti gli effetti il diritto di cittadinanza;<br />
d. individuare sul proprio territorio risorse abitative che possano essere destinate ad<br />
uso di comunità alloggio, gruppo appartamento, appartamento protetto, ecc.,<br />
favorendo esperienze e sperimentazioni di soluzioni alloggiative per persone che<br />
hanno concluso il percorso riabilitativo e necessitano di sostegno “all’abitare”;<br />
e. favorire l’inserimento in RSA dei propri cittadini che per età e per condizioni<br />
fisiche presentano bisogni di natura prevalentemente socio-sanitaria e socioassistenziale.<br />
3
RICORSO ALL’UTILIZZO DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SR NON A<br />
CONTRATTO CON QUOTA SU FONDO SANITARIO DELL’<strong>ASL</strong><br />
Dal 1998 l’orientamento a livello regionale è di non usufruire di queste strutture, considerato l’alto<br />
numero di posti accreditati a livello regionale. Storicamente nella realtà della Provincia di <strong>Lecco</strong> il<br />
n° dei posti letto è sempre stato nettamente inferiore alla media regionale per cui in passato,<br />
soprattutto per mantenere il paziente in prossimità del luogo di residenza o per particolari situazioni<br />
di difficile gestione, si è reso necessario il ricorso a questo tipo di residenzialità. Attualmente il<br />
numero di soggetti inseriti in tali strutture è di relativa modesta entità.<br />
Con l’apertura della CPM di Casatenovo e con i programmi di sviluppo di soluzioni in ambito<br />
sociale si ritiene che il ricorso alle SR non a contratto debba essere eccezionale e vincolato alla<br />
saturazione dell’offerta all’interno della rete delle SR accreditate a contratto della Provincia.<br />
L’eventuale ed eccezionale utilizzo delle SR socio-assistenziali (per ricoveri a valenza anche<br />
riabilitativa) o accreditate non a contratto sarà comunque vincolato al rispetto dei seguenti<br />
CRITERI:<br />
− il ricovero deve avere caratteristiche riabilitative e per l’inserimento deve comunque<br />
esserci coerenza tra il PTI, di responsabilità del CPS inviante, e PTR, attuato nella<br />
struttura;<br />
− i soggetti devono rispondere ai requisiti previsti per l’inserimento nelle SR, come<br />
stabilito dal PRSM, dalla circolare 28 San del luglio 04 e come vengono esplicitati<br />
nel documento tecnico allegato al presente protocollo;<br />
− la valutazione iniziale del bisogno, la presenza di patologia di interesse psichiatrico e<br />
la valenza riabilitativa del ricovero sono di pertinenza del DSM;<br />
− Per tali SR si applicherà il criterio di pagamento previsto dall’ “Atto di indirizzo e<br />
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” (D.P.C.M. 14.02.2001) e la<br />
successiva normativa relativa ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) - Gazzetta<br />
Ufficiale del 08.02.02 - che prevede per le SR a bassa intensità assistenziale una<br />
quota a carico del Comune pari al 60%.<br />
In base a tale definizione si stabilisce pertanto a carico del fondo sanitario dell’<strong>ASL</strong>:<br />
- una quota pari al 40% per strutture a bassa protezione (comunità alloggio e<br />
strutture accreditate non psichiatriche o a bassa protezione accreditate non a<br />
contratto);<br />
- una quota pari al 60% per comunità protette psichiatriche a media protezione<br />
accreditate non a contratto;<br />
- una quota pari all’80% per comunità protette psichiatriche ad alta protezione<br />
accreditate non a contratto.<br />
La restante quota socio-assistenziale è a carico dei Comuni che possono rivalersi<br />
sull’utente stesso o sui loro familiari secondo i propri regolamenti.<br />
La valutazione sulla situazione economica del soggetto e del suo nucleo familiare per<br />
la determinazione della quota da recuperare è di pertinenza del Comune di residenza<br />
del soggetto.<br />
I Soggetti firmatari si impegnano ad effettuare una revisione del gruppo di degenti “storici” nelle<br />
SR non a contratto, sulla base dei criteri stabiliti dal PRSM per la residenzialità, al fine di<br />
pianificare dei percorsi per il rientro nel nuovo sistema, nel rispetto dei diritti della persona e dei<br />
criteri di gestione degli Enti Locali.<br />
L’OCSM si farà promotore della stesura di una procedura di inserimento dei pazienti nelle RSA<br />
in collaborazione con i Responsabili e gli operatori delle stesse e i referenti dei Comuni.<br />
4
1<br />
ALL 2 A<br />
Rev_01 ott_07<br />
PROTOCOLLO D’INTESA AREA TEMATICA DELLA TERRITORIALITA’ FRA I<br />
COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, L’AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO,<br />
L’<strong>ASL</strong> DI LECCO, L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO per gli interventi<br />
di natura socio- assistenziale e di integrazione sociale e lavorativa<br />
Premessa:<br />
il presente protocollo, recependo le sintesi del tavolo di lavoro L. 328/00 (sottogruppo disagio<br />
mentale), ha la finalità, nell’ambito dell’“Atto di Intesa per la realizzazione e attuazione di un<br />
sistema locale di interventi nell’area della salute mentale in Provincia di <strong>Lecco</strong>”, di definire e<br />
normare le modalità di collaborazione, tra i soggetti firmatari, nel rispetto delle rispettive<br />
competenze. L’obiettivo condiviso è quello di integrare le analisi, le letture, le culture operative e<br />
le modalità di intervento, nello spirito di concorrere a ridurre la frammentazione esistente<br />
nell’offerta di servizi al cittadino.<br />
Il protocollo si riferisce in particolare agli interventi che vedono il coinvolgimento, in maniera<br />
diretta, delle competenze dei Comuni, nella realizzazione di servizi e prestazioni rivolti ai singoli<br />
e/o a gruppi, ed in particolare :<br />
• Contributi ed interventi economici<br />
• Assistenza domiciliare ed educativa<br />
• Pronto Intervento Assistenziale<br />
• Sostegno serale e festivo<br />
• Percorsi di integrazione socio-lavorativa<br />
• Iniziative di aggregazione e di integrazione sociale<br />
• Iniziative di formazione e sostegno delle famiglie<br />
• Iniziative di formazione degli operatori<br />
FINALITA’<br />
⇒ Promuovere e sostenere le capacità di vita autonoma della persona assistita nella comunità di<br />
appartenenza<br />
⇒ Realizzare interventi ad alta integrazione sociale e sanitaria<br />
⇒ Programmare, coordinare, realizzare e verificare gli interventi territoriali che richiedono<br />
l’integrazione fra i servizi<br />
⇒ Promuovere la crescita delle rete dei servizi istituzionali e associativi, valorizzando e<br />
sostenendo le realtà e gli interventi significativi.<br />
DESTINATARI<br />
• Utenti dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> (DSM) che presentano bisogni di<br />
carattere socio- assistenziale e sanitario<br />
• Gli operatori dei diversi enti istituzionali per la facilitazione dei compiti di analisi, ipotesi,<br />
intervento e verifica<br />
• Gli operatori del privato sociale e del volontariato che interagiscono con i servizi<br />
• Le famiglie degli utenti dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong>
MODALITA’ GENERALI DI SEGNALAZIONE<br />
Il protocollo si fonda sul presupposto che i processi di integrazione siano favoriti da una<br />
condivisione precoce dell'analisi del problema e dell’ipotesi di intervento tra servizi psichiatrici e<br />
servizi sociali comunali. Per questa ragione, per quanto riguarda gli interventi diretti agli utenti, il<br />
Centro Psicosociale (CPS) di riferimento <strong>territoriale</strong> segnalerà tramite lettera (facs-simile allegato)<br />
al Servizio Sociale Comunale, la presa in carico del soggetto per il quale si ipotizza l’utilità di un<br />
intervento integrato di natura sanitaria e sociale.<br />
Gli operatori dei diversi Enti coinvolti effettuano, entro un mese dalla segnalazione, una<br />
valutazione congiunta dei bisogni socio- assistenziali e sanitari e definiscono il Piano di<br />
Trattamento Individuale (P.T.I.) stabilendo obiettivi, modalità, tempi di attuazione, personale<br />
coinvolto, eventuali costi, verifiche. Per l’attivazione dell’intervento è necessaria la presentazione<br />
della situazione segnalata da parte del medico psichiatra referente e degli altri operatori del CPS,<br />
agli operatori degli altri servizi coinvolti. Copia del P.T.I. viene consegnata agli operatori sociali del<br />
comune, coinvolti nella situazione.<br />
Il servizio sociale comunale segnala eventuali situazioni di pazienti non consenzienti alla cura, da<br />
esso conosciute, non in carico ai servizi psichiatrici, che ritiene necessitino di valutazione<br />
psichiatrica ed eventuale presa in carico, tramite segnalazione scritta (facs-simile allegato) al<br />
medico di medicina generale (MMG), affinché vengano messi in atto gli interventi terapeutici<br />
ritenuti necessari. Nel caso di successiva presa in carico da parte del CPS si procede come previsto<br />
nel punto precedente.<br />
La comunicazione scritta al medico di medicina generale dell’avvio dell’intervento e, in seguito,<br />
dell’eventuale conclusione, viene data da parte del CPS, secondo le procedure interne previste.<br />
Gli operatori referenti degli Enti danno comunicazione congiunta all’utente sul programma<br />
concordato e sui tempi di avvio.<br />
FONDO SOCIALE gestito tramite le Gestioni Associate<br />
Per la realizzazione degli interventi di cui in premessa, a favore di pazienti in carico al DSM di<br />
<strong>Lecco</strong>, per i quali si rende necessaria una forte integrazione sociale e sanitaria, i Comuni mettono a<br />
disposizione annualmente risorse economiche (di seguito denominate “Fondo sociale”). La<br />
programmazione dei servizi e delle prestazioni erogabili attraverso tale fondo (con il relativo<br />
preventivo economico), e la verifica degli interventi effettuati (consuntivo) avviene tramite incontri<br />
tra operatori del DSM e rappresentanti dei Comuni, attraverso le loro articolazioni organizzative,<br />
entro il mese di ottobre di ogni anno.<br />
SERVIZI E PRESTAZIONI SU FONDO SOCIALE:<br />
CONTRIBUTI ECONOMICI<br />
L’attivazione di forme di intervento economico si pone l’obiettivo da un lato di consentire alla<br />
persona un’esistenza dignitosa sotto il profilo economico e abitativo, dall’altra di sostenerla in un<br />
percorso di riabilitazione e reinserimento sociale.<br />
Gli interventi economici sono normalmente di competenza del Comune di residenza del soggetto,<br />
che interverrà sulla base dei propri regolamenti e criteri, in relazione al progetto elaborato.<br />
Nella fase strettamente terapeutico/riabilitativa, il CPS potrà disporre direttamente contributi<br />
economici, tramite il Fondo sociale assegnato, anche sotto forma di buoni sociali, per situazioni di<br />
urgenza e con finalità di sostegno all’intervento terapeutico e/o riabilitativo, con erogazioni una<br />
2
tantum (max € 1.500). Tali contributi verranno comunque concordati, nell’ambito del progetto<br />
elaborato, con il Coordinatore della Gestione Associata e comunicati al Servizio Sociale comunale.<br />
ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA<br />
Nella fase terapeutico- riabilitativa il CPS attua a domicilio l’assistenza infermieristica e/o<br />
educativa che presta particolare attenzione agli aspetti legati alla patologia.<br />
Se il paziente presenta problematiche organiche importanti, in carico agli operatori del Servizio di<br />
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), il CPS si relaziona ed integra i propri interventi al<br />
domicilio del paziente con il Dipartimento Fragilità dell’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong>.<br />
In relazione ai bisogni specifici presentati dai pazienti, a questi interventi può essere affiancato o, a<br />
conclusione della fase terapeutico- riabilitativa sostituito, un intervento di assistenza domiciliare<br />
(SAD) da parte del personale dei Servizi Comunali, secondo modalità stabilite nel progetto<br />
individuale. Il personale del servizio comunale partecipa alle riunioni di impostazione,<br />
monitoraggio, supervisione e verifica dell’intervento.<br />
Nel caso non sussistessero i presupposti per l’intervento del SAD da parte dei Comuni nei confronti<br />
di pazienti in situazione di cronicità, ma comunque in grado di vivere nel proprio domicilio, e in<br />
gravi difficoltà economiche, si prevede e concorda la possibilità di intervenire, da parte del singolo<br />
comune, per il pagamento di personale domestico per interventi di pulizia dell’abitazione.<br />
Considerata e condivisa, inoltre, l’utilità di poter disporre della figura dell’educatore professionale<br />
per il sostegno dei soggetti che vanno sperimentando situazioni di parziale e/o completa autonomia,<br />
anche nella fase di reinserimento e consolidamento dei processi di integrazione sociale, i Comuni,<br />
tramite il Fondo sociale, garantiranno la copertura dei costi dell’assistenza educativa domiciliare,<br />
tramite convenzioni con cooperative. L’educatore lavorerà in stretta connessione sia con le équipes<br />
dei centri psicosociali di riferimento <strong>territoriale</strong>, sia con i servizi sociali comunali, garantendo<br />
un’interfaccia progettuale e informativa sull’intervento in atto.<br />
PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE<br />
Il servizio ha la finalità di garantire, in casi di emergenza assistenziale (mancanza della famiglia,<br />
della casa, necessità di un allontanamento momentaneo dal domicilio, ecc…), una struttura di<br />
accoglienza adeguata a soggetti in carico al DSM con prevalenti problematiche sociali che incidono<br />
sulle condizioni di salute. Tali interventi si rendono necessari al fine di evitare il ricorso improprio<br />
alle strutture sanitarie e/o di permettere l’osservazione e la valutazione del caso per determinare se<br />
sussistono le condizioni per intraprendere un percorso riabilitativo.<br />
Il servizio di pronto intervento è garantito attraverso convenzioni con le cooperative locali che<br />
gestiscono comunità maschili e femminili in grado di accogliere pazienti con patologia psichiatrica<br />
e che mantengono regolari rapporti con il servizio inviante.<br />
L’accesso alle strutture avviene su richiesta e valutazione del DSM in accordo con gli operatori<br />
della struttura individuata e con le gestioni associate che attraverso il fondo sociale garantiscono la<br />
copertura dei costi relativi al servizio e alla retta per un mese, prorogabile al massimo per altri 30<br />
gg.<br />
Il DSM dà inoltre tempestiva comunicazione al Comune di residenza del soggetto della richiesta di<br />
Pronto intervento per una eventuale impostazione e valutazione di un successivo programma.<br />
SOSTEGNO SERALE E FESTIVO<br />
Il servizio ha la finalità di garantire un riferimento e un supporto ai processi di integrazione<br />
soprattutto per quei pazienti per i quali si sta avviando un processo di autonomia, garantendo un<br />
contesto tutelato per il pasto serale e l’offerta di attività aggregative e ricreative. Tale intervento<br />
potrà essere avviato, all’occorrenza attraverso specifiche convenzioni con realtà della cooperazione<br />
e/o associative che garantiscano un adeguato contesto di riferimento.<br />
3
PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA<br />
L’accesso a percorsi di avvicinamento al lavoro rappresenta, per i soggetti in carico ai Servizi del<br />
DSM, un’importante occasione di evoluzione e ricostruzione di una prospettiva di integrazione<br />
sociale. Per questa ragione, secondo le declinazioni di seguito descritte, che tengono in<br />
considerazione la diversa natura dei bisogni dei soggetti e la possibilità di un progressivo cammino<br />
evolutivo, i Servizi territoriali e i Servizi Specialistici, congiuntamente, opereranno in chiave di<br />
raccordo progettuale con i diversi soggetti operanti nel settore.<br />
In particolare si prevede, sulla base del riconoscimento delle rispettive competenze e specificità, di<br />
sviluppare e valorizzare una collaborazione con il Servizio Fasce Deboli (SFD) della Provincia di<br />
<strong>Lecco</strong> e una integrazione con la programmazione e gli interventi previsti dal “Piano Provinciale<br />
Disabili”.<br />
Il DSM si attiverà inoltre, attraverso i canali normativi e le leggi di settore, nella presentazione di<br />
progetti e nella ricerca di nuove risorse a sostegno della progettualità in questo campo,<br />
coordinandosi con gli enti locali e i diversi soggetti istituzionali al fine di una razionalizzazione<br />
delle azioni e della spesa.<br />
1) Tirocini con finalità riabilitative<br />
I tirocini con finalità riabilitative si collocano nel percorso di cura e riabilitazione della persona con<br />
patologia psichiatrica e possono essere propedeutici ad un successivo programma d’inserimento<br />
lavorativo, ma non sono immediatamente finalizzati al collocamento definitivo in un contesto<br />
lavorativo.<br />
I tirocini riabilitativi e socio-occupazionali rappresentano un’occasione di confronto della persona<br />
con la realtà sociale esterna, attraverso l’elemento concreto dello svolgimento di un’attività e<br />
dell’assunzione di un ruolo diverso da quello di malato. Servono alla persona per riallacciare i fili<br />
di un dialogo interrotto o, in alcuni casi, mai esistito con il proprio contesto di vita, per promuovere<br />
scambi e rapporti tra soggetti sociali, per articolare il campo di interessi dell’individuo e quindi, in<br />
definitiva, possono svolgere un’importante funzione di produzione di senso economico, sociale e<br />
psicologico. Tali attività hanno quindi carattere formativo a forte valenza educativa e riabilitativa<br />
e/o propedeutica all’inserimento lavorativo.<br />
Il DSM organizza i tirocini riabilitativi, con proprio personale afferente all’équipe funzionale<br />
lavoro, così come previsto dal Piano Regionale Salute Mentale (D.g.r 17 maggio 2004 n.7/17513),<br />
nell’ambito dei progetti individuali concordati con i servizi sociali dei Comuni di residenza.<br />
Interlocutori privilegiati per l’attuazione dei tirocini sono il Consorzio Consolida con il quale è<br />
operativo un protocollo di intesa, le cooperative sociali del territorio e altre agenzie sociali<br />
disponibili allo scopo (amm.ni pubbliche, ditte artigiane, piccole aziende ecc.).<br />
Considerata inoltre la positiva esperienza del progetto socio-occupazionale Ce.Se.A. (Servizio<br />
previsto dall’Accordo di programma <strong>territoriale</strong> che vede l’adesione di Provincia, <strong>ASL</strong>, Azienda<br />
Ospedaliera, Comunità Montane, Comune di <strong>Lecco</strong> e oltre ottanta Comuni) per l’inserimento di<br />
situazioni di particolare fragilità di persone con patologia psichiatrica, si prevede di garantire la<br />
possibilità, anche attraverso una quota aggiuntiva su fondo sanitario, di affiancare il soggetto<br />
inserito con un operatore specifico, almeno per una fase dell’intervento. L’Azienda Ospedaliera,<br />
così come le Amministrazioni locali per ambiti territoriali, valuterà inoltre la possibilità di<br />
individuare, all’interno di servizi comunque erogati (manutenzioni, lavanderia, pulizie, ecc…) spazi<br />
per attività occupazionali, riconvertendo le economie risparmiate in borse/lavoro e forme di<br />
incentivazione.<br />
4
I finanziamenti relativi ad eventuali borse lavoro e alle spese di gestione, quando sia esplicitata dal<br />
DSM la valenza terapeutico/riabilitativa dell’intervento, sono a carico del fondo sanitario.<br />
L’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> si impegna a dare continuità, con finanziamenti specifici delle attività, a quanto<br />
messo in atto negli anni dal DSM di <strong>Lecco</strong> nel campo della riabilitazione socio-lavorativa e<br />
attualmente sostenuto dalla Regione attraverso il Programma innovativo “Una rete per il lavoro”.<br />
I soggetti firmatari del protocollo predisporranno, sulla base delle leggi di riferimento, progetti<br />
specifici a sostegno dell’iniziativa.<br />
L’attuale sistema d’offerta relativo ai tirocini con finalità riabilitativa garantita dal DSM<br />
concorrerà alla definizione delle nuove modalità previste dalla “Convenzione tra la Provincia di<br />
<strong>Lecco</strong> e gli Ambiti Distrettuali di Bellano, <strong>Lecco</strong> e Merate” per la definizione di interventi in favore<br />
delle fasce deboli del mercato del lavoro. Il DSM parteciperà con propri rappresentanti al gruppo di<br />
lavoro, di cui agli artt:<br />
- art. 3 Ambito Socio-Occupazionale<br />
Congiuntamente all’approvazione della Convenzione verrà attivato un gruppo di lavoro tra rappresentanti della<br />
Provincia, delle Gestioni Associate e dei Servizi Specialistici e specializzati che operano per conto degli Enti con la<br />
finalità di costruire una ipotesi organizzativa di natura socio-occupazionale come realtà d’offerta specifica e<br />
strettamente connessa con la programmazione dei Servizi. All’ambito socio-occupazionale afferiranno gli interventi in<br />
ordine ai processi preliminari al progetto di inserimento lavorativo (tirocini formativi e preparatori, sviluppo dei prerequisiti<br />
di base, formazione delle competenze di base…) e gli interventi alternativi al collocamento (percorsi e attività<br />
socio-occupazionali diverse) rivolti ai soggetti di cui all’art. 2 dell’allegato protocollo operativo.<br />
- art. 4 Risorse<br />
1. La Provincia di <strong>Lecco</strong>, nelle sue diverse articolazioni organizzative, metterà a disposizione spazi, strutture,<br />
personale attrezzature e materiali adeguati allo svolgimento dei servizi previsti.<br />
Modalità di segnalazione<br />
Qualora l’intervento non fosse già previsto da un progetto convenuto tra i servizi, il DSM segnalerà<br />
la situazione al Comune di residenza, secondo quanto indicato nelle modalità generali di<br />
segnalazione di cui in precedenza.<br />
Percorso<br />
L’équipe funzionale lavoro del DSM, in accordo con il Comune di residenza del soggetto e con<br />
l’Ente titolare della Convenzione di Tirocinio (Consorzio Consolida o gestione associata) attiva il<br />
tirocinio riabilitativo presso la realtà lavorativa individuata e disponibile. Nel contempo, se la<br />
persona è iscritta al collocamento disabili, viene data dall’Ente titolare della Convenzione,<br />
comunicazione di avvio al Servizio provinciale e il soggetto interessato, firma la temporanea “non<br />
disponibilità” ad essere collocata.<br />
Il Servizio psichiatrico si occuperà del monitoraggio e accompagnamento del tirocinante fino al<br />
termine del tirocinio. Qualora si presentassero le condizioni per il passaggio ad un tirocinio per<br />
l’inserimento lavorativo, la definizione delle intese vedrà il coinvolgimento attivo del Servizio<br />
Fasce Deboli previsto dalla convenzione fra la Provincia di <strong>Lecco</strong> e gli Ambiti Distrettuali di<br />
Bellano, <strong>Lecco</strong> e Merate.<br />
In allegato si riportano i criteri per l’erogazione delle borse lavoro adottati dalle gestioni Associate<br />
di <strong>Lecco</strong>, Merate e Bellano.<br />
5
2) Tirocini con finalità lavorativa<br />
La finalità dei percorsi di integrazione lavorativa è quella di offrire la possibilità di sperimentare<br />
capacità e attitudini lavorative, per soggetti in grado di affrontare un percorso lavorativo che sfoci in<br />
inserimento effettivo nel mondo del lavoro. Tali percorsi hanno lo scopo di consentire:<br />
• una osservazione e valutazione finalizzate all’inserimento lavorativo<br />
• l’acquisizione di mansioni, tempi e ritmi specifici comunemente richiesti dai contesti produttivi<br />
• l’instaurarsi di una adeguata integrazione socio- lavorativa<br />
Nel corso di questi anni, i Servizi per l’integrazione lavorativa, i servizi psichiatrici del DSM di<br />
<strong>Lecco</strong> e le realtà del privato e del privato sociale hanno avuto modo di approfondire la reciproca<br />
conoscenza ed affinare sempre meglio la metodologia d’intervento. Si è così potuto garantire anche<br />
alle persone con patologia psichiatrica di fruire, previa valutazione congiunta del DSM e dei Servizi<br />
per l’integrazione lavorativa, di programmi finalizzati al loro inserimento o reinserimento<br />
lavorativo, nell’ottica del lavoro di rete e di un’effettiva riappropriazione di cittadinanza da parte<br />
del paziente psichiatrico.<br />
L’intervento pertanto è rivolto a persone in cura con programma riabilitativo presso i servizi<br />
psichiatrici del DSM di <strong>Lecco</strong>, con risorse spendibili nel mondo del lavoro, ma con difficoltà ad<br />
accedervi autonomamente e con necessità di un percorso di accompagnamento individualizzato.<br />
Gli interventi sono realizzati da operatori del Servizio Fasce Deboli (SFD) in integrazione<br />
progettuale con i comuni di residenza dei soggetti e con gli operatori del DSM.<br />
Modalità di segnalazione<br />
Il DSM, quando ritiene perseguibile un inserimento lavorativo, invia una scheda di segnalazione<br />
individuale al Comune di residenza e, per tramite della gestione associata di riferimento, al SFD,<br />
con allegata una relazione illustrativa della situazione sociale, una valutazione funzionale ai fini<br />
lavorativi e una sintesi del piano di trattamento individuale (PTI) in atto per lo stesso. Il Servizio<br />
inviante, attraverso il tirocinio riabilitativo o socio-occupazionale effettuato, avrà verificato la<br />
presenza dei pre-requisiti necessari (di cui in allegato) per un inserimento lavorativo.<br />
Percorso<br />
1. Entro 60 giorni circa dall’invio della segnalazione, il SFD attiverà un proprio intervento d’intesa<br />
con i servizi interessati ed elaborerà un progetto di inserimento che dovrà indicare obiettivi<br />
perseguiti, ipotesi convenuta, rispettive competenze, impegni definiti in un apposito “accordo di<br />
servizio”. In attesa che il Servizio Fasce Deboli attivi un percorso di inserimento al lavoro, la<br />
persona interessata potrà continuare a svolgere il tirocinio riabilitativo o socio-occupazionale in<br />
atto.<br />
Il SFD dà riscontro dell’esito della presa in carico e dell’attivazione dell’intervento al Comune<br />
di residenza e alla gestione associata di riferimento, secondo lo procedure di cui all’art. 3 del<br />
protocollo allegato alla Convenzione con i Comuni, che a sua volta ne darà comunicazione al<br />
DSM.<br />
2. Il SFD, di norma, si occuperà della gestione e del monitoraggio del tirocinio fino alla<br />
conclusione dello stesso.<br />
Qualora la persona non fosse in possesso dei necessari pre-requisiti per l’ inserimento lavorativo o<br />
si verificasse la necessità di interrompere il percorso di accompagnamento al lavoro per<br />
sopravvenuta incompatibilità a causa della sua patologia, il SFD invierà una relazione di dimissione<br />
al Comune di residenza e alla Gestione Associata, e per loro tramite al DSM, affinché gli stessi<br />
possano valutare l’eventuale ripresa in carico.<br />
6
Gli eventuali costi per le borse lavoro sono a carico del Servizio Fasce Deboli come previsto dalla<br />
convenzione fra la Provincia di <strong>Lecco</strong> e gli Ambiti Distrettuali di Bellano, <strong>Lecco</strong>, Merate.<br />
3) Tirocini di adozione lavorativa a distanza<br />
La Provincia di <strong>Lecco</strong> – Servizio Collocamento Disabili – al fine di offrire adeguati momenti di<br />
integrazione sociale alle persone disabili non collocabili al lavoro, secondo le procedure di cui alla<br />
L. 68/99, ha ritenuto opportuno ricercare nuove forme di integrazione socio-lavorativa promovendo<br />
una particolare sperimentazione definita “tirocinio di adozione lavorativa a distanza”.<br />
Il “tirocinio di adozione lavorativa a distanza” viene attivato in accordo con una azienda soggetta<br />
agli obblighi di cui alla L. 68/99, a favore di una persona disabile con problematicità tali da poter<br />
essere collocata unicamente in un ambito “protetto” con tempi e modi personalizzati.<br />
Attraverso i “tirocini lavorativi a distanza” il Servizio Collocamento Disabili vuole:<br />
• favorire l’inserimento delle persone disabili che presentano particolari problematicità e che<br />
risiedono in territori con scarsa presenza di realtà produttive e con aziende appartenenti a<br />
settori produttivi dove è difficile operare adeguati inserimenti;<br />
• evitare l’inserimento delle persone disabili in strutture lavorative, educative, riabilitative…<br />
speciali quando è ipotizzabile un’integrazione socio-occupazionale in contesti lavorativi<br />
ordinari;<br />
• favorire il contenimento dei costi a carico degli enti e servizi pubblici che operano a favore<br />
delle persone disabili, in quanto i costi della Borsa Lavoro sono a carico di aziende soggette<br />
agli obblighi di cui alla L. 68/99.<br />
Visto l’esito positivo dell’esperienza e l’utilità sociale della stessa, soprattutto per le persone con<br />
disabilità mentale, si concorda di attivare una fase di collaborazione, fra il Servizio Collocamento<br />
Disabili e il Dipartimento di Salute Mentale, volta a valutare il bisogno ed eventualmente ad<br />
allargare il numero dei possibili beneficiari di questo strumento di integrazione.<br />
Questa fase di collaborazione consentirà anche di definire adeguate procedure operative.<br />
I costi di gestione sono a carico del Servizio Collocamento Disabili.<br />
Ai sensi del presente Protocollo, il monitoraggio dei tirocini lavorativi e di adozione, previa<br />
valutazione congiunta tra i Servizi, può essere effettuato da operatori dell’équipe funzionale lavoro<br />
del DSM, esplicitandolo nella Convenzione di tirocinio.<br />
Per l’applicazione delle soprascritte intese e, soprattutto, per dare continuità agli interventi messi in<br />
atto dai diversi Servizi sui soggetti in carico, si prevedono incontri almeno semestrali di verifica e<br />
progettazione congiunta su tutte le situazioni in carico al DSM, per ambito <strong>territoriale</strong>, tra: operatori<br />
équipe funzionale lavoro del DSM, responsabili e operatori del SFD.<br />
In allegato: criteri di riferimento per:<br />
- tirocini riabilitativi<br />
- inserimento lavorativo<br />
Per i tirocini di adozione lavorativa a distanza i criteri di riferimento sono contenuti nel relativo<br />
Regolamento del Servizio Collocamento Disabili della Provincia di <strong>Lecco</strong>.<br />
7
INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE.<br />
La domanda di spazi di aggregazione e di integrazione sociale è molto sentita e particolarmente<br />
segnalata dalle famiglie. Molti pazienti psichiatrici infatti, qualora non occupati o inseriti in tirocini,<br />
ovvero non inseriti nelle Strutture residenziali e semiresidenziali del DSM, devono fronteggiare una<br />
giornata spesso non finalizzata e priva di riferimenti se non quelli parentali. Per garantire al più alto<br />
numero possibile di soggetti una risposta adeguata alle proprie caratteristiche e bisogni e non solo<br />
occasioni di impiego del tempo “vuoto”, occorre uno sviluppo di sinergie tra i servizi specialisti e i<br />
servizi territoriali.<br />
Nell’ambito dell’ ”organismo di coordinamento per la salute mentale” si andrà pertanto elaborando<br />
una politica di sviluppo delle offerte, sulla base della rilevazione dei bisogni attualmente conosciuti.<br />
In particolare:<br />
• Verranno sostenute le forme di intervento esistenti e ritenute idonee, siano esse realizzate dai<br />
Comuni, da Cooperative sociali, dall’Associazionismo, nella definizione delle ipotesi e nello<br />
sviluppo di competenze, adeguando il modello e la forma gestionale ai bisogni. Il sostegno a tali<br />
iniziative avverrà da parte del DSM nella forma di consulenza, non solo per quanto riguarda i<br />
singoli soggetti inseriti, ma nella stessa conduzione dell’ipotesi di lavoro.<br />
• Verranno promosse iniziative innovative, che integrino la funzione di cura e riabilitazione<br />
attraverso l’offerta di contesti aggregativi finalizzati, meglio se integrati con altre progettualità e<br />
altre tipologie di utenza, per consentire lo sviluppo di una rete di servizi la cui esistenza<br />
rappresenterebbe, di per sé, un fattore preventivo e di tutela. Anche in questo caso il DSM<br />
sosterrà i progetti attraverso una funzione consulenza.<br />
• L’“organismo di coordinamento per la salute mentale” favorisce l’emissione di specifici bandi<br />
annuali, per valutare e sostenere economicamente le seguenti tipologie di progetti di<br />
risocializzazione a favore di portatori di patologia psichiatrica, del tipo (I) inerenti attività di<br />
aggregazione, risocializzazione, intrattenimento; (II) vacanze e soggiorni climatici; (III) di<br />
promozione, sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza; (IV) a carattere artistico<br />
e sportivo.<br />
L’emissione dei bandi sarà in capo alle gestioni associate che stabiliranno l’entità dei contributi in<br />
base alle risorse messe a disposizione dal fondo sociale L.328/00.<br />
L’obiettivo è il riconoscimento o la promozione di esperienze che, incontrando quotidianamente e<br />
naturalmente i soggetti, possano rappresentare il microcosmo relazionale di riferimento, capace di<br />
offrire accoglienza, rispetto, senso di utilità, di valore, di sicurezza, di aprire ad altri percorsi di<br />
relazione e rapporto con la realtà, sostenendo un cammino evolutivo o garantendo una situazione di<br />
stabilità, equilibrio, monitoraggio.<br />
In tal senso è possibile sostenere, tramite il fondo sociale e in base alla programmazione annuale,<br />
iniziative e realtà di aggregazione che rispondono a bisogni relazionali, ricreativi e di tempo libero<br />
dei pazienti.<br />
INIZIATIVE DI FORMAZIONE E SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE<br />
Esiste ormai un’ampia letteratura sul ruolo della famiglia e dei contesti parentali come problema<br />
che origina e al tempo stesso come potenziale risorsa delle difficoltà del soggetto. Anche per la<br />
patologia mentale questo tema può essere assunto, ponendo attenzione alle specificità e peculiarità<br />
del caso. Quello che è certo è che le famiglie che hanno un componente con problematiche di questa<br />
natura si trovano a gestire aspetti complessi, che attaccano la sfera emotiva e relazionale, degli<br />
affetti e, insieme provocano problemi pratici e complessi che si ripetono, che spesso non evolvono,<br />
8
che spingono a disagi nei rapporti con l’esterno, che originano problematiche di tipo economico. Il<br />
tutto drammatizzato da aspetti di cronicità, imprevedibilità, continua necessità di ridefinizione.<br />
Appare allora importante riconoscere anche la famiglia come destinatario/soggetto degli interventi e<br />
non solo come problema/risorsa.<br />
Le famiglie sottolineano la necessità di essere aiutate a “capire” la malattia, a mantenere il contatto<br />
con il familiare “problematico”, a imparare a convivere con la fatica e le contraddizione e, al tempo<br />
stesso chiedono di non vedersi incolpate per i propri limiti e incapacità e di non essere destinate ad<br />
un compito di “assistenza” che col tempo diventa gravoso e insostenibile. Le famiglie chiedono di<br />
non essere automaticamente “arruolate” nei compiti di cura e a tampone dei bisogni, segnalando<br />
come spesso venga implicitamente chiesto loro di essere a “disposizione”, di strutturare il proprio<br />
tempo e la propria vita in ragione dei bisogni prioritari del familiare. Sottolineano il rischio di un<br />
esito di chiusura alle relazioni e alle interazioni, di un conseguente impoverimento del nucleo, di<br />
una chiusura sul proprio problema che non aiuta ad elaborare la necessità di lucide distanze.<br />
In parte a questo bisogno si potrà dare risposta attraverso lo sviluppo di una rete di offerte e<br />
iniziative aggregative finalizzate, che alleggerisca le famiglie nella gestione del familiare.<br />
Tali iniziative e progetti potranno essere sostenuti anche attraverso i contributi dei bandi di cui al<br />
paragrafo precedente.<br />
INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI<br />
Lo sviluppo di progettazione e interventi integrati richiede la condivisione minima delle rispettive<br />
conoscenze e competenze e dei linguaggi tecnico/operativi. Richiede altresì, per la diversa genesi,<br />
tipologia, natura dei servizi coinvolti, la condivisone delle rispettive culture di riferimento,<br />
l’integrazione reale tra prassi e approcci di natura medico/specialistica e l’evoluzione attuale<br />
assunta dagli interventi sociali realizzati dai Comuni con il concorso del privato sociale.<br />
Tale livello di incontro potrà certamente avvenire nella sede dell’ “organismo di coordinamento”,<br />
ma dovrà essere facilitato da occasioni formative rivolte al personale sociale dei Comuni che opera<br />
negli interventi integrati. In tal senso il DSM si impegna a promuovere iniziative formative rivolte<br />
al proprio personale infermieristico e sociale ma anche al personale dei Comuni, per favorire<br />
occasioni permanenti di confronto non sulla casistica ma su contenuti generali, su argomenti<br />
specifici e sugli orientamenti. I Comuni si impegnano a garantire , in forma coordinata, la<br />
partecipazione dei propri operatori (assistenti sociali, assistenti domiciliari, educatori, formatori) al<br />
programma formativo formulato sulla base delle esigenze rilevate.<br />
Le proposte formative saranno inviate alla Provincia di <strong>Lecco</strong> – Servizi alla Persona, per una<br />
valutazione di possibili partnership all’interno del “Piano provinciale per la formazione e<br />
l’aggiornamento del personale dei servizi socio - assistenziali e socio- sanitari”.<br />
9
II PARTE<br />
Cap. 4<br />
Protocollo DSM-MMG<br />
PERCORSO DIAGNOSTICO – CLINICO<br />
TRA MEDICINA GENERALE E CENTRI<br />
PSICOSOCIALI :<br />
SISTEMA DI RELAZIONI<br />
Dr. Romolo Gadaldi – Az. Ospedale di <strong>Lecco</strong> - Area CPS<br />
Dr. Valter Valsecchi - Az. <strong>ASL</strong> <strong>Lecco</strong>- Direttore Dipartimento Servizi Sanitari di Base
INDICE<br />
PREMESSA ....................................................................................................................................................................... 3<br />
1. FASE 1 : ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL M.M.G................................................. 8<br />
1.1. Livelli di gestione da parte del Medico di Medicina Generale.............................................8<br />
1.2. Quando potrebbe essere opportuno l’invio del paziente al CPS...........................................9<br />
2. FASE 2 : INVIO DEL PAZIENTE ALLO SPECIALISTA DEL CPS ............................................................. 10<br />
2.1. Modalità di invio ...............................................................................................................10<br />
Contatto preliminare con il collega psichiatra del CPS ..........................................................10<br />
Unità di Offerta.......................................................................................................................11<br />
CPS di LECCO ...............................................................................................................11<br />
CPS DI MERATE...........................................................................................................12<br />
3. FASE 3 : ATTIVITÀ DEL CPS............................................................................................................................ 13<br />
4. FASE 4 : RESTITUZIONE AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE ........................................................ 14
PREMESSA<br />
Il presente protocollo prende avvio dalla considerazione della necessità di tradurre il rapporto tra i<br />
CPS e i MMG in termini di “processo” di attività. All’interno dell’analisi del processo è stato preso<br />
in considerazione “ciò che il medico di medicina generale (in considerazione dell’organizzazione<br />
della propria attività e rispetto alla complessità del paziente) “è in grado di fare da sé “ e “ciò che<br />
può fare con una consulenza specialistica<br />
SONO STATE INDIVIDUATE QUATTRO FASI del processo di rappresentazione del percorso del paziente<br />
(cure primarie e specialistiche)<br />
- L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL M.M.G<br />
- L’INVIO<br />
- L’ATTIVITA’ DEL CPS<br />
- LA RESTITUZIONE AL M.M.G.
FASE 1 : ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL MMG<br />
Utente<br />
M.M.G<br />
Sintomatologia<br />
ascrivibile ad una<br />
reazione di<br />
adattamento<br />
SI<br />
Trattamento farmacologico<br />
Verifica<br />
Remissione della<br />
sintomatologia<br />
SI<br />
Fine<br />
Supporto telefonico<br />
In caso di accesso diretto<br />
del paziente, si prevede<br />
relazione al MMG (vedi<br />
fase 4)<br />
NO<br />
NO<br />
Invio<br />
CPS
FASE 2 :INVIO DEL PAZIENTE ALLO SPECIALISTA DEL CPS<br />
NO<br />
Invio con modulo<br />
regionale di<br />
prescrizione / proposta<br />
Invio al CPS<br />
Contatto<br />
con lo<br />
Specialista<br />
SI<br />
ACCESSO AL CPS<br />
Spazio di contatto telefonico giornaliero con uno<br />
Specialista Psichiatra del CPS<br />
Scambio di informazioni sul<br />
paziente ; assegnazione di un<br />
appuntamento di prima visita per<br />
il paziente stesso da parte del CPS<br />
modulo regionale di<br />
prescrizione / proposta
FASE 3 : ATTIVITÀ DEL CPS<br />
Valutazione Diagnostica<br />
Presa in carico<br />
SI<br />
Formulazione del<br />
Progetto Terapeutico<br />
NO
FASE 4 : RESTITUZIONE AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE<br />
No<br />
Fine<br />
Ulteriori<br />
verifiche con<br />
lo Specialista<br />
SI<br />
Relazione al MMG<br />
Spazio di possibilità di contatto telefonico<br />
con lo Specialista Psichiatra del CPS che segue il caso
1. FASE 1 : ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL M.M.G<br />
Il MMG è la figura professionale che per prima riceve , direttamente o per riferito dai famigliari, la<br />
domanda di aiuto del paziente.<br />
1.1. LIVELLI DI GESTIONE DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE<br />
Il MMG ha la possibilità, stante il volume e l’organizzazione della propria attività di studio, di<br />
prendere in carico pazienti che presentano sintomi riconducibili a disturbi d’ansia e depressivi.<br />
DP ( Disturbo di Panico) : attacchi d’angoscia ad insorgenza<br />
improvvisa,apparentemente non correlabili ad accadimenti esterni precipitanti, con un<br />
ricco corteo sintomatologico di somatizzazioni<br />
(cardiache, urogenitali, intestinali, respiratorie). Manifestano andamento a poussés,<br />
spesso molto invalidanti e da non trascurare.<br />
GAD ( Disturbo d’Ansia Generalizzato): situazione clinica caratterizzata da un<br />
disturbo d’ansia tendenzialmente cronico o tendente alla cronicizzazione; sono<br />
presenti somatizzazioni che spesso rallentano la diagnosi di GAD orientando verso un<br />
disturbo organico ( che comunque va sempre indagato). A differenza del DP l’ansia è<br />
continua, spesso presenta momenti di riacutizzazione, mantiene il soggetto in un<br />
costante stato di apprensione. Anch’esso alquanto invalidante è spesso presente in<br />
comorbidità con un disturbo depressivo.<br />
Disturbi d’ansia situazionale: sono situazioni in cui compaiono sintomi d’ansia,<br />
preoccupazione, somatizzazioni e iperattivazione del sistema neurovegetativo; è di<br />
solito riconducibile ad un evento nella vita del paziente, vissuto come fonte di<br />
marcata preoccupazione.<br />
Disturbi depressivi: si manifestano generalmente come un abbassamento del tono<br />
dell’umore, alterazione del ritmo sonno – veglia, perdita di interesse per attività<br />
considerate abitudinarie ( lavoro, lavori domestici) o anche piacevoli ( hobbies,<br />
momenti di socializzazione con amici o parenti), perdita dell’interesse affettivo verso<br />
le persone care, riduzione/assenza di interesse sessuale. Possono anche manifestarsi<br />
come senso di fatica cronica, preoccupazioni esagerate per il proprio stato di salute<br />
fisica. La loro intensità è variabile da lieve a molto grave.Spesso sono correlabili ad<br />
eventi esterni di perdita.<br />
Queste sintomatologie, con un trattamento farmacologico adeguato e adeguatamente protratto,<br />
dovrebbero tendenzialmente migliorare e regredire nell’arco di un paio di mesi e appaiono spesso<br />
tendenzialmente transitorie.<br />
Generalmente si ha una ripresa dello stato di benessere del paziente, sia perché è stato interrotto il<br />
circuito negativo angoscia-paura dell’angoscia, sia perché le cause del malessere, se sono esterne al<br />
soggetto, vengono superate.Ovviamente il trattamento farmacologico non modifica gli aspetti di<br />
personalità del soggetto, tranne per quelle situazioni nelle quali, lo stato d’ansia o di depressione,<br />
abbiano indotto modificazioni della personalità, difensive rispetto ai disturbi ( ad esempio : la<br />
rinuncia ad uscire, in un soggetto con DP, crea anche un’immagine alterata di sé con conseguente<br />
modificazioni della personalità originale dell’individuo)
L’UOP di Psichiatra fornisce, comunque, un supporto “ specialistico” di orientamento diagnostico e<br />
terapeutico, sia attraverso visite specialistiche di consulenza, attivando uno spazio telefonico<br />
dedicato al M.M.G.<br />
La modalità individuata prevede che L’U.O. di Psichiatria, attraverso il CPS e/o le sue sedi<br />
ambulatoriali metta a disposizione dei M.M.G. :<br />
Uno spazio telefonico quotidiano dedicato ( possibilmente nella fascia oraria 12.,30 -<br />
13.30), di immediata attuazione, all’interno del quale il M.M.G. può confrontarsi con<br />
un collega specialista, qualora avesse dubbi diagnostici o terapeutici o circa l’utilità<br />
di inviare un soggetto a visita specialistica.<br />
Un secondo spazio telefonico dedicato, la cui attuazione potrebbe essere successiva,<br />
nel quale, un giorno alla settimana, ogni collega specialista dei CPS, potrà ricevere<br />
telefonicamente il M.M.G per un confronto sui casi che entrambi hanno già in<br />
cura.Tale spazio sarà reso noto ai colleghi M.M.G. non appena sarà stato individuato,<br />
anche se, per quanto non formalizzato all’interno di una precisa giornata e di una<br />
precisa fascia, è da considerare già esistente. Spesso infatti i colleghi M.M.G.<br />
telefonano allo specialista, che ha in cura con loro un paziente per averne notizie<br />
cliniche.<br />
1.2. QUANDO POTREBBE ESSERE OPPORTUNO L’INVIO DEL PAZIENTE AL CPS.<br />
1. Nel caso di mancata risoluzione dei sintomi o di assenza di percepibili miglioramenti entro<br />
tempi ragionevolmente prevedibili( solitamente nell’arco di due – tre mesi)<br />
2. Nei casi in cui la sintomatologia risulta essere particolarmente invalidante per il paziente<br />
(criteri di gravità potrebbero essere: marcata riduzione della capacità di affrontare i normali<br />
impegni sociali, come accudire ai compiti genitoriali; netto peggioramento di parametri<br />
fisiologici quali il sonno e l’alimentazione; comparsa di ideazione patologica a carattere<br />
delirante o a contenuto auto - etero aggressivo; manifestazioni impulsive riferite come<br />
incontrollabili dal soggetto)<br />
3. Nei casi in cui dall’anamnesi risultano essere presenti episodi ricorrenti della medesima<br />
manifestazione patologica.<br />
4. Nei casi in cui il soggetto sia già stato in cura per periodi consistenti presso una struttura<br />
specialistica.<br />
Per gli aspetti operativi inerenti le modalità di invio si veda la successiva: FASE 2
2. FASE 2 : INVIO DEL PAZIENTE ALLO SPECIALISTA DEL CPS<br />
2.1. MODALITÀ DI INVIO<br />
Contatto preliminare con il collega psichiatra del CPS<br />
Come già accennato precedentemente, la U.O. di Psichiatria, attraverso il CPS e/o le sue sedi<br />
ambulatoriali, e con le modalità già spiegate, metterà a disposizione dei MMG uno spazio telefonico,<br />
ogni giorno e per cinque giorni la settimana, all’interno del quale il collega inviante potrà<br />
confrontarsi con il collega specialista sia per le modalità di invio (fissare un appuntamento per il<br />
paziente, fornire informazioni su quali documenti debba avere con sé , etc.) sia per concordare<br />
eventuali altre necessità tra cui ad esempio la possibilità di una visita domiciliare congiunta.<br />
Il contatto preventivo con il medico specialista consente al Medico di Medicina Generale:<br />
di fornire elementi sulla situazione clinica e verificare l’opportunità/necessità dell’invio<br />
concordare le modalità di invio(attraverso l’apposizione, da parte del M.M.G., della scritta ”<br />
richiesta di visita specialistica presso il CPS” sul ricettario Regionale, attraverso la richiesta,<br />
concordata con lo specialista, di una visita domiciliare congiunta o altro)<br />
ricevere direttamente un appuntamento per il suo paziente e delucidazioni sulla eventuale<br />
documentazione clinica che il paziente dovrebbe avere con sé, utile per evidenziare altre<br />
situazioni cliniche, pregresse o in atto (ad esempio:terapie farmacologiche, in corso o<br />
pregresse di cui dover tenere conto, stati morbosi pregressi che potrebbero influire sulla<br />
situazione attuale, allergie etc.)<br />
conoscere il nome del medico specialista che eventualmente prenderà in carico il paziente<br />
inviato
CPS di LECCO<br />
Unità di Offerta<br />
Sede operativa di <strong>Lecco</strong>, Via Ghislanzoni 22 – Tel. 0341 489181<br />
- Comuni di riferimento: <strong>Lecco</strong>, Valmadrera, Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Calolziocorte,<br />
Carenno, Erve, Torre de’ Busi, Vercurago, , Monte Marenzo, Valgreghentino, Olginate,<br />
Pescate, Garlate, , Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio, Morterone.<br />
1. Orari di apertura dal Lunedì al Venerdì: dalle 8.30 alle 17.<br />
2. Sabato : dalle 8.30 alle 12.00<br />
3. Orari e telefono di riferimento per il contatto con lo specialista:<br />
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ; Tel. 0341 489181<br />
Sede operativa di Mandello del Lario. Tel. 0341489181<br />
Comuni di riferimento: , Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana<br />
Orari di apertura: Giovedì dalle 8.30 alle 12,30 ( prevista estensione al martedì mattina e al<br />
pomeriggio del giovedì)<br />
Orari e telefono di riferimento per il contatto con lo specialista.<br />
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 15.00. Tel. 0341 489181<br />
Sede operativa di Oggiono, Via Locatelli. Tel. 0341489181<br />
(Comuni di riferimento: Oggiono, Galbiate, Colle Brianza, Annone Brianza, Bosisio Parini,<br />
Bulciago, Castello Brianza, Cesana Brianza, Costamasnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate<br />
Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Sirone, Suello.)<br />
1. Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12,30<br />
2. Orari e telefono di riferimento per il contatto con lo specialista.<br />
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 15.30 Tel. 0341 489181<br />
Sede operativa di Bellano, presso Ospedale Umberto 1°. Tel 0341829325<br />
(Comuni di riferimento: Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio,<br />
Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo,<br />
Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno.)<br />
1. Orari di apertura dal lunedì al Venerdì dalla 8.30 alle 17.<br />
2. Orari e telefono di riferimento per il contatto con lo specialista:<br />
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 Tel. 0341 829325<br />
Sede operativa di Introbio, presso Nuovo Distretto <strong>ASL</strong>; Loc. Sceregalli. Tel 0341829325<br />
Orari di apertura: martedì mattino dalle 9 alle 12.30<br />
Orari e telefono di riferimento per il contatto con lo specialista:<br />
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 Tel. 0341 829325
CPS DI MERATE<br />
AREA DISTRETTUALE DI MERATE<br />
(Comuni di riferimento: Merate, Airuno, Olgiate Molgora, Calco, Brivio, Imbersago, Robbiate,<br />
Paderno d’Adda, Verderio Superiore, Verderio Inferiore, Osnago, Lomagna, Cernusco Lombardone,<br />
Montevecchia, Missaglia, Monticello, Casatenovo, Sirtori, Vigano, Barzanò, Cremella, Cassago,<br />
Barzago, Perego, Rovagnate, Santa Maria Hoè)<br />
1. Orari d’apertura dal lunedì al Venerdì dalla 8.30 alle 18.<br />
2. Unità d’offerta ambulatoriali : Ambulatori di Merate, Via Parini 8, dal Lunedì al Venerdì<br />
3. Orario e telefono di riferimento per il contatto con lo specialista:<br />
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Tel. 039 9902293
3. FASE 3 : ATTIVITÀ DEL CPS<br />
Lo Specialista Psichiatra valuterà, nell’ambito delle proprie competenze e dell’organizzazione<br />
interna del Servizio , se per il paziente inviato dovrà essere prevista (secondo le indicazioni del<br />
vigente PSSR) :<br />
Una Consulenza:in questo caso il paziente sarà valutato dallo Specialista per quanto<br />
attiene alla formulazione di una diagnosi e per un consiglio terapeutico; lo stesso<br />
specialista redigerà una relazione (su apposito modulo, vedi il facsimile in Allegato 1)<br />
per il M.M.G., nella quale saranno specificate: la diagnosi, il consiglio terapeutico, gli<br />
orari in cui il collega Specialista sarà disponibile per un colloquio telefonico col M.M.G.<br />
Il paziente in questo caso tornerà alle cure del M.M.G.<br />
Una Assunzione in Cura: in questo caso lo Specialista, dopo aver valutato il paziente e<br />
formulato una diagnosi, ritiene che il soggetto necessiti di un programma terapeutico con<br />
una necessità di intervento dello specialista continuativo.Come per la Consulenza,<br />
redigerà una relazione per il M.M.G., nella quale indicherà la diagnosi, la decisione della<br />
presa in cura, il periodo approssimativo della durata della stessa nonché le terapie<br />
consigliate.In misura ancora maggiore che per la Consulenza, concorderà con il collega<br />
M.M.G.,l’eventuale ruolo di quest’ultimo all’interno del progetto di cura, con modalità<br />
analoghe a quelle descritte per la Consulenza.<br />
Una Presa in Carico secondo il modello del trattamento integrato: questa modalità di<br />
intervento è riservata ai disturbi mentali gravi, “con rilevante sintomatologia clinica,<br />
associata a problemi di rilievo sociale e/o disabilità, per le quali deve essere assicurata<br />
la gestione e il trattamento terapeutico e riabilitativo personalizzato da parte dei servizi<br />
psichiatrici territoriali, che predisporranno in modo appropriato, con le necessarie<br />
integrazioni sociali, le risorse assistenziali e terapeutiche adeguate alla complessità dei<br />
casi”(cfr. Progetto Socio Sanitario 2002 - 2004 della Regione Lombardia). In questa<br />
situazione lo Specialista invierà una relazione clinica al M.M.G., che, non diversamente<br />
dalle situazioni precedenti, dovrà contenere la diagnosi, le indicazioni del progetto<br />
terapeutico e le terapie farmacologiche consigliate. L’eventuale ruolo del M.M.G. dovrà<br />
essere concordato con lo stesso in funzione della complessità dell’intervento e delle<br />
strategie più opportune per attuarlo.E’ previsto che il collega M.M.G. possa partecipare<br />
anche alle riunioni di équipe, qualora lo ritenga opportuno, in relazione alla sua<br />
partecipazione al progetto di cura e/o riabilitativo.
4. FASE 4 : RESTITUZIONE AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE<br />
L’esito della visita specialistica esiterà, quindi, sempre ( anche in caso accesso diretto del paziente),<br />
in una relazione clinica per il MMG (secondo il modello di cui all’allegato 1), che, di norma, verrà<br />
consegnato direttamente dallo specialista al paziente.<br />
La relazione dovrà contenere le indicazioni circa :<br />
La diagnosi (o l’eventuale comunicazione di necessità di un iter diagnostico)<br />
La proposta terapeutica o, nel caso di una presa in carico da parte del CPS, il progetto<br />
terapeutico, individuale o secondo il modello integrato.<br />
l’indicazione dello spazio telefonico durante il quale il MMG potrà telefonare allo specialista<br />
che ha in carico il paziente per avere/comunicare altre notizie su come sta evolvendo il progetto<br />
terapeutico indicato.<br />
Il ritorno al medico curante non prevede come finalità “la trascrizione” delle prescrizioni<br />
specialistiche connesse alla “cura del paziente”.
OSPEDALE DI LECCO<br />
AZIENDA OSPEDALIERA<br />
PROVINCIALE DEL S.S.N.<br />
RELAZIONE CLINICA AL MEDICO CURANTE<br />
MOD. DL 17.4a<br />
REV.000<br />
Al / Alla Dott._________________________________________________________________________________<br />
Il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________<br />
Visitato/a presso il nostro C.P.S. in data_________________________________________________________<br />
con diagnosi ___________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Viene affidato/a al Curante Presa in cura per un periodo di mesi……….<br />
E’ previsto un approfondimento diagnostico Invio presso altra Agenzia<br />
Progetto terapeutico Integrato /Consiglio Terapeutico_______________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Controllo previsto per il giorno:___________________________________<br />
Richiederei la Sua collaborazione per:<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Sono a Sua disposizione per un contatto telefonico il dalle alle<br />
Data______________________<br />
Timbro e Firma<br />
Centro Psicosociale di <strong>Lecco</strong>- Sede operativa di <strong>Lecco</strong>, Via Ghislanzoni, 22 –23900 <strong>Lecco</strong> .Tel. 0341 489181
OSPEDALE DI LECCO<br />
AZIENDA OSPEDALIERA<br />
PROVINCIALE DEL S.S.N.<br />
RELAZIONE CLINICA AL MEDICO CURANTE<br />
MOD. DL 17.4a<br />
REV.000<br />
Al / Alla Dott._________________________________________________________________________________<br />
Il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________<br />
Visitato/a presso il nostro C.P.S. in data_________________________________________________________<br />
con diagnosi ___________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Viene affidato/a al Curante Presa in cura per un periodo di mesi……….<br />
E’ previsto un approfondimento diagnostico Invio presso altra Agenzia<br />
Progetto terapeutico Integrato /Consiglio Terapeutico_______________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Controllo previsto per il giorno:___________________________________<br />
Richiederei la Sua collaborazione per:<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Sono a Sua disposizione per un contatto telefonico il dalle alle<br />
Data______________________<br />
Timbro e Firma<br />
Centro Psicosociale di <strong>Lecco</strong> – Sede operativa di Oggiono, Via Locatelli,22 – 23848 Oggiono – Tel. 0341 267920
OSPEDALE DI LECCO<br />
AZIENDA OSPEDALIERA<br />
PROVINCIALE DEL S.S.N.<br />
RELAZIONE CLINICA AL MEDICO CURANTE<br />
MOD. DL 17.4a<br />
REV.000<br />
Al / Alla Dott._________________________________________________________________________________<br />
Il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________<br />
Visitato/a presso il nostro C.P.S. in data_________________________________________________________<br />
con diagnosi ___________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Viene affidato/a al Curante Presa in cura per un periodo di mesi……….<br />
E’ previsto un approfondimento diagnostico Invio presso altra Agenzia<br />
Progetto terapeutico Integrato /Consiglio Terapeutico_______________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Controllo previsto per il giorno:___________________________________<br />
Richiederei la Sua collaborazione per:<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Sono a Sua disposizione per un contatto telefonico il dalle alle<br />
Data______________________<br />
Timbro e Firma<br />
Centro Psicosociale di <strong>Lecco</strong>- Sede operativa di Bellano, Via C. Alberto,25 – 23822 Bellano - 0341 829325
OSPEDALE DI LECCO<br />
AZIENDA OSPEDALIERA<br />
PROVINCIALE DEL S.S.N.<br />
RELAZIONE CLINICA AL MEDICO CURANTE<br />
Centro Psicosociale di Merate, Via Parini, 8 – 20059 Merate – Tel. 039 9902299 - 93<br />
MOD. DM 7.2 C<br />
REV.000<br />
Al / Alla Dott._________________________________________________________________________________<br />
Il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________<br />
Visitato/a presso il nostro C.P.S. in data_________________________________________________________<br />
con diagnosi ___________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Viene affidato/a al Curante Presa in cura per un periodo di mesi……….<br />
E’ previsto un approfondimento diagnostico Invio presso altra Agenzia<br />
Progetto terapeutico Integrato /Consiglio Terapeutico_______________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Controllo previsto per il giorno:___________________________________<br />
Richiederei la Sua collaborazione per:<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Sono a Sua disposizione per un contatto telefonico il dalle alle<br />
Data______________________<br />
Timbro e Firma
II PARTE<br />
Cap. 5<br />
Collaborazione tra il D.S.M dell’Azienda Ospedale di <strong>Lecco</strong> e il Settore<br />
Dipendenze dell’<strong>ASL</strong> per la gestione di pazienti che presentano doppia diagnosi<br />
( psichiatrica e di dipendenza da sostanze)<br />
Premessa<br />
Il presente protocollo d’intesa nasce dall’esigenza, degli operatori dei Servizi Psichiatrici e dei<br />
Servizi per le Dipendenze ( SER.T – Serv. Alcoologia), di trovare modalità di fattiva collaborazione<br />
e integrazione per la cura di soggetti portatori di un disturbo psichiatrico e di un disturbo da<br />
dipendenza da sostanze.<br />
Obiettivo del protocollo<br />
Obiettivo del protocollo è quello di individuare :<br />
corrette modalità di invio di soggetti portatori di doppia patologia, al fine di ottenere una<br />
consulenza specialistica da uno dei Servizi<br />
corrette modalità di presa in carico, qualora ne fosse ravvisata la necessità, per un percorso<br />
terapeutico condiviso<br />
corrette modalità di dimissione da uno dei Servizi<br />
A ) Il paziente in fase ambulatoriale<br />
INVIO DI SOGGETTI DA UN SERVIZIO ALL’ALTRO AI FINI DI UNA CONSULENZA<br />
Il Medico di uno dei Servizi, quando ravvisi la necessità di avere un parere specialistico da un<br />
collega di un altro Servizio, procede come di seguito:<br />
Telefona al Servizio per ottenere un appuntamento con il primo medico disponibile<br />
( l’appuntamento sarà concesso nei limiti temporali consueti, che salvo situazioni<br />
eccezionali, sono di 15 giorni )<br />
L’operatore che fissa la data dell’appuntamento riferisce al Medico richiedente il nome del<br />
Medico che vedrà il paziente<br />
Il Medico inviante contatterà telefonicamente il Medico che effettuerà la consulenza per<br />
avere con Lui un primo scambio di informazioni<br />
Il Medico inviante redigerà la “ richiesta di Consulenza Psichiatrica al CPS” ( documento<br />
del DSM che verrà fornito ai servizi del Settore Dipendenze dell’<strong>ASL</strong>) compilata in ogni sua<br />
parte, e la invierà il più celermente possibile, anche via Fax, al Servizio che effettuerà la<br />
consulenza
Il Medico che effettua la consulenza redigerà la “ relazione di Consulenza Psichiatrica”,<br />
( documento del DSM che verrà adottato, con intestazione propria, anche dal Settore<br />
Dipendenze dell’<strong>ASL</strong>) compilata in ogni sua parte, specificando l’eventuale progetto<br />
terapeutico formulato per il paziente, se questi sarà preso in carico. Qualora non vi fosse la<br />
necessità di una presa in carico, saranno indicati comunque gli eventuali consigli terapeutici.<br />
PRESA IN CARICO CONGIUNTA DI PAZIENTE CON DOPPIA DIAGNOSI<br />
La comunicazione della necessità di una presa in carico del paziente, da parte del Servizio che ha<br />
effettuato la Consulenza, viene comunicata al Servizio inviante tramite la “ relazione di Consulenza<br />
Psichiatrica” inviata dal Medico che effettua la Consulenza al Collega inviante.<br />
Stabilita la necessità di una presa in cura da parte di un secondo Servizio, il Medico che ha richiesto<br />
la Consulenza si accorderà con il Collega, che l’ha effettuata, per promuovere un primo incontro tra<br />
le due équipes curanti. Prima di tale incontro, le Assistenti Sociali di ciascun Servizio effettueranno<br />
una rilevazione / valutazione del bisogno sociale presentato dal paziente, dapprima per il proprio<br />
ambito di competenza e successivamente in maniera congiunta. Seguirà un primo incontro tra le<br />
èquipe congiunte, finalizzato alla stesura di un “progetto terapeutico congiunto”, nel quale<br />
dovranno essere specificati:<br />
gli obiettivi dell’intervento di ciascuna équipe<br />
i mezzi e le modalità attraverso le quali si pensa di raggiungere gli obiettivi<br />
gli operatori coinvolti nel progetto e i compiti loro assegnati all’interno del progetto stesso<br />
i tempi e i modi di verifica<br />
gli eventuali impegni di spesa, nell’ambito del progetto, che dovranno essere approvati dai<br />
Direttori dei singoli Servizi.<br />
Il progetto terapeutico, così formulato, deve essere scritto:<br />
per quanto concerne il CPS, nella cartella clinica Regionale del CPS, così come<br />
abitualmente viene fatto per ogni paziente in carico<br />
per quanto concerne il Settore Dipendenze, nella cartella clinica Regionale in dotazione.<br />
DIMISSIONE DEL PAZIENTE DA UNO DEI SERVIZI<br />
La dimissione del paziente può avvenire in tempi diversi per ognuno dei Servizi, come la pratica<br />
clinica insegna.<br />
Nel caso in cui uno dei Servizi ritenga di aver terminato l’intervento per il quale era stato coinvolto<br />
e ritenga di poter dimettere il paziente, comunicherà questa ipotesi al servizio con il quale sta<br />
collaborando, all’interno di uno dei momenti di verifica previsti nel progetto terapeutico.<br />
La dimissione sarà concordata all’interno di un incontro tra le due équipes, sentite le opinioni di<br />
tutti gli operatori.<br />
La dimissione, con le sue motivazioni, sarà, anch’essa, annotata nelle rispettive cartelle.
B ) Il paziente in fase di accesso/ricovero in Ospedale di <strong>Lecco</strong><br />
Si rimanda al Protocollo di Intesa Interdipartimentale, già in atto dal novembre 2002, che deve<br />
intendersi valido sia per le problematiche alcool correlate che per quelle da abuso di sostanze in<br />
genere, che precisa il percorso del paziente sia al suo arrivo in Pronto Soccorso sia durante la<br />
degenza ospedaliera, nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) o in altra Unità di<br />
degenza.<br />
Ad integrazione di tale Protocollo, appare utile precisare in questo documento il corretto iter di<br />
richiesta d’intervento dell’assistente sociale, viste le complesse problematiche presentate da questa<br />
tipologia di pazienti.<br />
Viene individuata la seguente procedura:<br />
- nel caso di paziente in Pronto Soccorso, per il quale si evidenzino, nell’immediato,<br />
problematiche sociali (es. impossibilità di rientro al domicilio, accessi frequenti ecc.), il medico del<br />
PS interpellerà direttamente le assistenti sociali ospedaliere, le quali fungeranno sia da immediato<br />
riferimento per la soluzione dell’urgenza, sia, successivamente, da “mediatori” rispetto agli altri<br />
servizi specialistici (SERT/NOA o CPS) o di base.<br />
- nel caso di paziente ricoverato nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura o visitato in altro<br />
Reparto Ospedaliero dal consulente psichiatra, le eventuali problematiche sociali emergenti,<br />
connesse allo stato patologico di doppia diagnosi, verranno segnalate nel modulo di “Richiesta di<br />
Consulenza al Settore Dipendenze”. Ciò al fine di consentire un intervento immediato, oltre che del<br />
medico del SER.D, anche dell’Assistente Sociale di tale servizio. La definizione del successivo<br />
progetto terapeutico prenderà le mosse da una valutazione congiunta dei bisogni socio ambientali<br />
del paziente da parte delle Assistenti Sociali dei due Servizi ( DSM e SER.D) le quali, ultimata la<br />
valutazione di loro competenza, si attiveranno a promuovere un primo incontro congiunto fra le due<br />
équipes. Per quanto attiene l’intervento delle Assistenti Sociali del DSM, questo competerà<br />
all’Assistente Sociale del CPS, qualora si tratti di un paziente già in cura presso detta struttura, e<br />
all’Assistente Sociale delegata all’SPDC quando il paziente non sia già noto al CPS. Sarà compito<br />
di quest’ultima Assistente Sociale promuovere il passaggio delle informazioni e quindi la presa in<br />
carico sociale, alla Collega del CPS.
II PARTE<br />
Cap. 6<br />
PROTOCOLLO DI INTESA INTERDIPARTIMENTALE PER IL<br />
TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE ALCOOL-CORRELATE<br />
Preso atto della complessità dell’argomento, dei dati della letteratura internazionale e,<br />
soprattutto, della rilevanza del fenomeno nel nostro territorio, si è ritenuto necessario<br />
cercare di definire un protocollo di intesa tra le branche specialistiche, che vengono<br />
più spesso chiamate in causa nel trattamento di pazienti, che presentano una patologia<br />
alcool-correlata, allo scopo di migliorare la collaborazione già in atto tra il Servizio<br />
Alcologia dell’Azienda Sanitaria Locale di <strong>Lecco</strong> ed i Dipartimenti di Urgenza,<br />
Medicina e Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong>.<br />
Si ritiene utile distinguere le seguenti entità cliniche:<br />
A) Intossicazione acuta da alcool<br />
E’ di competenza del medico di Pronto Soccorso (ove giunge pressoché<br />
esclusivamente il paziente, che presenta tale condizione morbosa) sia il<br />
trattamento terapeutico immediato sia, una volta risolto il quadro acuto e<br />
valutata la situazione clinica globale, l’invio ambulatoriale al Servizio<br />
Alcologia; solo nel caso in cui sia evidenziabile la presenza di una patologia<br />
psichiatrica, il medico di Pronto Soccorso chiederà la valutazione da parte<br />
dello psichiatra di guardia.<br />
Fatta salva la coesistenza di patologie, che esigano di per se stesse il<br />
trattamento ospedaliero, quest’ultimo viene predisposto, non in modo<br />
automatico dal medico del Pronto Soccorso, ma programmato in uno dei<br />
due reparti di Medicina, secondo la prassi usuale per le altre discipline, da<br />
parte dell’equipe del Servizio Alcologia, all’interno di un progetto terapeutico<br />
di disassuefazione, del quale è specifico titolare (vedi anche paragr. seg.)<br />
B) Dipendenza da alcool<br />
Poiché essa esiste sia come realtà clinica a sé stante, ma anche come<br />
comorbidità o addirittura come esclusivo epifenomeno di una malattia<br />
psichiatrica, sarà il concetto di “ patologia prevalente” a indirizzare la presa in<br />
carico da parte del Servizio Alcologia o del Centro PsicoSociale dell’Unità<br />
Operativa di Psichiatria, con ovvia possibilità di consulenza da parte,<br />
rispettivamente, del Centro PsicoSociale o del Servizio Alcologia,<br />
nell’ambito della più ampia collaborazione e disponibilità<br />
1
Parimenti, nel caso in cui durante il percorso terapeutico si renda necessario<br />
un ricovero ospedaliero, la degenza avverrà in ambito medico (Reparto di<br />
Medicina, Neurologia ecc.) se tale richiesta sarà fatta dal Servizio Alcologia<br />
(per malattie d’organo o intercorrenti, necessità di disintossicazione ecc.); il<br />
paziente inviato invece dal Centro PsicoSociale troverà una collocazione più<br />
adeguata nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (per scompensi<br />
psicotici, disturbi del tono dell’umore ecc.).<br />
E’ del tutto evidente la possibilità sia di eccezioni, motivate e concordate, sia<br />
di consulenze “incrociate” all’interno dei Reparti di degenza.<br />
C) Patologie particolari : delirium tremens e disturbi correlati all’astinenza<br />
alcolica.<br />
Si è ritenuto opportuno separare queste entità cliniche per la frequenza con<br />
cui si verificano in ogni Reparto ospedaliero e per il notevole impegno che<br />
richiedono per il personale medico e soprattutto infermieristico.<br />
Si concorda che il paziente affetto da tali patologie resti all’interno del<br />
Reparto in cui già è degente, con l’eventuale consulenza dell’internista e<br />
dello psichiatra per possibile successivo trasferimento.<br />
Allo scopo di uniformare e migliorare l’assistenza a questi pazienti, si ritiene utile<br />
allegare al presente protocollo una rapida sintesi, tratta dalle varie linee guida<br />
internazionali, delle essenziali misure terapeutico-assistenziali relative a tali entità<br />
cliniche.<br />
Si sottolinea, comunque, l’importanza della prevenzione dell’insorgenza del<br />
delirium, per la quale il Servizio Alcologia si impegna a fornire una linea guida sotto<br />
forma di apposita griglia da distribuire in tutte le Unità Operative dell’Ospedale.<br />
DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL DELIRIUM TREMENS E DELLE SINDROMI DA<br />
ASTINENZA ALCOLICA<br />
Cause più frequenti dell’astinenza alcolica:<br />
a) malattie intercorrenti, specialmente gastrite con vomito<br />
b) interventi medici, soprattutto il ricovero ospedaliero per una patologia<br />
non correlata<br />
c) mancanza di denaro per l’acquisto di alcolici<br />
d) un tentativo consapevole di sospendere l’uso di alcool<br />
Intervallo temporale: di solito nelle prime 24-72 ore, fino ad un massimo di 10 giorni<br />
2
Quadro clinico della sindrome d’astinenza alcolica e del delirium tremens<br />
(quest’ultimo ne rappresenta la varietà meno frequente, ma più grave e ad esordio<br />
tardivo) :<br />
Trattamento :<br />
1) Sintomi modesti o precoci<br />
a) disturbi gastrointestinali (anoressia, nausea, vomito, diarrea)<br />
b) disturbi del sonno (insonnia)<br />
c) alterazioni del sistema nervoso autonomo (tachicardia, ipertensione,<br />
sudorazione profusa, tremori, febbre)<br />
d) modifiche del comportamento (irritabilità, ostilità, agitazione)<br />
e) deficit cognitivi (facile distraibilità, scarsa concentrazione, deficit<br />
della memoria, difficoltà di giudizio)<br />
2) Sintomi gravi o tardivi<br />
a) peggioramento di tutte le manifestazioni precedenti<br />
b) alterazioni dello stato di coscienza (disorientamento spaziotemporale)<br />
c) allucinazioni (visive, “microzoopsie”, ma anche tattili ed uditive)<br />
d) deliri (di tipo persecutorio o professionale)<br />
e) crisi convulsive (tonico-cloniche generalizzate)<br />
Tenuto conto della gravità del quadro clinico con elevato rischio di mortalità (5-10 %<br />
dei casi) e del notevole impegno assistenziale richiesto, questa patologia è da ritenersi<br />
un’urgenza medica e come tale da trattarsi in ambito ospedaliero.<br />
a) FARMACOLOGICO<br />
1) reidratazione (sulla scorta della valutazione clinica e<br />
degli esami ematochimici): fleboclisi fisiologiche e<br />
glucosate, con frequente e attenta valutazione dello<br />
stato di idratazione del paziente e reintegrazione di<br />
eventuali squilibri elettrolitici<br />
2) polivitaminoterapia (soprattutto tiamina), in genere<br />
per via parenterale<br />
3) sedazione: benzodiazepine (BDZ) e.v.; ad esempio:<br />
Diazepam 20 mg in infusione 2-3 volte/die oppure<br />
3
) AMBIENTALE<br />
Lorazepam 2 mg 4 volte/die. L’uso di neurolettici è in<br />
genere sconsigliato per la loro azione ipotensiva e di<br />
abbassamento della soglia convulsivante; nel caso sia<br />
indispensabile aggiungerli alle BDZ per potenziare<br />
l’effetto sedativo e deliriolitico, utilizzare l’aloperidolo<br />
a dosaggio di 2-4 mg/die<br />
4) antibiotici<br />
5) antipiretici e/o ghiaccio<br />
6) si ritiene assolutamente controindicato l’uso di<br />
alcool a prevenzione di insorgenza del delirium<br />
tremens.<br />
E’ opportuno, se possibile, che il paziente possa essere ospitato in una stanza singola,<br />
ben illuminata, assistito e rassicurato, oltre che dal personale, anche dai propri<br />
famigliari.<br />
Nel caso in cui lo stato di confusione, agitazione, affaccendamento del paziente<br />
sia ingestibile in altro modo, non solo è consigliabile, ma è da ritenersi misura<br />
terapeutica indispensabile la contenzione fisica al letto. Tale provvedimento deve<br />
essere eseguito con la dovuta attenzione, ad evitare complicazioni come ulcere da<br />
decubito o compressioni/trazioni muscolari e nervose.<br />
4
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE INTEGRATE (A.S.S.I.)<br />
Settore Dipendenze -Servizio Alcoldipendenze<br />
<strong>Lecco</strong> - Via Tubi,43 Tel. 0341/482653 - Fax 0341/482403<br />
La prevenzione dell’astinenza alcolica, in particolare delle forme complicate (crisi convulsive,<br />
allucinazioni visive, uditive, tattili, olfattive fino al delirium tremens) si basa su :<br />
1) Corretta individuazione dei soggetti con problema di alcoldipendenza attuale,<br />
in assenza di astinenza alcolica<br />
2) Riconoscimento tempestivo dei sintomi/segni di astinenza alcolica quando<br />
presente<br />
A) Linee guida di prevenzione dell’astinenza<br />
3) Attuazione di adeguata terapia<br />
1) E’ anzitutto fondamentale, al momento del ricovero, individuare correttamente i<br />
soggetti a rischio di astinenza alcolica, vale a dire i soggetti con problemi di etilismo<br />
cronico, anche in assenza di quadro astinenziale, in base a:<br />
-anamnesi fisiologica: particolare attenzione all’introito alcolico riferito al presente ma anche al<br />
passato<br />
-anamnesi patologica: (elementi significativi: pregressi e ripetuti traumatismi e/o incidenti<br />
stradali, infortuni sul lavoro, disturbi della sfera psichica, compresi TS, e cognitiva, episodi<br />
compatibili con astinenza alcolica; presenza di patologie come cirrosi epatica, pancreatite acuta<br />
e cronica, neuropatia periferica, convulsività, riattivazione di TBC, cardiomiopatia dilatativa)<br />
-esame obiettivo (alitosi alcolica, acne rosacea, malnutrizione, obesità, tumefazione parotidea;<br />
segni/sintomi compatibili con cirrosi epatica, pancreatite acuta e cronica, neuropatia agli arti<br />
inferiori; segni di traumatismo recente)<br />
-motivo del ricovero: intossicazione alcolica acuta; tutte le cause di traumatismo, compresi gli<br />
incidenti stradali e gli infortuni sul lavoro,soprattutto qualora in PS non sia stata eseguita<br />
l’alcolemia; tutte le manifestazioni connesse con la presenza delle sottostanti patologie alcolcorrelate<br />
elencate sopra<br />
-esami ematochimici: particolare attenzione va prestata, oltre ai parametri epatici e, tra questi,<br />
a transaminasi e γGT, alla presenza di piastrinosi, di aumento del VGM, di ipercolesterolemia,<br />
ipertrigliceridemia, uricemia<br />
-esami strumentali: steatosi epatica all’ECO Add;atrofia cerebrale non compatibile con l’età alla<br />
TC encefalo<br />
L’individuazione dei soggetti alcoldipendenti da sottoporre a supporto<br />
antiastinenziale è fondamentale perché il momento dell’ospedalizzazione coincide<br />
spesso con un’astensione forzata dall’alcol, in particolare per quei pazienti che sono<br />
immobilizzati, allettati o impossibilitati ad un’alimentazione per os.<br />
5
2) E’ poi importante riconoscere tempestivamente i sintomi/segni dell’astinenza<br />
alcolica, ricordando che essi possono essere già presenti al momento del ricovero<br />
oppure manifestarsi anche dopo qualche ora. Se non si instaura adeguata terapia in<br />
presenza dei primi sintomi, il quadro può evolvere in una forma di astinenza complicata<br />
anche dopo giorni.<br />
Segni e sintomi astinenziali<br />
Stadio I: inizia dopo 6-12 ore dall’ultima ingestione di alcol<br />
Lieve agitazione /Ansia/ Irrequietezza/ Insonnia<br />
Inappetenza/Nausea/Vomito<br />
Tremori/Sudorazione/Ipertensione/Tachicardia<br />
Stadio II: inizia dopo 24 ore dall’ultima ingestione di alcol<br />
Sintomi/segni dello stadio I più<br />
Allucinazioni visive-tattili-olfattive-uditive<br />
Stadio III: inizia dopo 6-48 ore dalla sospensione di alcol<br />
Sintomi/segni degli stadi precedenti più<br />
Convulsioni (40% singole, 3% stato epilettico)<br />
Stadio IV: Delirium tremens: inizia da 2-3 giorni fino a 10 giorni dalla<br />
sospensione del potus (emergenza medica, con una mortalità del 10-20%)<br />
Sintomi /segni degli stadi precedenti più<br />
Profonda confusione<br />
Disorientamento<br />
3) E’ necessario infine instaurare una corretta terapia sia in<br />
soggetto riconosciuto alcoldipendente asintomatico che in<br />
soggetto già sintomatico<br />
Diazepam 20 gocce x 3-4 volte al giorno + lorazepam cp 1 mg 1 cp la sera prima di addormentarsi, a scalare<br />
dopo i primi 3-4 giorni , per almeno 7 giorni<br />
oppure<br />
GHB (Alcover sciroppo) 5-10 ml x 5 volte al giorno + clonazepam 0.5 mg 1 cp mattino e sera (non è<br />
necessario scalare la dose del GHB prima della dimissione, ma il farmaco va continuato; per l’uso di questo<br />
farmaco, utile soprattutto in presenza di notevole desiderio di introdurre alcolici, contattare il Servizio<br />
Alcologia)<br />
oppure<br />
(in sogetti con segni/sintomi più gravi o impossibilitati all’assunzione di terapia per os) Diazepam 1 fl 10 mg<br />
x ev in 250 cc sol. fis. X 3 volte al giorno + lorazepam 1 mg 1 cp a.b. passando dopo 3-4 giorni alla<br />
somministrazione per os come sopra.<br />
In ogni caso si consiglia di adattare la terapia con BDZP in base ai sintomi (ridurre se troppa sedazione,<br />
aumentare se controllo non ottimale dei sintomi/segni)<br />
In aggiunta, sempre:<br />
-supplementare con tiamina (vit. B1) 1 fl i.m. per 6 giorni + vitamine coB e ac.folico per os<br />
-controllare il bilancio elettrolitico e la glicemia; assicurare una buona idratazione (consigliare dove possibile<br />
l’assunzione di succhi di frutta)<br />
-segnalare i pazienti al Servizio Alcologia per una presa in carico dopo la dimissione (0341-482653/655)<br />
6
II PARTE<br />
Cap. 7<br />
PROTOCOLLO D’INTESA TRA DSM E UONPIA<br />
PASSAGGI IN CURA E CONDIVISIONE<br />
Allo scopo di garantire la continuità delle cure dei soggetti interessati e delle loro famiglie viene istituito<br />
tra le due Unità Operative un GRUPPO STABILE DI COLLEGAMENTO (GSC), in accordo<br />
con quanto indicato dal Piano Regionale per la Salute Mentale, deliberato recentemente dalla<br />
Regione Lombardia (DGR 17/05/2004, n° 7/17513).<br />
Periodicità<br />
Il GSC si riunirà, di norma, ogni tre mesi, secondo calendario e sedi da stabilirsi tra le rispettive équipes<br />
CPS – Polo Territoriale NPI delle aree di <strong>Lecco</strong> e di Merate. Rimane la possibilità per ciascuna<br />
delle parti di convocare riunioni straordinarie per situazioni particolari (sono escluse le urgenze<br />
cliniche, per le quali ci si riferirà al protocollo relativo).<br />
Composizione<br />
Il GSC sarà composto da:<br />
• I Medici NPI coinvolti nei singoli casi da presentare;<br />
• uno Psicologo referente per ogni Servizio;<br />
• un Assistente Sociale per ogni Servizio (dove presente);<br />
• un Educatore Prof. per ogni Servizio;<br />
• un Medico Psichiatra referente per il GSC, individuato dal CPS competente per area;<br />
• eventuali figure professionali coinvolte, o da coinvolgere, nei singoli casi saranno invitate ad<br />
hoc (per es.: Assistenti Sociali dei Comuni, Infermieri Prof., Educatori di altri Servizi, Volontari<br />
o rappresentanti del Privato Sociale);<br />
• rappresentanti designati dal Dipartimento ASSI (accordi in corso);<br />
• Operatori dei SerD, qualora i casi presentino comorbidità con disturbi da abuso di sostanze (accordi<br />
ancora da stabilire).<br />
Campione di soggetti interessati<br />
Il GSC sarà coinvolto per soggetti nella fascia di età tra i 17 e i 18 anni, con diagnosi appartenenti<br />
agli spettri delle psicosi e dei disturbi gravi di personalità (categorie F2 ed F6 dell’ICD X).<br />
Al GSC verranno discussi tutti i nuovi casi che presentino le caratteristiche descritte e, per il periodo<br />
di avvio, quelle situazioni già conosciute dalla UONPIA per le quali si prevede una necessità di<br />
cura a lungo termine, ben oltre il mero compimento della maggiore età.<br />
Per Pz appartenenti ad altre categorie diagnostiche, per i quali si ritenesse opportuno un passaggio<br />
in cura al Servizio per adulti, verranno presi accordi diretti tra i Medici interessati, prevedendo un<br />
adeguato passaggio delle informazioni sia tra i clinici, che coinvolgendo il soggetto e i suoi familiari.<br />
Obbiettivi<br />
Il GSC ha lo scopo di promuovere la condivisione e il confronto delle linee d’intervento sulle patologie<br />
psichiatriche, che si manifestano nell’adolescenza, partendo dall’analisi dei bisogni di cura e<br />
assistenza dei singoli casi, senza escludere un eventuale livello più generale/teorico.
Dal punto di vista operativo, il GSC dovrà individuare dei percorsi personalizzati di cura, che prevedano<br />
diversi livelli d’intervento:<br />
• clinico individuale (in armonia con PDT condivisi da formulare nel prossimo periodo);<br />
• sostegno alle famiglie;<br />
• individuazione di eventuali disturbi psichiatrici a carico dei familiari adulti del Pz, per elaborare<br />
le opportune strategie d’invio e intervento da parte del CPS;<br />
• formulazione di progetti psico-educativi sul territorio, avvalendosi anche delle risorse non istituzionali<br />
disponibili.<br />
Le modalità di collaborazione descritte nel presente protocollo saranno soggette a verifica, ed eventuale<br />
modificazione, dopo circa un anno di attività, nel corso di una riunione congiunta tra i GSC<br />
delle due aree di <strong>Lecco</strong> e Merate.
II PARTE<br />
Cap. 8<br />
PROTOCOLLO OPERATIVO INERENTE LE URGENZE PSICHIATRICHE<br />
IN ADOLESCENZA<br />
Nell’ambito della salute mentale, Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile rappresentano due discipline con<br />
proprie specificità clinico- operative che presentano aree di competenza contigue. Tali aree richiedono forme<br />
organizzative di collegamento progettate non solo in funzione dell’età degli utenti, ma piuttosto della<br />
tipologia dei problemi presentati, della loro prevedibile evoluzione, con l’obbiettivo di rispondere alle<br />
richieste e alle aspettative degli utenti e dei loro familiari.<br />
L’Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (UONPIA) e l’Unità Operativa di<br />
Psichiatria (UOP) concordano l‘applicazione del seguente protocollo operativo, finalizzato alla necessità di<br />
definire le modalità di gestione dell’ accesso in Pronto Soccorso di un adolescente con disturbi<br />
comportamentali gravi e acuti tali da richiedere, se del caso, il ricovero ospedaliero.<br />
1.COMPETENZE E RESPONSABILITA’ CLINICHE<br />
L’adolescente viene visitato, su richiesta di consulenza del Medico di Pronto Soccorso, da parte del<br />
Neuropsichiatria Infantile, nei giorni e nell’orario di apertura della UONPIA o dallo Psichiatra di<br />
guardia o reperibile, nei rimanenti giorni e orari: in entrambi i casi, se dalla valutazione clinica<br />
scaturisce la necessità del ricovero ospedaliero, sede e modalità saranno decise congiuntamente dal<br />
Medico di Pronto Soccorso e dallo Specialista Chiamato in consulenza secondo i criteri di cui al<br />
successivo punto 2.<br />
2. STRUTTURE DI RICOVERO<br />
2.1 Nel caso di soggetti di età inferiore a 17 anni, ove vi sia l’indicazione di ricovero, l’adolescente<br />
viene inviato presso uno dei Servizi ospedalieri di Neuropsichiatria Infantile della Regione<br />
Lombardia, dotati di posti letto (Monza, Pavia, Brescia), o viene previsto il ricovero nell’U.O. di<br />
Pediatria del Presidio ove ha avuto luogo l’accesso al Pronto Soccorso, subordinatamente a una<br />
valutazione con il Pediatra in merito ai requisiti di età, tipologia del disturbo comportamentale<br />
presente e struttura del Reparto pediatrico interessato.<br />
2.2 Gli utenti di età compresa tra 17 e 18 anni che si giungono in Pronto Soccorso con gravi e acuti<br />
disturbi comportamentali sono assistiti secondo la procedura seguente.<br />
2.2.1 In presenza di necessità di un ricovero, il Neuropsichiatria Infantile o, in sua assenza, lo Psichiatra<br />
verifica, congiuntamente al Medico di Pronto Soccorso, la possibilità di ricovero in un Reparto di<br />
Neuropsichiatria Infantile della Lombardia, dotato di posti letto, ove si trasferisce il soggetto,<br />
2.2.2 In mancanza di tale possibilità, si verifica la compatibilità con una degenza nel reparto di Pediatria di<br />
Presidio con i medesimi criteri di cui al punto 2.1.<br />
2.2.3 Nel caso il ricovero non sia compatibile con l’ambiente pediatrico, il Neuropsichiatra Infantile<br />
propone il ricovero in SPDC: tale ricovero viene convalidato dallo Psichiatra che lo dispone, di<br />
preferenza, nell’ambito delle degenze della Unità operativa di Psichiatria dell’Azienda o, se non
possibile, in altri SPDC. In assenza del Neuropsichiatra Infantile, lo Psichiatra dispone direttamente<br />
il ricovero.<br />
2.2.4 L’eventuale trasferimento ad altro Presidio o altra Azienda ospedaliera sarà effettuata con le<br />
consuete modalità previste per i trasferimenti inter-presdio e con il consenso e la presenza dei<br />
genitori durante il trasporto.<br />
3. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE<br />
3.1 In caso di ricovero in SPDC lo Psichiatra provvede a richiedere la consulenza \ visita a parere, con<br />
valenza anche di informativa al Direttore UONPIA di quanto avvenuto, del Neuropsichiatra Infantile<br />
che la effettua, nell’ambito dei giorni e dell’orario di apertura del Servizio, non appena ricevuta la<br />
segnalazione.<br />
Lo Psichiatra provvede alla stesura del piano di trattamento comprensivo del coinvolgimento<br />
consulenziale del Neuropsichiatra Infantile.<br />
4.GESTIONE DELL’ADOLESCENTE IN FASE DI POST-DIMISSIONE<br />
Nelle fasi successive alla dimissione il collegamento tra UOP e UONPIA garantisce,<br />
indipendentemente dall’età dell’adolescente, la coerenza e la continuità del progetto di cura e si<br />
avvale, a tal fine, delle procedure previste dal Protocollo d’intesa aziendale ‘Passaggio in cura e<br />
condivisione’ relativo all’adolescenza, con la permanenza in capo alla UONPIA della titolarità<br />
formale ivi comprese le responsabilità di tipo assistenziale fino al compimento del diciottesimo<br />
anno.<br />
5.VALIDITÀ DEL PROTOCOLLO<br />
Il presente protocollo entra in vigore a far tempo dal giorno ………….., con verifiche<br />
semestrali circa la necessità di apportare, di comune accordo, modifiche al testo.
II PARTE<br />
Cap.9<br />
PROTOCOLLO D’INTESA TRA DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI LECCO E<br />
1 PREMESSA<br />
CONSOLIDA CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.C.R.L.<br />
L’esperienza maturata nel corso degli anni dal Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> e dalle<br />
Cooperative Sociali aderenti al Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l. in tema di<br />
integrazione e sostegno sociale in favore delle persone in situazione di disagio psichico e gli<br />
obiettivi comuni volti a sostenere e tutelare la centralità della persona e dei suoi diritti nei processi<br />
istituzionali e sociali che concorrono alla realizzazione di ciascun individuo, ha fatto emergere la<br />
necessità di un’integrazione tra i diversi sistemi di valori e le prassi delle realtà sopra citate.<br />
Entrambe riconoscono infatti che per rispondere efficacemente alla complessità dei fattori che<br />
compongono la problematica del disagio psichico, occorre ricercare un costante confronto teso a<br />
valorizzare le risorse (umane, professionali, organizzative, finanziarie) presenti, riconoscendone<br />
talvolta i limiti, e a promuovere inoltre il coinvolgimento degli attori istituzionali e non della rete<br />
<strong>territoriale</strong> di riferimento.<br />
Per questa ragione dunque il Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> e le Cooperative Sociali<br />
aderenti al Consorzio Consolida riconoscono la necessità di attivare una collaborazione che a partire<br />
dai rispettivi ruoli e competenze si faccia carico della persona in situazione di disagio psichico e dei<br />
suoi diritti, finalizzando gli interventi alla cura, alla riabilitazione, al sostegno, all’evoluzione o al<br />
mantenimento di una condizione personale che è unica ed umana.<br />
Parlare di centralità della persona e dei suoi diritti quali valori posti a fondamento della<br />
realizzazione di obiettivi di integrazione e sostegno sociale, significa in particolare, considerare che<br />
esiste un potenziale in ogni essere umano e che ai fini del suo sviluppo, è fondamentale che l’agire<br />
professionale delle singole realtà territoriali coinvolte e firmatarie del seguente protocollo, si<br />
informi ai seguenti principi:<br />
l’assunzione del rischio della libertà.<br />
L’equilibrio nel trattamento della malattia mentale va cercato (e stimolato) al livello più alto<br />
delle possibilità della persona e del suo campo esistenziale.<br />
la follia è una condizione e come tale, ha una sua autonomia.<br />
La follia è parte integrante dell’essere umano e insieme alla ragione costituisce un binomio<br />
indissolubile.<br />
il lavoro è un mezzo e non un fine<br />
Il lavoro è una necessità che non si esaurisce in se stessa. Ad esso va applicato un corpus di<br />
intenzioni tecniche e formative perché possa realmente costituire un tramite all’essere nel<br />
mondo e al problema dell’integrazione socio-lavorativa.<br />
la centralità della comunità<br />
La comunità è idealmente il punto di partenza e di arrivo di qualsiasi azione di integrazione e<br />
sostegno sociale in favore delle persone con problematiche psichiatriche. È importante allora<br />
Protocollo d’Intesa tra Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> e Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l. 1
coinvolgere in modo coordinato nei progetti riabilitativi i gruppi sociali, le organizzazioni e gli<br />
enti che lavorano e sono coinvolti nella cura del disagio psichico.<br />
la famiglia come luogo di ricostruzione delle relazioni affettive<br />
La famiglia va riconosciuta e sostenuta come luogo di ricostruzione delle relazioni affettive<br />
aiutandola ad uscire dalla solitudine in cui si trova.<br />
l’approccio al sapere e allo scambio dei saperi<br />
Il sapere è un valore di scambio irrinunciabile per la crescita delle culture operative<br />
professionali di riferimento e per la garanzia di interventi efficaci.<br />
l’approccio al fare<br />
Le specificità e le complessità delle situazioni e dei bisogni delle persone in situazione di<br />
disagio psichico necessitano la promozione di sperimentazioni e di prassi innovative. In<br />
quest’ottica la forma d’impresa chiamata cooperativa sociale (forma societaria privatistica con<br />
finalità pubblica) può rappresentare un importante strumento per superare i classici modelli di<br />
erogazione di prestazione e gestione di servizi attivando processi di sussidiarietà e di<br />
responsabilità verso la gestione delle risorse.<br />
2 FINALITÀ<br />
Promuovere il benessere del cittadino in situazione di disagio psichico<br />
3 OBIETTIVI GENERALI<br />
a. Promuovere un approccio condiviso alle problematiche e ai bisogni delle persone in<br />
situazione di disagio psichico;<br />
b. Promuovere lo sviluppo di buone prassi ed interventi volti a sostenere processi di<br />
integrazione e sostegno sociale in favore delle persone in situazione di disagio psichico,<br />
privilegiando il coinvolgimento attivo dei diversi attori e servizi (pubblici e privati, sanitari e<br />
sociali, forme della cittadinanza attiva ecc.) che sul territorio operano a tutela della salute<br />
mentale, valorizzando le diverse risorse (umane e materiali) a disposizione nonché le<br />
esperienze della rete interconsortile di riferimento.<br />
4 OBIETTIVI SPECIFICI<br />
a. Sostenere scambi di esperienze, di professionalità e di saperi tra i firmatari del Protocollo<br />
d’Intesa;<br />
b. Favorire la condivisione dei bisogni afferenti l’area del disagio psichico;<br />
c. Favorire l’incontro, il confronto e il raccordo con altre realtà territoriali ed extraterritoriali<br />
che operano a tutela della salute mentale;<br />
c. Sostenere la crescita del livello di competenze e professionalità dei diversi operatori<br />
coinvolti per dare maggior certezza alle risposte;<br />
d. Definire nel tempo modelli operativi relativamente a:<br />
• l’approccio e il sostegno alle famiglie;<br />
• l’inserimento lavorativo;<br />
• il raccordo con i gruppi di auto-mutuo-aiuto;<br />
• i luoghi e le forme di accoglienza.<br />
e. Sviluppare progetti integrati tra il Dipartimento di Salute Mentale e le Cooperative Sociali<br />
del Consorzio Consolida anche con riferimento alle persone che hanno interrotto o a cui non<br />
sono proponibili percorsi di Inserimento Lavorativo.<br />
Protocollo d’Intesa tra Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> e Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l. 2
5 LE RISORSE<br />
Il Dipartimento di Salute Mentale e il Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l.<br />
nell’ambito delle relative competenze reperiranno le risorse per il conseguimento degli obiettivi<br />
previsti, presentando all’occorrenza, progetti comuni da finanziarsi con leggi o contributi locali.<br />
<strong>Lecco</strong>,Visto, si approva:<br />
Il Presidente Il Direttore<br />
Consorzio Consolida Dipartimento Salute Mentale<br />
Allegati:<br />
1. Procedura per la gestione dei percorsi di Tirocinio Lavorativo;<br />
2. Definizioni;<br />
3. Scheda di valutazione delle capacità lavorative;<br />
4. Progetto di Tirocinio e Rinnovo del Tirocinio;<br />
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI TIROCINIO LAVORATIVO<br />
Prima fase: Avvio<br />
La segnalazione del tirocinante<br />
L’Assistente Sociale del Centro Psico Sociale competente territorialmente (in base alla residenza<br />
della persona) si accorda con il Responsabile dell’Area Sociale della cooperativa prescelta, dopo<br />
aver precedentemente riscontrato la generica disponibilità della stessa ad accogliere lo specifico<br />
percorso di Tirocinio (cfr. all. n. 02) ipotizzato, per l’effettuazione di un incontro di presentazione<br />
del candidato.<br />
La segnalazione, accompagnata da un relazione sanitaria e sociale scritta che viene consegnata al<br />
Responsabile dell’Area Sociale della cooperativa coinvolta, avviene di norma presso il Centro Psico<br />
Sociale alla presenza delle seguenti figure professionali:<br />
a. l’Assistente Sociale del C.P.S. e l’Educatore incaricato a seguire il tirocinio;<br />
b. il Responsabile dell’Area Sociale della cooperativa interessata.<br />
La segnalazione che deve essere la più chiara possibile e dare punti di riferimento per orientare le<br />
valutazioni della cooperativa, deve comprendere almeno le seguenti indicazioni:<br />
a. i dati di anamnesi;<br />
b. la storia istituzionale della persona e i suoi rapporti con i diversi servizi;<br />
c. il contesto familiare e sociale;<br />
d. il percorso formativo e lavorativo eventualmente effettuato;<br />
e. il carico degli effetti collaterali da farmaci;<br />
f. le risorse presenti nella persona;<br />
g. i motivi che inducono a richiedere l’inserimento della persona in cooperativa e a che punto<br />
del suo percorso riabilitativo si colloca la richiesta;<br />
Protocollo d’Intesa tra Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> e Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l. 3
h. che tipo di valenza si pensa debba essere inizialmente assegnata al tirocinio (Borsa Lavoro o<br />
Tirocinio Terapeutico) (cfr. all. n. 02);<br />
i. le aree deficitarie (es. difficoltà nelle relazioni interpersonali, tenuta dei tempi, rispetto dei<br />
compiti assegnati, ecc.), su cui maggiormente lavorare in termini di obiettivi da porsi.<br />
I colloqui con il candidato<br />
Successivamente all’incontro descritto al punto 1.1 precedente e sulla scorta delle informazioni<br />
raccolte, la cooperativa valuta internamente la fattibilità del percorso.<br />
In caso di esito positivo, il Responsabile dell’Area Sociale della cooperativa contatta l’Assistente<br />
Sociale di riferimento del C.P.S. per concordare un primo incontro con il candidato.<br />
Durante questo colloquio viene approfondita la conoscenza reciproca e verificata la motivazione<br />
della persona (per come si esprime e si fonda) ad affrontare il percorso. Nell’incontro vengono di<br />
fatto introdotti e condivisi gli elementi distintivi che comporranno il progetto iniziale di riferimento:<br />
gli obiettivi, il patto di solidarietà e di scambio che si instaura tra la persona, la cooperativa, i servizi<br />
e le figure professionali coinvolte, le soluzioni organizzative, operative, gestionali ed economiche.<br />
Al termine del colloquio la cooperativa procede ad una valutazione complessiva e definitiva sulla<br />
persona e sulla sua possibilità di essere accolta in tirocinio.<br />
Qualora la valutazione avesse un esito positivo, il Responsabile dell’Area Sociale della cooperativa<br />
concorda con l’Assistente Sociale del C.P.S. un ulteriore incontro con il candidato per presentarlo al<br />
Tutor interno della cooperativa che fungerà da figura educativa di riferimento per il periodo di<br />
durata dell’intervento e per approfondire ulteriormente la conoscenza reciproca, consolidando così<br />
il rapporto avviato, ed infine siglare il progetto iniziale.<br />
Il progetto di tirocinio<br />
Il documento di progetto (all. n. 4), redatto dal C.P.S., verrà sottoscritto da tutte le parti coinvolte e<br />
conterrà almeno le seguenti informazioni:<br />
a. gli obiettivi dell’inserimento in cooperativa;<br />
b. i tempi di effettuazione del tirocinio;<br />
c. le modalità di sostegno ed accompagnamento;<br />
d. gli impegni assunti dalle diverse realtà pubbliche e private coinvolte e le reciproche<br />
modalità di comunicazione;<br />
e. le modalità e i tempi di monitoraggio e valutazione nonché le professionalità coinvolte.<br />
Seconda fase: Realizzazione<br />
Generalità<br />
In questa fase (che ha una durata massima di quatto anni) (cfr. all. n. 02), gli operatori delle realtà<br />
coinvolte si adoperano affinché gli obiettivi e gli impegni assunti alla firma del progetto siano<br />
raggiunti favorendo in tal senso il graduale progresso del percorso (da Tirocinio Terapeutico a borsa<br />
lavoro e da borsa lavoro ad assunzione).<br />
Protocollo d’Intesa tra Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> e Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l. 4
Il primo giorno<br />
Il primo giorno il tirocinante è accompagnato sul luogo di lavoro dall’educatore di riferimento del<br />
CPS, che funge da mediatore rispetto all’impatto con il nuovo ambiente e facilita l’avvio della<br />
relazione con i responsabili, il tutor assegnato e i colleghi di lavoro. Se necessario viene concordato<br />
un affiancamento quotidiano per i primi giorni.<br />
L’osservazione<br />
Il primo periodo di tirocinio (I° mese) è definito di osservazione.<br />
In questo lasso di tempo viene verificata la possibilità che l’inserimento possa realizzarsi alle<br />
condizioni previste attraverso un’attività di osservazione diretta e di raccolta dati da parte degli<br />
operatori e dei responsabili coinvolti nella gestione del caso.<br />
Al termine del primo mese di attività viene concordata una riunione di verifica cui sono presenti le<br />
seguenti figure professionali:<br />
per la cooperativa: il Responsabile dell’Area Sociale;<br />
per il CPS: il Medico, lo Psicologo, l’Educatore, e l’Assistente Sociale;<br />
le altre figure coinvolte nella fase di progettazione.<br />
In tale ambito avviene lo scambio e l’integrazione delle informazioni relative all’andamento del<br />
tirocinio e alla situazione complessiva del tirocinante.<br />
A questo incontro ne segue un altro con la persona interessata per socializzare i risultati della<br />
valutazione e conoscere le sue reazioni dopo il periodo iniziale. Vi partecipano:<br />
per il CPS: l’Educatore e l’assistente Sociale<br />
per la cooperativa: il Tutor e il Responsabile dell’Area Sociale;<br />
altre figure coinvolte nella fase di progettazione (eventualmente).<br />
Se non insorgono particolari urgenze, che necessitino ulteriori incontri, modifiche sostanziali al<br />
progetto iniziale e di conseguenza l’individuazione di nuove “regole del gioco” da pattuire con il<br />
tirocinante, vengono riconvocati gli incontri sopra descritti secondo le scadenze previste dal<br />
progetto.<br />
Dopo il periodo di osservazione l’educatore del C.P.S. mantiene i rapporti tra cooperativa e C.P.S.<br />
garantendo un monitoraggio almeno settimanale.<br />
I dati quantitativi e qualitativi relativi al periodo di osservazione in cooperativa sono raccolti nel<br />
documento Scheda di Valutazione delle Capacità Lavorative (All. n. 3) e riguardano:<br />
i tempi di lavoro;<br />
la qualità del lavoro;<br />
la motivazione al lavoro;<br />
le mansioni;<br />
il comportamento rispetto al lavoro;<br />
il comportamento con i colleghi;<br />
gli aspetti problematici soggettivi del tirocinante che interferiscono sulle modalità di<br />
presenza in cooperativa e sulla sua capacità lavorativa, su cui, in modo coordinato, operatori<br />
dell’U.O.P. e della cooperativa possono agire.<br />
Protocollo d’Intesa tra Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> e Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l. 5
La prosecuzione e realizzazione del tirocinio<br />
LE VERIFICHE INTERMEDIE<br />
Al termine del periodo di osservazione la cadenza delle verifiche intermedie da attuarsi nelle<br />
modalità descritte al precedente paragrafo è definita all’interno dei documenti di Progetto.<br />
Particolare attenzione viene posta durante le verifiche all’integrazione delle informazioni rispetto<br />
alla situazione familiare e sociale del tirocinante che, direttamente o indirettamente, possono<br />
influenzare le sue condizioni e il suo percorso di integrazione lavorativa.<br />
Tali verifiche hanno inoltre l’obiettivo di accertare se esistono le condizioni per l’evolversi e il<br />
progredire del Tirocinio (da Terapeutico a borsa-lavoro e da borsa-lavoro ad assunzione regolare).<br />
MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROBLEMI E RAPPORTI TRA COOPERATIVE E U.O.P.<br />
a. Qualora insorgessero dei problemi specifici relativi all’ambito lavorativo (ad esempio<br />
difficoltà del tirocinante rispetto all’attività che svolge o nei confronti di operatori e<br />
colleghi), che non possono essere risolti all’interno degli ambiti di verifica già previsti e<br />
dell’ordinario svolgimento delle attività di accompagnamento e monitoraggio, il<br />
Responsabile dell’Area Sociale della cooperativa può in ogni momento segnalare tali<br />
problemi all’Educatore o all’Assistente Sociale del CPS definendo con questi un incontro di<br />
confronto (allargato ad altri servizi e/o figure professionali se del caso) e successivamente<br />
delle opportune modalità d’intervento.<br />
b. Qualora si evidenzino problemi di ordine sanitario, legati alla sintomatologia psichiatrica o<br />
all’assunzione di farmaci, lo psichiatra si rende telefonicamente disponibile a fornire al<br />
Responsabile dell’Area Sociale o al Tutor della cooperativa le indicazioni ritenute<br />
necessarie. Se viene valutata opportuna, si fissa una visita con il tirocinante, in aggiunta a<br />
quelle già programmate, o un incontro con gli operatori e i responsabili della cooperativa.<br />
Se il medico del tirocinante non è in servizio, il problema viene affrontato dal collega<br />
presente al C.P.S. Se il servizio è chiuso è possibile riferirsi al medico di guardia o al<br />
reperibile, tramite accesso al Pronto Soccorso.<br />
Terza fase: la conclusione<br />
Il Tirocinio presso la Cooperativa può concludersi per tre principali ordini di motivi:<br />
1. Si ritengono raggiunti gli obiettivi del tirocinio e ci sono sia favorevoli condizioni soggettive<br />
del tirocinante sia la disponibilità di una risorsa, perché lo stesso possa proseguire il<br />
percorso lavorativo con il passaggio in un’azienda;<br />
2. Dalle verifiche effettuate il soggetto non risulta motivato e in grado, per svariati motivi, di<br />
procedere nell’impegno lavorativo (in quel dato momento e non in assoluto);<br />
Protocollo d’Intesa tra Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> e Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l. 6
3. C’è necessità che, raggiunti determinati obiettivi, il soggetto si sperimenti in un’assunzione<br />
regolare presso la stessa cooperativa, in attesa o in vista di un passaggio successivo ad<br />
un’azienda.<br />
Se il tirocinante rimane presso la cooperativa con un’assunzione, tra operatori del C.P.S. e della<br />
cooperativa viene mantenuto lo stesso tipo di relazioni descritto per il Tirocinio.<br />
Al Servizio per l’Impiego provinciale (Collocamento Mirato dei Disabili<br />
e delle Fasce Deboli) compete l’individuazione e il rapporto istituzionale<br />
con l’azienda. All’interno della collaborazione avviata con tale Servizio è<br />
previsto che, per le situazioni in carico al CPS in modo integrato, sia<br />
l’educatore di riferimento - dell’U.O.P. o dell’A.S.L. che lavora presso<br />
l’U.O.P. -, che ha monitorato il tirocinio, a proseguire<br />
l’accompagnamento della persona anche nella fase<br />
Protocollo d’Intesa tra Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong> e Consolida Consorzio Cooperative Sociali s.c.r.l. 7
II PARTE<br />
Cap. 10<br />
PROGRAMMA DI AZIONI INNOVATIVE PER LA SALUTE MENTALE<br />
Titolo del programma:<br />
UNA RETE PER IL LAVORO<br />
Istituzione proponente:<br />
Azienda Ospedaliera “Ospedale di <strong>Lecco</strong>”<br />
Riferimenti del bando<br />
Scheda sintetica di programma<br />
Area Tematica Obiettivo<br />
intervento strategica<br />
Area di intervento TR xxxxxxxxxx xxxxxxxx<br />
Tematica strategica principale TR TR4 xxxxxxxx<br />
Obiettivo principale TR TR4 TR4-2<br />
Altri obiettivi TR TR4 TR4-3<br />
Altri obiettivi TR TR1 TR1-2<br />
Responsabile Amministrativo del programma<br />
Nome e Cognome Paola Goretti<br />
Qualifica Dirigente Struttura Qualità, Accreditamento e Controllo Strategico<br />
Istituzione Azienda Ospedaliera “Ospedale di <strong>Lecco</strong>”<br />
Coordinatore scientifico del programma<br />
Nome e cognome Barbara Pinciara<br />
Qualifica Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong><br />
Istituzione Azienda Ospedaliera “Ospedale di <strong>Lecco</strong>”<br />
Curriculum<br />
professionale<br />
breve<br />
Laurea Medicina e Chirurgia presso l'Università Statale di Milano;<br />
Specializzazione Psichiatria con tesi sui “Rapporti tra il paziente<br />
psicotico, la madre ed il terapeuta”; Analisi personale con membro<br />
associato della Società Italiana di Psicoanalisi; Formazione Manageriale<br />
in Psichiatria; Formazione Manageriale Dirigenti Struttura Complessa;<br />
Relatrice convegni; Docente corsi aggiornamento; Supervisore èquipes;<br />
A partire dal 12/12/’95 e a tutt’oggi Direttore dell’Unità Operativa di<br />
Psichiatria, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda<br />
Ospedaliera di <strong>Lecco</strong>. Seminari e convegni su vari argomenti tra cui: "La<br />
1
Unità funzionali che partecipano al programma:<br />
devianza dell'adolescenza" e "Psicoterapia degli stati psicotici".<br />
Consorzio CONSOLIDA Sig. Fulvio Sanvito e<br />
Sig. Paolo Dell’Oro<br />
Dip. ASSI <strong>ASL</strong> <strong>Lecco</strong> Dr. Agostoni e<br />
Dr.ssa Marilanda Failla<br />
Servizio per l’Impiego Provincia di <strong>Lecco</strong> Dr. Virginio Brivio<br />
Dr. Marino Bottà<br />
Centro Servizi Formativi Comune di <strong>Lecco</strong> Sig. Ruggero Plebani<br />
Uffici di Piano Distretti socio-ass.li Coordinatori uffici di piano<br />
Dr. Flavio Polano<br />
Dr. Aurelio Mosca<br />
Sig.ra Alessandra Bianchi<br />
A.S.V.A.P. 7 di <strong>Lecco</strong> e prov Sig.ra Colombo Nadia<br />
Sono stati presi contatti con le Unità Funzionali, che verranno perfezionati a seguito<br />
dell’approvazione del progetto.<br />
Razionale del programma<br />
Si intende sviluppare un modello organizzativo per tutto il territorio della Provincia di <strong>Lecco</strong> che<br />
permetta di strutturare percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo a favore di soggetti con<br />
disturbi psichici, utenti dei servizi psichiatrici territoriali, attraverso la creazione di una équipe<br />
funzionale del DSM e una rete tra le istituzioni territoriali e il privato sociale.<br />
Inoltre, si intende offrire la possibilità di sperimentare le proprie capacità lavorative anche a pazienti<br />
con disturbo psichiatrico grave, attraverso la realizzazione di tirocini terapeutici guidati presso<br />
cooperative sociali di inserimento lavorativo del territorio. Si vuole offrire tale opportunità<br />
soprattutto ad utenti delle strutture residenziali e semiresidenziali che non possono accedere alle<br />
normali risorse messe a disposizione dal Servizio per l’Impiego senza un preliminare percorso<br />
guidato e strettamente integrato con i programmi riabilitativi messi in atto dai servizi psichiatrici.<br />
Si intende condurre progressivamente il soggetto grave alla dimissione dalle strutture residenziali o<br />
a una condizione di maggiore autonomia (passaggi da alta a media a bassa protezione) utilizzando<br />
percorsi territoriali integrati, fondati sulla riappropriazione di casa – lavoro – tempo libero,<br />
lavorando in sinergia con le forze istituzionali, del privato sociale e del volontariato.<br />
Obiettivi principali<br />
1. Definizione, all’interno dell’organismo di coordinamento per la salute mentale a livello di <strong>ASL</strong>,<br />
delle modalità di raccordo ed integrazione con il livello provinciale (Servizio per l’Impiego), i<br />
comuni, l’<strong>ASL</strong> e gli Uffici di Piano distrettuali, attraverso la stipula di Intese di programma e<br />
specifici protocolli relativi all’inserimento lavorativo di pazienti con disturbo psichico;<br />
2
2. Costituzione di un’équipe funzionale a carattere multidisciplinare, interna al DSM e<br />
composta dalle seguenti figure professionali: educatore, assistente sociale, psichiatra, psicologo,<br />
che si occupi in modo specifico della riabilitazione lavorativa dei pazienti psichiatrici. Tale<br />
équipe garantirà l’analisi e la valutazione della persona candidata all’inserimento lavorativo con<br />
strumenti ad hoc, il sostegno relazionale alla persona, la facilitazione di rete (CPS-tirocinioazienda),<br />
il monitoraggio nei luoghi dell’inserimento e la valutazione degli ambienti lavorativi;<br />
3. Ampliamento dell’offerta di luoghi di tirocinio nelle cooperative sociali del territorio,<br />
attraverso il meccanismo della riserva di posti, affinché sia possibile osservare e valutare in un<br />
contesto lavorativo le abilità residue di pazienti con disturbo psichiatrico grave ed avviare<br />
percorsi graduali di inserimento e reinserimento lavorativo;<br />
4. Avvio dell’attività di manutenzione del verde e di una serra, sia c/o il CRT che in altre sedi, per<br />
l’inserimento socio-occupazionale di 4-5 pazienti, attraverso la partecipazione al “Progetto<br />
CESEA” promosso dal Comune di <strong>Lecco</strong>.<br />
5. Consolidamento dei rapporti di collaborazione e di integrazione progettuale con le associazioni<br />
di volontariato del territorio che si occupano di disagio psichico.<br />
Metodologie e modelli gestionali<br />
1. Costituzione all’interno dell’organismo di coordinamento per la salute mentale di un gruppo di<br />
lavoro interistituzionale (Provincia, AO, Comuni, privato sociale) permanente, che fornisca<br />
dati e valutazioni circa l’attuazione dei protocolli d’intesa stipulati e che verifichi nel tempo la<br />
validità delle metodologie adottate;<br />
2. Sviluppo di una metodologia condivisa tra tutti gli operatori del DSM che si occupano di<br />
inserimento lavorativo attraverso la costituzione di un coordinamento “AREA LAVORO” che<br />
integri l’attività dell’équipe funzionale con le altre attività di integrazione sociale messe in atto<br />
dal DSM e si ponga quale interfaccia con le istituzioni esterne e il privato sociale;<br />
3. Realizzazione di un modello gestionale innovativo, tramite accordo (Convenzione) tra AO e il<br />
Consorzio di cooperative sociali CONSOLIDA (con il quale il DSM ha già stipulato generale<br />
protocollo d’intesa), per creare, con il concorso di 4-5 cooperative per l’inserimento lavorativo<br />
(tipo B) disponibili, spazi per la realizzazione di tirocini terapeutici per 16-20 pz. gravi,<br />
prioritariamente pazienti ospiti di strutture residenziali (CRT e CP del DSM e accreditate) e<br />
semiresidenziali, per favorire il loro processo di reinserimento <strong>territoriale</strong> e di autonomizzazione.<br />
Si prevede il riconoscimento al Consorzio, tenuto alla gestione diretta dei tirocini e al<br />
coordinamento con il DSM e tra le cooperative, di una quota complessiva per l’attività di<br />
tutoring interna a ciascuna cooperativa, la borsa-lavoro per ciascun tirocinante e il<br />
riconoscimento di attività complementari e di supporto ai pazienti inseriti. Si prevede altresì la<br />
possibilità che il Consorzio stipuli accordi con altre agenzie (ditte artigiane, enti locali, piccole<br />
aziende) per l’inserimento in tirocinio di altri pazienti indicati dal DSM;<br />
4. Adesione all’accordo di programma, in via di ridefinizione, tra <strong>ASL</strong>, Provincia, AO, Comune<br />
di <strong>Lecco</strong> e Comuni aderenti “per la gestione degli interventi di natura formativo-educativa e<br />
socio-occupazionale rivolti alle fasce socialmente deboli” – Progetto CESEA – avvio<br />
dell’attività di manutenzione del verde e di una serra presso il CRT di Bosisio. Si prevede di<br />
3
iconoscere l’attività di un operatore esperto che all’interno di tale progetto possa seguire in<br />
modo particolare i soggetti con disturbo psichiatrico per facilitarne l’inserimento;<br />
5. Integrazione dei percorsi lavorativi avviati, con i programmi di assistenza domiciliare, ricreativi<br />
e di risocializzazione messi in atto dal privato sociale e dalle associazioni di volontariato del<br />
territorio; in particolare si prevede il rinnovo della Convenzione in vigore con l’A.S.V.A.P. di<br />
<strong>Lecco</strong> e prov. per la gestione del Centro Ricreativo “Il Girasole” di <strong>Lecco</strong>.<br />
Risultati attesi<br />
Creare una rete permanente per l’integrazione lavorativa nel territorio di competenza del<br />
DSM di <strong>Lecco</strong> (Provincia di <strong>Lecco</strong>) e migliorare la comunicazione tra tutti i soggetti<br />
istituzionali coinvolti nell’inserimento lavorativo di soggetti con disturbo psichiatrico,<br />
attraverso la chiara definizione di competenze, ruoli e modalità di intervento tra operatori del<br />
DSM, Servizio per l’Impiego, Comuni e <strong>ASL</strong>.<br />
Definire ed attuare un coordinamento interno al DSM per l’Area lavoro, attraverso la<br />
costituzione di un’équipe funzionale a carattere multidisciplinare e l’integrazione di questa<br />
con i programmi territoriali e residenziali avviati all’interno del DSM, affinché vi siano invii<br />
più mirati e percorsi meglio finalizzati.<br />
Realizzare un modello gestionale innovativo di mix tra pubblico e privato sociale per<br />
l’ampliamento dell’offerta di luoghi di tirocinio e per la gestione degli stessi. Aumentare le<br />
opportunità di inserimento lavorativo per i pazienti in carico.<br />
Migliorare l’offerta di attività ricreative e per il tempo libero ad integrazione dei programmi<br />
messi in atto dal DSM.<br />
Trasferibilità al SSR<br />
La prosecuzione del progetto deve poi trovare finanziamento attraverso l’<strong>ASL</strong> che valorizza gli<br />
interventi di riabilitazione <strong>territoriale</strong> tra i quali rientrano i tirocini a finalità terapeutico-riabilitativa.<br />
Trasferibile è il modello di gestione proposto (affidamento della gestione tecnico-operativa dei<br />
tirocini ad un consorzio di cooperative).<br />
4
II PARTE<br />
Cap. 11<br />
PROGRAMMA DI AZIONI INNOVATIVE PER LA SALUTE MENTALE<br />
Scheda sintetica di programma<br />
Titolo del programma:<br />
PREVENZIONE E TRATTAMENTO PRECOCE PER I DISTURBI PSICHICI GRAVI<br />
Istituzione proponente:<br />
Azienda Ospedaliera “Ospedale di <strong>Lecco</strong>”<br />
Riferimenti del bando<br />
Area Tematica Obiettivo<br />
intervento strategica<br />
Area di intervento TR xxxxxxxxxx xxxxxxxx<br />
Tematica strategica principale TR TR3 xxxxxxxx<br />
Obiettivo principale TR TR3 TR3-2<br />
Altri obiettivi TR TR1 TR1-4<br />
Altri obiettivi TR TR1 TR1-7<br />
Responsabile Amministrativo del programma<br />
Nome e Cognome Paola Goretti<br />
Qualifica Dirigente Struttura Qualità, Accreditamento e controllo<br />
strategico<br />
Istituzione Azienda Ospedaliera “Ospedale di <strong>Lecco</strong>”<br />
Coordinatore scientifico del programma<br />
Nome e cognome Barbara Pinciara<br />
Qualifica Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di <strong>Lecco</strong><br />
Istituzione Azienda Ospedaliera “Ospedale di <strong>Lecco</strong>”<br />
Curriculum professionale<br />
breve<br />
Dr.ssa Barbara Pinciara, nata a Milano il 1.5.1951, abitante a Milano in via<br />
Quadronno 24, tel 02/58301014.<br />
Laurea Medicina e Chirurgia presso l'Università Statale di Milano;<br />
Specializzazione Psichiatria con tesi sui “Rapporti tra il paziente psicotico,<br />
la madre ed il terapeuta”; Analisi personale con membro associato della<br />
Società Italiana di Psicoanalisi; Formazione Manageriale Psichiatria;<br />
Formazione Manageriale Dirigenti Struttura Complessa; Relatrice convegni;<br />
Docente corsi aggiornamento; Supervisore èquipes; A partire dal 12/12/’95<br />
e a tutt’oggi Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria, Direttrice<br />
Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong>. Seminari e<br />
convegni su vari argomenti tra cui: "La devianza dell'adolescenza",<br />
"Psicoterapia degli stati psicotici"
Unità funzionali che partecipano al programma:<br />
UNITA FUNZIONALE ISTITUZIONE RESPONSABILE<br />
SERD<br />
MMG<br />
Informa Giovani<br />
Scuole secondarie 2° grado<br />
<strong>ASL</strong><br />
<strong>ASL</strong><br />
Dr.ssa Marabelli<br />
Dr. V. Valsecchi<br />
Enti Locali/Provincia<br />
Ufficio Scolastico<br />
Dr. V. Brivio<br />
CSA Centro Servizi Dr. F. Tucci<br />
Amministrativi<br />
Sono stati presi contatti con le Unità Funzionali, che verranno perfezionati a seguito<br />
dell’approvazione del progetto.<br />
Razionale del programma<br />
I disturbi psicotici, unitamente ai gravi disturbi di personalità, che negli ultimi anni rappresentano<br />
una “nuova” utenza particolarmente impegnativa sul piano delle strategie di trattamento, sono<br />
disturbi mentali ad alta rilevanza sanitaria e sociale che suggeriscono l’opportunità di attuare<br />
modelli di intervento specifici in un’ottica di prevenzione e di miglioramento dell’ esito a lungo<br />
termine.<br />
La comunità scientifica ha ampiamente dimostrato come l’intervento precoce nelle fasi iniziali di<br />
questi disturbi psichici, sia determinante per contrastare una evoluzione del processo<br />
psicopatologico in termini “cronicizzati”.<br />
L’attuazione di programmi di presa in carico, per soggetti giovani, al loro primo contatto con il<br />
servizio e nelle fasi iniziali del disturbo, ha lo scopo di realizzare progetti terapeutici specifici e<br />
tempestivi proprio in quella fase della malattia dove le distorsioni della percezione e del pensiero<br />
non sono ancora stabili e pertanto risulta possibile modificarne la prognosi sia psicopatologica che<br />
sociale.<br />
Obiettivi principali<br />
1. istituzione di due équipes multiprofessionali (operanti sul territorio di Merate e di <strong>Lecco</strong>) con le<br />
seguenti competenze rappresentate: psichiatra, psicoterapeuta, terapeuta della famiglia e/o di<br />
gruppi, educatore professionale, assistente sociale, infermiere professionale con la finalità di<br />
attuare sia programmi informativi/formativi volti alla precoce individuazione degli stati<br />
mentali e dei disturbi comportamentali a “rischio”, sia tempestivi e specifici trattamenti sulla<br />
persona sofferente e sul suo contesto famigliare e sociale.<br />
2. definizione di un programma specifico di formazione per gli operatori delle due équipes<br />
funzionali per il raggiungimento di uno stile di lavoro improntato alla maggiore omogeneità<br />
“teorica” possibile, per favorire l’apprendimento di nuove strategie terapeutiche e per garantire<br />
la costante supervisione/verifica degli interventi attuati.
Metodologie e modelli gestionali<br />
1. attuazione di programmi di prevenzione per il riconoscimento dei primi segnali di “rischio”<br />
e le modalità di invio al servizio:<br />
2. contatti con le scuole del territorio o altre agenzie del mondo giovanile<br />
3. informazione/formazione con i MMG, per il loro ruolo di primo riconoscimento del disagio<br />
4. elaborazione di un PTI specifico, per soggetti affetti da psicosi e/o gravi disturbi di<br />
personalità, con l’adozione di scale di valutazione per il monitoraggio del percorso di cura e<br />
dell’ esito<br />
5. redazione di un protocollo con l’UONPIA per l’individuazione di adolescenti con patologie<br />
gravi che necessitano tempestivamente dell’avvio di percorsi di cura specifici prima del<br />
diciottesimo anno di età e costituzione di un gruppo di lavoro stabile di collegamento<br />
6. redazione di un protocollo con i servizi per le dipendenze per la gestione dei soggetti con<br />
doppia diagnosi<br />
7. collaborazione con Enti Locali e/o terzo settore per l’inserimento lavorativo attraverso<br />
percorsi non stigmatizzanti (Informa Giovani)<br />
Risultati attesi<br />
Definizione di un programma informativo/formativo che faciliti l’individuazione di<br />
sintomi sentinella e/o di comportamenti a rischio meritevoli di consultazione con l’invio<br />
all’équipe preposta.<br />
Miglioramento nell’utilizzo delle risorse sanitarie, da destinare con maggiore intensità, nelle<br />
fasi di malattia più sensibili all’intervento terapeutico e al miglioramento della prognosi.<br />
Acquisizione di nuove strategie terapeutiche nel trattamento dei disturbi psicotici e di<br />
personalità.<br />
Individuazione di indicatori di esito sia clinici che di funzionamento sociale.<br />
Promozione di una maggiore integrazione con altre agenzie sanitarie e non, in un’ottica di<br />
percorsi “flessibili” e non stigmatizzanti.<br />
Trasferibilità al SSR<br />
• Programma di prevenzione e modalità di integrazione con la rete di istituzioni (scuole, agenzie<br />
giovanili etc.).<br />
• Percorso di cura specifico e relativo finanziamento (pacchetto di prestazioni con nuove voci di<br />
46 SAN).<br />
• introduzione nell’operatività del DSM di strumenti per la valutazione della qualità<br />
dell’assistenza e dell’ esito.
Titolo del programma<br />
IL CASTELLO SOLIDALE<br />
II PARTE<br />
Cap. 12<br />
PROGRAMMA DI AZIONI INNOVATIVE<br />
PER LA SALUTE MENTALE<br />
Scheda sintetica di Programma<br />
______________________________<br />
Istituzione proponente<br />
L’ARCOBALENO cooperativa sociale a r.l. ONLUS – Sede Legale: Via S.Nicolò,7 – 23900 <strong>Lecco</strong><br />
P.IVA 01461770131<br />
Riferimenti del bando (indicare i codici presenti nell’allegato 1)<br />
Area<br />
Tematica<br />
Obiettivo<br />
intervento<br />
strategica<br />
Area di intervento RS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />
Tematica strategica<br />
principale ¹<br />
RS RS/1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />
Obiettivo principale ² RS RS/1 RS1-1<br />
Altri obiettivi ³ RS RS/1 RS1-2<br />
Altri obiettivi ³ RS RS/1 RS1-3<br />
Responsabile Amministrativo del programma<br />
Nome e Cognome Dott. DAVIDE INVERNIZZI<br />
Qualifica Consigliere di amministrazione<br />
Istituzione L’arcobaleno coop.soc. a r.l. ONLUS<br />
Coordinatore Scientifico del Programma<br />
Nome e Cognome Dott.ssa CHIARA NESPOLO<br />
Qualifica MEDICO PSICHIATRA<br />
Istituzione Collaboratore L’Arcobaleno coop.soc. a r.l.
Curriculum professionale<br />
breve (10 righe)<br />
Unità Funzionali che partecipano al programma<br />
Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Milano 1995.<br />
Diploma di Specializzazione in Psichiatria 1999<br />
Iscrizione Elenco degli Psicoterapeutici dell’Ordine Professionale dei<br />
Medici Chirurghi di Milano del 10.7.2000<br />
Attività clinica: è consulente psichiatra presso l’Istituto Geriatrico<br />
“Redaelli” da giugno 2000; della Comunità Cascina Contina di Rosate;<br />
del Consorzio di Cooperative “Farsi Prossimo”, per le “Comunità Mizar 1<br />
e 2” di Milano, a media protezione e della Casa Alloggio a bassa<br />
protezione “Casa Sara” di <strong>Lecco</strong>. Svolge attività di studio privato come<br />
psichiatra e psicoterapeuta. Svolge numerose attività di ricerca.<br />
UNITA’ FUNZIONALE ISTITUZIONE RESPONSABILE<br />
DSM Azienda Ospedaliera <strong>Lecco</strong> Dott.ssa Barbara Pinciara<br />
Amministrazione Comunale Comune di Cesana Brianza Rag. Piergiuseppe Castelnuovo<br />
Razionale del programma<br />
La Cooperativa Sociale L’ARCOBALENO a r.l. con Sede Legale in Via S. Nicolò, 7 in <strong>Lecco</strong>, è<br />
promossa nell’ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con lo scopo di sviluppare e<br />
gestire i servizi socio-sanitari-educativi promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutari.<br />
La Cooperativa, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità<br />
alla promozione umana e sociale in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, l’integrazione sociale, la<br />
cura e la presa in carico dei soggetti deboli attraverso la gestione di servizi socio-sanitari-educativi a<br />
favore di soggetti in difficoltà, emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza.<br />
Nell’ambito di questo scopo la Cooperativa si propone di promuovere presso le comunità civili ed<br />
ecclesiali gli interventi di risposta al bisogno, la loro integrazione con le strutture del territorio, la loro<br />
interazione con le comunità per un’effettiva integrazione dei soggetti, la loro funzione di<br />
sensibilizzazione e di ricerca di modelli d’intervento innovativi e sperimentali per rispondere in<br />
maniera adeguata e significativa alle diverse forme di povertà manifestate.<br />
La Cooperativa L’ARCOBALENO opera con servizi propri e in appalto nelle aree della grave<br />
emarginazione, degli anziani non autosufficienti, delle malati di aids, degli stranieri e dei minori.<br />
In particolar modo opera, nell’area della salute mentale, attraverso:<br />
CASA SARA<br />
Comunità a bassa protezione, di n.2 posti letto, accreditata dalla Regione Lombardia con Delibera<br />
n.VII/8986 del 7.5.2002, iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n.539, titolare del<br />
contratto con l’ASl di <strong>Lecco</strong> del 31.10.2002<br />
CASA DEL LAGO – Comunità protetta a media protezione n.10 p.l. dell’Azienda Ospedaliera di<br />
<strong>Lecco</strong> - GESTIONE ALBERGHIERA E SOCIO-EDUCATIVA E INFERMIERISTICA dal 1 Luglio<br />
1999
COMUNITA’ PROTETTA di Casatenovo (Lc) – Comunità protetta a media protezione per n.16 p.l<br />
dell’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong> – GESTIONE ALBERGHIERA E SOCIO-EDUCATIVA E<br />
INFERMIERISTICA – Aggiudicatario della gara di appalto, in attesa dell’apertura prevista per Ottobre<br />
2004.<br />
Descrizione della struttura<br />
“Il Castello” è una struttura sita a Cesana Brianza (Lc) piccolo comune a ridosso della città di <strong>Lecco</strong><br />
(10 km).<br />
L’amministrazione comunale ha ristrutturato lo stabile realizzando gli spazi per l’inserimento di un<br />
Centro Diurno Integrato per anziani e una serie di piccoli appartamenti. L’intera struttura è stata data in<br />
comodato alla Caritas Ambrosiana e da questa in sub-comodato alla cooperativa L’ARCOBALENO,<br />
affinché vi sia realizzato un progetto innovativo. Per questo da subito si è lavorato per realizzare il CDI<br />
che ha ottenuto l’accreditamento della Regione Lombardia e il conseguente contratto con l’<strong>ASL</strong> di<br />
<strong>Lecco</strong> per garantire l’accoglienza di n.17 persone anziane.<br />
Sono rimasti a disposizione gli appartamenti, che già nel progetto iniziale presentato dalla cooperativa<br />
L’Arcobaleno all’amministrazione comunale, prevedevano l’accoglienza di persone con disagio<br />
psichico.<br />
Il progetto prevede di costituire n.6 posti letto, utilizzando n.3 bilocali da n.2 posti letto ciascuno, e un<br />
ampio monolocale come spazio comune,per malati psichici di età superiore a 50 anni che non abbiano<br />
più la possibilità di rimanere al proprio domicilio o che siano inseriti in comunità residenziali da lunghi<br />
periodi.<br />
Obiettivi principali<br />
L’obiettivo è di sperimentare un modello di gestione flessibile e funzionale al bisogno dei pazienti di<br />
non entrare, o rimanere, in percorsi di cronicità e di dipendenza.<br />
Proprio per loro questi spazi, dove l’intervento è soprattutto di natura educativa e d’accompagnamento,<br />
sono opportunità di sviluppo, d’autonomie e d’integrazione. E’ uno spazio in cui i soggetti inseriti<br />
possono, attraverso un accompagnamento individualizzato, sperimentarsi in un ambiente ancora<br />
ritenuto protetto, ma corrispondente ad un ambiente che richiama, nella sua struttura e nelle modalità<br />
gestionali, la normale abitazione civile.<br />
Inoltre, la presenza del centro diurno integrato, che rimane comunque uno spazio sia fisico sia<br />
riabilitativo autonomo e indipendente, permette l’integrazione tra due servizi, che hanno in comune il<br />
metodo di lavoro educativo ed alcune risorse strutturali ed umane come elemento specifico e<br />
qualificante. La finalità è pertanto quella di rimessa in moto di un processo evolutivo, promuovendo<br />
momenti di comunicazione, occasione d’incontro, acquisizione di competenze assicurando il<br />
contenimento, tollerando fasi di regressione e proteggendo aspetti precari e non ancora integrati.<br />
Caratteristiche di innovazione:<br />
• dal punto di vista strutturale<br />
i mini-appartamenti sono inseriti all’interno di un'unica struttura, totalmente indipendenti,<br />
completamente arredati, con locale cucina autonomo e con alcuni locali comuni (possibilità di<br />
attività e ritrovo comune);<br />
Al seminterrato vi è ormai funzionante il CDI che permetterebbe funzionali e significativi<br />
collegamenti con il progetto.
• dal punto di vista gestionale<br />
si vuole realizzare la gestione con un modello innovativo tra pubblico e privato sociale, così<br />
come da anni sperimentato nella gestione della comunità protetta Casa del Lago di Garlate (Lc)<br />
e così come si sperimenterà nella Comunità protetta di Casatenovo.<br />
• dal punto di vista delle patnership<br />
L’amministrazione comunale di Cesana Brianza, la Caritas Ambrosiana e la cooperativa<br />
L’Arcobaleno riconoscendosi nelle finalità del progetto mettono a disposizione dello stesso<br />
l’uso della struttura in forma gratuita, completamente arredata e sono coinvolte direttamente<br />
nella realizzazione degli interventi.<br />
Metodologie e modelli gestionali<br />
Gli appartamenti messi a disposizione sono perfettamente autonomi, ma nello stesso tempo<br />
garantiscono una convivenza solidale che permette a ciascun ospite un sostegno reciproco. Ad<br />
integrazione, dell’accoglienza residenziale verranno realizzate le prestazioni sanitarie per cui è<br />
richiestati il finanziamento.<br />
Inoltre, gli ospiti a parziale copertura delle spese alberghiere saranno chiamati a partecipare a tali oneri<br />
con il pagamento di una quota mensile.<br />
Si prevede la creazione di una convenzione con il DSM per attivare una collaborazione con l’équipe<br />
<strong>territoriale</strong> (medico psichiatra, assistente sociale) per la presa in carico dei pazienti a garanzia del<br />
principio di continuità terapeutica e in coerenza con il PTI elaborato in sede <strong>territoriale</strong> (unitarietà del<br />
percorso di cura). Ne consegue, che il paziente rimane in carico ai servizi territoriali che valutano con<br />
l’équipe della cooperativa l’inserimento, la coerenza tra PTI e PTR, e la dimissione.<br />
Inoltre, sono previste collaborazioni con gli Enti Locali di residenza del paziente per gli aspetti di<br />
carattere prettamente sociali.<br />
E’ previsto un coinvolgimento di soggetti non istituzionali per il tempo libero e gli interventi<br />
risocializzanti.<br />
Risultati attesi (Impatto del progetto sullo scenario organizzativo attuale)<br />
• Favorire la dimissione da strutture a maggiore protezione dei pazienti istituzionalizzati appartenenti<br />
al territorio. (Attualmente la percentuale di utenti dimessi dalle SR nel corso di un anno non<br />
raggiunge il 20%).<br />
• Garantire un’idonea collocazione per le persone di età adulta o anziana, con buona autonomia<br />
residua, non necessitanti di effettuare programmi riabilitativi intensivi ma solo estensivi o di<br />
mantenimento, per periodi lunghi anche per tutto l’arco della vita;<br />
• Avviare una forma di collaborazione e gestione flessibile ed integrata tra pubblico e privato che<br />
garantisca i percorsi di cura individuati;<br />
Trasferibilità al SSR<br />
E’ trasferibile il modello proposto nel presente progetto che, in linea con gli indirizzi definiti dal Piano<br />
Regionale Salute Mentale ed in particolare dalla Circolare 28 SAN che fornisce le prime norme<br />
attuattive relativamente alla residenzialità psichiatrica, individua nuove soluzioni organizzative<br />
(miniappartamenti), alternative alla residenzialità attualmente esistente consentendo da un lato<br />
l’erogazione programmi a minore intensità riabilitativa e assistenziale, consentendo al contempo la
dimissione da strutture residenziali ad intensità riabilitativa più elevata creando quindi disponibilità per<br />
pazienti che necessitano di trattamenti più complessi. Inoltre come indicato nei risultati attesi<br />
l’attuazione del presente progetto consentirebbe di sperimentare un modello gestionale flessibile tra<br />
pubblico e privato eventualmente estensibile al resto del SSR.
Richiesta finanziaria<br />
1) Costi stimati del programma innovativo da parte del DI proponente (sono esclusi<br />
interventi strutturali, investimenti e mutui)<br />
Tipologia di costo<br />
Risorse Umane (dettagliare)<br />
Euro<br />
- Educatori<br />
- ASA<br />
449.439,28<br />
- Custodi (2)<br />
- Coordinatore educatori<br />
Beni e servizi (dettagliare)<br />
- Formazione personale<br />
- Attrezzature e utilities<br />
Altri oneri (dettagliare)<br />
- Attività di programmazione verifica e<br />
coordinamento<br />
15.000<br />
5.000
2) Valorizzazione attività erogate (solo per Area Territoriale e Residenziale)<br />
Tipologia prestazione n° prestazioni<br />
per mese<br />
1) intervento di supporto alla vita<br />
quotidiana<br />
130<br />
2) intervento sulle abilità di base,<br />
interpersonali e sociali<br />
3) colloquio<br />
4) colloqui con i familiari<br />
5) riunione interna UOP<br />
6) riunione con strutture sanitarie<br />
e altri enti<br />
Valorizzazione per mese<br />
Valorizzazione per anno<br />
Valorizzazione nel triennio<br />
52<br />
12<br />
2<br />
12<br />
6<br />
Euro<br />
€ 7.251,40<br />
€ 3.061,76<br />
€ 520,46<br />
€ 105,36<br />
€ 1.533,84<br />
€ 567,06<br />
€ 13.211,18<br />
€ 156.479,76<br />
€ 469.439,28
III PARTE<br />
Gli attori<br />
Cap. 1<br />
PROVINCIA E COMUNI PER LA SALUTE MENTALE<br />
LA PROVINCIA DI LECCO: DALLA FORMAZIONE ALL’IMPIEGO<br />
La Provincia di <strong>Lecco</strong> è tra i soggetti istituzionali firmatari dell“Atto di intesa per la realizzazione e attuazione di un<br />
sistema locale di interventi nell’area della salute mentale in Provincia di <strong>Lecco</strong>”, in cui si riconosce che il tema della<br />
salute mentale investe, per aspetti diversi ma complementari, i ruoli delle diverse istituzioni ma anche la comunità<br />
locale e le sue forme aggregative.<br />
Nella prospettiva tracciata dall’Atto d’intesa la Provincia assume e svolge il ruolo centrale affidatole dalla normativa e<br />
riconosciutole dai Comuni in materia di formazione e di collocamento al lavoro, di governo dei servizi all’impiego<br />
anche per l’area della disabilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro.<br />
La relazione e integrazione progettuale e operativa fra i servizi socio- sanitari e i servizi per l’impiego rappresenta<br />
infatti una risorsa fondamentale per la riuscita dei progetti di integrazione socio-lavorativa e per l’emancipazione dei<br />
soggetti con problematiche psichiatriche dal circuito assistenziale.<br />
La Provincia è inoltre l’ente a cui spesso vengono portate istanze anche dai cittadini su temi complessi e delicati, come<br />
la tutela della salute mentale, in quanto ha assunto nel territorio un ruolo fondamentale nel favorire una progettazione<br />
partecipata fra i diversi soggetti, enti locali, istituzioni, associazioni di volontariato e cooperative sociali ed ha promosso<br />
una crescita della sensibilità collettiva sui temi sociali e del disagio.<br />
Per quanto riguarda la programmazione dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell’art. 7 (Funzioni delle Province),<br />
comma 1, lettera d, della Legge 328/2000, la Provincia ha sottoscritto gli Accordi di programma per la realizzazione dei<br />
Piani di Zona L. 328/2000 – seconda triennalità 2006-2008 dei tre Ambiti distrettuali di Bellano, <strong>Lecco</strong> e Merate e<br />
partecipa alla redazione, all’aggiornamento e alla verifica dei Piani di Zona stessi, secondo le modalità previste dalla<br />
normativa vigente, in accordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e con le Assemblee Distrettuali.<br />
A tal proposito svolge un ruolo di supporto e di collaborazione con i Comuni sia nell’attuazione dei Piani di Zona,<br />
strumento di programmazione dei servizi sociali, che nella gestione diretta di alcune attività, svolte in prevalenza<br />
attraverso l’Osservatorio per le Politiche Sociali e il Piano Formativo provinciale.<br />
Con l’Osservatorio si propone in una funzione di servizio al territorio, rispondendo alle frequenti sollecitazioni sia dei<br />
Comuni sia dei soggetti del terzo settore e dei cittadini, che la identificano come un qualificato punto di riferimento.<br />
Attraverso lo strumento del “Piano provinciale per la formazione e l’aggiornamento del personale dei servizi socio-<br />
assistenziali e socio- sanitari”, che viene costruito insieme agli interlocutori del territorio significativi per lo sviluppo<br />
delle politiche sociali, la Provincia interviene in modo consono al proprio ruolo, rispondendo alle esigenze formative e<br />
di aggiornamento degli operatori dei Comuni e degli altri enti territoriali.<br />
Estratto del “PIANO DI ZONA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E<br />
INTERVENTI SOCIALI<br />
DELL’AMBITO TERRITORIALE<br />
DEL DISTRETTO DI LECCO”<br />
Secondo triennio - 2006/2008<br />
PREMESSA<br />
“Il Piano di Zona è lo strumento principale della comunità locale per realizzare sul suo territorio azioni di politica<br />
sociale miranti a dare risposte di bisogni emergenti e latenti della popolazione in ambito socio-assistenziale e sociosanitario<br />
e per la promozione e la tutela delle persone e delle famiglie.<br />
Questo documento si riferisce al sistema programmatorio di interventi e servizi previsto dalla Legge quadro 328/00 e<br />
dal successivo Piano Sociale Nazionale, nonché tiene conto delle indicazioni fornite dal Piano Socio Sanitario<br />
1
Regionale 2002-2004 e dalla Circolare Regionale n° 48 del 27/10/2005 “Linee guida per la definizione dei piani di<br />
Zona – 2° triennio”.<br />
Il presente documento è il risultato di un confronto avvenuto all’interno dell’Ufficio di piano e dei Gruppi Tematici e<br />
successivamente completato nell’Esecutivo Distrettuale, per soddisfare sia l’esigenza di effettuare una valutazione del<br />
primo Piano di zona sia l’urgenza di avviare il processo di definizione del Piano di zona 2006 – 2008.<br />
In questo senso è da considerare una “traccia” da ampliare ed integrare con i contributi di tutti i soggetti interessati alla<br />
ricerca di soluzioni che migliorino le condizioni e la qualità della vita delle persone più esposte al bisogno e disponibili<br />
a collaborare alla costruzione di un sistema locale dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.<br />
Questa “traccia” intende confermare i principi posti alla base del primo Piano e costituire la base per attivare un lavoro<br />
di progettazione partecipata che consentirà, a partire dagli obiettivi strategici complessivi qui indicati, di definire e<br />
declinare le decisioni programmatorie adeguate all’evoluzione del contesto <strong>territoriale</strong> e delle caratteristiche sociodemografiche.<br />
Principi quali:<br />
⇒ Il principio dell’integrazione come concetto che aiuta ad affrontare e tradurre concretamente in azioni (per<br />
tutelare), i problemi delle persone più fragili; quindi una integrazione tra aree e servizi diversi con il preciso<br />
obiettivo di lavorare per una migliore qualità della vita di questi soggetti. Da ciò deve scaturire anche una<br />
naturale (ma necessaria) integrazione tra le diverse professionalità coinvolte nei processi di lavoro.<br />
⇒ Il principio della compartecipazione alla spesa secondo un concetto di selettività universalistica rispetto alle<br />
prestazioni erogate e dove i fruitori concorrano in misura correlata alla loro capacità economica.<br />
⇒ Il principio della concertazione come modalità permanente di rapporto tra i soggetti istituzionali e il terzo<br />
settore in una logica di collaborazione orientata al risultato.<br />
Il Piano termina con la programmazione zonale – macro analisi del piano economico 2006.<br />
4. LE AREE DI BISOGNO<br />
Analizzare la domanda e l’offerta in un dato contesto sociale necessiterebbe di spazi articolati e strumenti specifici, in<br />
grado di mettere in evidenza le continuità storiche e i punti di innovazione nella delineazione e implementazione delle<br />
politiche sociali, secondo una lettura intrecciata con il più complessivo sviluppo del territorio di riferimento.<br />
La Regione Lombardia, nella Circolare Regionale n° 48 del 27/10/2005 indica le seguenti aree di programmazione:<br />
Anziani, Disabili, Minori, Immigrazione, Adulti in difficoltà: emarginazione sociale, povertà, dipendenze, salute<br />
mentale, specificando inoltre di ricomprendere in quest’area i problemi delle persone in esecuzione penale interna ed<br />
esterna.<br />
In questo documento la rappresentazione delle aree di bisogno viene articolata tenendo conto di quanto suggerito dalla<br />
Regione, con la consapevolezza che alcuni aspetti o problematiche risultano essere trasversali alle quattro aree<br />
considerate (Area Anziani – Area Disabili - Area Adulti in difficoltà – Area Minori e Famiglia).<br />
Gli elementi comuni e/o di connessione saranno ripresi nella parte sugli obiettivi strategici e di sistema, per quanto<br />
concerne le azioni/interventi, e nella parte metodologica per quanto concerne le modalità di lavoro e la necessità di<br />
armonizzare regole e/o criteri.<br />
4.3 Area Adulti in difficoltà<br />
Gli immigrati ed i soggetti esposti al rischio dell’esclusione sociale (adulti in difficoltà, famiglie monoreddito con più<br />
figli, ex carcerati, soggetti psichiatrici e/o in condizione di fragilità psico-sociale, tossicodipendenti,<br />
alcooldipendenti, donne maltrattate, pensionati poveri, persone in esecuzione penale esterna ed interna), richiedono<br />
interventi specifici e mirati a favorire l’integrazione o il reinserimento delle persone.<br />
Si rende necessario pertanto affrontare tali situazioni con interventi concreti e coerenti, attivando prestazioni integrate<br />
tra i servizi, anche di tipo socioeducativo.<br />
Il gruppo di lavoro dell’Area Adulti, alla luce della complessa e variegata articolazione dei bisogni riferibili ad un target<br />
di utenza molto ampio, ha ritenuto, per una impostazione di più immediata comprensione, e non certamente con<br />
l’intendimento di semplificare per categorie, di connotare la rilevazione dei principali fenomeni sociali attraverso ciò<br />
che viene letto nei servizi e secondo la ripartizione nelle subaree: immigrazione, dipendenze, salute mentale e nuove<br />
povertà. Sono stati pertanto predisposti distinti documenti, ognuno riferibile alle subaree del rispettivo gruppo di lavoro,<br />
riferiti ai nuclei tematici delle aree di bisogno trasversalmente identificate: residenzialità, lavoro, scuola e formazione.<br />
SUBAREA SALUTE MENTALE<br />
2
Sulla base delle indicazioni della L.328/2000, i Comuni della Provincia di <strong>Lecco</strong> hanno avviato, con il Piano di zona<br />
2002/2004, prorogato sino al 31 dicembre 2005, un processo teso a garantire a tutti i cittadini una risposta compiuta,<br />
integrata e unitaria ai bisogni socio-assistenziali del territorio, avviando un processo di confronto volto al superamento<br />
della frammentazione e della frammentarietà proprie di un territorio costituito in larga parte da Comuni molto piccoli,<br />
ma anche di un sistema di servizi erogati da Enti istituzionali con competenze diverse.<br />
In tale contesto, all’interno del gruppo Disabilità e disagio mentale si è costituito il sottogruppo “psichiatria” che ha<br />
visto la rappresentanza di tecnici dei Comuni, dell’Azienda ospedaliera, di operatori della cooperazione sociale e<br />
dell’associazionismo familiare e di settore, mentre il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ha promosso la<br />
costituzione di un gruppo tecnico e tecnico/politico per lavorare, anche sulla base delle indicazioni emerse dai gruppi<br />
tematici dei Piani di Zona, alla stesura di un accordo istituzionale sull’area della Psichiatria.<br />
Al termine del percorso di lavoro svolto, nel corso del 2005 si è giunti, in sintonia con le indicazioni del “ Piano<br />
regionale triennale per la salute mentale” approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta n. 7/17513<br />
del 17 maggio 2004, alla definizione di un “Atto di intesa per la realizzazione e attuazione di un sistema locale di<br />
interventi nell’area della salute mentale in Provincia di <strong>Lecco</strong>”, in cui si riconosce che il tema della salute mentale<br />
investe, per aspetti diversi ma complementari, i ruoli dei diversi Enti istituzionali ma anche la comunità locale e le sue<br />
forme aggregative.<br />
Tale Atto di Intesa, che è stato recentemente approvato dall’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong>, dall’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong>, dalla<br />
Provincia di <strong>Lecco</strong> e dalle tre Assemblee Distrettuali, è uno strumento di definizione delle interazioni, delle prassi<br />
operative e collaborative tra i soggetti firmatari, ma riconosce il ruolo svolto dalle realtà cooperative, associative,<br />
aziendali che concorrono alla costruzione dei processi di integrazione dei soggetti destinatari degli interventi.<br />
I soggetti istituzionali firmatari, con l’intento di concorrere con eguale responsabilità alla realizzazione di interventi<br />
socio-sanitari per la prevenzione della salute mentale e la tutela delle persone con patologia psichiatrica, hanno assunto<br />
il compito di sviluppare un lavoro costante indirizzato all’integrazione e alla gestione <strong>territoriale</strong> delle competenze di<br />
ciascun soggetto.<br />
Nel territorio provinciale, gli interventi a tutela della salute mentale, sono ora garantiti dal raggiunto Atto di Intesa e<br />
vengono attuati secondo le modalità previste da protocolli operativi.<br />
I primi due protocolli operativi per cui si è predisposta una presa d’atto in concomitanza con l’approvazione dell’Atto di<br />
Intesa sono:<br />
Area tematica della territorialità:<br />
1. Protocollo tra i soggetti firmatari dell’Atto di Intesa per gli interventi di natura socio-assistenziale e di<br />
integrazione sociale e lavorativa;<br />
Il protocollo si riferisce in particolare agli interventi che vedono il coinvolgimento, in maniera diretta, delle<br />
competenze dei Comuni, nella realizzazione di interventi individualizzati e/o rivolti a gruppi e recepisce le<br />
indicazioni emerse dai tavoli tecnici della L. 328/00 sul disagio mentale.<br />
Area tematica della residenzialità:<br />
2. Protocollo con linee guida rispetto agli interventi di tipo residenziale<br />
I protocolli attuativi sono strumenti che, in una dimensione di costante aggiornamento, devono trovare concreta e<br />
urgente applicazione. Il tema della salute mentale rappresenta infatti un ambito del lavoro sociale che fatica ancora a<br />
trovare accettazione e attenzione e che, necessariamente, per essere assunto e riconosciuto dalle comunità locali come<br />
questione “trattabile”, deve vedere ampia intesa e condivisione tra i diversi attori del sistema sanitario/sociale e del<br />
volontariato.<br />
In riferimento a ciascuno dei due protocolli si sono attivati due gruppi di lavoro, ampliamente rappresentativi delle<br />
diverse componenti, a cui partecipano referenti dei Comuni.<br />
Per rendere efficace la comunicazione sullo stato di attuazione dei protocolli si prevede di mantenere un raccordo<br />
periodico tra i tecnici inseriti nell’Organismo di coordinamento per la salute mentale e nei gruppi Territorialità e<br />
Residenzialità ed il livello politico.<br />
È in questa cornice quindi che il secondo Piano di Zona dovrà collocare, sviluppare e realizzare appropriati interventi<br />
nell’Area della Salute Mentale.<br />
A questo proposito, su indicazione dell’Ufficio di piano, si ritiene opportuno avviare nell’ambito distrettuale di <strong>Lecco</strong><br />
un tavolo di confronto aggiuntivo a quelli attivati all’interno dell’Organismo di coordinamento per la salute mentale.<br />
A) SPECIFICITA’ RILEVATE NELLA SITUAZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO<br />
Si rileva come in generale, la situazione delle persone in condizione di fragilità sia oggi maggiormente complessa per<br />
fattori diversi ma ugualmente riconducibili ad una “modernità” che produce sempre più bisogni immateriali (e quindi di<br />
difficile soluzione) ma non ha ancora risolto molte questioni materiali (basti pensare allo squilibrio tra il reddito<br />
3
pensionistico da invalidità – o alla precarietà attuale del lavoro- e i costi della vita). Questi elementi che rendono<br />
difficile per tutti il percorso di emancipazione anche relazionale dai nuclei originari, diventano ostacoli difficili da<br />
superare quando incontrano anche la fragilità personale, la patologia delle relazioni, l’insicurezza per il futuro. In questi<br />
anni l’investimento dei diversi Servizi ha contrastato questi fenomeni, ha parzialmente assunto questi bisogni, ma la<br />
realtà è ancora lontana dal vedere una risposta adeguata. Il ritardo è certamente condizionato da molti fattori, ma a<br />
livello locale ha certamente giocato una certa frammentazione nell’offerta di servizi e di risorse, una difficoltà nel<br />
dialogo interistituzionale, una esperienza ancora giovane della concertazione e mediazione tra istanze troppo spesso<br />
autoreferenziali e in antitesi. Nello specifico dell’ambito psichiatria certamente si sconta la difficoltà del confronto tra<br />
la dimensione specialistica e quella <strong>territoriale</strong> anche se l’impegno profuso per la stesura dei protocolli e con<br />
l’Organismo di Coordinamento ha permesso di compiere alcuni significativi passi avanti. Più in generale si rileva come<br />
le tematiche di quest’area siano difficilmente comprimibili in una dimensione distrettuale e la necessità di una<br />
diffusione degli interventi, di un decentramento sul territorio, di un presidio diffuso del malessere sociale, di una<br />
continuità e differenziazione delle azioni richiederebbero invece riferimenti istituzionali di natura provinciale, per una<br />
gestione dei budget più efficace, per una agilità dell’azione, per una reale integrazione fra i livelli specialistici e quelli<br />
territoriali.<br />
B) PROBLEMI EMERGENTI RILEVATI<br />
Sostenere il processo di costruzione di un linguaggio comune e di prassi operative condivise fra servizi specialistici<br />
e territoriali e con le realtà del volontariato, come indicato nei protocolli;<br />
Articolare le forme e le opportunità di accesso al lavoro e ad esperienze pre-professionali e/o occupazionali<br />
Mettere a tema l’offerta di opportunità di incontro/aggregazione relazione;<br />
Articolare le forme e le opportunità “dell’abitare”, sviluppando un’azione sinergica fra i diversi livelli istituzionali<br />
e fra questi e il volontariato, prevedendo una attenta azione di monitoraggio e accompagnamento delle esperienze<br />
Garantire il supporto alle famiglie attraverso iniziative che prevedano interventi di sollievo, il pronto intervento<br />
assistenziale, momenti di distacco programmato, vacanze ecc.<br />
6.3. Gli Obiettivi di “qualità della vita”: priorità e risultati attesi nelle<br />
aree d’intervento<br />
Sono quegli obiettivi riferiti alle aree di programmazione definite a livello distrettuale che comprendono tutto ciò che<br />
attiene ai servizi, prestazioni, interventi e progetti diretti a favore dei singoli, delle famiglie o di gruppi specifici.<br />
Area Adulti in difficoltà<br />
Dimensione assistenziale e di reinserimento sociale<br />
(comune alle subaree:immigrazione, dipendenze,<br />
salute mentale e nuove povertà)<br />
Priorità:<br />
- Gestione coordinata delle risorse economiche per attivare interventi individualizzati d’inserimento lavorativo<br />
e di reinserimento sociale per soggetti con fragilità psico-sociali, ex carcerati, psichiatrici, dipendenti da<br />
sostanze, etc.<br />
Risultati attesi<br />
- Migliorare l’integrazione degli interventi tra il Centro per l’impiego (Servizio collocamento mirato fasce<br />
deboli) e le realtà che si occupano di reinserimento socio-lavorativo.<br />
- Possibilità di iscrizione al Centro per l’impiego (Servizio collocamento mirato fasce deboli), anche per le<br />
persone con il solo domicilio sulla provincia di <strong>Lecco</strong>.<br />
- Creare un tavolo di lavoro tematico operativo al fine di promuovere un protocollo condiviso di orientamentoaccompagnamento.<br />
− Risultati attesi (reinserimento sociale e sostegno economico)<br />
4
1) Attivazione di sostegni di carattere socio-economico erogati sulla base di progetti individualizzati<br />
in ordine al reinserimento, in raccordo tra le diverse realtà che si occupano delle specifiche<br />
situazioni.<br />
Attivazione di sostegni di carattere socio-economico erogati sulla base di progetti<br />
individualizzati in ordine al reinserimento , in raccordo tra le diverse realtà che si<br />
occupano delle specifiche situazioni.<br />
attivazione di strumenti adeguati - ad esempio borse lavoro a gettone di presenza” - per<br />
utenti a bassa soglia.<br />
Omogeneita’ nell’erogazione di contributi economici di minimo vitale;<br />
adozione dello schema di convenzione tipo per l’inserimento lavorativo di soggetti<br />
svantaggiati predisposto dalla Regione Lombardia<br />
attuazione di Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Distrettuale e la Provincia per i<br />
servizi del collocamento mirato delle fasce deboli.<br />
GESTIONE: associata a livello distrettuale<br />
Tempi di realizzazione : 2006, 2007, 2008<br />
Subarea salute mentale<br />
Obiettivo strategico : Avviare un progetto <strong>territoriale</strong>, di natura provinciale, in grado di programmare uno sviluppo di<br />
offerte abitative tutelate e differenziate sulla base delle esigenze e caratteristiche delle persone, per consentire percorsi<br />
di autonomia, reinserimento sociale, processi di adultizzazione e emancipazione. Promuovere a questo fine la necessaria<br />
integrazione fra le competenze del DSM e le risorse (abitative, di servizi e professionalità) dei Comuni e del territorio.<br />
Costituire equipes territoriali pluricomposte e multidisciplinari di intervento (operatori del DSM e dei Comuni,<br />
volontariato) con funzioni di sostegno all’abitare, riferimento, monitoraggio e analisi. Si tratta di costruire una rete di<br />
integrazione e supporto alle esperienze, valorizzando la presenza e il ruolo della comunità locale, favorendo anche una<br />
maggiore sensibilizzazione e disponibilità.<br />
Dimensione promozionale e preventiva<br />
Priorità<br />
a) Promuovere periodici incontri territoriali in ambito distrettuale ( o sub ambito) tra DSM e Servizi sociali dei<br />
Comuni, altri Servizi territoriali, per favorire occasioni di conoscenza, scambio, approfondimento sulle diverse<br />
tematiche, con l’obiettivo di costruire un linguaggio comune, prassi concretamente condivise, ipotesi di lavoro<br />
concordate, dando piena attuazione ai protocolli;<br />
b) Promuovere, in un progetto tra Provincia, DSM, Comuni, Privato Sociale, offerte formative rivolte al personale<br />
sociale che opera nei Comuni, per sostenere i processi di conoscenza, competenza e integrazione<br />
Risultati attesi<br />
- Facilitare la comprensione delle diverse logiche operative, avvicinare il ruolo specialistico e quello di base che<br />
deve fronteggiare la quotidianità della presenza e delle difficoltà del singolo e del nucleo.<br />
- Strumentare i servizi territoriali, anche attraverso una funzione di “consulenza” nell’elaborazione e conduzione<br />
degli interventi;<br />
- Ampliare l’attenzione delle comunità al tema salute mentale, vincendo le ancora presenti resistenze e paure<br />
Gestione: associata a livello distrettuale e interdistrettuale;<br />
Tempi:<br />
obiettivo a) entro il primo anno progettare gli incontri, d’intesa fra i soggetti e, alla verifica, impostare la<br />
programmazione per gli anni successivi.<br />
obiettivo b) nel primo anno procedere ad una verifica dei fabbisogni formativi e prevedere un piano triennale di attività<br />
di informazione/formazione rivolta a diversi target di destinatari<br />
Dimensione assistenziale e di reinserimento sociale<br />
Priorità<br />
a) In un quadro di programmazione <strong>territoriale</strong> avviare e sostenere progetti abitativi di accoglienza, privilegiando<br />
quelli di piccola dimensione, valorizzando la collaborazione dei Comuni, della Cooperazione e del volontariato.<br />
5
) Costituzione di equipes territoriali pluricomposte e multidisciplinari di intervento (operatori del DSM e dei<br />
Comuni, volontariato) con funzioni di sostegno, riferimento, monitoraggio e accompagnamento delle residenze<br />
abitative.<br />
c) Allargamento del pronto intervento assistenziale anche all’utenza femminile<br />
d) Uniformare e rendere omogenee, evitando sovrapposizioni, le diverse procedure e gli strumenti di accesso a<br />
tirocini formativi e/o propedeutici e ai percorsi di avviamento al lavoro previste dai Servizi per l’Impiego e dai<br />
Servizi specialistici<br />
e) Valorizzare e promuovere le forme di aggregazione e gestione del tempo libero e le iniziative occupazionali.<br />
Risultati attesi<br />
Ampliare e articolare l’offerta abitativa e residenziale su tutto il territorio provinciale, procedendo per<br />
sperimentazioni e verifiche, sulla base di bisogni definiti e non in modo aprioristico<br />
Fornire una rete di supporto ad ogni realtà in grado di integrare competenze e ruoli (DSM, Servizi<br />
Comunali, volontariato) coordinata dal DSM. Garantire un presidio permanente della rete per permettere<br />
una crescita e uno scambio professionale tra le esperienze, per fare sintesi, per verificare la riproducibilità<br />
dei modelli.<br />
Gestione: associata a livello distrettuale e interdistrettuale<br />
Tempi:<br />
- obiettivo a) avvio entro il primo anno di una ricognizione dei bisogni e di una ipotesi che preveda una progressiva<br />
copertura del territorio provinciale in accordo tra DSM e Comuni. Analisi del fabbisogno di risorse e ricerca delle<br />
fonti di finanziamento (progetto pluriennale) Entro il secondo anno avvio dei due appartamenti di Calolziocorte<br />
messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Entro il terzo anno avvio di nuove sperimentazioni<br />
- obiettivo b) entro il primo anno avviare una riflessione su questo tema con tutti i soggetti coinvolti, con il secondo<br />
anno sperimentare intorno ad una prima realtà abitativa, sviluppando progressivamente l’intervento nell’anno<br />
successivo<br />
- obiettivi c) e d) entro il primo anno<br />
- obiettivo e) nel primo anno sviluppare una riflessione partecipata e compiuta su questo tema in termini di<br />
significato, analisi del bisogno, verifica delle esperienze. Dal secondo anno promuovere, valorizzare e raccordare le<br />
iniziative, come peraltro indicato nel protocollo territorialità…”<br />
6
Estratto del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Merate<br />
(seconda triennalità 2006/2008) riguardanti la Salute Mentale<br />
3. Le aree di bisogno<br />
Dalle principali dinamiche sociali e dalla mappatura dei servizi esistenti emergono una serie di “aree” di<br />
bisogno (macro – aree) attorno alle quali si concentra la domanda di interventi e servizi sociali.<br />
Si tratta di domande che rinviano alle mutate condizioni sociali ed educative nelle quali le persone, gli<br />
individui e le famiglie si trovano a portare avanti i propri compiti, responsabilità, esigenze di cura e di<br />
assistenza.<br />
L’individuazione di queste macro aree offre un quadro completo della situazione <strong>territoriale</strong> che orienta la<br />
pianificazione zonale.<br />
Queste aree di bisogno costituiscono quindi un riferimento essenziale sia per le scelte strategiche che di<br />
priorità operative del presente Piano ma altresì per una pianificazione che sappia essere aderente alla<br />
situazione <strong>territoriale</strong> nel medio – lungo periodo.<br />
3.3. Area Adulti in difficoltà (Dipendenze, Psichiatria, Immigrazione e Povertà)<br />
Rispetto al precedente piano il territorio ha maturato una maggiore consapevolezza e chiarezza<br />
nell’individuazione dei soggetti esposti al rischio dell’esclusione sociale (adulti in difficoltà, famiglie<br />
monoreddito con più figli, ex carcerati, soggetti psichiatrici e/o in condizione di fragilità psico-sociale,<br />
tossicodipendenti, alcooldipendenti, donne maltrattate, pensionati poveri, persone in esecuzione penale<br />
esterna ed interna), connotando gli interventi in modo più concreto, consistente e coerente con le priorità<br />
d’ambito.<br />
E’ stato predisposto un atto di intesa, in fase di adozione dai singoli Comuni, per la realizzazione degli<br />
interventi riferiti ad adulti in situazione di disagio psichico e/o psichiatrico.<br />
Sono confermati come bisogni di sistema:<br />
• il consolidamento dei tavoli di coordinamento per la prevenzione che vedono la partecipazione dei<br />
servizi pubblici e del privato sociale;<br />
• l’integrazione delle risorse pubblico/privato - sociale/sanitario, che rafforzi la flessibilità dei<br />
programmi d’intervento finalizzati a meglio garantire la loro individualizzazione.<br />
Per quanto riguarda i bisogni dei cittadini immigrati si rileva come il problema della casa sia centrale.<br />
Infatti, dai dati in possesso dei Comuni e degli Sportelli emerge una situazione preoccupante circa la non<br />
disponibilità di alloggi o posti letto per i cittadini stranieri.<br />
Accanto ai bisogni primari (casa, lavoro, ect..) risalta la necessità di favorire l’accesso dei cittadini stranieri<br />
ai servizi pubblici e privati di natura sociale, sanitarie, educativa ed orientativa.<br />
5. Obiettivi, priorità e risultati attesi<br />
Dall’analisi dei servizi esistenti e dei bisogni emergenti nonché delle linee guida della circolare regionale n.<br />
48 del 27 ottobre 2005, si individuano una gamma di obiettivi e priorità da realizzare nel triennio di<br />
validità del Piano che si possono raggruppare nelle seguenti tipologie:<br />
• obiettivi strategici;<br />
• obiettivi di sistema (trasversali alle aree d’intervento);<br />
• obiettivi di salute riferiti a ciascuna area d’intervento con l’indicazione delle priorità e dei risultati<br />
attesi.<br />
5.2. Gli obiettivi di sistema<br />
Gli obiettivi di sistema comprendono tutti gli aspetti inerenti l’organizzazione del sistema, dalla definizione<br />
delle rete, al coordinamento delle risorse interne ed esterne, alle modalità di accesso e governo delle rete,<br />
all’integrazione di responsabilità, professionalità e competenze.<br />
La realtà <strong>territoriale</strong> dell’area distrettuale meratese appare caratterizzata da una diffusa e consolidata<br />
presenza di servizi e attività a forte valenza assistenziale ed educativa.<br />
Un sistema integrato di servizi già fortemente consolidato nella sua struttura portante vede crescere nel<br />
contesto <strong>territoriale</strong> un altrettanto forte domanda di qualificazione e di qualità.<br />
Per il primo aspetto dovranno essere delle azioni di sistema a garantire il miglioramento della rete legato<br />
alla professionalizzazione delle risposte ai bisogni.<br />
Il miglioramento qualitativo della rete dovrà essere perseguito attraverso l’implementazione e<br />
strutturazione della dimensione “relazionale” dei servizi e degli interventi:<br />
• la ricerca e la definizione dei raccordi e delle integrazioni;<br />
• la domiciliarità come sostegno alle risorse informali e della famiglia;<br />
7
• l’allargamento sistematico del confronto e della collaborazione con le diverse espressioni del<br />
privato sociale e dell’associazionismo.<br />
Occorre proseguire da un lato, con maggiore sistematicità, il percorso di confronto avviato con alcuni<br />
progetti di leggi di settore nel precedente Piano e, dall’altro individuare nuovi protocolli operativi.<br />
Inoltre è necessario prevedere, a medio termine, una centratura che tenga conto dei cambiamenti di natura<br />
istituzionale e legislativa, in atto alla rete dei servizi diurni e residenziali “tradizionali” (DGR. N. 18334 del<br />
23/07/2004; DGR. N. 20588 del 11/2/2205; DGR. N. 20762 del 16/02/2005; DGR. N. 20763 del<br />
16/02/2005). Spetterà ai singoli tavoli di coordinamento e di confronto, previsti in ogni area d’intervento,<br />
approfondire i nuovi scenari e riposizionare queste unità d’offerta nella rete di servizi del territorio.<br />
5.2.1. Integrazione socio-sanitaria<br />
L’integrazione socio-sanitaria prevede, per la sua compiuta attuazione, approcci e paradigmi differenziati,<br />
non solo attinenti alla dimensione istituzionale e interistituzionale ma anche i profili organizzativi –<br />
gestionali della costituzione / funzionamento dei gruppi di lavoro.<br />
Obiettivo strategico:<br />
• Realizzare un sistema integrato di interventi e servizi, attraverso modalità di coordinamento ed<br />
integrazione tra gli attori coinvolti nella realizzazione del sistema.<br />
Priorità 1:<br />
• Attuazione degli adempimenti previsti dal documento “Gruppo di lavoro: DPCM 14 febbraio<br />
2001” (si veda allegato A)<br />
Risultati attesi:<br />
• Individuazione del modello operativo relativo alla gestione della casistica dei minori (se modello<br />
proposto dall’<strong>ASL</strong> di “consulenza strutturata” oppure se modello proposto dai referenti UdP di<br />
“équipes multi disciplinare”);<br />
• stesura e sottoscrizione di un accordo di programma tra <strong>ASL</strong>, Consiglio di Rappresentanza,<br />
Assemblee Distrettuali, differenziato per settori (minori/famiglia; disabili, anziani …) e/o<br />
problematiche differenziate per Piani di Zona.<br />
Gestione: associata a livello provinciale.<br />
Tempi: 2006, 2007.<br />
Priorità 2:<br />
• Attuazione dei protocolli d’intesa fra i Comuni della provincia di <strong>Lecco</strong>, l’Azienda Ospedaliera di<br />
<strong>Lecco</strong>, l’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> e l’Amministrazione Provinciale relativi alle seguenti aree della salute<br />
mentale:<br />
o area della territorialità, per gli interventi di natura socio-assistenziale e di integrazione<br />
sociale e lavorativa;<br />
o area della residenzialità.<br />
Gestione: associata a livello provinciale.<br />
Tempi: 2006, 2007, 2008.<br />
Priorità 3:<br />
• Definizione di un piano di continuità assistenziale finalizzato alla verifica dell’integrazione tra il<br />
sociale e il sanitario soprattutto per gli ambiti materno-infantile, anziani e fragilità.<br />
Risultato atteso:<br />
• Verifica della sostenibilità economica ed organizzativa di servizi socio-sanitari integrati gestiti in<br />
forma associata.<br />
Tempi: 2007, 2008.<br />
5.3. Gli obiettivi di salute: priorità e risultati attesi nelle aree d’intervento<br />
Sono quegli obiettivi riferiti alle aree di programmazione definite a livello distrettuale che comprendono<br />
tutto ciò che attiene ai servizi, prestazioni, interventi e progetti diretti a favore dei singoli, delle famiglie o<br />
di gruppi specifici.<br />
5.3.3. Adulti in difficoltà<br />
Area emarginazione sociale, povertà, dipendenze, salute mentale<br />
Obiettivo strategico:<br />
• Attivare interventi a contrasto alla povertà e di reinserimento delle persone con problematiche di<br />
dipendenza con un insieme di prestazioni integrate di tipo socio-educativo.<br />
Livelli Essenziali:<br />
• Consolidamento ed ampliamento dei centri di accoglienza e di contrasto alla povertà.<br />
Dimensione promozionale e preventiva<br />
Priorità 1:<br />
• Coordinamento degli sportelli a livello provinciale che valorizzi gli apporti degli sportelli locali,<br />
attraverso una forte collaborazione fra Enti Locali ed Associazioni.<br />
8
Risultati attesi:<br />
• condivisione univoca sui criteri d’accesso e dell’utilizzo delle risorse;<br />
• implementazione del lavoro di rete già avviato nel precedente piano e promozione degli stessi;<br />
• stesura di una carta dei servizi per gli immigrati unica sul territorio.<br />
Gestione: associata a livello distrettuale e provinciale.<br />
Tempi: 2006, 2007, 2008.<br />
Dimensione assistenziale e di reinserimento sociale<br />
Priorità 1:<br />
• Gestione coordinata delle risorse economiche per interventi individualizzati d’inserimento<br />
lavorativo e di reinserimento sociale per soggetti con fragilità psico-sociali, ex carcerati,<br />
psichiatrici, dipendenze da sostanze …<br />
Risultati attesi:<br />
• criteri omogenei nell’erogazione di contributi economici di minimo vitale;<br />
• adozione dello schema di convenzione tipo per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati<br />
predisposto dalla Regione Lombardia<br />
• attuazione della “Convenzione Protocollo per gestione fasce deboli” con la Provincia di <strong>Lecco</strong><br />
Tempi di realizzazione: 2006, 2007, 2008.<br />
Priorità 2:<br />
• Valutazione della necessità di attivare servizi di prima necessità (mensa, doccia, dormitorio,…)<br />
rivolti alla popolazione povera/gravemente emarginata<br />
Risultato atteso:<br />
• stesura di un progetto di fattibilità con il coinvolgimento del terzo settore<br />
Tempi realizzazione: 2007, 2008<br />
Priorità 3:<br />
• Attuazione del protocollo d’intesa tra i Comuni della provincia di <strong>Lecco</strong>, l’Azienda Ospedaliera di<br />
<strong>Lecco</strong>, l’<strong>ASL</strong> e l’Amministrazione Provinciale per gli interventi di natura socio-assistenziale e di<br />
integrazione sociale e lavorativa<br />
Risultato atteso:<br />
• realizzazione di servizi e prestazioni rivolti ai singoli e/o a gruppi come da protocollo.<br />
Gestione: associata a livello provinciale.<br />
Tempi: 2006, 2007, 2008.<br />
Priorità 4:<br />
• Attuazione del Protocollo d’intesa tra i Comuni della provincia di <strong>Lecco</strong>, l’Azienda Ospedaliera di<br />
<strong>Lecco</strong>, l’<strong>ASL</strong> e l’Amministrazione provinciale per l’area tematica della residenzialità<br />
Risultati attesi:<br />
• realizzazione di tutti gli interventi previsti dal protocollo in stretta connessione con il servizio<br />
sociale comunale;<br />
• ampliamento della collaborazione tra gli operatori sanitari e i servizi sociali comunali.<br />
Gestione: associata a livello provinciale.<br />
Tempi: 2006, 2007, 2008.<br />
9
PREMESSA<br />
Estratto del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Bellano<br />
(seconda triennalità 2006/2008) riguardanti la Salute Mentale<br />
3. AREA SALUTE MENTALE<br />
Tale area comprende il campo del disagio psichico e delle problematiche ad esso collegate. Sul territorio del Distretto<br />
di Bellano è operativa una sede del Centro Psico-Sociale (CPS) di <strong>Lecco</strong> appartenente al Dipartimento di Salute<br />
Mentale dell’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong> che si trova presso l’Ospedale Umberto I di Bellano - orario 8.30/1700 dal<br />
lunedì al venerdì (tel. 0341.829325). Sul territorio sono attivi due ambulatori: Introbio (martedì mattina) e Mandello<br />
(giovedì mattina) all’interno dei distretti <strong>ASL</strong>. Il personale in organico è il seguente: 2 medici psichiatri, 1 psicologopsicoterapeuta,<br />
1 caposala con presenza settimanale, 1 educatore prof., 4 infermieri prof. (di cui 1 part-time) e 1<br />
assistente sociale.<br />
Al fine di fornire un quadro generale rispetto all’emergere delle patologie psichiatriche sul territorio del Distretto di<br />
Bellano, si riportano alcuni dati inerenti l’utenza in carico al CPS nell’arco degli ultimi quattro anni (2002/20005).<br />
Rilevazione attività sede CPS area Distrettuale di<br />
Bellano<br />
2002 2003 2004 2005<br />
Pazienti con almeno una prestazione … 739 681 664 707<br />
… di cui al primo contatto con la struttura 264 208 185 182<br />
SERVIZI- INTERVENTI TERRITORIALI<br />
SERVIZIO SOCIALE DI BASE<br />
E’ presente in ogni comune e permette di integrare le risorse della psichiatria con quelle del territorio tramite progetti<br />
personalizzati. La necessità di una stretta collaborazione con il territorio viene sancita anche tramite l’Atto d’Intesa per<br />
la realizzazione e l’attuazione di interventi nell’area salute mentale in Provincia di <strong>Lecco</strong>, atto approvato dall’<strong>ASL</strong> di<br />
<strong>Lecco</strong>, dall’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong>, dalla Provincia e dalle Assemblee Distrettuali di Bellano, <strong>Lecco</strong> e Merate.<br />
Per meglio attuare gli interventi a tutela della salute mentale previsti nell’Atto d’intesa, gli enti firmatari hanno<br />
condiviso l’elaborazione di protocolli operativi e precisamente:<br />
-Area tematica della territorialità : Protocollo tra i soggetti firmatari dell’Atto d’Intesa per gli interventi di natura socioassistenziale<br />
e di integrazione sociale e lavorativa;<br />
-Area tematica della residenzialità : Protocollo con linee guida per gli interventi di tipo residenziale.<br />
Per quanto concerne le modalità tecnico-operative emerge la richiesta di costituire un tavolo tecnico distrettuale di<br />
confronto per declinare nella pratica il protocollo operativo riguardante gli interventi di natura socio-assistenziali e di<br />
integrazione sociale e lavorativa e fornire eventuali suggerimenti.Si veda inoltre lo specifico capitolo dedicato al<br />
Servizio Sociale di Base.<br />
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE<br />
Il SAD è attivo su tutto il Distretto di Bellano, seppur con notevoli differenze rispetto alle prestazioni erogate e ai<br />
progetti attivati. Da parte del personale ausiliario (ASA) emerge una necessità formativa specifica rispetto al settore<br />
“psichiatria”, mentre per gli operatori psichiatrici c’è la necessità di poter usufruire di un servizio “flessibile”, in grado<br />
di rispondere ai bisogni dell’utenza psichiatrica. Tale risorsa permette infatti un concreto supporto all’autonomia delle<br />
persone e favorisce una migliore qualità di vita.<br />
10
FONDO SOCIALE PSICHIATRIA<br />
Tale Fondo, assegnato sulla base delle risorse L. 328/00, prevede la possibilità di attivare alcuni importanti interventi a<br />
favore di pazienti psichiatrici. L’attivazione di queste risorse si inserisce all’interno di un progetto personalizzato<br />
elaborato dall’équipe curante ed in “sintonia” con i servizi sociali territoriali. Nello specifico, le principali aree<br />
d’intervento sono:<br />
Sostegno economico - (contributi economici straordinari a sostegno dell’autonomia della persona, NON in sostituzione<br />
delle competenze proprie dell’ente locale, ma all’interno di una progettualità condivisa con i servizi sociali di base);<br />
Soggiorni estivi e/o ricreativi - (tale possibilità tende sempre più a concretizzarsi tramite la collaborazione con le<br />
associazioni di volontariato, in particolare Asvap e Psiche Lombardia di <strong>Lecco</strong>);<br />
Inserimenti lavorativi - (attivazione di percorsi di tirocinio o borsa lavoro per favorire l’inserimento o il reinserimento<br />
di soggetti con problematiche psichiatriche. Nello specifico si provvede all’attivazione della posizione INAIL ed<br />
all’erogazione di un corrispettivo mensile);<br />
Pronto intervento assistenziale – (servizio attivato con l’obiettivo di evitare il ricorso improprio a ricoveri in strutture<br />
psichiatriche a fronte di bisogni assistenziali. Il servizio viene attuato attraverso specifica convenzione tra l’<strong>ASL</strong> e la<br />
Coop. Arcobaleno che gestisce la comunità “Casa Abramo” di <strong>Lecco</strong>. Il servizio è attivo unicamente per un’utenza<br />
maschile);<br />
Assistenza Domiciliare Educativa – (tale servizio offre la possibilità di attivare risorse educative che integrano le<br />
prestazioni degli operatori del CPS nell’attuazione di progetti domiciliari).<br />
(Si veda tabella finale)<br />
La psichiatria ha contatti anche con altre risorse del territorio, non specifiche per l’area salute mentale, ma trasversali<br />
al disagio adulto. Si veda pertanto il paragrafo dedicato alle SERVIZI –INTERVENTI AREA DISAGIO ADULTO.<br />
ASVAP – Sede operativa presso il centro ricreativo “Il Girasole” di <strong>Lecco</strong>, via Ghislanzoni 28. Tel 0341/350195. Email<br />
asvaplecco@asvap.it - sito internet www.asvap.it<br />
L’associazione gestisce “Il Girasole”, centro ricreativo che intende favorire la risocializzazione delle persone con<br />
disagio psichico, organizza incontri di formazione e sostegno per i familiari e gruppi di auto-aiuto.<br />
PSICHE LOMBARDIA<br />
Sede operativa Via Paolo VI , 29 –23900 LECCO.<br />
Tel. 0341/499.782, cell. 347/4900799; Winfax 0341499782. E-mail vfacchetti@tin.it<br />
L’Associazione Psiche Lombardia – Sezione di <strong>Lecco</strong> ha attivato il progetto “INSIEME PER E CON NOI” finanziato<br />
dalla Regione Lombardia in relazione al bando 2005 – L.R. 23/99 (Politiche Regionali per la famiglia), valevole per il<br />
territorio di <strong>Lecco</strong> e Provincia.<br />
Il progetto intende promuovere la costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto tra famigliari di persone psicosofferenti e<br />
attivare interventi di sostegno psicoeducativo alla loro famiglia, in modo particolare durante l’esordio della malattia e il<br />
ricovero per acuzie in ospedale.<br />
Inoltre è attivo a <strong>Lecco</strong> il laboratorio relazionale “IL MULINO A VENTO” aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15:00<br />
alle 17:00 dove vengono svolte attività di bricolage e artistiche di vario genere a cui potrebbero accedere anche persone<br />
psicosofferenti del distretto di Bellano residenti in zone che accedono facilmente a <strong>Lecco</strong>.<br />
SESTO SENSO<br />
Sede operativa Via Papa Giovanni XXIII n. 2 - BELLANO<br />
Tel. 0341 - 810350<br />
Si occupa di attività artistiche, culturali e di sensibilizzazione sul territorio del Distretto di<br />
Bellano.<br />
TABELLA DI SINTESI<br />
11
SERVIZIO /<br />
INTERVENTO<br />
Servizio Sociale<br />
di Base<br />
Servizio<br />
di Assistenza<br />
Domiciliare<br />
Inserimenti<br />
Lavorativi<br />
Sostegno<br />
alle famiglie<br />
Fondo sociale<br />
Psichiatria<br />
-<br />
Pronto Intervento<br />
Assistenziale<br />
STATO<br />
RAGGIUNGIMENTO<br />
OBIETTIVI PRIMA<br />
TRIENNALITA’<br />
Servizio attivato su tutto il<br />
territorio del Distretto di<br />
Bellano.<br />
AREA SALUTE MENTALE<br />
Disomogeneità a<br />
livello <strong>territoriale</strong><br />
nell’erogazione di<br />
tale servizio.<br />
Parzialmente<br />
raggiunto<br />
l’obiettivo di un<br />
coordinamento degli<br />
operatori domiciliari<br />
con quelli del CPS.<br />
Positiva collaborazione con<br />
la Coop. “Larius” di Colico;<br />
presenza di una nuova<br />
risorsa: Coop. “Di Mano in<br />
Mano Solidale” con sede a<br />
Ballabio.<br />
Attivo il centro di ascolto<br />
telefonico per il disagio<br />
psichico dell’associazione<br />
“Ti Ascolto” di Pasturo.<br />
Non raggiunto l’obiettivo<br />
dell’istituzione di un posto<br />
letto per donne a livello<br />
provinciale.<br />
BISOGNI<br />
EMERGENTI<br />
OBIETTIVI<br />
SECONDA<br />
TRIENNALITA’<br />
Valutata positivamente la Incrementare i rapporti tra Servizio<br />
ricaduta sul territorio, si Sociale di Base e Servizio<br />
riscontra la necessità di un Psichiatrico attraverso la<br />
potenziamento del Servizio, strutturazione di incontri periodici<br />
anche in considerazione della per la definizione dei progetti<br />
particolarità <strong>territoriale</strong> del d’intervento.<br />
distretto e dell’aumento dei<br />
bisogni.<br />
Garantire su tutto il territorio<br />
la possibilità di usufruire di<br />
tale servizio, favorendo lo<br />
sviluppo di una prestazione<br />
flessibile ai bisogni<br />
dell’utenza psichiatrica.<br />
Emerge inoltre un chiaro<br />
bisogno di formazione da<br />
parte del personale ASA in<br />
merito a questa materia.<br />
Difficoltà nel trovare spazi per<br />
percorsi di borsa lavoro o<br />
tirocinio, oltre a “soluzioni<br />
lavorative stabili” successive a<br />
tali percorsi.<br />
Il servizio telefonico non è<br />
stato utilizzato da parte della<br />
popolazione in generale.<br />
Emerge la richiesta di<br />
maggior presenza del Servizio<br />
psichiatrico sul territorio.<br />
Permane a livello provinciale<br />
la necessità di tale risorsa.<br />
Corso di formazione per il<br />
personale ASA (da poter<br />
sviluppare a livello provinciale).<br />
Sensibilizzazione dei comuni in<br />
merito a tale servizio, al fine di<br />
sviluppare una copertura<br />
<strong>territoriale</strong> completa e rispondente<br />
ai bisogni dei soggetti con<br />
problematiche psichiatriche.<br />
Sostegno alle coop. per gli<br />
inserimenti lavorativi che<br />
necessitano di un costante contesto<br />
“protetto”; istituzione di un tavolo<br />
tecnico distrettuale tra provincia,<br />
comuni e servizio psichiatrico per<br />
integrare gli interventi in ambito<br />
lavorativo.<br />
Valutare la necessità di maggior<br />
informazione alla popolazione<br />
rispetto a tale risorsa ed<br />
eventualmente collegarsi con<br />
realtà già esistenti e strutturate (ex.<br />
Ass.ne Itaca).<br />
Strutturazione di momenti di<br />
ascolto sul territorio promossi<br />
dall’ass.ne Psiche Lombardia<br />
(progetto “Insieme … per e con<br />
noi”, finanziato con fondi legge<br />
regionale 23/99).<br />
Si ripropone tale obiettivo per il<br />
triennio 2006-2008.<br />
Fondo sociale Raggiunto l’obiettivo di un Si sottolinea l’importanza di Mantenere i rapporti fra CPS e<br />
12
Psichiatria fondo distinto per il Distretto<br />
di Bellano, oltre al<br />
mantenimento di un rapporto<br />
con l’Ufficio di Piano e i<br />
componenti dell’Esecutivo<br />
Associazioni:<br />
attività/iniziative<br />
per il tempo libero<br />
Distrettuale.<br />
Collaborazione con le<br />
associazioni Asvap di <strong>Lecco</strong>,<br />
Psiche Lombardia di <strong>Lecco</strong><br />
e Sesto Senso di Bellano.<br />
SERVIZI INTERVENTI TERRITORIALI<br />
SERVIZIO SOCIALE DI BASE<br />
mantenere tali rapporti anche<br />
in futuro, anche in<br />
considerazione dei<br />
cambiamenti istituzionali in<br />
atto.<br />
Maggior raccordo con il<br />
territorio e con le altre realtà<br />
dell’associazionismo;<br />
necessità di maggiori<br />
opportunità per il tempo<br />
libero.<br />
1.2 AREA DISAGIO ADULTO<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
Si veda capitolo del Piano di Zona specifico sul Servizio Sociale di Base;<br />
Analisi e osservazioni;<br />
Nell’ambito del disagio adulto, l’intervento dell’Assistente Sociale si configura essenzialmente in<br />
tre tipologie:<br />
- invio ai servizi specialistici;<br />
- sostegno economico straordinario;<br />
- assistenza abitativa d’emergenza.<br />
organi tecnico-istituzionali del<br />
Distretto di Bellano.<br />
Momenti di coordinamento fra le<br />
varie associazioni.<br />
Attivazione di iniziative/azioni di<br />
sensibilizzazione nell’ambito del<br />
territorio distrettuale.<br />
Descrizione del servizio intervento<br />
Convenzione Servizio Fasce Deboli promossa dalla Provincia di <strong>Lecco</strong>, Settore Politiche per l’impiego e rivolta agli<br />
ambiti distrettuali per attività di accompagnamento al lavoro di persone in condizioni di svantaggio sociale. Gli<br />
interventi anche propedeutici sono finalizzati all’inserimento lavorativo (temporaneo e/o definitivo) di soggetti<br />
svantaggiati. La valenza di questa risorsa è trasversale a tutte e tre le sub- aree considerate.<br />
Per meglio articolare e strutturare la collaborazione fra enti firmatari è stato predisposto un protocollo operativo.<br />
Soggetti erogatori<br />
Provincia di <strong>Lecco</strong>, Settore Politiche per l’impiego<br />
Via Balicco, 63 23900 –<strong>Lecco</strong>.<br />
Tel. 0341/295532-3 fax 0341295591<br />
Tipologia di utenza<br />
Ex tossicodipendenti, ex alcoldipendenti, minori e giovani a rischio di emarginazione, soggetti psichiatrici, soggetti con<br />
gravi disturbi di alimentazione, soggetti adulti con gravi situazioni di indigenza o fragilità personali, disabili, ex<br />
detenuti.<br />
TELEFONO DONNA<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
Fornisce consulenza psicologica con operatrici d’accoglienza e consulenza legale a donne in difficoltà per situazioni di<br />
violenza psicologica, fisica e sessuale.<br />
L’Unione Donne Italiane (U.D.I.) realizza inoltre iniziative di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla<br />
violenza nella famiglia e nella coppia; mantiene rapporti con le istituzioni su progetti specifici rivolti alle donne.<br />
Tipologia di utenza<br />
Donne in difficoltà per situazioni di violenza psicologica, fisica e sessuale.<br />
Soggetti erogatori<br />
13
Il Telefono Donna di <strong>Lecco</strong> – U.D.I. Tel. 0341- 493985 FAX 0341- 363484<br />
“VILLA MAGGIO”<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
E’ una realtà poco strutturata che accoglie vari tipi di disagio (adulti in difficoltà, anziani autosufficienti, minori, adulti<br />
senza fissa dimora, ecc.).<br />
Soggetti erogatori<br />
Ha sede a Mandello del Lario. E’gestito dalla Fondazione Famiglia dell’Ave Maria.<br />
Tel. 0341 - 731231 e-mail: villamaggioaccoglienza@virgilio.it<br />
Analisi e osservazioni<br />
Il territorio è quasi totalmente privo di risorse residenziali per le urgenze abitative temporanee e contingenti.<br />
COMUNITA’ ALLOGGIO “CASA S. GIUSEPPE” (comunità per mamme con bambini)<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
La comunità alloggio mamme con bambini “Casa S Giuseppe”, della coop. soc. “Casa del Giovane”, si trova a<br />
Vendrogno via Roma, 31 -23838- (LC).<br />
La nostra comunità si propone di aiutare le mamme a recuperare quella serenità di fondo che permette loro di assumere<br />
un ruolo genitoriale sufficiente per garantire una continuità non traumatica del vivere insieme ai propri figli.<br />
L’intervento di sostegno e di recupero delle funzioni genitoriali viene svolto mantenendo in modo esplicito la gestione<br />
educativa dei minori da parte della madre e sollecitando la sua responsabilità in un contesto di supporto che è graduato a<br />
seconda delle risorse e dei bisogni della madre, e delle risorse e dei bisogni del figlio.<br />
La comunità opera attraverso un’ équipe educativa formata da un responsabile, da un coordinatore e da operatori<br />
professionali.<br />
Tipologia di utenza<br />
Accoglie, in forma residenziale donne, (capienza: n. 10 posti) italiane e straniere, con figli minori a carico, in situazione<br />
di necessità; bisognose di sostegno per situazioni di abbandono, di maltrattamento o di difficoltà nella tutela e/o nel<br />
mantenimento dei figli. In comunità non vengono accolte donne con problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di<br />
alcoldipendenza.<br />
Soggetti erogatori<br />
Coop. soc. “Casa del Giovane” Pavia. Per informazioni rivolgersi a Pomi Fausto, Via Roma 31<br />
23838 Vendrogno –LC- Tel: 0341 870159 Fax: 0341 811598 E-mail: cgiglio@cdg.it<br />
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA NOTTURNA (Progetto Domus)<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
Il Centro di Prima Accoglienza Notturna (C.P.A.N.) del Comune di <strong>Lecco</strong> ha la possibilità di ospitare, limitatamente<br />
alle ore notturne, anche le persone italiane che si trovino in grave stato di disagio sociale per un massimo di 6 posti.<br />
Tipologia di utenza<br />
Persone italiane che si trovino in grave stato di disagio sociale per mancata autonomia e autosufficienza socioeconomica,<br />
ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 1/86.<br />
Soggetti erogatori<br />
Il Comune di <strong>Lecco</strong> attraverso il C.P.A.N. collegato ai “Servizi per l’Immigrazione”.<br />
COOP. LARIUS – COLICO<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
La Cooperativa Sociale Larius, nata nel 1998 su iniziativa del Comune di Colico e del Sert di Bellano, è ubicata in un<br />
territorio fra tre Province: LECCO, COMO, SONDRIO, ricco di paesi situati in zone montane (Valsassina, Valvarrone<br />
), di pianura (Bassa Valtellina) ed in zone di lago (Riviera del lago di Como).<br />
14
Svolge la propria attività volta all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ( in base all’art. 4 della L 381/91); dal<br />
suo nascere la Cooperativa ha sempre privilegiando i rapporti con gli Enti Locali, attraverso Convenzioni dirette e<br />
collaborando con le varie realtà territoriali specialistiche e di volontariato, per garantire un ambito lavorativo il più<br />
vicino possibile alle esigenze delle persone segnalate.<br />
Gli enti pubblici e privati con cui la Cooperativa collabora sono:<br />
- Centro Psico – Sociale , Unità di Psichiatria dell’Ospedale di <strong>Lecco</strong> e di Morbegno;<br />
- Servizio Disabili dell’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> e di Morbegno (SO);<br />
- Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli della Provincia di <strong>Lecco</strong>;<br />
- Servizi Sociali dei Comuni del Distretto di Bellano e alcuni del Distretto di Morbegno;<br />
- Associazione Comunità “Il Gabbiano”;<br />
- Caritas di Colico;<br />
Le attività della Cooperativa Larius si svolgono grazie a contratti stipulati con Enti Pubblici e Privati per la gestione di<br />
mense scolastiche ed aziendali, per servizi di pulizia per amministrazioni pubbliche e ditte private, per servizi di<br />
guardiania, per gestione di visite guidate e gestione bar.<br />
I rapporti di lavoro attualmente si svolgono con Provincia di <strong>Lecco</strong> – Istituzione Villa Monastero, con i Comuni di<br />
Colico,Piantedo, Dervio, Vestreno, Introzzo, Tremenico, Bellano, Unione dei Comuni della Valvarrone.<br />
Tipologia di utenza<br />
Persone svantaggiate secondo l’art. 4 della L 381/91: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti<br />
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione<br />
di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.<br />
Oltre a questi soggetti, si presentano in Cooperativa alla ricerca di un lavoro :<br />
- adulti in situazione di grave difficoltà economica;<br />
- adulti con disagio psichico non certificato;<br />
- extracomunitari in situazione di bisogno lavorativo e/o disagio familiare, alcuni dei quali necessitano di<br />
regolarizzare il proprio permesso di soggiorno;<br />
- donne (> 35 anni), anche con figli, in situazione di disagio lavorativo e/o familiare, che necessitano di un<br />
orario flessibile.<br />
Le segnalazioni dei soggetti svantaggiati sociali provengono da vari Servizi Specialistici dislocati sul territorio del<br />
Distretto di Bellano (LC) e della Provincia di Sondrio.<br />
Analisi ed osservazioni<br />
L’intervento socio-lavorativo attuato in questi anni dalla Cooperativa Sociale ha permesso l’integrazione di alcuni<br />
soggetti svantaggiati che difficilmente sarebbero riusciti a trovare un ambito di lavoro adeguato alle proprie necessità:<br />
intervento di sostegno personalizzato per situazioni critiche emerse da poco o cronicizzate negli anni , flessibilità<br />
nell’organizzazione del lavoro in funzione dei loro specifici bisogni, presa in carico globale della persona, con<br />
interventi che esulano dallo specifico lavorativo, ma che raggiungono anche l’ambito familiare e sociale (qui la<br />
collaborazione con il Servizio inviante è indispensabile).<br />
Emerge la necessità di maggiori risorse in termini di opportunità di collocamento per attuare nuovi inserimenti<br />
lavorativi.<br />
La Cooperativa Larius è ubicata a Colico, in Via Parravicini 20/c .<br />
Tel. 0341.941688 - Fax 0341.931392 – E-mail coop.larius@virgilio.it<br />
Obiettivi e priorità<br />
Rafforzare la collaborazione con tutti gli Enti Pubblici e Privati e le Associazioni del territorio al fine di costruire<br />
insieme progetti di opportunità lavorative per le persone inviate in Cooperativa dai Servizi.<br />
Valutare l’opportunità di usufruire di spazi attualmente sottoutilizzati (di proprietà pubblica) per creare nuovo lavoro,<br />
mediante la predisposizione di appositi progetti da realizzarsi nel Distretto di Bellano.<br />
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS MANDELLO<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
Il centro d’ascolto offre agli adulti in difficoltà e agli immigrati che vi si rivolgono uno spazio di accoglienza, ascolto,<br />
orientamento e accompagnamento, entrando in contatto con le problematiche quotidiane delle persone, offrendo un<br />
punto di riferimento a coloro che sono in difficoltà e mettendosi a disposizione di quanti hanno bisogno di essere<br />
ascoltati e guidati.<br />
Inoltre la parrocchia Sacro Cuore di Mandello del Lario ha due mini alloggi per una prima accoglienza di emergenza,<br />
per un tempo massimo di un mese e a titolo gratuito. Gli alloggi sono di proprietà della parrocchia del Sacro Cuore e<br />
sono gestiti dalla Caritas Zonale tramite un’apposita commissione.<br />
Per l’occupazione di questi mini alloggi si fa riferimento al regolamento diocesano (diocesi di Como).<br />
15
Presso la Parrocchia del Sacro Cuore è presente anche un servizio di distribuzione di abiti, stoviglie, mobili usati ecc..<br />
Questo servizio non è gestito dal Centro di Ascolto.<br />
Soggetti erogatori<br />
Il Centro d’ascolto ha sede presso la Parrocchia Sacro Cuore di Mandello del Lario, in piazza Sacro Cuore n.5. Gli orari<br />
di apertura sono il martedì mattina dalle 9,30 alle 11,30 e il sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30.<br />
Telefono e fax: 0341-733774 e-mail: cdamandello@caritas.it<br />
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS COLICO<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
Lo Sportello Caritas di Colico è stato aperto per agevolare le persone bisognose del territorio che richiedono un aiuto<br />
agli operatori volontari della Caritas; è collegato con Centro di ascolto e di aiuto della Caritas – Bassa Valtellina.<br />
La Caritas ha come primo obiettivo la sensibilizzazione della comunità cristiana attraverso gli strumenti del Centro di<br />
Ascolto, l’Osservatorio della Povertà, le Commissioni di studio della realtà.<br />
In modo specifico lo Sportello della Caritas di Colico (come quello di Morbegno) accoglie le persone dando spazio<br />
all’ascolto, informandole sulle risorse e sui vari servizi già presenti sul territorio analizzando i problemi e progettando<br />
insieme all’interessato una possibile soluzione.<br />
Tipologia di utenza<br />
Famiglie o singoli, italiani ed extracomunitari, in gravi difficoltà economiche e relazionali, alla ricerca di una<br />
sistemazione abitativa e/o lavorativa; soggetti che si sentono soli ad affrontare problematiche specifiche.<br />
Soggetti erogatori<br />
Operatori volontari provenienti dalle varie parrocchie del territorio sostenuti dalla consulenza di esperti in vari settori.<br />
Lo Sportello Caritas di Colico è aperto tutti i lunedì dalle 9.30 alle 11.30, presso la parrocchia S. Giorgio. Per<br />
informazioni si può chiamare il Centro di Ascolto di Morbegno (0342/61.55.34)<br />
Analisi ed osservazioni<br />
Il servizio si propone di rafforzare i rapporti con gli Enti Territoriali e specialistici, condividendo e analizzando i vari<br />
problemi: prendersi carico e accompagnare chi si trova in situazione di disagio psichico ; indirizzare i soggetti in carico<br />
alle risorse già presenti sul territorio ed ai Servizi preposti sollecitando nuove risposte, sia pubbliche che private.<br />
Continuare nella erogazione di contributi e aiuti materiali (pacco viveri, vestiario, mobilio, prestiti, ecc…).<br />
Come priorità d’ intervento, la Caritas sta attuando il progetto della costruzione di un Centro di Accoglienza per<br />
persone con problemi abitativi ( il Centro si troverà a Morbegno, ma potranno accedervi anche soggetti provenienti<br />
dall’area di Colico).<br />
C.A.V. DI MANDELLO<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
Il C.A.V., Centro di Aiuto alla Vita Onlus di Mandello del Lario, si occupa di fornire assistenza a donne in attesa, a<br />
madri e coppie con minori in difficoltà.<br />
Questo ente si occupa di organizzare anche incontri formativi e culturali rivolti alla popolazione. Nonché gestire il<br />
Centro Aiuto alla Vita.<br />
Inoltre raccoglie e consegna indumenti per bambini e materiale d'uso (lettini, carrozzine ecc.).<br />
Il C.A.V. mantiene rapporti con enti pubblici (Comune di Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Lierna) e gruppi di<br />
volontariato (Caritas, C.I.F., San Vincenzo, Acli).<br />
Soggetti erogatori<br />
Centro Aiuto alla Vita<br />
Sede: Piazza Sacro Cuore, 5 Mandello del Lario (presso Parrocchia Sacro Cuore)<br />
Tel./Fax 0341 - 733180<br />
Apertura: martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00<br />
CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO - C.O.E.<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
16
Il Centro Orientamento Educativo è un'associazione di laici volontari cristiani impegnati in Italia e in altri Paesi del<br />
mondo nella formazione. Riconosciuto Organismo idoneo alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, attiva e<br />
sostiene progetti di volontariato internazionale e opera in Italia per la formazione a una nuova mentalità interculturale e<br />
alla solidarietà.<br />
Soggetti erogatori<br />
COE, via Milano 4 Barzio<br />
Telefono 0341-996453<br />
Fax 0341-910311<br />
E-mail: coebarzio@coweb.org<br />
SOCIETÀ SAN VINCENZO DE’ PAOLI<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
Queste realtà legate alle parrocchie operano nella prima assistenza ai più bisognosi. Forniscono aiuto alle persone e ai<br />
nuclei familiari poveri tramite la distribuzione di pacchi viveri, interventi per pagamento medicinali, rate affitto,<br />
bollette, utenze.<br />
Assistono e disbrigano pratiche burocratiche. Svolgono servizio di assistenza di prima accoglienza ai cittadini stranieri.<br />
Collaborano con le istituzioni e le altre associazioni di volontariato.<br />
Soggetti erogatori<br />
I gruppi attivi operano Bellano, Mandello del Lario e Premana.<br />
Conferenza S.Vincenzo Bellano-Piazza San Giorgio-23822 –Bellano Tel. 0341/820545;<br />
Conferenza S.Dionigi Via Reppublica, 14 -23834 –Premana Tel.0341/576108;<br />
Parrocchia San Lorenzo, Piazza S. Lorenzo, 11 -23826 – Mandello Lario cell. 340-1507631.<br />
CASA ABRAMO<br />
Descrizione del servizio-intervento<br />
La comunità “Casa Abramo”, inaugurata nel 1996, accoglie adulti in situazione di difficoltà, marginalità, disagio, o<br />
coloro i quali hanno vissuto l’esperienza carceraria, per sviluppare percorsi individuali di recupero e di<br />
risocializzazione.<br />
E’ una comunità educativa residenziale, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento secondo la Legge Regionale<br />
1/86 e può accogliere fino a 14 adulti maschi.<br />
Soggetti erogatori<br />
La comunità, gestita dalla Cooperativa L’Arcobaleno, ha sede a <strong>Lecco</strong> in via Montalbano 9.<br />
Telefono 0341-251074<br />
17
TABELLA DI SINTESI AREA DISAGIO ADULTI<br />
SERVIZIO/<br />
INTERVENTO<br />
Servizio sociale<br />
di base<br />
Centro<br />
d’accoglienza per<br />
adulti<br />
Soggetti non<br />
residenti<br />
OBIETTIVI/PRIORITA’<br />
PDZ 2004/2004 E STATO DI<br />
RAGGIUNGIMENTO<br />
Potenziamento del servizio,<br />
favorendo la presenza fisica<br />
degli operatori nei vari<br />
comuni.<br />
Attuato su tutto il territorio del<br />
Distretto di Bellano.<br />
Creazione di strutture<br />
residenziali ad utenza<br />
sovracomunale per le urgenze<br />
abitative<br />
BISOGNI EMERGENTI OBIETTIVI SECONDA<br />
TRIENNALITA’<br />
Individuare corrette modalità<br />
di interazione e<br />
collaborazione tra i servizi<br />
specialistici, il volontariato e<br />
il Servizio sociale di base<br />
Mancano, in alcuni casi,<br />
indicazioni precise circa la<br />
possibilità d’accesso ai<br />
servizi di persone che non<br />
hanno la residenza sul<br />
territorio.<br />
18<br />
Individuare, sulla base di<br />
esperienze concrete, modalità di<br />
lavoro che possano diventare<br />
prassi operative di<br />
collaborazione tra servizi<br />
specialistici, volontariato e<br />
servizio sociale di base<br />
Creazione di strutture<br />
residenziali ad utenza<br />
sovracomunale per le urgenze<br />
abitative<br />
Favorire l’accessibilità ai servizi<br />
anche da parte di persone non<br />
residenti, almeno per quanto<br />
concerne i LEA.
Responsabile<br />
S.I.T.R.A<br />
Dr.ssa A. Cazzaniga<br />
R esp. R iabilit.<br />
Signora<br />
R. Scaramelli<br />
Responsabile S.S.D.<br />
Area di <strong>Lecco</strong><br />
Dr. R . G adaldi<br />
S.S.D<br />
Area di <strong>Lecco</strong><br />
STRUTTURA: SPDC <strong>Lecco</strong><br />
Sede operativa<br />
Ospedale Manzoni <strong>Lecco</strong><br />
Tel. 0341 489175<br />
STRUTTURA: CPS <strong>Lecco</strong><br />
Sedi operative:<br />
III PARTE<br />
Cap. 2<br />
DSM: ORGANIGRAMMA E UNITA’ D’OFFERTA<br />
Direttore Sanitario Azienda<br />
Ospedale <strong>Lecco</strong><br />
Dr. A Zoli<br />
R.A.D.<br />
Sign. J.C.<br />
Floriani<br />
<strong>Lecco</strong> - Tel. 0341 489181<br />
Bellano - Tel. 0341 829325<br />
Mandello - Tel. 0341 489181<br />
Introbio - Tel. 0341 829325<br />
Calolziocorte - Tel.0341 489181<br />
Oggiono - Tel. 0341 489181<br />
Responsabile Strutture<br />
Sanitarie Territoriali<br />
D r. G . Barbaglio<br />
Responsabile S.S.D .<br />
Area di Merate<br />
Dr.ssa G. Colombo<br />
Legenda:<br />
S.S.D. = Struttura Semplice Dipartimentale<br />
S.S.F. = Struttura Semplice Funzionale<br />
Direttore Generale Azienda<br />
Ospedale <strong>Lecco</strong><br />
Dr. P. Caltagirone<br />
Responsabile D.S.M<br />
Dr.ssa B. Pinciara<br />
Responsabile S.S.D.<br />
Area Riabilitazione<br />
Dr. F. Rossi<br />
Aree e Strutture<br />
S.S.D.<br />
Area di Merate<br />
STRUTTURA: SPDC Merate<br />
Sede operativa<br />
Ospedale Mandic Merate<br />
Tel. 039 5916493<br />
STRUTTURA: D.H. Merate<br />
Sede operativa<br />
Ospedale Mandic Merate<br />
Tel. 039 5916493<br />
STRUTTURA: CPS Merate<br />
Sede operativa Merate<br />
Tel. 039 9902293<br />
Direttore Am m inistrativo Azienda<br />
Ospedale <strong>Lecco</strong><br />
Dr. ssa I.G alluzzo<br />
Direttore Attività Amministrative<br />
Dipartimenti<br />
Dr. A. Albonico<br />
Segreteria DSM<br />
Signora G.Verzeri<br />
Responsabile Qualità<br />
Dr. D. Chianese<br />
Responsabile Formazione<br />
Dr. G . Orlando<br />
Responsabile S.S.F.<br />
Psicologia C linica<br />
Dr. V. Rigamonti<br />
Responsabile Area Sociale<br />
Dr.ssa D. Puccia<br />
S.S.D.<br />
Area R iabilitazione<br />
STRUTTURA: CRA Garbagnate<br />
Garbagnate Rota<br />
Tel. 031 865460<br />
STRUTTURA: CRA Cernusco<br />
Cernusco Lombardone<br />
Tel. 039 9901298<br />
STRUTTURA: CPM Garlate<br />
Garlate<br />
Tel.0341 681451<br />
STRUTTURA: CPM Casatenovo<br />
Casatenovo<br />
Tel. 039 9275289<br />
STRUTTURA: CD Merate<br />
Merate<br />
Tel. 039 9900358<br />
STRUTTURA: CD <strong>Lecco</strong><br />
<strong>Lecco</strong><br />
Tel. 0341 288064
EQUIPE<br />
Dr.ssa Barbara Pinciara<br />
Direttore Dipartimento Salute Mentale<br />
(<strong>Lecco</strong>) Direttore Struttura Complessa<br />
(sede Merate)<br />
bpinciara.merate@ospedale.lecco.it<br />
Sig.ra Giuseppina Verzeri Segretaria Dipartimento Salute Mentale<br />
Responsabile Struttura Semplice<br />
g.verzeri@ospedale.lecco.it<br />
Dr. Romolo Gadaldi<br />
Gestionale Dipartimentale<br />
Coordinamento Area di <strong>Lecco</strong><br />
r.gadaldi@ospedale.lecco.it<br />
Dr. PierLuigi Taroni Dirigente Medico - SPDC <strong>Lecco</strong> p.taroni@ospedale.lecco.it<br />
Dr.ssa Silvia Confalonieri Dirigente Medico - SPDC <strong>Lecco</strong><br />
Dr.ssa Antonella Spreafico Dirigente Medico - SPDC <strong>Lecco</strong><br />
Dr. Flavio Colombo Dirigente Medico - SPDC <strong>Lecco</strong><br />
Dr.ssa Susanna Brambilla Dirigente Medico - CPS <strong>Lecco</strong><br />
Dr. Enrico Bedina Dirigente Medico - CPS <strong>Lecco</strong><br />
Dr. Giovanni Orlando Dirigente Medico - CPS <strong>Lecco</strong><br />
Dr.ssa Liliana Allevi Dirigente Medico - CPS <strong>Lecco</strong><br />
Dr. Mario Lanfranconi Dirigente Medico - CPS <strong>Lecco</strong><br />
Dr. Giuseppe Giunta Dirigente Medico - CPS Bellano<br />
Dr. Giovanni Somenzini Dirigente Medico - CPS Bellano<br />
Responsabile Struttura Semplice<br />
Dr.ssa Giovanna Colombo Gestionale Dipartimentale Coordinamento gi.colombo@ospedale.lecco.it<br />
Area di Merate<br />
Dr. Diego Chianese Dirigente Medico - SPDC Merate d.chianese@ospedale.lecco.it<br />
Dr. ssa Alessandra Ferrara Dirigente Medico - SPDC Merate<br />
Dr. Sergio Surace Dirigente Medico - SPDC Merate<br />
Dr. Paolo F. Tommesani Dirigente Medico – CPS Merate<br />
Dr.ssa Sara Caparrelli Dirigente Medico – CPS Merate<br />
Dr. Giuseppe Zecca Dirigente Medico – CPS Merate<br />
Dr.ssa Luigia Bocciarelli<br />
Dirigente Medico – CPS Merate<br />
Dr. Fulgenzio Rossi<br />
Responsabile Struttura Semplice<br />
Gestionale Dipartimentale<br />
Coordinamento Attività Riabilitative<br />
Dr. Cesare Savino Dirigente Medico – CRA Garbagnate R.<br />
Dr.ssa Simonetta Martini Dirigente Medico - CRA Cernusco L.<br />
Dr. Cesare Savino Dirigente Medico - CD <strong>Lecco</strong><br />
Dr. Sara Caparrelli Dirigente Medico – CD Merate<br />
Sig.ra Nadia Manzoni Coordinatore Coop.l’Arcobaleno – CPM Garlate<br />
Sig.ra Alessandra Mazzei<br />
(Sig.ra Rossella Farina)<br />
Coord. Coop.l’Arcobaleno – CPM Casatenovo<br />
Responsabile Struttura Semplice<br />
Dr. Vittorio Rigamonti<br />
Funzionale Dipartimentale<br />
Coordinamento Attività Psicologica<br />
Dr.ssa Evita Tommasella Dirigente Psicologo CPS <strong>Lecco</strong>/Dip. Cuore<br />
Dr. Enrico Magni Dirigente Psicologo CPS Bellano<br />
Dr.ssa Laura Gandolfo Dirigente Psicologo CPS <strong>Lecco</strong><br />
Dr.ssa M. Grazia Masini Dirigente Psicologo CRA Cernusco/CPS Merate<br />
Dr.ssa Carmen Baldi Dirigente Psicologo CPS Merate<br />
Dr.ssa Donatella Puccia<br />
Sig.ra Noemi Arcelli<br />
Sig.ra Alessia Montanelli<br />
Sig.ra Lieta Romeri<br />
Dr.ssa Cristiana Sacchi<br />
Sig. Sandro Frara<br />
Sig. Jean Claude Floriani<br />
Sig.ra Barbara Baggio<br />
Responsabile Area Sociale<br />
Assistente Sociale<br />
Assistente Sociale (maternità)<br />
Assistente Sociale<br />
Assistente Sociale<br />
Assistente Sociale<br />
Responsabile Area Dipartimentale<br />
Coordinatore CRA Garbagnate R.<br />
fulros@mediacom.it<br />
d.puccia@ospedale.lecco.it<br />
Sig.ra Nadia Signorelli Facente funzione Coordinatore SPDC <strong>Lecco</strong> n.signorelli@ospedale.lecco.it<br />
Sig.ra Giuseppina Magatti Coordinatore – CPS <strong>Lecco</strong>; Bellano, cps.lecco@ospedale.lecco.it<br />
Sig.ra Monica Riva Coordinatore SPDC e CPS Merate psichiatria.merate@ospedale.lecco.it<br />
Sig.ra Rosa Pini<br />
Sig.ra Gianna Cerasoli<br />
Coordinatore CRA Cernusco L.<br />
Coordinamento Personale Riabilitazione
STRUTTURA<br />
NUMERI UTILI ORARI DI APERTURA<br />
Segreteria<br />
Reparto di degenza <strong>Lecco</strong> (SPDC)<br />
Tel: + (39) 0341 489 171 – 170<br />
Tel: + (39) 0341 489 175<br />
Dal lun al ven dalle 9:00 alle16:00<br />
24 h. su 24<br />
Reparto di degenza Merate (SPDC) Tel: + (39) 039 5916 494 24 h. su 24<br />
Day-Hospital Merate<br />
Centro Psico Sociale <strong>Lecco</strong> (CPS)<br />
Ambulatorio Oggiono (CPS <strong>Lecco</strong>)<br />
Centro Psico Sociale Bellano (CPS)<br />
Ambulatorio Mandello (CPS Bellano)<br />
Ambulatorio Introbio (CPS Bellano)<br />
Centro Psico Sociale Merate (CPS)<br />
Centro Residenziale Garbagnate R.<br />
Tel: + (39) 039 5916 493<br />
Tel: + (39) 0341 489 181<br />
Tel: + (39) 0341 267 920<br />
Tel: + (39) 0341 829 111<br />
Tel: + (39) 0341 739.415<br />
Tel: + (39) 0341 983.322<br />
Tel: + (39) 039 99 02 299-293<br />
Tel: + (39) 031 865 460<br />
Dal lun al ven dalle 9:00 alle15:00<br />
Dal lun al ven dalle 8:30 alle18:00<br />
Sabato 8:30 alle 12:00<br />
Lun Mer Ven dalle 9:00 alle12:00<br />
Dal lun al ven dalle 8:30 alle17:00<br />
Giovedì dalle 8:30 alle 12:30<br />
Martedì dalle 9:00 alle 12:00<br />
Dal lun al ven dalle 8:30 alle18:00<br />
Sabato 8:30 alle 12:30<br />
24 h. su 24<br />
(CRA)<br />
Centro Residenziale Cernusco L. (CRA) Tel: + (39) 039 99 01 612 24 h. su 24<br />
Comunità Protetta Garlate (CPM) Tel: + (39) 0341 68 1451 24 h. su 24<br />
Comunità Protetta Casatenovo(CPM) Tel: + (39) 039 92 75 289 24 h. su 24<br />
Centro Diurno Merate Tel: + (39) 039 99 00 358 Dal lun al ven dalle 9:00 alle16:00<br />
Centro Diurno <strong>Lecco</strong> Tel: + (39) 039 28 80 64 Dal lun al ven dalle 8:30 alle18:00<br />
Sabato 9:00 alle 12:30<br />
L'ATTIVITÀ CLINICA si articola in<br />
o attività di degenza ospedaliera per l’acuzie<br />
o attività di Day-Hospital<br />
o attività <strong>territoriale</strong> (ambulatoriale e domiciliare), con i seguenti percorsi di cura: consulenza,<br />
assunzione in cura e programmi integrati di presa in carico<br />
o attività residenziale a diverso gradiente riabilitativo-assistenziale<br />
o attività semiresidenziale con finalità riabilitativo - risocializzante<br />
PUNTI DI FORZA DELLA STRUTTURA<br />
La Struttura Complessa di Psichiatria individua come sua finalità prendersi cura di pazienti con patologie<br />
psichiatriche gravi, definendo Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDT) e Piani di Trattamento Individuali<br />
(PTI).<br />
L’attività clinica, articolata nei diversi presidi/strutture del DSM, prevede:<br />
attività di lavoro in équipe secondo il modello dell’integrazione funzionale, con il coinvolgimento e<br />
la partecipazione di tutte le figure professionali e l’utilizzo delle differenti funzioni<br />
per trattare i molteplici problemi correlati alla patologia psichiatriche (sociali, familiari…);<br />
formulazione di piani di trattamento individuali e percorsi diagnostico terapeutici finalizzati a<br />
ridurre la cronicizzazione dei pazienti e uniformare la qualità delle prestazioni;<br />
integrazione attraverso il lavoro di rete con le altre agenzie del territorio e con le famiglie<br />
(MMG, <strong>ASL</strong>, Volontariato…);<br />
riduzione al minimo delle istituzionalizzazioni attraverso attività di riabilitazione e risocializzazione,<br />
per mantenere il paziente con un sufficiente stato di autonomia, all’interno del territorio di<br />
appartenenza.
III PARTE<br />
Cap. 3<br />
<strong>ASL</strong> PER LA SALUTE MENTALE<br />
IL PIANO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO AZIENDALE<br />
PREMESSA<br />
Il Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale è un documento formale ad uso interno ed<br />
esterno, che evidenzia il modello organizzativo dell’Azienda Sanitaria della Provincia di <strong>Lecco</strong> e la<br />
strategia che la stessa si è data.<br />
La “strategia” è il raggio d’azione di un’azienda nel lungo termine che, idealmente, combina le sue<br />
risorse con i cambiamenti dell’ambiente in cui opera e in particolare con il mercato interno, gli<br />
utenti dei servizi, e le aspettative degli stakeholder 1 .<br />
Il Piano Strategico fissa la natura della mission dell’organizzazione, gli obiettivi e le azioni messe in<br />
campo dalla Direzione per conseguirli e, a cascata, dai diversi livelli del management aziendale. Il<br />
La Mission dell’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong><br />
La “mission” di una organizzazione è la finalità istituzionale per la quale l’organizzazione è sorta e<br />
che connota gli obiettivi di lungo periodo che la stessa si attribuisce.<br />
Per l’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> la “mission aziendale” è volta a rafforzare la funzione di programmazione,<br />
acquisto e controllo delle prestazioni socio-sanitarie, nonché a consolidare la funzione “propria” di<br />
governo della domanda e di vigilanza e controllo degli erogatori accreditati.<br />
La missione strategica consiste nel dare soddisfazione ai bisogni e alle aspettative della salute dei<br />
cittadini, assicurando, in conformità degli obiettivi posti dagli atti di pianificazione nazionali e<br />
regionali, livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nel rispetto dei seguenti principi:<br />
- sussidiarietà orizzontale e verticale<br />
- appropriatezza, efficacia e qualità delle prestazioni di prevenzione e cura<br />
- integrazione delle risposte<br />
- dignità, tempestività, equità e libertà di accesso<br />
- economicità ed efficienza nella gestione delle risorse<br />
- formazione continua del personale<br />
al fine di:<br />
• Orientare i programmi e le attività dell’Azienda e delle altre strutture erogatrici di prestazioni<br />
Sanitarie a rispondere alla domanda di salute, presente nell’ambito <strong>territoriale</strong>, individuando le<br />
priorità e garantendo prestazioni efficaci accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno nel<br />
momento in cui si rendono necessarie.<br />
• Porre il cittadino utente al centro dell’attività Aziendale, orientando i Servizi e gli operatori alla<br />
risoluzione dei problemi dell’utente a cui deve essere garantita la continuità dei percorsi<br />
diagnostico assistenziali.<br />
• Raccordare le iniziative e le attività socio-sanitarie con le indicazioni regionali, consultando gli<br />
Enti Locali e i loro organismi di rappresentanza.<br />
La pianificazione strategica, da cui deriva l’assetto organizzativo (struttura e sistemi operativi), è<br />
essenziale per l’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> per comunicare con gli stakeholder e ottenere un assenso collettivo<br />
interno all’organizzazione; fornisce poi una base per ottenere e allocare le risorse, identifica i passi<br />
specifici dell’azione e ne definisce i tempi e, infine, fornisce gli standard di performance da<br />
confrontare con gli effettivi progressi.<br />
1 Il collegamento tra strategia e stakeholders (interni ed esterni) introduce fortemente anche nella pubblica amministrazione il<br />
concetto di “ACCOUNTABILITY”, ossia la necessità per l’azienda pubblica di rendere conto ai propri portatori d’interessi<br />
(stakeholders), in modo trasparente ed esaustivo,delle proprie azioni e dei risultati.
In riferimento al governo della domanda, alla funzione di programmazione delle funzioni sociosanitarie<br />
e alla pianificazione strategica, l’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> riconosce quale passaggio importante la<br />
verifica con gli Enti Locali e i loro organismi di rappresentanza<br />
La struttura organizzativa dell’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> è composta da Distretti, Dipartimenti, Servizi ed<br />
Uffici. Sulla base delle responsabilità attribuite dalla Direzione Generale e gestite dalla stessa<br />
articolazione organizzativa, queste si caratterizzano per essere strutture complesse o strutture<br />
semplici nell’ambito dell’organigramma dell’Azienda Sanitaria Locale.<br />
I Dipartimenti Aziendali sono sei:<br />
• Dipartimento di Prevenzione Medica, dipartimento funzionale a cui afferiscono i servizi<br />
delle aree di igiene e sanità pubblica e di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro<br />
• Dipartimento di Prevenzione Veterinario, dipartimento funzionale a cui afferiscono i<br />
servizi dell’area di medicina veterinaria<br />
• Dipartimento delle Cure Primarie, dipartimento funzionale a cui afferiscono i servizi<br />
dell’area assistenza sanitaria primaria e farmaceutica e che assume il coordinamento dei<br />
Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta<br />
• Dipartimento per le Attività Socio-Sanitarie Integrate (A.S.S.I), dipartimento funzionale<br />
a cui afferiscono i servizi dell’area socio-sanitaria e delle tossicodipendenze<br />
• Dipartimento della Fragilità, dipartimento funzionale, a cui afferiscono i servizi dell’area<br />
delle cure domiciliari di base, sanitarie e di alta intensità<br />
• Dipartimento di Programmazione, Acquisto e Controllo, dipartimento funzionale a cui<br />
afferiscono i servizi dell’area di programmazione, acquisto, valutazione delle prestazioni<br />
sanitarie e socio-sanitarie.<br />
I Distretti Socio-Sanitari ed i Distretti Veterinari sono tre: Distretto di <strong>Lecco</strong>, Distretto di Merate,<br />
Distretto di Bellano.<br />
LA SALUTE MENTALE NEL POFA DELL’<strong>ASL</strong> DI LECCO<br />
RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI PROGRAMMAZIONE, ACQUISTO E CONTROLLO<br />
E’ fondamentale per la tutela della Salute Mentale nel territorio della Provincia di <strong>Lecco</strong> il ruolo del<br />
Dipartimento di Programmazione, Acquisto e Controllo (P.A.C)<br />
Il Dipartimento di Programmazione, Acquisto e Controllo è un dipartimento funzionale<br />
intraziendale a cui sono assegnate le funzioni di programmazione acquisto e controllo delle<br />
prestazioni prodotte dagli erogatori accreditati.<br />
Le suddette funzioni richiedono l’integrazione tra i Servizi del Dipartimento e i Distretti Socio<br />
Sanitari finalizzata ad assicurare il collegamento tra programmazione e controllo dell’offerta di<br />
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e governo della domanda, per la definizione del budget di<br />
distretto. A tal fine il Comitato di Dipartimento, come di seguito definito, comprende, quali<br />
componenti, i Distretti Socio-Sanitari che assicurano il supporto nella definizione dei contratti con<br />
le strutture erogatrici e nel monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate.<br />
La funzione di governo dell’attività erogativa è realizzata attraverso i seguenti interventi di analisi e<br />
valutazione delle attività assistenziali prodotte nel territorio finalizzati alla lettura della domanda di<br />
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie:<br />
‐ Definizione delle priorità in termini di allocazione delle risorse,<br />
‐ Verifica della qualità dei servizi<br />
‐ Promozione dell’appropriatezza delle prestazioni<br />
‐ Controllo della dinamica dei costi mediante l’applicazione dei criteri di compatibilità<br />
economica rispetto alle risorse disponibili.
Il Dipartimento PAC assicura alla Direzione Generale il supporto tecnico professionale per la<br />
definizione delle linee strategiche e delle politiche di acquisto e controllo delle prestazioni<br />
specialistiche e socio-sanitarie garantendo il raccordo con gli organismi di staff della Direzione<br />
Aziendale e l’integrazione con i Dipartimenti ed i Servizi sanitari ed amministrativi aziendali per le<br />
specifiche competenze.<br />
Le linee di intervento proprie del Dipartimento sono rappresentate dai processi di:<br />
- monitoraggio e lettura degli indicatori di domanda e di offerta di prestazioni sanitarie<br />
specialistiche, socio-sanitarie e socio-assistenziali<br />
- verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle<br />
strutture erogatrici pubbliche e private accreditate<br />
- negoziazione dei contratti con le citate strutture sulla base degli indici programmatori regionali<br />
- valutazione e controllo della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate in nome e<br />
per conto del servizio sanitario regionale<br />
- gestione dei rapporti economici e delle procedure inerenti la remunerazione delle prestazioni<br />
sanitarie specialistiche, socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate dai soggetti pubblici e<br />
privati accreditati.<br />
L’insieme delle funzioni e delle attività descritte garantiscono il diritto dei cittadini ad<br />
un’assistenza quanti-qualitativa adeguata ai bisogni. Tale diritto si realizza attraverso i soggetti<br />
e le strutture dei comparti socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari autorizzati e accreditati che<br />
costituiscono la rete dei servizi del territorio provinciale.<br />
Lo svolgimento delle funzioni assegnate al Dipartimento comporta lo sviluppo e l’esercizio di<br />
specifiche competenze professionali sanitarie ed amministrative articolate in aree di attività:<br />
- Servizio Programmazione, Acquisto, Valutazione delle prestazioni sanitarie<br />
- Servizio Accreditamento, Vigilanza, Valutazione delle prestazioni socio-sanitarie.<br />
Servizio Programmazione, Acquisto, Valutazione delle prestazioni sanitarie<br />
Svolge le seguenti linee di attività:<br />
Accreditamento e controllo prestazioni e strutture sanitarie specialistiche<br />
• Verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle<br />
strutture erogatrici di prestazioni sanitarie specialistiche in regime di ricovero ed ambulatoriale<br />
• Monitoraggio delle dotazioni organiche e dei livelli di assistenza<br />
• Effettuazione delle attività di vigilanza programmate e su segnalazione in merito ai requisiti<br />
strutturali ed organizzativi<br />
• Programmazione ed effettuazione dei controlli sull’appropriatezza delle prestazioni<br />
specialistiche di ricovero e ambulatoriali sulla base delle linee guida emanate dalla Regione<br />
• Monitoraggio degli indicatori di produzione e consumo di prestazioni specialistiche a supporto<br />
delle attività del servizio e delle funzioni di programmazione del dipartimento<br />
Acquisto prestazioni e gestione contratti<br />
• Predisposizione contratti e relative integrazioni con le strutture accreditate<br />
• Predisposizione atti per la liquidazione delle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale,<br />
psichiatria e gestione dei relativi rapporti con strutture erogatrici, Aziende Sanitarie Locali,<br />
Uffici Regionali<br />
• Monitoraggio dei volumi di attività e verifica degli adempimenti e indicazioni alle strutture<br />
erogatrici per la corretta applicazione della normativa contrattuale e di sistema<br />
• Predisposizione atti amministrativi in materia di accreditamento, contratti, saldi, tempi d’attesa,<br />
attività di vigilanza e controllo<br />
Servizio Accreditamento, Vigilanza, Valutazione delle prestazioni socio-sanitarie<br />
Svolge seguenti linee di attività :
Vigilanza e Controllo Qualità Prestazioni:<br />
• Verifica e vigilanza sul possesso e il mantenimento dei requisiti gestionali e strutturali delle<br />
strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari<br />
• Controllo e validazione dell’appropriatezza e qualità delle prestazioni ed attività socio-sanitarie<br />
e socio-assistenziali erogate da soggetti pubblici e privati sottoposti ad autorizzazione al<br />
funzionamento e/o accreditati<br />
• Istruttoria dei provvedimenti di autorizzazione del funzionamento delle strutture socio-sanitarie<br />
ed espressione dei pareri per il relativo accreditamento<br />
• Espressione dei pareri per l’autorizzazione del funzionamento delle strutture socio-assistenziali<br />
Accreditamento e Contratti:<br />
• Validazione del debito informativo delle strutture socio-sanitarie, finalizzato al controllo<br />
contabile e amministrativo dei dati relativi alla valorizzazione delle prestazioni rese e fatturate<br />
dalle strutture accreditate per la liquidazione a carico del bilancio socio-sanitario<br />
• Monitoraggio degli indicatori di domanda, offerta e produzione delle prestazioni socio-sanitarie<br />
per la predisposizione dei Contratti con i soggetti accreditati ed a supporto delle altre attività del<br />
servizio e delle funzioni di programmazione del dipartimento<br />
• Predisposizione dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra <strong>ASL</strong> e<br />
strutture accreditate sulla base degli indici programmatori regionali e il monitoraggio delle<br />
condizioni previste.<br />
Il Servizio Accreditamento, Acquisto, Controllo delle prestazioni socio-sanitarie mantiene un<br />
raccordo con il Dipartimento ASSI nell’ambito di protocolli concordati con il Dipartimento PAC in<br />
materia di:<br />
- programmazione delle attività di controllo e verifica<br />
- procedure amministrative per la liquidazione delle remunerazioni tariffarie per le<br />
prestazioni rese dagli enti accreditati<br />
- individuazione dei volumi di prestazioni da contrattualizzare con gli enti accreditati in<br />
relazione alla rilevazione del fabbisogno ed alle disponibilità del Bilancio socio-sanitario<br />
- partecipazione di operatori del Dipartimento ASSI alle verifiche di appropriatezza e qualità<br />
delle prestazioni socio-sanitarie.<br />
RUOLO DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE INTEGRATE<br />
(A.S.S.I.)<br />
All’attività del Dipartimento P.A.C. si affianca per l’alta valenza sociale quella del Dipartimento<br />
per le Attività Socio-Sanitarie Integrate (A.S.S.I.)<br />
Il Dipartimento ASSI, dipartimento funzionale costituito dall’insieme dei Servizi ad esso afferenti,<br />
garantisce a livello aziendale l’integrazione delle attività socio-sanitarie.<br />
Le linee strategiche e programmatiche fortemente innovative del PSSR 2002-2004, comportano e<br />
propongono una profonda revisione delle funzioni e degli assetti organizzativi del Dipartimento<br />
ASSI. Nel prossimo triennio, ma per alcuni aspetti già a breve termine, il Dipartimento ASSI dovrà<br />
attuare una trasformazione organizzativa, in linea con il passaggio dalla gestione alla "governance",<br />
per operare quindi nel nuovo scenario interistituzionale risultante dal quadro normativo nazionale e<br />
regionale di riforma, sanitaria e sociale, in raccordo con i Comuni, i soggetti privati profit e non<br />
profit, in raccordo con le aziende di servizi alla persona (ASP), derivanti dalla trasformazione delle<br />
IPAB.<br />
Tale riorganizzazione dovrà altresì tenere conto dei principi enunciati nel citato PSSR 2002-2004<br />
che possono essere così richiamati:
• quelli definiti nel Regolamento regionale di funzionamento del Dipartimento ASSI, del giugno<br />
1999, rivisti sulla base delle nuove indicazioni fornite dall’U.O. Programmazione della<br />
Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale<br />
• il rafforzamento delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo (PAC) del sistema<br />
socio-sanitario, vale a dire, la necessità di:<br />
− una programmazione il più possibile integrata con i vari soggetti, istituzionali e non,<br />
partecipi del sistema<br />
− pervenire alla metodica “contrattazione/acquisto” di servizi e prestazioni, come<br />
strumento di governo e di regolazione del sistema<br />
− espletare tutte le forme di controllo: istituzionale, tecnico-qualitativo ed<br />
amministrativo, utili a tutelare e garantire il cittadino.<br />
• la sperimentazione di forme di esternalizzazione graduale dei servizi e/o delle prestazioni oggi<br />
a gestione diretta <strong>ASL</strong><br />
• la distinzione tra organi preposti alle funzioni di governo/controllo e organi preposti alle<br />
funzioni di produzione/erogazione delle prestazioni<br />
• la distrettualizzazione delle funzioni di produzione ed erogazione dei servizi e delle prestazioni:<br />
in tale contesto va inserita anche la funzione di interfaccia con gli uffici di Piano dei comuni ai<br />
sensi della l. 328/2000<br />
• la necessità di assicurare le funzioni di assistenza socio-sanitaria integrata e di garantire i livelli<br />
essenziali di assistenza (LEA) alla popolazione al fine di consentire ai cittadini di poter<br />
esercitare il proprio diritto di libertà di scelta .<br />
Il Dipartimento ASSI si articola nelle seguenti strutture organizzative:<br />
• Servizio Programmazione Sociale<br />
• Servizio Famiglia, Infanzia ed Età Evolutiva<br />
• Servizio Disabili ed Anziani<br />
• Servizio Tossicodipendenze<br />
• Servizio Alcoologia.<br />
Servizio Disabili ed Anziani<br />
Il Servizio Disabili e Anziani è una struttura semplice del Dipartimento ASSI.<br />
Il Servizio Disabili e Anziani si occupa di una fascia di popolazione (i soggetti stessi e le loro<br />
famiglie) estremamente fragile e che necessita di interventi e servizi specifici, non erogati per la<br />
totalità della popolazione, in collaborazione con il Dipartimento della Fragilità.<br />
Obiettivi principali sono:<br />
- la tutela della salute dei disabili attraverso la promozione di un sistema integrato di interventi e<br />
servizi con lo scopo di sviluppare al massimo le potenzialità residue e favorire l’integrazione<br />
sociale dei soggetti disabili<br />
- la tutela della salute degli anziani attraverso lo sviluppo di politiche assistenziali tra loro integrate,<br />
che ritardino il più possibile l’istituzionalizzazione sostenendo ed aiutando le famiglie, anche alla<br />
luce dei diversi percorsi socio-assistenziali attivati dal Dipartimento della Fragilità.<br />
E’ importante, ai fini di una razionalizzazione delle risorse, mettere in rete e raccordare i diversi<br />
interventi messi in atto dai servizi territoriali in un’ottica di programmazione dei servizi e di<br />
progettualità individuale.<br />
Attività del Servizio<br />
L’attività del Servizio è rivolta alle seguenti linee professionali (aree di attività):<br />
1. Attività socio-sanitarie e integrazione con neuropsichiatria infantile e psichiatria
• Programmazione dei servizi socio-sanitari a favore di soggetti disabili, controllo qualitativo<br />
delle attività e delle prestazioni erogate<br />
• Gestione programma SIDI, in collaborazione con il Servizio Accreditamento e Vigilanza,<br />
per l’applicazione delle nuove normative regionali<br />
• Collaborazione, per quanto di specifica competenza, con l'Ufficio Leggi di Settore<br />
• Prosecuzione delle Unità Multidisciplinari (UMD) con protocollo d’intesa con la A.O, per le<br />
prestazioni relative all’integrazione scolastica e all’integrazione sociale<br />
• Gestione dell’ accordo di programma con l’A. O. e con i Comuni per interventi a carattere<br />
socio-sanitario integrato a tutela della salute mentale.<br />
2. Anziani:<br />
• Programmazione delle politiche socio-sanitarie a favore degli anziani, raccordo con le RSA,<br />
collaborazione nelle politiche di sostegno a favore delle famiglie<br />
• Programmazione delle attività di Pronto intervento e Telesoccorso.<br />
3. Attività delegate:<br />
• Gestione delegata, dai comuni e dall’Amministrazione Provinciale, degli interventi socioassistenziali,<br />
riabilitativi e di risocializzazione dei disabili<br />
• Centri socio Educativi<br />
• Inserimenti lavorativi (disabili e fasce deboli)<br />
• Interventi socio assistenziali di cui alla legge 67/93 :<br />
Le varie prestazioni vengono erogate a livello centrale o a livello distrettuale, a seconda della loro<br />
tipologia.<br />
- Livello centrale: quelle di carattere programmatorio e gestionale per garantire le funzioni di<br />
indirizzo, supporto e controllo tecnico e professionale, con particolare riferimento ai processi di<br />
formazione del personale<br />
- Livello distrettuale: consulenza al singolo, alle famiglie, alle istituzioni; attività diagnostica; presa<br />
in carico dei soggetti; sostegno psicologico e/o psicoterapeutico ai disabili e alle loro famiglie;<br />
certificazioni per l’invalidità civile.<br />
RUOLO DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI<br />
Una importante funzione di analisi <strong>territoriale</strong> dei bisogni e delle risposte è svolta dai Distretti<br />
Socio-Sanitario.<br />
La finalità del Distretto Socio-Sanitario è di assicurare alla popolazione residente le prestazioni, in<br />
quantità e qualità, previste dai livelli di assistenza indicati dai piani Sanitari e dalla Legislazione<br />
Nazionale e Regionale nell’ambito delle strategie Aziendali2 e dagli indirizzi tecnico professionali<br />
dati dai Servizi.<br />
Il Distretto Socio-Sanitario configurandosi come Area sistema, grazie alla simultanea presenza dei<br />
tre momenti specifici di intervento (sanitario, socio-sanitario e sociale) e alla complementarità delle<br />
reti di offerta, rappresenta la dimensione idonea per conoscere la domanda di salute e di benessere<br />
sociale per coordinare ed integrare i soggetti erogatori favorendo le relative sinergie.<br />
I Distretti dell’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> assicurano: - la corretta gestione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria,<br />
dell'educazione sanitaria, dell'informazione, della prevenzione e delle attività socioassistenziali;<br />
- il governo della domanda di specialistica ambulatoriale e farmaceutica, in<br />
collaborazione coi medici di medicina generale ed i comitati distrettuali previsti; - il raccordo con i<br />
2 Nell’ambito del Budget assegnato dal Direttore Generale, il Distretto è dotato di autonomia Economico Finanziaria, con contabilità separata<br />
all’interno del bilancio Aziendale, nonché Autonomia Gestionale per lo svolgimento delle proprie funzioni e il conseguimento degli obiettivi<br />
Aziendali ivi compreso il coordinamento organizzativo ed erogativo delle attività (art 9 comma 7. LR 31/97).
Comuni per l’integrazione tra servizi socio-sanitari e servizi sociali come strutturati nel Piano di<br />
Zona; - la garanzia dell’attività di informazione all’utenza e di accesso al SSR.<br />
L’efficace esercizio della funzione del Distretto, quale centro di riferimento sanitario della comunità<br />
locale, presuppone una completa e costante valorizzazione del ruolo delle Autonomie Locali. In tale<br />
ottica, l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci esplica funzioni consultive e propositive sulla<br />
programmazione distrettuale delle attività formulata dal Direttore di Distretto e sul livello di<br />
soddisfazione dei bisogni di salute rispetto i servizi erogati.<br />
Il Distretto si caratterizzata quindi come “area della produzione” articolata in più sedi dove sono<br />
erogati servizi alla persona, definiti dai LEA. Il Distretto compartecipa alla programmazione e<br />
all’espletamento di funzioni di acquisto e controllo dei servizi/prestazioni alla persona delegati, dal<br />
punto di vista organizzativo, ai Distretti Socio-Sanitari.<br />
L’<strong>ASL</strong> si articola in tre Distretti individuati tenendo conto delle caratteristiche territoriali, delle<br />
realtà organizzative, della presenza di Presidi Sanitari e dei relativi flussi di utilizzo:<br />
‐ Distretto di Bellano<br />
‐ Distretto di <strong>Lecco</strong><br />
‐ Distretto di Merate<br />
I Distretti si articolano in zone territoriali nelle quali sono presenti uno o più Presidi Sanitari<br />
dell’<strong>ASL</strong> dove vengono erogate tutte le attività di primo accesso dell’utenza al Servizio Sanitario.<br />
Le zone costituiscono un ambito privilegiato di fattiva partecipazione dei Comuni.<br />
COORDINAMENTO DELL’OCSM DELLA PROVINCIA DI LECCO<br />
Il Piano Regionale triennale per la salute mentale in attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale<br />
2002-2004 – DGR n. VII/17513 del 17 maggio 2004, prevede che le <strong>ASL</strong> istituiscano gli organismi<br />
di coordinamento per la salute mentale, e alle stesse <strong>ASL</strong> è data la funzione di coordinamento di<br />
tale organismo, nella persona del Direttore sanitario o suo delegato.<br />
L’<strong>ASL</strong> di <strong>Lecco</strong> ha istituito tale organismo con delibera 710 del 22/12/2004 affidando il<br />
coordinamento al Responsabile del Servizio di Programmazione Sociale del Dipartimento A.S.S.I.<br />
Nel corso dell’anno 2005, sono così stati prodotti e approvati i seguenti documenti:<br />
- “Protocollo di intesa area tematica della residenzialità”;<br />
- Documento tecnico “Il sistema residenzialità”;<br />
- “Prime indicazioni operative per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi riabilitativi di<br />
pazienti inseriti in strutture residenziali”;<br />
che definiscono quadro d’offerta, modalità di accesso alle strutture e criteri di appropriatezza dei<br />
percorsi di cura in funzione dei bisogni clinici dei pazienti.<br />
E’ stata inoltre istituita, come previsto dal regolamento dell’OCSM, un’équipe<br />
multidisciplinare per la valutazione dell’appropriatezza dei programmi riabilitativi su singoli<br />
pazienti.<br />
E’ stato richiesto formalmente a tutte le strutture l’invio dei protocolli di “Accoglimento”,<br />
“Trattamento” e “Dimissione adottati, la trasmissione dell’elenco aggiornato dei pazienti nonché dei<br />
PTI.<br />
I Compiti attribuiti all’ OCSM sono quelli previsti dalla normativa regionale, in particolare:<br />
- predisporre un <strong>Patto</strong> <strong>territoriale</strong> per la salute mentale coerente con il Piano Regionale per la<br />
Salute Mentale;
- organizzare annualmente una Conferenza <strong>territoriale</strong> per la salute mentale con la<br />
partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella tutela della salute mentale.<br />
Durante il 2005 l’Organismo si è riunito nove volte e, articolatosi per gruppi di lavoro, ha<br />
preparato una serie di documenti significativi ai fini dell’attuazione del programma regionale.<br />
Per quanto riguarda i rapporti del Dipartimento di salute mentale con gli altri Dipartimenti e<br />
Servizi, riprendendo le proposte formulate nei gruppi di lavoro, sono stati approvati alcuni<br />
protocolli: Protocollo d’intesa tra DSM e UONPIA, Protocollo operativo inerente le urgenze<br />
psichiatriche in adolescenza, Protocollo tra il DSM dell’Azienda ospedaliera e il Settore<br />
Dipendenze dell’<strong>ASL</strong>, Protocollo d’intesa interdipartimentale per il trattamento delle patologie<br />
alcoolcorrelate.<br />
Per quanto riguarda invece i rapporti fra i vari Enti è stato predisposto un “Atto di intesa per<br />
la Realizzazione e Attuazione di un sistema locale di interventi dell’area della salute mentale<br />
in Provincia di <strong>Lecco</strong>”, come strumento di definizione delle interazioni, delle prassi operative e<br />
collaborative fra i soggetti firmatari (<strong>ASL</strong>, Azienda Ospedaliera, Comuni e Provincia),<br />
riconoscendo al contempo il ruolo svolto dalle realtà cooperative, associative e del privato sociale.<br />
Tale atto è stato approvato: dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di <strong>Lecco</strong> con<br />
delibera n. 518 dell’1/9/2005, dall’Azienda Ospedaliera di <strong>Lecco</strong> con delibera n. 1074 del<br />
04/08/2005, dalla Provincia di <strong>Lecco</strong> con delibera del Consiglio Provinciale n. 68 del 19/09/2005,<br />
dall’Assemblea Distrettuale di Bellano in data 14/07/2005, dall’Assemblea Distrettuale di <strong>Lecco</strong> in<br />
data 29/07/2005, dall’Assemblea Distrettuale di Merate in data 24/10/2005.<br />
All’interno dell’atto sono stati poi predisposti ed approvati dei Protocolli operativi riferiti a<br />
due aree tematiche:<br />
- “area tematica della territorialità” per gli interventi di natura socio- assistenziale e di<br />
integrazione sociale e lavorativa, riguardanti: l’erogazione di contributi economici sostitutivi di<br />
ricovero, l’assistenza domiciliare ed educativa, il pronto intervento assistenziale, l’attivazione di<br />
soggiorni estivi e ricreativi, iniziative di aggregazione, formazione e socio-occupazionale,<br />
tirocini con finalità riabilitative e per l’inserimento lavorativo, iniziative di formazione e<br />
sostegno delle famiglie;<br />
- “area tematica della residenzialità” con linee guida per gli interventi di tipo riabilitativo a<br />
livello residenziale. Da questo punto di vista si è provveduto alla rilevazione della situazione<br />
attuale delle strutture accreditate a contratto e non a contratto nell’ambito provinciale di <strong>Lecco</strong><br />
anche in previsione del percorso di riqualificazione previsto dal piano regionale.<br />
Successivamente, anche a seguito delle indicazioni regionali (circ. 49/SAN e successive<br />
integrazioni operative), è stata attivata un’èquipe multidisciplinare di valutazione<br />
dell’appropriatezza dei programmi riabilitativi, attuati presso le strutture residenziali<br />
accreditate. I lavori della Commissione si svolgeranno nel corso del 2006.<br />
Tutto il lavoro sopra descritto è stato presentato durante la “Conferenza Territoriale per la<br />
salute mentale” organizzata a in data 20 Ottobre 2005.<br />
Nel corso dell’anno 2006 l’OCSM si è riunito in seduta plenaria sei volte più gli incontri dei<br />
gruppi di lavoro. In particolare ha affrontato:<br />
• la nomina del nuovo coordinatore, la ridefinizione dei componenti e l’introduzione di una<br />
segreteria specificatamente dedicata con funzioni organizzative/istituzionali;<br />
• per quanto concerne i gruppi di lavoro: revisione dei compiti; semplificazione dei<br />
componenti garantendo una piu’ ampia partecipazione istituzionale, professionale e di<br />
rappresentativita’ sociale; determinazione delle priorita’ di lavoro;<br />
• è stata inviata in Regione la valutazione clinico epidemiologica “percorsi riabilitativi<br />
assistenziali nella rete delle strutture residenziali psichiatriche” ;
• è stata considerata/analizzata la proposta del DSM-AO <strong>Lecco</strong> di riorganizzazione dell’area<br />
di Bellano;<br />
• è stata organizzata e realizzata la conferenza <strong>territoriale</strong> annuale;<br />
• si è iniziata la stesura del patto per la salute mentale, con la decisione di pubblicarlo in<br />
formato elettronico sul sito aziendale <strong>ASL</strong><br />
Per quanto riguarda gli obiettivi dell’OCSM 2006-2007 si rimanda al “Cap. 4 OCSM - Obiettivi,<br />
priorità e azioni 2006 2007” – I PARTE del presente documento.
OBIETTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI<br />
III PARTE<br />
Cap. 4<br />
STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE<br />
CASA SARA<br />
COMUNITÀ PROTETTA DI AMBITO PSICHIATRICO<br />
A BASSA ASSISTENZA<br />
Aut./Acc.: DGR VII/8986 del 07.05.2002<br />
CASA SARA È UNA COMUNITÀ PROTETTA DI AMBITO PSICHIATRICO A BASSA ASSISTENZA (CPM<br />
DI TIPO B), ISCRITTA NELL’ELENCO REGIONALE DELLE STRUTTURE ACCREDITATE (N° 539).<br />
LA COMUNITÀ ACCOGLIE DUE PERSONE NELL’AMBITO DI UNA STRUTTURA ABITATIVA ED HA LA<br />
FINALITÀ DI REALIZZARE PROGETTI SOCIO-RIABILITATIVI IN UN AMBIENTE ANCORA RITENUTO<br />
PROTETTO, CON UN’ASSISTENZA EDUCATIVA DI DUE ORE GIORNALLIERE, MA CHE HA LE<br />
CARATTERISTICHE DI UNA NORMALE ABITAZIONE CIVILE.<br />
IL METODO DI LAVORO EDUCATIVO HA COME RIFERIMENTO IL MODELLO INTEGRATO E SI<br />
SPECIFICA OPERATIVAMENTE NELLA COSTRUZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI. GLI OBIETTIVI<br />
PREVEDONO: DI MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI AUTONOMIA ATTRAVERSO LO STIMOLO<br />
DELL’ACQUISIZIONE DI ALCUNE ABILITÀ; DI RAGGIUNGERE UN LIVELLO DI BUONA<br />
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E DI CURA DELLA PERSONA E DEL PROPRIO AMBIENTE; DI MIGLIORARE<br />
LE RELAZIONI CON GLI ALTRI; DI PROMUOVERE LA SOCIALIZZAZIONE E L’INSERIMENTO<br />
LAVORATIVO.<br />
CHI OPERA NELLA COMUNITÀ<br />
L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE È COMPOSTA DA:<br />
• UN RESPONSABILE DI COMUNITÀ.<br />
• UN EDUCATORE PROFESSIONALE PER 2 ORE GIORNALIERE.<br />
• UN OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE A SECONDA DEL PROGETTO DEL PAZIENTE.<br />
• UN MEDICO PSICHIATRA CONSULENTE CHE SUPERVISIONA LA DISCUSSIONE DEI CASI E<br />
INTERVIENE NELLE EMERGENZE.<br />
CASA SARA<br />
VIA MONTALBANO9/11<br />
23900 LECCO<br />
TEL. E FAX : 0341 251074<br />
E_MAIL: casa.sara@larcobaleno.coop
OBIETTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI<br />
RESIDENZA IL POGGIO<br />
COMUNITÀ PROTETTA DI AMBITO PSICHIATRICO<br />
AD ELEVATA ASSISTENZA<br />
Aut./Acc.: DGR VII/3080 del 12.01.2001<br />
e DGR VIII/2055 dell’ 8.03.2006<br />
LA RESIDENZA IL POGGIO È UNA COMUNITÀ PROTETTA DI AMBITO PSICHIATRICO AD ELEVATA ASSISTENZA,<br />
ISCRITTA NELL’ELENCO REGIONALE DELLE STRUTTURE ACCREDITATE (CODICE STRUTTURA N° 409).<br />
E’ ORGANIZZATA SECONDO IL MODELLO DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA, CON LE FINALITÀ DI REALIZZARE PROGETTI<br />
SOCIO-RIABILITATIVI CON PROGRAMMI A TERMINE, CHE RICHIEDONO IL TEMPORANEO INSERIMENTO DEL PAZIENTE IN<br />
UN AMBITO ASSISTENZIALE DI 24 ORE SU 24.<br />
L’OBIETTIVO CHE LA STRUTTURA PERSEGUE È QUELLO DI PROMUOVERE LA RIDETERMINAZIONE SIA DELLE ABILITÀ<br />
SOCIALI CHE DELLE CAPACITÀ DI RIESPRIMERE I PERSONALI DESIDERI NONCHÈ LA REINTEGRAZIONE SOCIALE, ANCHE<br />
PARZIALE. ALTRO OBIETTIVO È QUELLO DI FAVORIRE, MANTENERE OD ACCENTUARE IN CIASCUN OSPITE,<br />
UN’ADEGUATA AUTONOMIA E LE CAPACITÀ DECISIONALI CHE LA PATOLOGIA POSSA AVER INIBITO.<br />
CHI OPERA NELLA COMUNITÀ<br />
È GARANTITA L’ASSISTENZA MEDICO-PSICHIATRICA GIORNALIERA PER 4 ORE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ E PER 2 ORE IL<br />
SABATO.<br />
L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 24 ORE SU 24 È GARANTITA DA INFERMIERI PROFESSIONALI DI PROVATA<br />
ESPERIENZA. I PROGETTI SOCIO-RIABILITATIVI VENGONO PREDISPOSTI E MONITORATI DALLO PSICOLOGO.<br />
PER GLI ADEMPIMENTI DI NATURA FUNZIONALE, OLTRE AGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI, SONO PREVISTI SUPPORTI<br />
SIA DA PARTE DEGLI OPERATORI AUSILIARI PREPOSTI CHE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ESITENTI NEL<br />
TERRITORIO.<br />
SERVIZI INTEGRATIVI S.P.A.<br />
VIA DELLA VIGNA, 9<br />
23849 ROGENO (LECCO)<br />
TEL. E FAX : 031 865758<br />
E_MAIL: res.ilpoggio@libero.it
Antropos<br />
Residenza psichiatrica terapeutica riabilitativa<br />
Comunità Protetta a media protezione<br />
Accreditata S.S.N. c/o Reg. Lombardia (Del.G.R. N° 21319 del 18/04/2005)<br />
23825 Esino Lario (LC) Via per Agueglio, 24<br />
Tel. 0341.860554 Fax 0341.860907 E-mail: antropos@caltanet.it<br />
OBIETTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI<br />
♦ La Residenza psichiatrica terapeutica riabilitativa Antropos, concepita secondo le indicazioni<br />
contenute nel Piano di Salute Mentale adottato dalla Regione Lombardia, è una Comunità a media<br />
protezione, iscritta nell’elenco regionale delle Strutture Accreditate (codice struttura 777).<br />
♦ E’ rivolta alle esigenze sociosanitarie dei pazienti psichiatrici che necessitano di trattamenti<br />
terapeutico-riabilitativi. Opera pertanto, garantendo i presidi terapeutici del caso, per sostenere e<br />
sviluppare le residue capacità di autonomia del paziente che vi soggiorna, in condizione di<br />
residenzialità protetta, per il periodo previsto dal progetto terapeutico-riabilitativo individuale<br />
concordato con la struttura psichiatrica inviante e continuativamente aggiornato in relazione<br />
all’evoluzione clinica del quadro psicopatologico.<br />
♦ Il numero di posti disponibili è 20; la Comunità è dotata di ampi spazi comuni, idoneamente<br />
attrezzati, che si prestano alle più varie attività riabilitative, di un’ampia ed attrezzata cucina, di un<br />
locale adibito alla lavanderia e stireria, di una piccola palestra e di idonei spazi per gli operatori.<br />
CHI OPERA NELLA COMUNITA’<br />
L’assistenza è assicurata nelle 24 ore dall’équipe coordinata dal Direttore Clinico e composta da :<br />
•Medici psichiatri, a cui compete l’attività diagnostica-terapeutica in collaborazione con<br />
psicologi psicoterapeuti;<br />
•Infermieri professionali presenti giornalmente in struttura<br />
•Educatori professionali responsabili del progetto educativo-riabilitativo<br />
•Operatori socio assistenziali che garantiscono un adeguato e continuativo supporto<br />
assistenziale.<br />
*******************************************************************<br />
Antropos S.r.L. Sede amministrativa: 20052 MONZA - Via Italia, 50<br />
Tel 039.367338-039.321676 Fax 039.326895 Cod. Fisc. e P. IVA 03761340961
IL VOLO Società Cooperativa Sociale – ONLUS<br />
Albo Reg. Coop. Sociali Sez. "A" nr. 221<br />
Comunità Protetta ad Alta Assistenza “VILLA RATTI”<br />
Via Provinciale, 42<br />
23876 Monticello Brianza – LC<br />
web: www.ilvolo.com mail: ilvolo@ilvolo.com<br />
tel. 039 9275575 fax. 039 9275197<br />
Autor. Accr. Del. N. VII/21481 del 06/05/2005<br />
OBIETTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI<br />
VILLA RATTI È UNA COMUNITÀ PSICHIATRICA PROTETTA AD ELEVATA ASSISTENZA, ISCRITTA NELL’ELENCO REGIONALE<br />
DELLE STRUTTURE ACCREDITATE (CODICE STRUTTURA N° 03)<br />
SI RIVOLGE PREVALENTEMENTE A GIOVANI ADULTI CON GRAVE DISAGIO PSICOSOCIALE, ASCRIVIBILE ALLA DIAGNOSI<br />
DI DISTURBO DI PERSONALITÀ<br />
ACCOGLIE FINO AD UN MASSIMO DI 20 OSPITI DI ENTRAMBE I SESSI<br />
ADOTTA UN MODELLO TERAPEUTICO CHE PREVEDE UN INTERVENTO INTEGRATO DI PSICOTERAPIA E SOCIOTERAPIA<br />
STRUTTURA<br />
LA VILLA È DI PROPRIETÀ DEL DEMANIO ED È STATA APPOSITAMENTE RISTRUTTURATA PER LE ESIGENZE DELL’UTENZA. È<br />
INSERITA IN UN CONTESTO TRANQUILLO E INTEGRATO IN UN TESSUTO URBANO ED È DOTATA DI MOLTEPLICI ED AMPI<br />
LOCALI<br />
ATTIVITA’ E PRESTAZIONI<br />
AREA ASSISTENZIALE: ASSISTENZA INFERMIERISTICA NELL’ARCO DELLE 24, CON LA PRESENZA DI ALMENO DUE<br />
OPERATORI NEL TURNO DI NOTTE, ASSISTENZA MEDICO PSICHIATRICA CON UNA PRESENZA ATTIVA IN COMUNITÀ PER<br />
ALMENO 4 ORE GIORNALIERE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ E 2 ORE AL SABATO - PRESENZA DEL MEDICO DI MEDICINA<br />
GENERALE PER LE VISITE DI CONTROLLO PERIODICHE<br />
QUOTIDIANITA’: VENGONO GARANTITI TUTTI I SERVIZI DI HOSPICE E ALL’OSPITE GLI VIENE RICHIESTO UN<br />
COINVOLGIMENTO ATTIVO NELLA CURA DEGLI SPAZI PERSONALI E COMUNI, NELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL<br />
SERVIZIO, NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL TEMPO LIBERO<br />
AREA CLINICA, VISITE PSICHIATRICHE PERIODICHE CON IMPOSTAZIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO DEI TRATTAMENTI<br />
FARMACOLOGICI -PSICOTERAPIA INDIVIDUALE CON UN INCONTRO E DI GRUPPO CON DUE INCONTRI ALLA SETTIMANA<br />
AREA SOCIORIABILITATIVA: INTERVENTI INDIVIDUALI VOLTI ALLA (RI)ACQUISIZIONE DI COMPETENZE ED ABILITÀ<br />
SOCIALI, DI BASE E RELAZIONALI E ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AL REINSERIMENTO LAVORATIVO E/O RIPRESA<br />
DEL PERCORSO SCOLASTICO - INTERVENTI DI GRUPPO CHE SI ARTICOLANO NEI LABORATORI DI INFORMATICA,<br />
ORTOFLORIVIVAISMO E CUCINA E NEGLI INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE E DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ<br />
AREA ESPRESSIVA E CULTURALE: GRUPPI DI LETTURA, CINEFORUM, ATELIER DI PITTURA, MUSICA, CERAMICA<br />
INTERVENTI FAMIGLIARI: COLLOQUI PERIODICI CON I CLINICI E INCONTRI DI GRUPPO MULTIFAMIGLIARI CON<br />
SCADENZA MENSILE<br />
PERSONALE<br />
1 PSICOLOGO A TEMPO PARZIALE CON FUNZIONE DI RESPONSABILE DI COMUNITA’ - 3 MEDICI PSICHIATRI A TEMPO<br />
PARZIALE, DI CUI UNO CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI DIRETTORE SANITARIO - 4 EDUCATORI A TEMPO PIENO, DI CUI UNO<br />
SVOLGE LA FUNZIONE DI COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ SOCIORIABILITATIVE - 5 INFERMIERI PROFESSIONALI A TEMPO PIENO,<br />
DI CUI UNO SVOLGE LA FUNZIONE DI CORDINATORE E RESPONSABILE DELL’HOSPICE, E 3 A TEMPO PARZIALE - 3 AUSILIARI<br />
SOCIOSANITARI A TEMPO PIENO - 3 PSICOLOGI CONSULENTI - 3 ESPERTI DI LABORATORIO CONSULENTI - 1 CUOCO - 1<br />
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
III PARTE<br />
Cap. 5<br />
Associazioni per il disagio psichico<br />
ASVAP DI LECCO E PROVINCIA – Associazione familiari e Volontari aiuto Ammalati<br />
Psichici<br />
Indirizzo: Via Figini, 21 – 23900 LECCO (LC)<br />
Telefono: 0341.350195<br />
Fax: 0341.350195<br />
E-mail: asvaplecco@tin.it<br />
Sito Internet: www.asvap.it<br />
Responsabile: Nadia Colombo<br />
Per informazioni rivolgersi a: Nadia Colombo, tel. 0341.582950; Giancarla Sala,<br />
tel. 0341.366262<br />
Attività: Sostegno e tutela dei diritti dei malati psichici – Percorsi di risocializzazione e attività su<br />
progetti mirati presso il “Centro Ricreativo Il Girasole “ aperto in convenzione con l’Ospedale di<br />
<strong>Lecco</strong> – Progetto “Attraverso il Teatro” laboratorio di teatro creativo – Progetto “apertaMENTE” di<br />
comunicazione, risocializzazione e interazione con il territorio – PUNTO DI INCONTRO con i<br />
familiari.<br />
PSICHE LOMBARDIA SEZIONE DI LECCO<br />
Indirizzo: Via Paolo IV, 29 – 23900 LECCO (LC)<br />
Telefono: 0341.499782 347.4900799<br />
FAX: 0341.499782<br />
E-mail: vfacchetti@tin.it<br />
Responsabile: Donata Crimella<br />
Per informazioni rivolgersi a: Donata Crimella<br />
ALTRI INDIRIZZI E RECAPITI:<br />
- SPORTELLO SOCIALE<br />
Indirizzo: Presso Presidio Ospedaliero – sportello AVO – MERATE<br />
Telefono: 035-4380020 – cell. 339-5832938<br />
COORDINAMENTO SCIENTIFICO: D.ssa SILVANA MAZZOLENI<br />
E-mail: MAZZOL62@MAZZOLENISILVANA.191.it<br />
Attività: informazione, ascolto e sostegno psicologico alle famiglie – Accompagnamento ai Servizi<br />
– Interventi di sostegno domiciliare – Auto mutuo aiuto – Attività artistiche di vario genere,<br />
bricolage, etc. – Attività ricreative.<br />
U.R.A.SA.M. UNIONE REGIONALE ASSOCIAZIONI PER LA SALUTE MENTALE/<br />
LOMBARDIA<br />
Indirizzo: Sede legale: Via M.A. Colonna, 57 - 20149 MILANO (MI) – Sede operativa: Via Asiago,<br />
67 - 20059 VIMERCATE (MI)
Telefono: 388.3700632<br />
Fax: 178.6005199<br />
E-mail:rivaeugenio@tiscali.it; urasam@libero.it<br />
Sito Internet: www.urasamlombardia.it<br />
Responsabile: Riva Eugenio<br />
Per informazioni rivolgersi a: Riva Eugenio tel. 338.3700632<br />
Attività: Associazione di 2° livello, è impegnata sul fronte dei diritti per la salute mentale.<br />
Rappresenta in Lombardia oltre 50 Associazioni di base di famigliari e di volontari per la salute<br />
mentale. Favorisce in modo volontario, gratuito e solidale la collaborazione tra le Associazioni<br />
aderenti per lo svolgimento dei loro compiti nei rispettivi ambiti territoriali.<br />
Unitamente alle Associazioni di base, il nostro impegno mira a fare i modo che i portatori di disagio<br />
psichico siano PERSONE con diritto di cittadinanza, anche per quanto attiene il campo socioassistenziale,<br />
la casa, il diritto al lavoro, l’assistenza domiciliare, convinti che l’attuazione di questo<br />
obiettivo significhi riportare la Persona al centro dell’attenzione di tutti gli attori sociali.<br />
Promuovendo momenti di informazione per diffondere una cultura della salute mentale per superare<br />
lo stigma, le singole Comunità avranno la possibilità di sentirsi parte attiva nell’accoglienza di<br />
queste persone all’interno del contesto sociale.<br />
VOLONTARIA-MENTE ONLUS<br />
Indirizzo: Via Annunciata, 24 – 23807 MERATE (LC)<br />
Telefono: 039.5916568 c/o H”Mandic” Merate lun e merc 15.00-17.00, giov. 16.30-18.30, oppure<br />
039.9906205 – 347.5616502 – 339.3685077<br />
Fax: 039.9285793<br />
E-mail: sint-dicagno@tiscali.it<br />
Responsabile: Anna Maria Di Cagno<br />
Per informazioni rivolgersi a: Mietta Consonni, tel. 039.9906205 – 339.3685077<br />
Attività: Gruppi di auto-mutuo-aiuto per gli utenti e i familiari – Organizzazione di attività artistiche<br />
per gli utenti (atelier di pittura, laboratorio cinema, laboratorio teatrale, attività musicali, …) –<br />
Organizzazione di eventi di intrattenimento volti a favorire l’integrazione degli utenti e dei familiari<br />
nel tessuto sociale – Organizzazione di incontri di sensibilizzazione sul tema del disagio mentale<br />
nelle sue varie forme.<br />
DENOMINAZIONE “ TALITA’ KUM”<br />
Indirizzo: via Spluga 49 – 23854 OLGINATE (LC)<br />
Telefono: 0341-681050<br />
Fax:<br />
E-mail: per_il_recupero @ libero.it<br />
Responsabile: Sig. Baiocco Gianfranco<br />
Per informazioni rivolgersi a: Sig. Baiocco Gianfranco<br />
Attività: Recupero delle persone con disagio psichico attraverso il lavoro e percorsi di<br />
risocializzazione. “Per il recupero” Mercatino dell’usato che occupa 5 ragazzi con problemi di<br />
disagio psichico inviati dal collocamento fasce deboli. Gite domenicali e vacanze estive.
III PARTE<br />
Cap. 6<br />
CONSORZIO CONSOLIDA<br />
MISSION<br />
La missione del Consorzio, riportata nello statuto, recita in sintesi all’art.3:<br />
“Il Consorzio è costituito per agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire<br />
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini<br />
nello spirito e secondo le modalità previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.<br />
Operando secondo queste finalità intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini<br />
di lucro qualsiasi attività volta a favorire le cooperative sociali consorziate e non, nel<br />
raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere e stimolare una fattiva collaborazione tra le<br />
cooperative sociali e gli enti pubblici del territorio.”<br />
OBIETTIVI<br />
Coerentemente con il proprio Statuto, Consolida opera costantemente su due macro-obiettivi:<br />
1. Favorire e sostenere la crescita e lo sviluppo (imprenditoriale, economico, professionale,<br />
innovativo) della cooperazione sociale del territorio lecchese, attraverso l’offerta di<br />
strumenti adeguati e differenziati.<br />
2. Favorire la crescita di un sistema di rete <strong>territoriale</strong>, in cui convergano le diverse<br />
soggettività (istituzionali, sociali, imprenditoriali), teso a cogliere bisogni e istanze dei<br />
cittadini, con particolare attenzione a coloro che vivono situazioni di disagio, e a costruire<br />
percorsi e strumenti concreti di risposta”.<br />
ATTIVITA’<br />
In relazione al raggiungimento dei macro-obiettivi più sopra descritti, Consolida gestisce e realizza<br />
una serie di attività, svolgendo funzioni differenziate:<br />
3.1. Rivolte alle cooperative aderenti:<br />
Servizi amministrativi (Gestione paghe, contabilità e consulenza)<br />
Consolida ha al proprio interno un ufficio paghe e contabilità di cui possono usufruire le<br />
cooperative aderenti.<br />
Si avvale inoltre di consulenti interni ed esterni su diversi temi: assetto societario, lavoro, aspetti<br />
legali e fiscali, bilancio, progettazione di interventi e servizi.<br />
Formazione<br />
Consolida dispone di un’area formazione, che cura sia la rilevazione dei bisogni formativi delle<br />
cooperative che la predisposizione di piani annuali di formazione.<br />
Attraverso l’accreditamento presso la Regione Lombardia per la formazione, Consolida offre alle<br />
cooperative percorsi di formazione, rivolti a dirigenti e operatori, su temi differenti: legislazione,<br />
metodi e tecniche del lavoro sociale, management, politiche attive del lavoro, bilancio sociale,<br />
organizzazione dei servizi.<br />
General contractor
Questa funzione è finalizzata a sostenere le cooperative sociali nei rapporti con Enti Pubblici e<br />
Privati ed a facilitare integrazioni tra cooperative che svolgono attività differenti, offrendo in tal<br />
modo ai committenti servizi complessi e diversificati.<br />
3.2. Rivolte al territorio:<br />
Partecipazione a gruppi di lavoro e/o di coordinamento territoriali, su temi inerenti le<br />
politiche sociali e del lavoro<br />
In quanto soggetto del territorio impegnato nello sviluppo di un sistema a rete, Consolida è presente<br />
all’interno di organismi e gruppi di lavoro organizzati a livello istituzionale, per portare la propria<br />
visione, esperienza e competenza.<br />
Formazione<br />
L’accreditamento per la formazione fa di Consolida un’agenzia formativa <strong>territoriale</strong>, in grado di<br />
progettare e gestire percorsi formativi sia per operatori sociali che per persone in condizione di<br />
svantaggio sociale, anche in collaborazione con altri soggetti territoriali.<br />
Orientamento e accompagnamento<br />
L’esperienza maturata soprattutto dalle cooperative di tipo B del territorio, rende Consolida in<br />
grado di offrire al territorio Servizi orientativi e di accompagnamento e sostegno al lavoro rivolti<br />
alle fasce deboli, ossia a quelle persone che faticano ad orientarsi autonomamente nel mondo del<br />
lavoro.<br />
Servizio civile nazionale<br />
In partnership con l’Associazione Mosaico di Bergamo, Consolida è nel territorio lecchese ente che<br />
accoglie ragazze/i in servizio civile volontario. Consolida realizza sia l’attività di selezione che la<br />
successiva formazione dei candidati, centrata sui progetti specifici in cui le ragazze/i sono inseriti.<br />
Promozione e sostegno di nuove cooperative sociali<br />
In coerenza con la propria mission, Consolida sostiene forme nascenti di cooperative sociali, con<br />
attenzione ai bisogni delle differenti zone territoriali. Lo sviluppo di nuove cooperative sociali può<br />
nascere sia da spinte imprenditoriali di gruppi di cittadini, sia da azioni riorganizzative delle<br />
cooperative già presenti, finalizzate a realizzare processi di maggior specializzazione nell’offerta di<br />
servizi e interventi e/o a mantenere dimensioni che garantiscano partecipazione e democrazia<br />
interne.<br />
SOCI COOPERATIVE DI TIPO A<br />
Accoglienza e Lavoro<br />
Coop.sociale Onlus<br />
Via Aldo Moro 92-23847 Molteno<br />
Tel.031/851492 fax 031/875871<br />
info@calmolteno.com<br />
www.calmolteno.org<br />
AERIS<br />
Coop.Soc.ARL<br />
Via Kennedy 19-20059 Vimercate(MI)<br />
Tel.039/6853523-fax.039/6918941<br />
amministrazione@coopaeris.it<br />
www.coopaeris.it
Arcobaleno<br />
Soc.Coop.Onlus<br />
Via Promessi Sposi 129-23868 Valmadrera<br />
0341/580828 fax.0341/204686<br />
cooperativaarcobaleno@tin.it<br />
Atipica<br />
Soc.Coop.Onlus<br />
Via Molino Filo 1-20050 Verano Brianza(MI)<br />
Tel.0362/900144-fax.0362/1792854<br />
info@atipica.org<br />
www.atipica.org<br />
Eco 86<br />
Soc.Coop.Arl<br />
Via Baracca 49,23900 <strong>Lecco</strong><br />
Tel.0341/365798 fax.0341/371887<br />
coopeco@tin.it<br />
Il Talento<br />
Soc.Coop.Onlus<br />
Via Palestro 21-23900 <strong>Lecco</strong><br />
Tel.0341/363567 fax.0341/351207<br />
info@iltalentocoop.it<br />
www.iltalento.coop<br />
L’Arcobaleno soc.coop.Onlus<br />
Via Mascari 1,23900 <strong>Lecco</strong><br />
Tel 0341/350838 fax.0341/351318<br />
info@larcobaleno.coop<br />
www.larcobaleno.coop<br />
La Grande Casa<br />
Soc.coop.Onlus<br />
Via Petrarca 146,20099 Sesto S.Giovanni<br />
Tel.02/2412461 fax.02/24124644<br />
Lagrandecasa@lagrandecasa.it<br />
www.lagrandecasa.com<br />
La Linea dell’Arco<br />
Soc.Coop.ARL<br />
Via Balicco 11 <strong>Lecco</strong> 23900 LC<br />
Tel.0341/362281 fax.0341/285012<br />
cooplda@iol.it<br />
www.cooplda.it<br />
La Tata<br />
Coop.sociale<br />
Via Volta 313-23010 Piantedo(SO)<br />
Tel.339/7664083<br />
info@latata.it
La Vecchia Quercia<br />
Coop.sociale<br />
Via Vitalba 40,23801 Calolziocorte(LC)<br />
Tel 0341/630909 fax.0341/633787<br />
info@lavecchiaquercia.org<br />
www.lavecchiaquercia.org<br />
<strong>Lecco</strong> Soccorso<br />
Corso Carlo Alberto 116,23900 <strong>Lecco</strong><br />
0341/272345 fax 0341/272345<br />
<strong>Lecco</strong>soccorso@libero.it<br />
Le Betulle<br />
Via Cà Manzoni 1,23814 Cremeno Frazione Moggio(LC)<br />
0341/918559 FAX.0341/911577<br />
cooplebetulle@libero.it<br />
Le Grigne<br />
Soc.coop.Onlus<br />
Via Galilei 1/A-23819 Primaluna(LC)<br />
0341/980750 FAX.0341/982777<br />
Coop.legrigne@infinito.it<br />
Paso<br />
Coop.Sociale<br />
Via Marconi 211-23807 Merate<br />
Tel.039/9289392 fax.039/9280298<br />
Paso.cooperativa@libero.it<br />
SOCI COOPERATIVE TIPO B<br />
Alma Faber<br />
Coop.Soc.Onlus<br />
Via Gramsci 4-23851 Galbiate(LC)<br />
Tel.0341/240106 fax.0341/241786<br />
info@almafaber.com<br />
Aquilone<br />
Coop.Soc.Onlus<br />
Via della Repubblica 1-23899 Robbiate(Lc)<br />
039/513163<br />
coopaquilone@alice.it<br />
Di Mano in Mano Solidale<br />
Coop.Sociale<br />
Via Ponte dei Re,6-23811 Ballabio(LC)<br />
Tel.0341/530114 fax.0341/530114<br />
dimanoinmanosolidale@tiscali.it<br />
Dimensione Lavoro<br />
Soc.Coop.Onlus
Via P.Sposi 144-23868 Valmadrera(LC)<br />
Tel.0341/200252 fax.0341/200252<br />
info@dimensione-lavoro.it<br />
www.dimensione-lavoro.it<br />
Don Bosco<br />
Soc.Coop.Onlus<br />
Via P.Vitalba 40-23801 Calolziocorte(LC)<br />
(sede amministrativa)<br />
Via Padri Serviti 1-Calolziocorte<br />
0341/644279 fax.0341/644485<br />
Coop_donbosco@iol.it<br />
Duemani<br />
Soc.Coop.Arl<br />
Via Risorgimento 10 <strong>Lecco</strong><br />
0341/360081 fax 0341/361160<br />
info@duemani.it<br />
www.duemani.it<br />
Il Nuovo Mondo<br />
Coop.Sociale Arl<br />
Via Tagliamento 8/10-23900 <strong>Lecco</strong>(LC)<br />
Tel.0341/496440 fax.0341/496440<br />
info@ilnuovomondo.net<br />
Kwa Kusaidia<br />
Coop.Soc.Onlus<br />
Via Roncate 1/b-23851 Galbiate(LC)<br />
Tel 0341/240493 fax.0341/240102<br />
info@kwa.it<br />
www.kwa.it<br />
Padre Daniele Badiali Onlus<br />
Via S.Mayer 6-24034 Cisano Bergamasco(Bg)<br />
Tel.035/4364508 fax.035/4363364<br />
info@padredanielecoop.it<br />
Larius<br />
Coop.Sociale<br />
Via Parravicini 20/c 23823 Colico(LC)<br />
0341/941688 fax 0341/931392<br />
Coop.larius@virgilio.it<br />
ASSOCIAZIONI<br />
Il Gabbiano<br />
Soc.Coop.Onlus<br />
Villa Malpensata 23823 Olgiasca di Colico(LC)<br />
Tel.0341/930074 fax.0341/930774<br />
amministrazione@gabbianoonlus.it