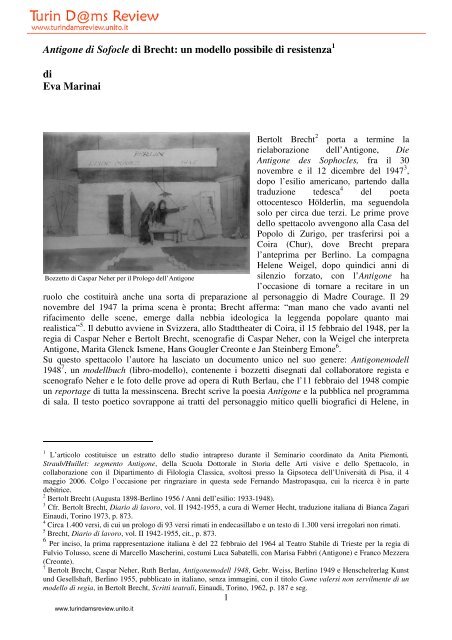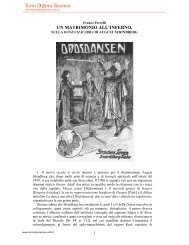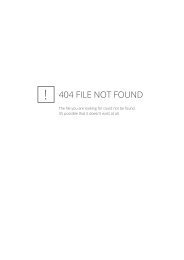Antigone di Sofocle di Brecht: un modello possibile di resistenza di ...
Antigone di Sofocle di Brecht: un modello possibile di resistenza di ...
Antigone di Sofocle di Brecht: un modello possibile di resistenza di ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Antigone</strong> <strong>di</strong> <strong>Sofocle</strong> <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong>: <strong>un</strong> <strong>modello</strong> <strong>possibile</strong> <strong>di</strong> <strong>resistenza</strong> 1<br />
<strong>di</strong><br />
Eva Marinai<br />
Bertolt <strong>Brecht</strong> 2 porta a termine la<br />
rielaborazione dell’<strong>Antigone</strong>, Die<br />
<strong>Antigone</strong> des Sophocles, fra il 30<br />
novembre e il 12 <strong>di</strong>cembre del 1947 3 ,<br />
dopo l’esilio americano, partendo dalla<br />
traduzione tedesca 4 del poeta<br />
ottocentesco Hölderlin, ma seguendola<br />
solo per circa due terzi. Le prime prove<br />
dello spettacolo avvengono alla Casa del<br />
Popolo <strong>di</strong> Zurigo, per trasferirsi poi a<br />
Coira (Chur), dove <strong>Brecht</strong> prepara<br />
l’anteprima per Berlino. La compagna<br />
Helene Weigel, dopo quin<strong>di</strong>ci anni <strong>di</strong><br />
silenzio forzato, con l’<strong>Antigone</strong> ha<br />
l’occasione <strong>di</strong> tornare a recitare in <strong>un</strong><br />
ruolo che costituirà anche <strong>un</strong>a sorta <strong>di</strong> preparazione al personaggio <strong>di</strong> Madre Courage. Il 29<br />
novembre del 1947 la prima scena è pronta; <strong>Brecht</strong> afferma: “man mano che vado avanti nel<br />
rifacimento delle scene, emerge dalla nebbia ideologica la leggenda popolare quanto mai<br />
realistica” 5 . Il debutto avviene in Svizzera, allo Stadttheater <strong>di</strong> Coira, il 15 febbraio del 1948, per la<br />
regia <strong>di</strong> Caspar Neher e Bertolt <strong>Brecht</strong>, scenografie <strong>di</strong> Caspar Neher, con la Weigel che interpreta<br />
<strong>Antigone</strong>, Marita Glenck Ismene, Hans Gougler Creonte e Jan Steinberg Emone 6 .<br />
Su questo spettacolo l’autore ha lasciato <strong>un</strong> documento <strong>un</strong>ico nel suo genere: <strong>Antigone</strong>modell<br />
1948 7 Bozzetto <strong>di</strong> Caspar Neher per il Prologo dell’<strong>Antigone</strong><br />
, <strong>un</strong> modellbuch (libro-<strong>modello</strong>), contenente i bozzetti <strong>di</strong>segnati dal collaboratore regista e<br />
scenografo Neher e le foto delle prove ad opera <strong>di</strong> Ruth Berlau, che l’11 febbraio del 1948 compie<br />
<strong>un</strong> reportage <strong>di</strong> tutta la messinscena. <strong>Brecht</strong> scrive la poesia <strong>Antigone</strong> e la pubblica nel programma<br />
<strong>di</strong> sala. Il testo poetico sovrappone ai tratti del personaggio mitico quelli biografici <strong>di</strong> Helene, in<br />
1<br />
L’articolo costituisce <strong>un</strong> estratto dello stu<strong>di</strong>o intrapreso durante il Seminario coor<strong>di</strong>nato da Anita Piemonti,<br />
Straub/Huillet: segmento <strong>Antigone</strong>, della Scuola Dottorale in Storia delle Arti visive e dello Spettacolo, in<br />
collaborazione con il Dipartimento <strong>di</strong> Filologia Classica, svoltosi presso la Gipsoteca dell’Università <strong>di</strong> Pisa, il 4<br />
maggio 2006. Colgo l’occasione per ringraziare in questa sede Fernando Mastropasqua, cui la ricerca è in parte<br />
debitrice.<br />
2<br />
Bertolt <strong>Brecht</strong> (Augusta 1898-Berlino 1956 / Anni dell’esilio: 1933-1948).<br />
3<br />
Cfr. Bertolt <strong>Brecht</strong>, Diario <strong>di</strong> lavoro, vol. II 1942-1955, a cura <strong>di</strong> Werner Hecht, traduzione italiana <strong>di</strong> Bianca Zagari<br />
Einau<strong>di</strong>, Torino 1973, p. 873.<br />
4<br />
Circa 1.400 versi, <strong>di</strong> cui <strong>un</strong> prologo <strong>di</strong> 93 versi rimati in endecasillabo e <strong>un</strong> testo <strong>di</strong> 1.300 versi irregolari non rimati.<br />
5<br />
<strong>Brecht</strong>, Diario <strong>di</strong> lavoro, vol. II 1942-1955, cit., p. 873.<br />
6<br />
Per inciso, la prima rappresentazione italiana è del 22 febbraio del 1964 al Teatro Stabile <strong>di</strong> Trieste per la regia <strong>di</strong><br />
Fulvio Tolusso, scene <strong>di</strong> Marcello Mascherini, costumi Luca Sabatelli, con Marisa Fabbri (<strong>Antigone</strong>) e Franco Mezzera<br />
(Creonte).<br />
7<br />
Bertolt <strong>Brecht</strong>, Caspar Neher, Ruth Berlau, <strong>Antigone</strong>modell 1948, Gebr. Weiss, Berlino 1949 e Henschelrerlag K<strong>un</strong>st<br />
<strong>un</strong>d Gesellshaft, Berlino 1955, pubblicato in italiano, senza immagini, con il titolo Come valersi non servilmente <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
<strong>modello</strong> <strong>di</strong> regia, in Bertolt <strong>Brecht</strong>, Scritti teatrali, Einau<strong>di</strong>, Torino, 1962, p. 187 e seg.<br />
www.turindamsreview.<strong>un</strong>ito.it<br />
1
iferimento all’esperienza dell’esilio e all’atteggiamento politico 8 . <strong>Antigone</strong> è esaltata come<br />
“antitesi ad ogni forma <strong>di</strong> ingiustizia e <strong>di</strong> violenza” 9 .<br />
<strong>Antigone</strong><br />
Esci dalla penombra e cammina<br />
davanti a noi <strong>un</strong> poco,<br />
gentile, con il passo leggero<br />
della donna risoluta a tutto, terribile<br />
per i terribili<br />
Distolta a forza, io so<br />
come temevi la morte, ma<br />
ancora più ti faceva orrore<br />
la vita indegna<br />
E non fosti indulgente<br />
in nulla verso i potenti, e non scendesti<br />
a patti con gli intriganti, e non<br />
<strong>di</strong>menticasti mai l’ingiuria e sui loro<br />
misfatti non crebbe mai l’erba<br />
Salut! 10<br />
Nella tra<strong>di</strong>zione tedesca la<br />
traduzione <strong>di</strong> Hölderlin gode <strong>di</strong> <strong>un</strong>a<br />
certa fort<strong>un</strong>a, anche se inizialmente<br />
è oggetto <strong>di</strong> contestazione per<br />
l’intrinseca fragilità filologica,<br />
come rileva George Steiner 11 . Pare,<br />
infatti, che il poeta ed esegeta si sia<br />
basato su <strong>un</strong>a inaffidabile e<strong>di</strong>zione<br />
cinquecentesca 12 . In epoca moderna<br />
il lavoro <strong>di</strong> Hölderlin è rivalutato<br />
da stu<strong>di</strong>osi quali Walter Benjamin e<br />
Martin Heidegger, perché il suo<br />
stile, anche se non aderisce<br />
perfettamente all’originale, crea<br />
“<strong>un</strong>’aura poetica”, <strong>di</strong>versa da quella<br />
sofoclea, ma molto suggestiva 13 .<br />
Pietro Montani fa notare proprio come “per Hölderlin riscoprire il versante nascosto della grecità<br />
non significa tanto promuovere <strong>un</strong> nuovo sapere del passato, correggere le fantasie classiciste della<br />
tra<strong>di</strong>zione umanistica, quanto comprendere il senso della poiesis moderna: la domanda chi sono i<br />
Greci è sempre posta per essere rovesciata, interrogandosi su chi sia l’uomo moderno” 14 . Sono<br />
proprio tali potenzialità attualizzanti del mito insite nella traduzione <strong>di</strong> Hölderlin, congi<strong>un</strong>tamente al<br />
prestigio acquisito in quegli anni dal testo 15 <strong>Antigone</strong>, condotta dalla guar<strong>di</strong>a al cospetto <strong>di</strong> Creonte, spiega il “gesto<br />
esemplare”<br />
grazie anche alla sua fascinazione lessicale, che<br />
8<br />
Cfr. Bertolt <strong>Brecht</strong>, Poesie, vol. II (1934-1956), E<strong>di</strong>zione con testo a fronte a cura <strong>di</strong> Luigi Forte, Einau<strong>di</strong>, Torino<br />
1963, p. 1681.<br />
9<br />
Luigi Forte, L’<strong>Antigone</strong> <strong>di</strong> Bertolt <strong>Brecht</strong> ovvero la trage<strong>di</strong>a del potere, in Roberto Alonge (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong>, volti<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma. Da <strong>Sofocle</strong> alle Brigate Rosse, Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Torino, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pagina, Bari 2008, p. 237.<br />
10<br />
Bertolt <strong>Brecht</strong>, Poesie, vol. II (1934-1956), cit., p. 1197.<br />
11<br />
Cfr. George Steiner, Le Antigoni, Garzanti, Milano 1990.<br />
12<br />
Valerio Magrelli (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong> <strong>di</strong> <strong>Sofocle</strong> nella traduzione tedesca <strong>di</strong> Friedrich Hölderlin, versione italiana <strong>di</strong><br />
Giuseppina Lombardo Ra<strong>di</strong>ce; In appen<strong>di</strong>ce adattamento <strong>di</strong> Bertolt <strong>Brecht</strong> da Hölderlin, Einau<strong>di</strong>, Torino 1996, p. 201.<br />
13<br />
Cfr. Ibidem.<br />
14<br />
Pietro Montani (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong> e la filosofia: Hegel, Kirkegaard, Hölderlin, Heidegger, Bultmann, Donzelli,<br />
Roma 2001, p. 115.<br />
15<br />
Cfr. Valerio Magrelli (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong> <strong>di</strong> <strong>Sofocle</strong> nella traduzione tedesca <strong>di</strong> Friedrich Hölderlin, cit., p. 201.<br />
www.turindamsreview.<strong>un</strong>ito.it<br />
2
convincono <strong>Brecht</strong> a farne uso per la messinscena. George Steiner chiama quella <strong>di</strong> Hölderlin per<br />
L’<strong>Antigone</strong> la “terza lingua” 16 , oltre il greco e il tedesco: “dalla <strong>di</strong>stanza fra le due lingue in<br />
questione nascono i tratti, il <strong>di</strong>segno in chiaroscuro <strong>di</strong> <strong>un</strong>a terza lingua, <strong>di</strong> quell’Ursprache o<br />
linguaggio adamitico presente sotto tutte le lingue umane, il solo che rende <strong>possibile</strong> la traduzione,<br />
[… con <strong>un</strong>] avvertimento: per quelli che hanno penetrato in quell’area interlinguistica, non c’è<br />
ritorno <strong>possibile</strong>” 17 . Nei Diari <strong>di</strong> lavoro, il 25 <strong>di</strong>cembre 1947, <strong>Brecht</strong> annota: “la lingua<br />
dell’<strong>Antigone</strong> <strong>di</strong> Hölderlin avrebbe meritato <strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o più approfon<strong>di</strong>to <strong>di</strong> quello che ho potuto<br />
de<strong>di</strong>cargli questa volta. È <strong>di</strong> <strong>un</strong>a ra<strong>di</strong>calità stupefacente” 18 . Il regista però tenta ben presto <strong>un</strong><br />
superamento dell’operazione hölderliniana ricorrendo a traduzioni alternative, in modo da<br />
recuperare per buona parte il valore semantico dell’originale sofocleo. L’esito drammaturgico mette<br />
in atto <strong>un</strong> tra<strong>di</strong>mento a Hölderlin, sulla scia del percorso creativo <strong>di</strong> quest’ultimo che arrivò a<br />
definire la propria <strong>un</strong>a traduzione contro 19 <strong>Sofocle</strong>.<br />
D’altro canto, secondo i canoni teorici <strong>di</strong><br />
<strong>Brecht</strong>, “la libertà <strong>di</strong> fronte al <strong>modello</strong> è<br />
assoluta e senza limiti” 20 . D<strong>un</strong>que sia dal<br />
p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista linguistico sia da quello<br />
semantico sussiste <strong>un</strong>a volontà <strong>di</strong><br />
autonomia, pur nel rispetto degli schemi<br />
classici e del nucleo tragico. Basti<br />
pensare all’eliminazione dell’elemento<br />
mistico-religioso: “l’atmosfera <strong>di</strong><br />
sacralità presente in <strong>Sofocle</strong> e in<br />
Hölderlin è spogliata della presenza <strong>di</strong><br />
qualsiasi numen e il testo laicizzato<br />
secondo la concezione marxista della<br />
storia” 21 . Permane solo Bacco, che non ha<br />
Creonte con la maschera <strong>di</strong> Bacco compie la danza della vittoria<br />
3<br />
<strong>un</strong>a valenza celeste, bensì terrestre, come<br />
<strong>di</strong>o dell’ebbrezza. Anche il personaggio<br />
<strong>di</strong> Tiresia è svuotato della peculiarità<br />
<strong>di</strong>vinatoria; nel rifacimento brechtiano, in realtà, non è dotato <strong>di</strong> spirito profetico, ma <strong>di</strong> acuta<br />
osservazione, risultando quin<strong>di</strong> più realista che veggente. Secondo le parole <strong>di</strong> Pierre Biner:<br />
“L’essenziale, nell’adattamento <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong>, è il passaggio dal piano religioso a quello politico. Il<br />
destino dell’'uomo è l’uomo'” 22 . <strong>Antigone</strong>, infatti, incarna il concetto supremo <strong>di</strong> antitheos, cioè <strong>di</strong><br />
chi ha <strong>un</strong> atteggiamento <strong>di</strong> sfida nei confronti degli dei 23 , impersonando a pieno la <strong>di</strong>mensione<br />
tragicamente umana della lotta titanica contro forze superiori, anch’esse com<strong>un</strong>que inerenti la sfera<br />
dell’umano. Infatti <strong>un</strong> altro aspetto che non compare nella versione <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong>, e che già era assente<br />
in Höderlin, è il fato, elemento tragico aristotelico che ha come conseguenza l’impossibilità per<br />
l’uomo <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il proprio destino, come avviene nel teatro drammatico; quando invece nel<br />
16<br />
Cfr. Ivi, pp. 169-196.<br />
17<br />
Ivi, p. 186.<br />
18<br />
Bertolt <strong>Brecht</strong>, Diario <strong>di</strong> lavoro, vol II, cit., p. 880.<br />
19<br />
Cfr. George Steiner, Oltre il greco e il tedesco. La «terza lingua» <strong>di</strong> Hölderlin, traduzione italiana <strong>di</strong> Claude Béguin-<br />
Almansi, in Valerio Magrelli (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong> <strong>di</strong> <strong>Sofocle</strong> nella traduzione tedesca <strong>di</strong> Friedrich Hölderlin, cit., p.<br />
189: “In tutta l’opera <strong>di</strong> Hölderlin questo concetto hegeliano <strong>di</strong> lotta è centrale (ad esempio, egli parla <strong>di</strong> «tradurre<br />
contro» <strong>Sofocle</strong>)”.<br />
20<br />
Valerio Magrelli (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong> <strong>di</strong> <strong>Sofocle</strong> nella traduzione tedesca <strong>di</strong> Friedrich Hölderlin, cit., p. 202.<br />
21<br />
Ibidem.<br />
22<br />
Pierre Biner, Il Living Theatre, De Donato, Milano 1968, p. 151<br />
23<br />
Cfr. George Steiner, Oltre il greco e il tedesco. La «terza lingua» <strong>di</strong> Hölderlin, traduzione italiana <strong>di</strong> Claude Béguin-<br />
Almansi, in Valerio Magrelli (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong> <strong>di</strong> <strong>Sofocle</strong> nella traduzione tedesca <strong>di</strong> Friedrich Hölderlin, cit., p.<br />
192: “L’Antitheos è qualc<strong>un</strong>o […] che, in <strong>un</strong> senso <strong>di</strong>vino, si comporta come se fosse contro Dio”; cfr. anche Lia Secci,<br />
Il mito greco nel teatro tedesco espressionista, Bulzoni, Roma 1969, p. 141, nota 37: “[…] Hölderlin caratterizza<br />
<strong>Antigone</strong> come 'Antitheos', come esponente <strong>di</strong> <strong>un</strong>o dei due poli opposti del <strong>di</strong>vino”.<br />
www.turindamsreview.<strong>un</strong>ito.it
teatro epico si è fuori dal dramma, d<strong>un</strong>que si può agire su <strong>di</strong> esso, proprio attraverso l’azione<br />
<strong>di</strong>mostrativa. Un’azione cui dà corpo il singolo in veste <strong>di</strong> collettività e che acquista quin<strong>di</strong> valore<br />
emblematico.<br />
Per capire il senso dell’operazione compiuta da <strong>Brecht</strong> nel rifacimento dell’<strong>Antigone</strong> sofoclea,<br />
infatti, è interessante partire dal valore probante del <strong>modello</strong> e sviluppare la tesi del palesamento<br />
dell’esempio come concetto formale che assume significato politico all’interno del processo storico.<br />
D<strong>un</strong>que “<strong>modello</strong>” come principio, elemento fisso e originario da cui partire, ma anche come gesto<br />
esemplare.<br />
Nella Prefazione al «<strong>modello</strong> per<br />
L’<strong>Antigone</strong> 1948», <strong>Brecht</strong><br />
condanna la “generica sete <strong>di</strong><br />
novità” prodotta dalla società<br />
contemporanea e afferma che non<br />
bisogna salutare con simpatia ogni<br />
modernità, ogni originalità, a<br />
maggior ragione nel campo<br />
dell’arte. Occorre, invece, ripensare<br />
criticamente le categorie <strong>di</strong><br />
“nuovo” e <strong>di</strong> “vecchio” 24 . Il<br />
<strong>modello</strong>, come proposta, è <strong>un</strong>a<br />
sfida al “nuovo”. <strong>Brecht</strong>, infatti, è<br />
attratto dal testo dell’<strong>Antigone</strong><br />
perché l’argomento può “rivestire <strong>un</strong>a certa attualità” e nello stesso tempo, sul piano tecnico, porre<br />
“interessanti problemi” 25 <strong>di</strong> messinscena. Per il regista bavarese lo scopo è quello <strong>di</strong> “sperimentare<br />
su <strong>un</strong> testo antico non tanto <strong>un</strong>a nuova drammaturgia, quanto <strong>un</strong> nuovo genere <strong>di</strong> recitazione” 26 . Da<br />
qui l’idea <strong>di</strong> stabilire <strong>un</strong> “<strong>modello</strong> vincolante per la messinscena” 27 che fornisca <strong>un</strong> esempio da<br />
imitare e da tra<strong>di</strong>re (“<strong>un</strong> misto <strong>di</strong> tipo e <strong>di</strong> archetipo, <strong>di</strong> imitabile e inimitabile” 28 ). La f<strong>un</strong>zione del<br />
<strong>modello</strong> è d<strong>un</strong>que più formale che archetipica. Inteso come esempio, stabilisce <strong>un</strong>a nuova<br />
convenzione che non è però autoritaria in sé, ma rappresenta <strong>un</strong> co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> com<strong>un</strong>icazione, <strong>un</strong>a<br />
convenzione da violare, “giacché lo scopo del <strong>modello</strong>, in realtà, non è affatto <strong>di</strong> fissare <strong>un</strong> tipo <strong>di</strong><br />
regia: tutt’altro!” 29 . Il tra<strong>di</strong>mento per l’app<strong>un</strong>to del <strong>modello</strong> permette l’istaurarsi <strong>di</strong> <strong>un</strong> rapporto<br />
<strong>di</strong>alettico con il <strong>modello</strong> stesso. In tal senso l’imitazione rappresenta <strong>un</strong> atto <strong>di</strong> estrema libertà. Sul<br />
<strong>modello</strong> <strong>di</strong> regia come esperimento e come continuum <strong>di</strong>alettico, <strong>Brecht</strong> afferma che “non si deve<br />
attribuire eccessivo peso alla primitiva invenzione <strong>di</strong> <strong>un</strong> <strong>modello</strong>, mentre è app<strong>un</strong>to l’attore che lo<br />
utilizza a conferirgli in modo imme<strong>di</strong>ato il suo apporto personale. Egli ha piena facoltà <strong>di</strong> escogitare<br />
varianti al <strong>modello</strong>, purché siano tali da rendere più simile al vero, più illuminante, ovvero<br />
artisticamente più sod<strong>di</strong>sfacente, l’immagine della realtà che deve trasmetterci. […] Le varianti,<br />
qualora siano giustamente apportate, acquistano a loro volta carattere esemplare: l’allievo si fa<br />
maestro, il <strong>modello</strong> si trasforma” 30 .<br />
Quin<strong>di</strong> la necessità artistica <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> sembra tradursi nella possibilità <strong>di</strong> <strong>un</strong> confronto e <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>’interazione tra il testo archetipico e la realtà contemporanea, in grado <strong>di</strong> produrre <strong>un</strong> testo-gesto<br />
altro, che non pertiene alla sfera semantica della riscrittura, bensì a quella della rivitalizzazione<br />
dell’opera in chiave storica, attraverso l’apporto sostanziale degli attori, intesi come testimoni.<br />
24 Bertolt <strong>Brecht</strong>, Scritti teatrali III, Note ai drammi e alle regie, Einau<strong>di</strong>, Torino 1962, pp. 237-244.<br />
25 Ivi, p. 238.<br />
26 Ivi, p. 239.<br />
27 Ibidem.<br />
28 Ibidem.<br />
29 Ivi, p. 240.<br />
30 Ibidem.<br />
www.turindamsreview.<strong>un</strong>ito.it<br />
Il coro <strong>di</strong> Anziani con la maschera <strong>di</strong> Bacco<br />
4
La pièce è introdotta da <strong>un</strong>a<br />
<strong>di</strong>dascalia che recita: “Berlino,<br />
aprile 1945. E’ l’alba. Due sorelle<br />
escono dal rifugio antiaereo per far<br />
ritorno alla loro abitazione” 31 (fig.<br />
1 32 ). Segue il Prelu<strong>di</strong>o, <strong>un</strong><br />
microdramma a due voci, spazio<br />
della contestualizzazione storica<br />
contemporanea. Nel primo<br />
Prologo, il Vorspiel <strong>di</strong> Coira,<br />
l’attualizzazione è il motivo<br />
dominante; nel secondo, il Prolog<br />
<strong>di</strong> Greiz del 1951 affidato alla voce<br />
<strong>di</strong> Tiresia, <strong>Brecht</strong> palesa le<br />
motivazioni dell’origine dei<br />
personaggi e delle loro azioni.<br />
<strong>Antigone</strong>, come presenza scenica e<br />
come voce narrante, allo stesso tempo è la “grande figura <strong>di</strong> resistente” dell’antico dramma e non è<br />
l’incarnazione degli eroi della Resistenza tedesca al nazismo. In coerenza, quin<strong>di</strong>, con le sue “teorie<br />
sul rifacimento <strong>di</strong> testi antichi, <strong>Brecht</strong> non altera la cronologia dell’azione” 33 (il collegamento con<br />
l’attualità è limitato al primo prologo) e mantiene il maggior numero <strong>di</strong> riferimenti ai dati culturali<br />
della Grecia classica, conservando anche gli epiteti, che costituiscono <strong>un</strong> tratto stilistico evidente<br />
della lingua epica e tragica. Questo permette <strong>di</strong> evitare l’identificazione tra la resistente <strong>Antigone</strong> e i<br />
resistenti tedeschi, mantenendo la narrazione in <strong>un</strong> “alone <strong>di</strong> remota storicità” 34 al fine <strong>di</strong><br />
raggi<strong>un</strong>gere lo scopo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a “traslazione metaforica” 35 , come rivitalizzazione dell’esempio antico e<br />
riflessione critica sugli eventi attuali narrati, sospinti nell’<strong>un</strong>iverso del mito.<br />
Il prologo <strong>di</strong> Coira ripete, nel contesto della Germania nazista, la storia degli orrori descritti da<br />
<strong>Sofocle</strong>: la guerra <strong>di</strong> conquista del singolo assetato <strong>di</strong> potere (Creonte vuole le miniere <strong>di</strong> bronzo <strong>di</strong><br />
Argo), la tirannia, la morte dei figli, con la variante della <strong>di</strong>serzione <strong>di</strong> Polinice, che combatte nello<br />
stesso esercito del fratello e che è accusato ed ucciso per codar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> fronte al nemico.<br />
Due sorelle, in<strong>di</strong>cate come “la prima” e “la seconda”, tornando a casa trovano dei viveri e le vesti<br />
del fratello Polinice. Sperano che questi sia tornato fuggendo alla guerra. Alc<strong>un</strong>i rumori sospetti le<br />
mettono in allarme, ma decidono <strong>di</strong> non andare a vedere cosa sta succedendo all’esterno. Presto le<br />
due sorelle scoprono il cadavere del fratello Polinice, impiccato <strong>di</strong> fronte alla porta <strong>di</strong> casa, ad <strong>un</strong><br />
gancio da macellaio. Irrompe <strong>un</strong>a SS e chiede loro notizie sul morto. Le donne negano <strong>di</strong><br />
conoscerlo, per paura, così come Madre Courage nel dramma omonimo non riconosce il cadavere<br />
del figlio, non parla, non vede, è come <strong>un</strong>a morta. La Courage è vista soprattutto “come <strong>un</strong>a Niobe<br />
che non riesce a proteggere i suoi figli dalla fatalità della guerra” 36 Bozzetto <strong>di</strong> Caspar Neher per l’ingresso <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong> con la gogna<br />
; il personaggio archetipico <strong>di</strong><br />
<strong>Antigone</strong> rappresenta per <strong>Brecht</strong> colei che può sfidare il destino, ma non riuscirà nel suo intento.<br />
Ella è già destinata alla morte, come è scritto nel nome, insieme al suo ideale <strong>di</strong> libertà. Nel prologo,<br />
infatti, siamo dentro la vicenda storica della Germania <strong>di</strong> Hitler, <strong>di</strong> cui si conoscono gli esiti<br />
irreparabili.<br />
31 Bertolt <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>, traduzione italiana <strong>di</strong> M. Carpitella, in <strong>Sofocle</strong>, Anouilh, <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>. Variazione sul<br />
mito, a cura <strong>di</strong> Maria Grazia Ciani, Marsilio, Venezia 2000, p. 121.<br />
32 La numerazione delle figure fa riferimento all’<strong>Antigone</strong>modell. Bertolt <strong>Brecht</strong>, Caspar Neher, Ruth Berlau,<br />
<strong>Antigone</strong>modell 1948, cit.<br />
33 Cesare Molinari, Storia <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong> da <strong>Sofocle</strong> al Living Theatre: <strong>un</strong> mito nel teatro occidentale, De Donato, Bari<br />
1977, pp. 160-161.<br />
34 Bertolt <strong>Brecht</strong>, Scritti teatrali, cit., p. 189.<br />
35 Stefano Bajma Griga, Bertolt <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>, in Roberto Alonge (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong>, volti <strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma, cit, p.<br />
254.<br />
36 Bertolt <strong>Brecht</strong>, Scritti teatrali, cit., p. 175<br />
www.turindamsreview.<strong>un</strong>ito.it<br />
5
Anche sul piano strettamente linguistico, la<br />
<strong>di</strong>versificazione tra prologo e trage<strong>di</strong>a è netta. Il<br />
linguaggio del componimento tragico, al <strong>di</strong> là della<br />
traduzione <strong>di</strong> Hölderlin, è complesso, a volte<br />
oscuro, sprofondato in <strong>un</strong> passato immemorabile,<br />
con <strong>un</strong>a cadenza arcaica che evoca la metrica<br />
classica. La lingua del prologo invece è semplice e<br />
piana, scan<strong>di</strong>ta da <strong>un</strong> ritmo familiare <strong>di</strong> coppi<br />
rimanti <strong>di</strong> endecasillabi. Non vi sono metafore,<br />
presenti invece in abbondanza nel testo<br />
drammatico vero e proprio. Nel prelu<strong>di</strong>o non<br />
parlano antichi re ed eroi del mito, bensì due<br />
povere ragazze costrette a lavorare duramente in<br />
fabbrica. Di pari grado, immenso e <strong>di</strong>sumano, è<br />
però il dolore, che deriva dall’oppressione del<br />
potere. Queste due donne anonime sono la<br />
reincarnazione <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong> ed Ismene, anche se<br />
con <strong>un</strong> rovesciamento: la mite è colei che vuol<br />
soccorrere il fratello, la dura è quella che<br />
impe<strong>di</strong>sce il soccorso. Nel prologo attualizzante il<br />
gesto “irragionevole”, solitario ed esemplare, non<br />
viene compiuto. La <strong>resistenza</strong> al nazismo, infatti,<br />
per <strong>Brecht</strong> non è <strong>un</strong> fatto in<strong>di</strong>viduale ma <strong>di</strong><br />
coscienza collettiva.<br />
Non sussiste nel testo <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> il <strong>di</strong>lemma tra la legge non scritta (nomos agraphos) <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong> e<br />
la legge scritta <strong>di</strong> Creonte, il dubbio <strong>di</strong> <strong>un</strong>a verità che oscilla da <strong>un</strong> capo all’altro: le ragioni della<br />
pietas familiare e <strong>di</strong>vina da <strong>un</strong>a parte e le ragioni del <strong>di</strong>ritto, della legge dello Stato dall’altra; e<br />
neppure, secondo l’interpretazione del testo sofocleo data da Guido Paduano 37 , l’idea che lo scopo<br />
primario dell’atto <strong>di</strong> ribellione <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong> sia l’amore, allorché “<strong>Antigone</strong> è perfettamente<br />
consapevole, sin dall’inizio, che lei sola è la portaban<strong>di</strong>era intrepida della fedeltà al ghénos, che in<br />
lei sola è l’orgoglio <strong>di</strong> appartenere a quella stirpe regale (maledetta ma regale)” 38 . Nel testo <strong>di</strong><br />
<strong>Brecht</strong> si ha <strong>un</strong>a <strong>di</strong>stinzione manichea: da <strong>un</strong> lato “il tiranno tout court”, come rileva Roberto<br />
Alonge, “nel senso moderno, non in quello greco, che talvolta vale semplicemente capo” 39 , assieme<br />
al coro <strong>di</strong> vecchi tebani 40 , dall’altro <strong>Antigone</strong> che vi si oppone ideologicamente, “solo per dare <strong>un</strong><br />
esempio” 41 (fig. 15). <strong>Antigone</strong>, infatti, intende contrapporre <strong>un</strong> segnale <strong>di</strong> rifiuto a quello <strong>di</strong> terrore<br />
imposto alla città da Creonte. Cesare Molinari afferma a ragione che: “dare <strong>un</strong> esempio significa<br />
porsi sul piano dell’opposizione non più in<strong>di</strong>viduale ma politica” 42 <strong>Antigone</strong> con la tavola e Creonte<br />
. La <strong>di</strong>scussione tra <strong>Antigone</strong> e<br />
Creonte passa dal significato morale del gesto dell’eroina (il gesto va compiuto anche se non è utile<br />
e non mo<strong>di</strong>ficherà niente; la potenza del tragico sta nell’affermazione <strong>di</strong> questo gesto) alla critica<br />
37<br />
Cfr. Guido Paduano, <strong>Antigone</strong> e la democrazia ateniese, in in Roberto Alonge (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong>, volti <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
enigma, cit.<br />
38<br />
Roberto Alonge, <strong>Antigone</strong>, volti <strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma, in “Turin D@ms Review”, 2007,<br />
http://obelix.cisi.<strong>un</strong>ito.it/turindamsreview/link/antigone.pdf<br />
39<br />
Roberto Alonge, <strong>Antigone</strong>, volti <strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma, in “Turin D@ms Review”, 2007,<br />
http://obelix.cisi.<strong>un</strong>ito.it/turindamsreview/link/antigone.pdf<br />
40<br />
Come afferma Lia Secci “il coro [è] il termine <strong>di</strong> paragone più sintomatico per le versioni moderne <strong>di</strong> trage<strong>di</strong>e<br />
greche” e nel rifacimento <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> continua a rivestire <strong>un</strong> ruolo fondamentale. Cfr. Lia Secci, Il mito greco nel teatro<br />
tedesco espressionista, cit., p. 134.<br />
41<br />
Bertolt <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>, traduzione italiana <strong>di</strong> M. Carpitella, in <strong>Sofocle</strong>, Anouilh, <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>. Variazione sul<br />
mito, a cura <strong>di</strong> Maria Grazia Ciani, cit., p. 142. Tavola 15 <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong>modell, cit.. La <strong>di</strong>dascalia recita: “<strong>Antigone</strong><br />
quando venne condotta, interrogata perché avesse infranto la legge, guardò intorno e vide gli Anziani, li vide atterriti e<br />
<strong>di</strong>sse loro: questo è <strong>un</strong> esempio!”<br />
42<br />
Cesare Molinari, Storia <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong> da <strong>Sofocle</strong> al Living Theatre, cit., p. 165.<br />
www.turindamsreview.<strong>un</strong>ito.it<br />
6
della condotta politica del tiranno 43 . <strong>Antigone</strong> svela la verità del potere <strong>di</strong>ttatoriale: la guerra non è<br />
della patria, ma del despota:<br />
A. Sono due cose <strong>di</strong>verse morire per te e morire per la patria.<br />
C. E allora non c’è <strong>un</strong>a guerra?<br />
A. Sì. La tua! 44<br />
Creonte <strong>di</strong>viene, da accusatore, accusato e l’esito tragico <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong> suggella il carattere<br />
annientatore della guerra “dal grande bottino” 45 , camuffata da amor <strong>di</strong> patria. Nel processo <strong>di</strong><br />
razionalizzazione del mito messo in atto da <strong>Brecht</strong> la figura del sovrano assoluto è emblema della<br />
legge iniqua. Il personaggio “<strong>di</strong>venta, sulla scia della catastrofe europea, l’incarnazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>o Stato<br />
inquinato dall’ingiustizia” 46 , tanto che il comportamento <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong> provoca lo smascheramento<br />
delle contrad<strong>di</strong>zioni insite al potere. Il ruolo dell’eroina sofoclea, infatti, si arricchisce in <strong>Brecht</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a valenza demistificatoria. Lo stereotipo ideologico dell’autocrate guerrafondaio e ingannatore<br />
che occulta le peggiori nefandezze <strong>di</strong>etro <strong>un</strong>’apparenza pacifica, gaia ed entusiasta è rappresentato<br />
con la figura <strong>di</strong> <strong>un</strong> Creonte danzante (alza le ginocchia e abbassa il bacino, battendo ritmicamente i<br />
pie<strong>di</strong> per terra con impeto) mentre si accinge a parlare al popolo innalzando la maschera <strong>di</strong> Bacco,<br />
<strong>di</strong>o della gioia e della concor<strong>di</strong>a 47 (fig. 69). Si tratta <strong>di</strong> <strong>un</strong> enorme volto a forma rettangolare,<br />
caratterizzato da <strong>un</strong> sorriso abbozzato e da <strong>un</strong>a capigliatura scomposta, fatta <strong>di</strong> ciuffi sfrangiati. La<br />
maschera è posizionata su <strong>un</strong> l<strong>un</strong>go bastone e usata all’occorrenza dal tiranno e dal coro <strong>di</strong> Anziani<br />
che partecipano alla ridda bacchica, giustapposta davanti al volto (fig. 34) o agitata in aria come <strong>un</strong><br />
tirso <strong>di</strong>onisiaco. Creonte e il suo seguito danzano in maschera con pose che evocano la danza <strong>di</strong><br />
Hitler alla capitolazione della Francia, <strong>di</strong> cui <strong>Brecht</strong> conserva testimonianza nei Diari <strong>di</strong> lavoro (17<br />
giugno 1940):<br />
Hitler balla. Il Führer balla <strong>un</strong>a giga per la vittoria. […] Imme<strong>di</strong>atamente prima che fossero riprese<br />
queste immagini Hitler aveva firmato l’invito rivolto a Mussolini per <strong>un</strong> incontro a Monaco, allo<br />
scopo <strong>di</strong> accordarsi sulle con<strong>di</strong>zioni da imporre alla Francia sconfitta. Egli è ebbro <strong>di</strong> gioia. Battendo<br />
energicamente i tacchi, serra i pugni e muove a scatti le braccia in su e in giù con <strong>un</strong> ghigno pieno <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>’estasi spasmo<strong>di</strong>ca e affettata. […] Questo è il volto del trionfo, scoperto, sfacciato. 48<br />
43 Cfr. Ibidem.<br />
44 Bertolt <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>, traduzione italiana <strong>di</strong> M. Carpitella, in <strong>Sofocle</strong>, Anouilh, <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>. Variazione sul<br />
mito, a cura <strong>di</strong> Maria Grazia Ciani, cit., p. 143.<br />
45 Franca Angelini, <strong>Antigone</strong> antica e moderna, in Paola Trivero (a cura <strong>di</strong>)Per <strong>Antigone</strong>, Vittorio Alfieri nel 250°<br />
anniversario della nascita. Convegno <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, Torino, 25-26 febbraio 1999, I Quaderni del Castello <strong>di</strong> Elsinore,<br />
DAMS, Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Torino, Stu<strong>di</strong>o Lexis, 2002, p. 28: “Sostanzialmente rispettoso del testo <strong>di</strong> origine,<br />
<strong>Brecht</strong> lo usa per <strong>un</strong>a violenta requisitoria contro la guerra ‘dal grande bottino’, per la quale combattono i due fratelli<br />
eroicamente o vilmente ‘È giusto morire per la guerra o per la patria?’ – si chiede <strong>Antigone</strong> (è questa la chiave anche<br />
della ripresa del Living del 1967)”.<br />
46 Luigi Forte, L’<strong>Antigone</strong> <strong>di</strong> Bertolt <strong>Brecht</strong> ovvero la trage<strong>di</strong>a del potere, in Roberto Alonge (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong>, volti<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma, cit., p. 238.<br />
47 Cfr. Bertolt <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>, traduzione italiana <strong>di</strong> M. Carpitella, in <strong>Sofocle</strong>, Anouilh, <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>. Variazione<br />
sul mito, a cura <strong>di</strong> Maria Grazia Ciani, cit., pp. 158-159: “Bacco non devasta / il globo terrestre con mano violenta,<br />
bensì / Pacifico, fin da principio si associa / Al nascere <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> accor<strong>di</strong>. Poiché non bellicosa / Con lui cospira la<br />
<strong>di</strong>vina bellezza”.<br />
48 Bertolt <strong>Brecht</strong>, Diario <strong>di</strong> lavoro, vol. I 1938-1942, a cura <strong>di</strong> Werner Hecht, traduzione italiana <strong>di</strong> Bianca Zagari,<br />
Einau<strong>di</strong>, Torino 1973, p. 529, nota in riferimento alle illustrazioni <strong>di</strong> pp. 103-113.<br />
www.turindamsreview.<strong>un</strong>ito.it<br />
7
L’imperativo morale che <strong>Antigone</strong> incarna durante l’interrogatorio <strong>di</strong> Creonte (questo è <strong>un</strong> esempio)<br />
e la sua “libera azione” producono<br />
<strong>un</strong> netto <strong>di</strong>stanziamento dal testofonte.<br />
Franco Perrelli ben evidenzia<br />
come nel gesto <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong> si<br />
proietti il destino <strong>di</strong> E<strong>di</strong>po e come<br />
solo questo induca lo spettatore<br />
greco ad <strong>un</strong>a pena profonda. “Di<br />
contro, se si vedesse il gesto<br />
dell’eroina come <strong>un</strong> fatto isolato,<br />
come <strong>un</strong>a collisione tra l’amore <strong>di</strong><br />
sorella e l’arbitrario <strong>di</strong>vieto umano,<br />
<strong>Antigone</strong> cesserebbe <strong>di</strong> essere <strong>un</strong>a<br />
trage<strong>di</strong>a greca, sarebbe <strong>un</strong> soggetto<br />
<strong>Antigone</strong>, curva sotto il peso della tavola, <strong>di</strong> fronte a Creonte sullo scranno<br />
8<br />
tragico del tutto moderno, come in<br />
effetti accade nello spettacolo del<br />
Living Theatre e in tutte le<br />
interpretazioni in chiave più o meno politica del suo mito” 49 . L’esempio d<strong>un</strong>que rientra in <strong>un</strong>a<br />
concezione storica: il gesto deve essere imitato, ma l’io-attante (<strong>Antigone</strong>) non compie <strong>un</strong>a mimèsi<br />
del gesto, bensì lo “narra” come <strong>un</strong>a testimone, secondo la <strong>di</strong>mensione epica della teoria brechtiana;<br />
“<strong>Antigone</strong> vive nell’atto stesso <strong>di</strong> raccontarsi e per raccontarsi” 50 . Occorre ricordare a questo<br />
proposito che egli intende praticare <strong>un</strong>a “letterarizzazione” del teatro: sostituire al “figurato” il<br />
“formulato” 51 . In questa <strong>di</strong>rezione si colloca l’uso dei cartelli, dei titoli e delle <strong>di</strong>dascalie in tutte le<br />
messinscene brechtiane e d<strong>un</strong>que anche nel “dramma <strong>di</strong>dattico” 52 dell’<strong>Antigone</strong>. La scelta del<br />
passato remoto nei titoli che accompagnano le immagini del modellbuch e che sono recitati dagli<br />
attori in scena come brevi prelu<strong>di</strong> all’azione ha la duplice f<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> situare l’evento in <strong>un</strong>o spaziotempo<br />
lontano e contemporaneamente <strong>di</strong> presentificarlo e <strong>un</strong>iversalizzarlo attraverso il drama agito.<br />
Il <strong>di</strong>alogo che si intreccia tra la parola e l’immagine, tra le <strong>di</strong>dascalie e la scena delinea <strong>un</strong> coerente<br />
percorso epico-illustrativo, <strong>un</strong>a sorta <strong>di</strong> trama visiva, in cui i nessi semantici e i segni iconici<br />
concorrono alla realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a partitura mimico-recitativa <strong>di</strong> “esemplare contemporaneità” 53 .<br />
È sufficiente a tal proposito osservare lo sviluppo dell’iconografia <strong>di</strong> <strong>Antigone</strong>. Nel bozzetto <strong>di</strong><br />
Neher l’eroina tragica compare con la testa e le braccia chiuse da <strong>un</strong>a gogna (fig. 78), strumento <strong>di</strong><br />
tortura e lu<strong>di</strong>brio che traduce metaforicamente l’upò zugo, “sotto il giogo”, del testo sofocleo 54 . La<br />
gogna sarà poi sostituita in scena da <strong>un</strong>a tavola <strong>di</strong> legno (fig. 70) che costringe l’attrice ad assumere<br />
<strong>un</strong>a posizione curva in avanti, con le mani appoggiate alla schiena, incastrate all’interno <strong>di</strong> due fori<br />
praticati nel legno (fig. 18). La sentinella ha appoggiato quest’asse sulla donna prima del suo<br />
ingresso nell’area della rappresentazione. La partitura fisica dell’attrice e l’oggetto metaforico<br />
esprimono in modo illustrativo la schiavitù del popolo nei confronti del tiranno. La battuta che<br />
<strong>Antigone</strong> pron<strong>un</strong>cia è:<br />
Non è vero. Terra è fatica. Per l’uomo la patria<br />
49<br />
Franco Perrelli, Kierkegaard, <strong>Antigone</strong> e la costruzione del dramma moderno, in Roberto Alonge (a cura <strong>di</strong>),<br />
<strong>Antigone</strong>, volti <strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma, cit., p. 213.<br />
50<br />
Stefano Bajma Griga, Bertolt <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>, in Roberto Alonge (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong>, volti <strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma, cit., p.<br />
254.<br />
51<br />
Bertolt <strong>Brecht</strong>, Scritti teatrali, cit., p. 38: “Letterarizzazione significa sostituire al 'figurato' il 'formulato': essa dà al<br />
teatro la possibilità <strong>di</strong> stabilire <strong>un</strong>a connessione con altri istituti de<strong>di</strong>ti all’attività spirituale; ma rimane <strong>un</strong> fatto<br />
<strong>un</strong>ilaterale finché anche il pubblico non partecipi ad essa e, attraverso essa, riesca a penetrare al <strong>di</strong> sopra della vicenda”.<br />
52<br />
Roberto Alonge, <strong>Antigone</strong>, volti <strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma, in “Turin D@ms Review”, 2007,<br />
http://obelix.cisi.<strong>un</strong>ito.it/turindamsreview/link/antigone.pdf<br />
53<br />
Stefano Bajma Griga, Bertolt <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>, in Roberto Alonge (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong>, volti <strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma, cit., p.<br />
254.<br />
54 Cfr. nota seguente.<br />
www.turindamsreview.<strong>un</strong>ito.it
Non è solo la terra, la casa: non dove ha versato<br />
Sudore, né la casa che derelitta attende il fuoco<br />
Non chiama patria il luogo ove ha chinato la testa. 55<br />
La resistente della versione brechtiana, costretta ad <strong>un</strong>a posa innaturale come in <strong>un</strong> calvario<br />
cristologico, traballa sotto il peso della tavola, ma quando l’azione lo richiede denota fermezza e<br />
determinazione e lo strumento <strong>di</strong> tortura accresce la sua imponenza e la sua ostinazione.<br />
Anche l’ambientazione scenica entro cui si muove è considerata da <strong>Brecht</strong> spazio esemplare, che ha<br />
l'obbligo <strong>di</strong> essere conservato proprio in quanto capace <strong>di</strong> sopportare qualsiasi variazione.<br />
L’allestimento, infatti, si presenta scarno ed essenziale. Non esiste sipario. Allo spettatore deve<br />
essere chiaro che l’attore non è immedesimato nel personaggio, ma sta raccontando <strong>un</strong>a storia cui<br />
ha assistito, annullando così qual<strong>un</strong>que <strong>di</strong>sposizione illusionistica. Gli attori, come quasi sempre<br />
avviene nelle messinscene <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong>, occupano il palco per tutta la durata dello spettacolo, seduti su<br />
l<strong>un</strong>ghe panche ai lati della scena ma com<strong>un</strong>que a vista. Solo quando entrano nello spazio della<br />
recitazione, ben illuminato, assumono gli atteggiamenti prescritti per i personaggi. Le azioni<br />
sceniche si svolgono <strong>di</strong> fronte ad <strong>un</strong> emiciclo <strong>di</strong> paraventi. Il luogo della rappresentazione è<br />
delimitato da quattro bastoni sopra i quali sono appesi teschi equini, carcasse teriomorfe simbolo <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>struzione e morte.<br />
Tra le rovine della Germania e dell’Europa tutta, <strong>Brecht</strong> scopre nel mito <strong>un</strong>a testimonianza<br />
para<strong>di</strong>gmatica che, se vivificata e fatta vibrare, è in grado <strong>di</strong> risvegliare lo spirito politico dei<br />
contemporanei, come tensione verso lo svelamento. Sul piano formale, in<strong>di</strong>vidua nel <strong>modello</strong> <strong>un</strong><br />
percorso <strong>di</strong> avvicinamento al “vero” 56 ; <strong>un</strong> processo <strong>di</strong> attualizzazione della parola parlata, che ha lo<br />
scopo <strong>di</strong> narrare ed illustrare la realtà per agire su <strong>di</strong> essa.<br />
Sì, ogni volta che ritorna Creonte, ritorna anche <strong>Antigone</strong>. 57<br />
55 Bertolt <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>, traduzione italiana <strong>di</strong> M. Carpitella, in <strong>Sofocle</strong>, Anouilh, <strong>Brecht</strong>, <strong>Antigone</strong>. Variazione sul<br />
mito, a cura <strong>di</strong> Maria Grazia Ciani, cit., p. 145. Ai vv. 289-292 del testo sofocleo Creonte recita: “Piuttosto, c’è in<br />
questa città gente che sopporta a stento il mio governo, scuote il capo in silenzio, e non piega il collo sotto il giogo<br />
come è giusto, non mi obbe<strong>di</strong>sce volentieri”, traduzione <strong>di</strong> Guido Paduano.<br />
56 Cfr. Bertolt <strong>Brecht</strong>, Scritti teatrali, cit., p. 191.<br />
57 Roberto Alonge (a cura <strong>di</strong>), <strong>Antigone</strong>, volti <strong>di</strong> <strong>un</strong> enigma, cit., Prefazione, p. 8. Per <strong>un</strong> approfon<strong>di</strong>mento del tema si<br />
veda Rossana Rossanda, <strong>Antigone</strong> ricorrente, saggio introduttivo a <strong>Sofocle</strong>, <strong>Antigone</strong>, traduzione <strong>di</strong> Luisa Biondetti,<br />
Feltrinelli, Milano 1987.<br />
www.turindamsreview.<strong>un</strong>ito.it<br />
9