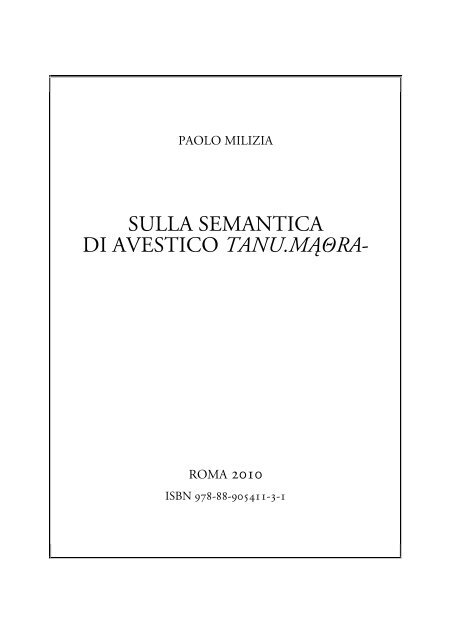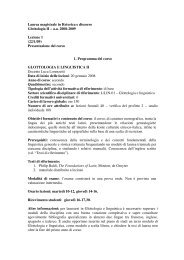sulla semantica di avestico tanu.mąθra - Università degli Studi di ...
sulla semantica di avestico tanu.mąθra - Università degli Studi di ...
sulla semantica di avestico tanu.mąθra - Università degli Studi di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PAOLO MILIZIA<br />
SULLA SEMANTICA<br />
DI AVESTICO TANU.MĄΘRA-<br />
ROMA 2010<br />
ISBN 978-88-905411-3-1
Paolo Milizia<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
<br />
ISBN-13 978-88-905411-3-1 eBook PDF<br />
EDELA e<strong>di</strong>zioni elettroniche accademiche<br />
Roma
* Forse come forma <strong>di</strong> omaggio alla sede <strong>di</strong> pubblicazione, gli<br />
Jahrbücher der Biblischen Wissenschaft, nello stu<strong>di</strong>o del 1853 «Erklärung<br />
Persischer wörter des Alten Testamentes» Martin Haug, capitatogli <strong>di</strong> citare,<br />
nella <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> tutt’altra forma, l’<strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-, faceva seguire tra<br />
parentesi tonde questa glossa esplicativa: «das Leibgewordene wort vgl. λόγος<br />
im ev. Johann.» ‘la parola <strong>di</strong>ventata corpo, cf. λόγος nel Vangelo <strong>di</strong> Giovanni’.<br />
Difficile è <strong>di</strong>re se e quanto la suggestione giovannea abbia effettivamente<br />
influenzato l’esegesi moderna su questo particolare problema della filologia<br />
avestica; noi nelle pagine che seguono cercheremo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare che<br />
<strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- non significa ‘il <strong>mąθra</strong>- fatto corpo’ e che l’indagine<br />
sull’intensione <strong>di</strong> tale composto va condotta nell’ambito <strong>di</strong> un sistema<br />
nozionale affatto <strong>di</strong>verso.<br />
1. Attestazioni ed etimo<br />
La parola <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-, attestata nell’Avesta recente, è primariamente<br />
epiteto <strong>di</strong> Sraoša (Y. 3.20; 4.23; 7.20; 57.1,33; V. 18.14; S. 1.17). Nel Mihr<br />
Yašt compare come epiteto <strong>di</strong> Mithra (Yt. 10.25); come osserva Mary Boyce<br />
(1970: 33, n. 68), si tratta <strong>di</strong> uno dei pochi attributi trasferiti da Sraoša a<br />
Mithra, laddove gli altri tratti comuni vanno <strong>di</strong> norma interpretati come<br />
originarie caratteristiche <strong>di</strong> Mithra secondariamente attribuite a Sraoša. In<br />
tre luoghi avestici <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- è riferito a figure umane, ossia all’officiante <strong>di</strong><br />
un rito <strong>di</strong> offerta (Yt. 10.137), a Zarathustra in quanto sacerdote (Yt. 5.91) e<br />
all’uomo rinato nella palingenesi finale (frašō.kərəti-) prevista dalla dottrina<br />
zoroastriana (V. 18.51). Nel Frawardīn Yašt, infine, è attributo <strong>di</strong> due<br />
persone: Vīštāspa e Karsna (Yt. 13.99,106).<br />
<br />
* Ringrazio Marco Mancini per gli utili commenti e suggerimenti. Solo mia è,<br />
naturalmente, la responsabilità <strong>di</strong> eventuali errori od omissioni nel testo.<br />
Paolo Milizia – Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- – ISBN 978-88-905411-3-1
Paolo Milizia<br />
L’etimologia, a parte una derivazione alternativa teoricamente<br />
possibile che <strong>di</strong>scuteremo in seguito, non pone problemi: <strong>tanu</strong>° rappresenta<br />
tanū- 1 , identico all’ai. tan-, sostantivo femminile che vale ‘corpo’, forse da<br />
un originario significato <strong>di</strong> ‘involucro teso’, e che deriva dalla base ie. *ten-<br />
‘tendere’ (cf. EWA I, 621, sv. tan-; IEW 1065 s.); <strong>mąθra</strong>-, identico all’ai.<br />
mantra-, è originariamente nome <strong>di</strong> strumento dalla base ie. *men- ‘pensare’<br />
(IEW 726-8), che evolve <strong>semantica</strong>mente, già in fase indoiranica, in<br />
‘pensiero’, ‘pensiero formulato’, ‘parola, formula’ 2 .<br />
2. L’interpretazione <strong>di</strong> Burnouf e Gershevitch: il problema della determinazione<br />
della testa del composto<br />
L’interpretazione <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- come ‘il cui corpo è <strong>mąθra</strong>-’ risale<br />
almeno ad Eugène Burnouf che glossava (1833: 41): «“celui qui a la parole<br />
pour corps, celui dont la parole est le corps;” et peut-être par extension :<br />
“parole faite corps, incarnée”». Analogamente intedevano pure Friedrich<br />
Spiegel («dessen Leib der Manthra ist», 1864: 387) e Johannes Hertel<br />
(1929), che rendeva l’epiteto con «dessen Leib aus Liedern besteht» 3 .<br />
<br />
1 La quantità breve della vocale u nella forma che compare come primo elemento <strong>di</strong><br />
composto non rappresenta un problema: frequenti sono nella tra<strong>di</strong>zione avestica i<br />
fenomeni <strong>di</strong> scambio breve/lunga a carico <strong>di</strong> i e u, cf. Hoffmann-Forssman 2004: 55. In<br />
particolare, i temi nominali in -ū- mostrano una tendenza a confluire con i temi in -u-,<br />
v. de Vaan 2003: 327-9, 300.<br />
2 Cito qui alcune tra le <strong>di</strong>verse rese <strong>degli</strong> interpreti moderni: nella versione francese <strong>di</strong><br />
Jean Kellens e Eric Pirart (1989-91) e nella traduzione inglese <strong>di</strong> Helmut Humbach<br />
(Humbach et al. 1991) il lessema è tradotto con ‘formule’, ‘formula’; Ilya Gershevitch<br />
(1959: 85) e Mary Boyce (1996:60) rendono rispettivamente con ‘<strong>di</strong>vine word’ e ‘sacred<br />
word’; Prods Oktor Skjærvø traduce con ‘poetic thought’ (cf. 2002: 400, n. 9). Per l’uso<br />
<strong>di</strong> derivati <strong>di</strong> *men- in riferimento alla poesia si veda, da ultimo, M. West (2007: 33 ss.).<br />
3 La stessa interpretazione è seguita anche da James Darmesteter («incarnate Word»,<br />
1880: 192), e da Lawrence H. Mills («whose Body is the Mãthra», 1887: 305). Al<br />
contrario, il primo traduttore occidentale dell’Avesta, Abraham-Hyacinthe Anquetil Du<br />
Perron aveva tradotto con «corps obéïssant» (1771, I-2, 404), influenzato evidentemente<br />
dalla tra<strong>di</strong>zione esegetica zoroastriana, che mette l’epiteto in relazione con la virtù<br />
dell’obbe<strong>di</strong>enza (cf. infra). Una sorta <strong>di</strong> fusione tra la linea interpretativa <strong>di</strong> Burnouf e<br />
l’esegesi tra<strong>di</strong>zionale è la soluzione <strong>di</strong> Charles de Harlez che traduceva «incarnation de la<br />
loi» e spiegava in nota «Çraocha, le génie de la loi et de l’obéissance a, pour ainsi <strong>di</strong>re, le<br />
2
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
Contro questa interpretazione sta il fatto che ad una simile <strong>semantica</strong>,<br />
come notò già a suo tempo Jacques Duchesne-Guillemin (1936: 155),<br />
corrisponderebbe canonicamente *mąθrō.<strong>tanu</strong>- giacché i composti <strong>di</strong> tipo<br />
bahuvrīhi hanno <strong>di</strong> regola la testa a destra. In <strong>di</strong>fesa dell’interpretazione <strong>di</strong><br />
Burnouf e <strong>di</strong> Hertel, si è espresso Ilya Gershevitch (1954:180-1), secondo il<br />
quale <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- apparterrebbe a una classe, realtivamente rara, <strong>di</strong><br />
bahuvrīhi con testa a sinistra, che comprenderebbe tipicamente composti<br />
conententi una identificazione metaforica: dello stesso tipo sarebbe il<br />
composto in<strong>di</strong>ano vṛkṣá-keśa- ‘i cui alberi sono (come) capelli’ = ‘montagna<br />
boscosa’. In realtà, tale composto può e deve essere interpretato come<br />
normale bahuvrīhi con testa a sinistra e vale quin<strong>di</strong> ‘i cui capelli sono alberi’.<br />
Proprio questa è, d’altra parte, l’interpretazione che più rispetta la natura<br />
metaforica dell’espressione: la montagna ha capelli, che, fuor <strong>di</strong> metafora,<br />
sono alberi. Il fatto che, come nota Gershevitch (p. 180, n. ‡), sia il secondo<br />
termine del composto a fornire il termine figurativo dell’identificazione, non<br />
rappresenta quin<strong>di</strong> nulla <strong>di</strong> inatteso rispetto all’analisi <strong>di</strong> vṛkṣá-keśa- come<br />
struttura con testa a destra.<br />
Recentemente Fridrik Thordarson (2009, cap. 4) ha accostato il caso<br />
<strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-, interpretato secondo la linea Hertel-Gershevitch, ad altri<br />
composti bahuvrīhi che paiono pure presentare una inversione dell’or<strong>di</strong>ne<br />
testa-mo<strong>di</strong>ficatore. Si tratta tipicamente <strong>di</strong> composti il cui secondo membro<br />
denota una parte del corpo: av. barəsmō.zasta- ‘che tiene il barəsman nella<br />
mano’ (AiWb. 949); ved. iṣuhasta- ‘che tiene una freccia nella mano’. In<br />
realtà in questi casi l’interpretazione secondo lo schema canonico è<br />
ugualmente ammissibile: ‘la cui mano è dotata <strong>di</strong> freccia’ (cf. MW 169 «<br />
‘arrow-handed’, carrying arrows in the hand)». Pertanto o questi composti<br />
sono sincronicamente ancora analizzabili come aventi la testa a destra,<br />
oppure hanno testa a sinistra in virtù <strong>di</strong> un fenomeno <strong>di</strong> rianalisi in base al<br />
quale un bahuvrīhi A+B che equivale originariamete a ‘la cui parte del corpo<br />
B è (dotata <strong>di</strong>) A’ è reinterpretato come ‘che ha A in B’ 4,5 .<br />
<br />
corps pénétré de la loi; c’est elle qui en meut les organes, il n’agit que par elle» (1881 2 :<br />
179 e n. 6).<br />
4 Un’interpretazione sintatticistica <strong>di</strong> tali composti è stata proposta da Jochem Schindler<br />
(1986: 395), secondo il quale i bahuvrīhi formati secondo questo schema avrebbero<br />
corrisposto sincronicamente, in una prima fase, a sintagmi formati dal secondo membro<br />
più un aggettivo possessivo in -vant- derivato dal primo membro: così il gao.zasta- <strong>di</strong> Y.<br />
3
Paolo Milizia<br />
Nei composti <strong>di</strong> questo tipo, dunque, l’inversione strutturale da un<br />
lato è secondaria, dall’altro è insorta in virtù della presenza <strong>di</strong> un nome <strong>di</strong><br />
parte del corpo come secondo membro: è evidente a questo punto come il<br />
caso <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- sia del tutto <strong>di</strong>verso.<br />
Altri casi <strong>di</strong> libera inversione dell’or<strong>di</strong>ne testa mo<strong>di</strong>ficatore sarebbero<br />
ravvisabili, ancora secondo Thordarson (loc. cit.) nell’onomastica avestica: in<br />
particolare in Nəmō.vaŋhu- (cf. Mayrhofer 1979, I/64, n. 231) che sarebbe<br />
in tutto corrispondente a Vohu.nəmah- ‘la cui venerazione è buona’ (cf.<br />
Mayrhofer 1979, I, n. 387). In realtà, accanto a tale spiegazione <strong>di</strong><br />
Nəmō.vaŋhu- come inversione <strong>di</strong> Vohu.nəmah-, che risale a August Fick<br />
(1899: 307), sono state proposte per il nome in esame altre due<br />
interpretazioni: la prima è quella <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nand Justi che nel suo Namenbuch<br />
(1895: 228) traduceva Nəmōvaŋhu- come «gut im Gebet», assegnando<br />
quin<strong>di</strong> al composto una <strong>semantica</strong> rispettosa dell’or<strong>di</strong>ne mo<strong>di</strong>ficatore-testa,<br />
l’altra è quella <strong>di</strong> Christian Bartholomae (AiWb. 1071) che intende il nome<br />
come un delocutivo da una frase ellittica nəmō vaŋhauuō “Verehrung, ihr<br />
Guten!”. Se da un lato nessuna <strong>di</strong> queste due ipotesi alternative può essere<br />
scartata, è pure significativo che per trovare possibili bahuvrīhi avestici con<br />
<br />
62.1 = Yt. 10.91 ‘che tiene del latte nella mano’ avrebbe avuto alla sua base (in una<br />
prospettiva implicitamente trasformazionale) un sintagma analogo a quello che leggiamo<br />
in Yt. 13.50: gaomata zasta ‘con la mano piena <strong>di</strong> latte’ 4 ; solo successivamente, in<br />
seguito all’uscita dall’uso <strong>di</strong> sintagmi formati da nomi <strong>di</strong> parti del corpo accompagnati<br />
da aggetivi in -vant-, lo stesso tipo <strong>di</strong> composto sarebbe stato messo in relazione con<br />
sintagmi locativali, sicché rukmá-vakṣas ‘che ha un monile d’oro sul seno’ sarebbe<br />
sincronicamente equivalente a vákṣassu rukmḥ ‘monili d’oro (sono) sui suoi seni’ (RV<br />
1.166.10). Anche nella prospettiva <strong>di</strong> Schindler, dunque, la assunzione del ruolo<br />
strutturale <strong>di</strong> testa da parte del primo membro è secondaria e si deve a un fenomeno <strong>di</strong><br />
rianalisi.<br />
5 Si prestano pure a rianalisi simile alcune strutture composizionali in cui il secondo<br />
membro, originariamente nominale, può essere reinterpretato <strong>semantica</strong>mente come<br />
esprimente una azione verbale. Ciò vale ad esempio per i composti con °vacah-: una<br />
struttura X-°vacah- ‘la cui parola è X’ può essere rianalizzata come equivalente a ‘che<br />
<strong>di</strong>ce X’; così āfrī.vacah- è sincronicamente analogo a ‘che proferisce bene<strong>di</strong>zione (āfrī-)’.<br />
Un fenomeno <strong>di</strong> rianalisi <strong>di</strong> struttura composizionale parzialmente analogo a questi è<br />
quello dei composti greci con φίλος, per il quale si rimanda alla trattazione <strong>di</strong> Palmira<br />
Cipriano (1990).<br />
4
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
testa a sinistra si debba cercare tra gli antroponimi, forme il cui statuto<br />
semantico è del tutto sui generis 6,7 .<br />
Secondo Gershevich una formazione parallela a <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- avente<br />
testa a sinistra sarebbe <strong>tanu</strong>.kəhrpa-, composto che compare nel Wištāsp Yašt.<br />
Nel passo in questione, il soggetto parlante rivolge a Vištāspa delle formule<br />
<br />
6 Un nome proprio può in effetti perdere la relazione sincronica con le parole comuni su<br />
cui è basato anche nel caso che queste ultime persistano nell’uso. D’altra parte, il<br />
significato <strong>di</strong> un nome proprio sincronicamente ricavabile dalla sua struttura<br />
morfologica non ha rilevanza nell’uso del nome stesso, ma solo nell’imposizione; in<br />
quest’ultima tuttavia insieme con il valore semantico, e anche più <strong>di</strong> esso, possono<br />
giocare un ruolo criteri <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso (si pensi ad esempio al caso dei nomi germanici,<br />
che affidano tendenzialmente al primo membro la funzione <strong>di</strong> segnalare una<br />
<strong>di</strong>scendenza genelogica, cf. Woolf 1939) – sul problema in generale si veda Anderson<br />
2007: 100 s. Non sorprende quin<strong>di</strong> il fatto che, come mostra Thordarson (2009: 99 s.),<br />
la documentazione antico-iranica <strong>di</strong>retta e in<strong>di</strong>retta presenti antroponimi interpretabili<br />
come bahuvrīhi invertiti. In particolare, nel caso dei nomi propri avestici è stato notato<br />
da Rü<strong>di</strong>ger Schmitt (2005) come alcuni <strong>di</strong> essi rappresentino unioni <strong>di</strong> lessemi<br />
combinati «with no regard to their semantic appropriateness». Significativo ci sembra il<br />
fatto che a questa tipologia appartenga, a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Schmitt il nome Mązdrāuuaŋhu-<br />
(Yt. 13.118; cf. Mayrhofer 1979, I/62, n. 225) i cui elementi significano ‘saggio,<br />
intelligente’ (mązdrā) e ‘buono’ o ‘il bene’ (vaŋhu-). Notevole è che accanto a<br />
Mązdrāuuaŋhu- sia attestato Srīrāuuaŋhu- (cf. Mayrhofer 1979, I/78s., n. 296); è<br />
verosimile che le due persone fossero fratelli e che dunque l’identità del secondo<br />
membro del composto segnalasse una relazione <strong>di</strong> parentela. Si noti che Nəmō.vaŋhu-<br />
contiene esattamente lo stesso secondo membro presente nei due nomi ora citati,<br />
probabilmente formati con criterio ‘genealogico’ anziché semantico; pare quin<strong>di</strong><br />
sostanzialmente superflua l’ipotesi che tale nome rappresenti una inversione <strong>di</strong><br />
Vohu.nəmah-, tanto più che lo stesso Schmitt (2005), nella sua classificazione <strong>degli</strong><br />
schemi dei nomi propri avestici, inserisce sì una classe <strong>di</strong> “inverted forms” ma adduce<br />
come esempio <strong>di</strong> tale classe il solo Nəmō.vaŋhu- anteponendo, per giunta, all’esempio<br />
un prudenziale ‘probably’. Fick (1899: 307) citava come caso <strong>di</strong> inversione anche mp.<br />
Dādweh rispetto ad av. Vaŋhuδāta-, ma l’esempio non funziona perfettamente, dato che<br />
mp. weh continua, come è noto, il comparativo *u̯ah-i̯ah-. Ancor meno significativi<br />
come esempi <strong>di</strong> bahuvrīhi invertiti sono d’altra parte i due nomi avestici <strong>di</strong> dubbia<br />
interpretazione Baēšatastūra- e Ōiγmatastūra- (Mayrhofer 1979 I/31, n. 78 e I/65, n.<br />
236).<br />
7 La mancanza <strong>di</strong> casi sicuri <strong>di</strong> bahuvrīhi invertiti in iranico antico è stata notata già da<br />
Stefan Zimmer (1992: 423), cui pure si rimanda per una <strong>di</strong>scussione dei meccanismi<br />
<strong>di</strong>acronici capaci <strong>di</strong> provocare la creazione del tipo invertito.<br />
5
Paolo Milizia<br />
augurali, tra cui figurano le seguenti: zaiiā̊ṇte <strong>tanu</strong>.kəhrpa 8 (Vyt. 1), zaiiā̊ṇte<br />
<strong>tanu</strong>.kəhrpa dasa puθra (Vyt. 3), ‘(a te) nascano (figli) <strong>tanu</strong>.k°’ e ‘(a te)<br />
nascano <strong>di</strong>eci figli <strong>tanu</strong>.k°’. La resa inglese del composto proposta da<br />
Gershevitch, che suona ‘whose bo<strong>di</strong>es are (like your) shape’, dove ‘body’<br />
traduce <strong>tanu</strong>- e ‘shape’ traduce kəhrp(-a)-, e che presuppone in effetti un<br />
or<strong>di</strong>ne con testa a destra, presenta in realtà due <strong>di</strong>fficoltà. Innanzitutto il<br />
composto in<strong>di</strong>cherebbe una somiglianza tra elementi eterogenei: la tanū-<br />
(corpo) dei figli somiglierebbe alla kəhrp- (sembiante) <strong>di</strong> Vištāspa, mentre<br />
sarebbe logico attendersi che la somiglianza fosse tra le kəhrp- dell’uno e<br />
<strong>degli</strong> altri (o, al più, tra le tanū- dell’uno e <strong>degli</strong> altri). Ma soprattutto, come<br />
<strong>di</strong>mostrano le parentesi tonde tra cui Gershevitch pone l’espressione “like<br />
your”, il concetto della somiglianza a Vištāspa, andrebbe riguadagnato<br />
esclusivamente attraverso il processo interpretativo, mentre sarebbe <strong>di</strong> fatto<br />
assente sul piano locutivo, cosa questa alquanto improbabile dal momento<br />
che tale nozione rappresenta l’elemento centrale dell’epiteto e dell’intero<br />
augurio. Sembra perciò molto <strong>di</strong>fficile dare conto della <strong>semantica</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>tanu</strong>.kəhrpa- se non partendo dal presupposto che l’elemento <strong>tanu</strong>- abbia qui<br />
un valore pronominale. È noto, infatti, che sia l’iranico sia l’in<strong>di</strong>ano antichi<br />
testimoniano lo sviluppo da parte dell’elemento lessicale indoiranico *tan-<br />
‘corpo’ <strong>di</strong> un valore grammaticalizzato <strong>di</strong> tipo riflessivo/intensificatore 9 .<br />
Significativamente uno dei casi in cui questo valore sembra ravvisabile con<br />
<br />
8 In Vyt. 1 la formula è seguita da kəhrpa xaiiəūš, espressione che va però probabilmente<br />
considerata come una glossa (cf. Gershevitch, loc. cit.). Dove non <strong>di</strong>versamente<br />
specificato il testo <strong>avestico</strong> è citato secondo Geldner 1889-96.<br />
9 Cf. AiWb. 633-636. I processi sviluppo <strong>di</strong> pronomi intensificatori a partire dalla<br />
grammaticalizzazione <strong>di</strong> nomi <strong>di</strong> parti del corpo sono ben noti a livello interlinguistico<br />
(cf. Moravcsik 1972; König e Siemund 1999: 55 s.; Schladt 1999; Heine 2000). In<br />
<strong>avestico</strong> è talvolta <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>stinguere tra il valore <strong>di</strong> ‘corpo’ e il valore riflessivo, così, ad<br />
es. in Yt. 17.55 āat azəm tanūm aguze ‘allora io mi nascosi/nascosi il corpo’. Altre volte<br />
tanū- è accompagnato dal riflessivo gat. x v a- rec. huua- e hauua- (cf. Yt. 4.4 haom<br />
tanūm guzaēta), cosa che tuttavia più che assenza <strong>di</strong> grammaticalizzazione in tanū- pare<br />
in<strong>di</strong>care il costituirsi <strong>di</strong> una tendenziale solidarietà <strong>semantica</strong> tra le due parole,<br />
testimoniata dalla corrispondente univerbazione nel neopersiano xwēštan ‘se stesso’. Un<br />
caso in cui il valore riflessivo è indubbio è documentato pure per il persiano antico (XPf<br />
30-32): Dārayavauš haya manā pitā pasā tanūm mām maθištām akunauš ‘Dario mio<br />
padre mi ha reso il più grande dopo se stesso’. Per l’in<strong>di</strong>ano si veda KEWA I, 475, sv.<br />
tanḥ; EWA I, 621, sv. tan-; alla trattazione <strong>di</strong> Leonid Kulikov (2007) si rimanda per<br />
una ampia casistica dell’uso pronominale <strong>di</strong> tan- in in<strong>di</strong>ano antico.<br />
6
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
maggiore sicurezza è quello dell’aggettivo <strong>tanu</strong>.kərəta- che occorre in luogo<br />
<strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.kəhrpa- in una formula augurale, per il resto identica a quella del<br />
Wištāsp Yašt, attestata nell’ Āfrīn-ī-Zardošt: puθra uszaiiā̊ṇte <strong>tanu</strong>.kərəta (Az.<br />
1). Giustamente Bartholomae traduce <strong>tanu</strong>.kərəta- con ‘von der eigenen<br />
Person gemacht, selbstgezeugt’ (AiWb. 636). È dunque evidente che anche<br />
<strong>tanu</strong>.kəhrpa- deve contenere un pronome intensificatore, coreferenziale in<br />
questo caso con la seconda persona 10 , corrispondente a Vištāspa, cui è rivolto<br />
l’augurio: il composto equivale ad ‘aventi il tuo stesso sembiante’ e va<br />
analizzato come un normale bahuvrīhi con testa a destra.<br />
3. L’interpretazione <strong>di</strong> Burnouf e Gershevitch: il problema dottrinale<br />
Anche dal punto <strong>di</strong> vista strettamente dottrinale l’idea <strong>di</strong> Sraoša come<br />
corporeizzazione, o incarnazione della parola sacra, che pure ha trovato<br />
l’adesione autorevole <strong>di</strong> Mary Boyce (1996: 60), non appare priva <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fficoltà. Innanzitutto il parallelo del Saošyant invocato da Gershevich (loc.<br />
cit.) è del tutto improprio: se nell’Avesta il Saošyant è chiamato Astuuaərəta-,<br />
ossia ‘verità (fatta) corpo materiale’, è per il semplice fatto che il<br />
Saošyant è un uomo e quin<strong>di</strong> è necessariamente dotato <strong>di</strong> un corpo fatto,<br />
appunto, <strong>di</strong> carne ed ossa (ast-); Sraoša è invece non un uomo ma un’ipostasi<br />
<strong>di</strong>vina e l’epiteto <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- gli attribuirebbe un corpo fatto non <strong>di</strong> materia<br />
ma <strong>di</strong> <strong>mąθra</strong>-. Se d’altra parte l’immagine del <strong>mąθra</strong>- come corpo <strong>di</strong> Sraoša è<br />
da intendersi come espressione figurata, quale interpretazione si dovrebbe<br />
dare a tale figura? Si potrebbe pensare che sia un modo per <strong>di</strong>re che il <strong>mąθra</strong>-<br />
e Sraoša sono la stessa cosa, ma ciò che creerebbe in realtà un’aporia<br />
<strong>di</strong>fficilmente superabile giacché Sraoša è già un’ipostasi dell’obbe<strong>di</strong>enza e<br />
non può essere dunque anche ipostasi del <strong>mąθra</strong>-.<br />
Secondo Boyce (1970: 33) l’epiteto <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- rinvierebbe alla<br />
speciale relazione che lega Sraoša alla liturgia e alla preghiera: «Sraoša has is<br />
intangible representative in the liturgy itself, for he is <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- ‘having<br />
<br />
10 Un uso <strong>di</strong> ai. tan-, nel caso accompagnato da sva-, come pronome intensificatore<br />
coreferenziale con la seconda persona – e in assenza <strong>di</strong> pronome <strong>di</strong> seconda persona – è<br />
in RV 10.83.5: suv tanr bala-déyāya mā˘ íhi ‘vieni tu stesso per darmi forza’ (Kulikov<br />
2007: 1425). Anche in indoario antico, inoltre, il comparire come primo elemento <strong>di</strong><br />
composto non altera i caratteri funzionali <strong>di</strong> tale elemento pronominale (cf. Kulikov<br />
2007: 1427 s.).<br />
7
Paolo Milizia<br />
the sacred word as body’.» Per la Stu<strong>di</strong>osa, il <strong>di</strong>o è presente ad ogni<br />
cerimonia <strong>di</strong>vina, e lo è in quanto ‘embo<strong>di</strong>ed by men’s prayers and hymns’.<br />
Una simile spiegazione, che pure si basa su una caratteristica del <strong>di</strong>o ben<br />
documentata (cf. Kreyenbroeck 1985: 169), resta tuttavia non<br />
completamente sod<strong>di</strong>sfacente per ragioni analoghe a quelle menzionate<br />
sopra. Se Sraoša è presente alle liturgie in quanto ‘incarnato dalle preghiere’,<br />
si deve concludere che egli sia assente in assenza <strong>di</strong> preghiera? Al contrario, la<br />
pienezza <strong>di</strong> Sraoša si riflette in tutte le attività umane, come emerge<br />
chiaramente, ad esempio, da Y. 57.14 (testo secondo Kreyenbroek 1985:<br />
42): «yeŋ́he nmāniia sraošō aṣǐiō vərəθrajā̊ θrąfəδō asti paiti.zaṇtō nāca aṣǎuua<br />
frāiiō.humatō frāiiō.hūxtō frāiiō.huuarštō» ‘(nella casa <strong>di</strong> quello) nella cui casa<br />
Sraoša, il conforme all’Or<strong>di</strong>ne (aṣǐia-), è vincente, sod<strong>di</strong>sfatto e ben accolto,<br />
anche l’uomo giusto (aṣǎuuan-) è dotato in sommo grado <strong>di</strong> buoni pensieri,<br />
<strong>di</strong> buone parole e <strong>di</strong> buone azioni’.<br />
Significativo a questo riguardo è il fatto che la tra<strong>di</strong>zione esegetica<br />
persiana non colleghi affatto l’aggettivo <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- con gli aspetti liturgici,<br />
ma proprio con la nozione <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza. Nella traduzione pahlavica<br />
<strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-, reso meccanicamente con tan e framān (traducente regolare <strong>di</strong><br />
<strong>mąθra</strong>-), è glossato infatti (Y. 57.1) con kū tan pad framān ī yazdān dārēd<br />
‘cioè: tiene il corpo al comando <strong>degli</strong> Yazata’ (cf. Dhabhar 1949, gloss. 80;<br />
Kreyenbroek 1985: 76 s., nota 1.9).<br />
In conclusione, possiamo <strong>di</strong>re che l’interpretazione <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
come ‘il cui corpo è il <strong>mąθra</strong>-’ o come ‘che ha il <strong>mąθra</strong>- come corpo’ è<br />
insod<strong>di</strong>sfacente non solo dal punto <strong>di</strong> vista linguistico ma anche da quello<br />
esegetico.<br />
4. L’interpretazione <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- come ‘che <strong>di</strong>stende il <strong>mąθra</strong>-’<br />
Un’interpretazione <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- del tutto originale rispetto agli<br />
stu<strong>di</strong> precedenti è stata proposta recentemente da Prods Oktor Skjærvø 11 .<br />
Sulla base del ruolo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atore tra umano e <strong>di</strong>vino svolto da Sraoša (su<br />
<br />
11 Skjærvø 2007: 136, n. 55. Approfitto <strong>di</strong> questa nota per ringraziare sentitamente il<br />
prof. P. O. Skjærvø delle preziose in<strong>di</strong>cazioni bibliografiche e <strong>degli</strong> utili consigli critici<br />
in merito all’ipotesi che qui <strong>di</strong>scuto. Come d'uso, ciò non implica in nessun modo che il<br />
prof. Skjærvø aderisca in qualche misura alle affermazioni qui esposte, che restano <strong>di</strong><br />
mia esclusiva responsabilità.<br />
8
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
questo tema cf. anche Kreyenbroek 1985: 30), lo Stu<strong>di</strong>oso rende l’epiteto<br />
<strong>avestico</strong> con ‘who stretches the Holy Word’ (‘colui che <strong>di</strong>stende la parola<br />
sacra’, p. 121). L’elemento <strong>tanu</strong>- avrebbe quin<strong>di</strong> il valore <strong>di</strong> ‘tendere’,<br />
proprio della ra<strong>di</strong>ce indoiranica tan- 12 . L’immagine del ‘<strong>di</strong>stendere la Parola<br />
Sacra’, peraltro innegabilmente suggestiva, è così spiegata: «Sraoša,<br />
apparently, conveys the sacred utterances of Ahura Mazdā down to the<br />
sacrificer and, perhaps, those of the sacrificer to Ahura Mazdā».<br />
Occorre notare, tuttavia, che in in<strong>di</strong>ano nei composti con <strong>tanu</strong>-, con u<br />
breve, tale lessema equivale all’aggettivo tanú- ‘sottile’, mentre i composti<br />
con tanū- con ū lungo contengono il sostantivo tan- 13 ; analogamente<br />
mancano in <strong>avestico</strong> altri composti con <strong>tanu</strong>- in cui a tale membro possa<br />
essere assegnata una interpretazione verbale 14 . Dal punto <strong>di</strong> vista esegetico va<br />
detto, inoltre, che la connessione tra la resa ‘che <strong>di</strong>stende il <strong>mąθra</strong>-’ e il ruolo<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>atore <strong>di</strong> Sraoša presuppone l’idea – non <strong>di</strong>rettamente ricavabile dalla<br />
<strong>semantica</strong> della base tan- – che questo ‘<strong>di</strong>stendere’ da un lato equivalga a un<br />
‘far arrivare a’ e dall’altro si configuri come movimento <strong>di</strong>rezionato lungo un<br />
asse verticale cielo-terra 15 .<br />
<br />
12 Nel contributo citato lo Stu<strong>di</strong>oso non si <strong>di</strong>ffonde sull’analisi del composto. D’altra<br />
parte, la resa ‘che tende la Parola Sacra’ potrebbe ben essere giustificata sul piano<br />
morfologico da un’interpretazione <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>- come tema verbale (va ricordato in proposito<br />
che la base tan- forma in indoiranico e in greco un presente in -nu-; cf. EWA I, 618,<br />
AiWb. 633, Kellens 1984: 170). In tal caso la forma andrebbe classificata come<br />
composto a rezione verbale con testa a sinistra <strong>di</strong> tipo φερέοικος.<br />
13 Più complessa è la situazione del greco, dove alcuni composti con primo membro<br />
τανυ- ‘sottile, allungato’ sono stati secondariamente reinterpretati come composti a<br />
rezione verbale connessi con τάνυµαι ‘tendo’ (cf. DÉLG 1092, s.v. τανυ-; <strong>di</strong>versa<br />
interpretazione in GEW II, 852-3).<br />
14 Va osservato, d’altra parte, che, giacché esiste invece in <strong>avestico</strong> una serie <strong>di</strong> composti<br />
con <strong>tanu</strong>- da tanū-, la trasparenza sincronica <strong>di</strong> un ipotetico composto contenente un<br />
tema verbale <strong>tanu</strong>- sarebbe stata presto compromessa in modo critico, sicché se anche<br />
l’epiteto fosse stato realmente in origine un composto a rezione verbale esso sarebbe<br />
comunque <strong>di</strong>venuto rianalizzabile come composto <strong>di</strong> tanū-; va ricordato, in proposito,<br />
che la tra<strong>di</strong>zione esegetica me<strong>di</strong>opersiana traduce <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- con tan (‘corpo, persona’)<br />
framān.<br />
15 A sostegno <strong>di</strong> questa interpretazione Skjærvø cita Y. 19.7 e Y. 71.15. Nel primo passo<br />
Ahura Mazdā minaccia <strong>di</strong> tirare/tenere fuori dall’esistenza buona l’uruuan- (anima) <strong>di</strong><br />
una persona – e l’uruuan-, come ci ricorda lo Stu<strong>di</strong>oso, rappresenta anche, secondo una<br />
possibile interpretazione <strong>di</strong> Y. 28.4, «the breath on which the songs are conveyed» – nel<br />
9
Paolo Milizia<br />
In conclusione, se l’interpretazione <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- come ‘che <strong>di</strong>stende<br />
la Parola sacra’ potrà essere accolta solamente in mancanza <strong>di</strong> una soluzione<br />
alternativa che sia più solidamente corroborata tanto sul piano formale<br />
quanto su quello semantico, l’insod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong>mostrata da Skjærvø per le<br />
interpretazioni tra<strong>di</strong>zionali dell’epiteto conferma la necessità <strong>di</strong> un<br />
approfon<strong>di</strong>mento critico.<br />
5. L’interpretazione <strong>di</strong> Christian Bartholomae<br />
Nell’AiWb. (col. 637) <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- è reso con «mit dessen Leib das<br />
heilige Wort verbunden ist, der es in sich aufgenommen, mit ihm eins<br />
geworden ist» (col cui corpo la parola sacra è legata, che ha assunto la parola<br />
sacra in sé, che è <strong>di</strong>ventato una cosa sola con essa).<br />
A questa parafrasi come pure all’interpretazione <strong>di</strong> Jacques Duchesne-<br />
Guillemin (1936:155) – considerata equivalente a quella <strong>di</strong> Bartholomae –<br />
Gershevitch ha creduto <strong>di</strong> poter muovere due critiche (1954:180).<br />
Innanzitutto, secondo lo Stu<strong>di</strong>oso il significato ‘having the <strong>mąθra</strong>- in his<br />
body (person)’ sarebbe incompatibile con Sraoša e con Mithra in quanto<br />
rimanderebbe a una proprietà specifica <strong>di</strong> Ahura Mazdā, e questo perché in<br />
Yt. 13.81 si <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Ahura Mazdā che il suo uruuan- (‘anima’) è il <strong>mąθra</strong>-.<br />
Sembrerebbe <strong>di</strong> capire che, per Gershevitch, dalla premessa che l’anima <strong>di</strong><br />
Ahura Mazdā è il <strong>mąθra</strong>- e dalla premessa implicita che l’anima risiede nel<br />
corpo si possa concludere sillogisticamente che Ahura Mazdā ‘ha il <strong>mąθra</strong>-<br />
nel corpo’ 16 .<br />
<br />
secondo, il <strong>di</strong>o, simmetricamente, promette <strong>di</strong> tirare fuori l’uruuan- dall’esistenza cattiva<br />
(71.15). È vero che in entrambi i casi tale tirare/tenere fuori è espresso appunto con il<br />
presente tanauu-/<strong>tanu</strong>- (tanauua 1a pers. sing. cong.); tuttavia, l’accezione specifica <strong>di</strong><br />
queste due occorrenze del verbo pare strettamente connessa con la presenza, nello stesso<br />
sintagma verbale, <strong>di</strong> pairi e <strong>di</strong> un sitagma preposizionale con haca: Bartholomae (AiWb.<br />
63) rende la costruzione pairi tan- con haca + abl. con il tedesco ‘fernhalten von’ (‘tenere<br />
lontano da’).<br />
16 Così il testo: frauuaṣǐnąm. iδa. yazamaide./frauuaṣ̌īm. auuąm./ yąm. ahurahe.<br />
mazdā̊./[…]/yeŋ́he. uruua. mąϑrō. spəṇtō./auruṣ̌ō. raoxṣňō. frādərəsrō. (Yt. 13.80b-d, 81ab).<br />
Va ricordato, in proposito, che dal punto <strong>di</strong> vista teologico il Fravardīn Yašt (Yt. 13)<br />
ha uno statuto del tutto particolare: secondo Mary Boyce (2001), pur rappresentando<br />
tra tutti gli Yašt quello più ricco <strong>di</strong> dottrina zoroastriana, questo testo mostra a volte<br />
10
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
In realtà, l’espressione ‘che ha il <strong>mąθra</strong>- nel suo corpo’ non<br />
corrisponde esattamente alla frase <strong>di</strong> Bartholomae che abbiamo riportato<br />
sopra; pure impreciso è Gershevitch nello scrivere che per Bartholomae<br />
<strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- «has <strong>tanu</strong>- virtually in the loc.»; nella nota 2 della voce del<br />
Wörterbuch leggiamo anzi che «Das I. Glied ist als Instr. oder Lok. zu<br />
denken». L’interpretazione locativale del primo membro, ossia la resa <strong>di</strong><br />
<strong>tanu</strong>- come ‘nel corpo’, non è affatto in<strong>di</strong>spensabile nel quadro dell’esegesi<br />
del Bartholomae: se l’espressione «der es in sich aufgenommen» rimanda a<br />
una relazione locativale, la resa «mit dessen Leib das heilige Wort verbunden<br />
ist» allude invece a un possibile sociativo-strumentale. Di fatto, secondo il<br />
Bartholomae l’epiteto <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- in<strong>di</strong>ca semplicemente il trovarsi in una<br />
relazione intima, essenziale con il <strong>mąθra</strong>-.<br />
Parimenti opinabile è la seconda obiezione mossa da Gershevitch:<br />
osservato che l’epiteto <strong>tanu</strong>.druj- si presenta come controparte negativa <strong>di</strong><br />
<strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- e deve avere pertanto una interpretazione speculare rispetto a<br />
quella <strong>di</strong> quest’ultimo, si contesta che, se <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- valesse “colui che ha il<br />
<strong>mąθra</strong>- nel suo corpo”, allora <strong>tanu</strong>.druj- dovrebbe valere “che ha Druj nel<br />
suo corpo”, una qualifica che poco si adatterebbe al contesto in cui compare<br />
nel Vidēvdād (cf. infra) e che sarebbe piuttosto più adatta, secondo<br />
Gershevitch, alla Nasu-, demone della putrefazione. In realtà Bartholomae<br />
(AiWb., 636) rende <strong>tanu</strong>.druj- con «des Leib mit der Dr. [Drug] verbunden,<br />
der mit ihr eins geworden ist», dove è la seconda frase, ossia “che è una cosa<br />
sola con la Druj” a definire propriamente il valore sincronico del composto,<br />
mentre la prima non fa che esplicitarne la motivazione etimologica.<br />
Se è vero che alle obiezioni <strong>di</strong> Gershevitch si espone, almeno in parte,<br />
la resa, alquanto meccanica, <strong>di</strong> Jacques Duchesne-Guillemin (1936:155),<br />
che traduceva <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- con «ayant la parole sacrée au corps» e <strong>tanu</strong>druj-<br />
con «ayant la D. [Drug] au corps», <strong>di</strong>verso è dunque il caso <strong>di</strong> Bartholomae.<br />
Questi, infatti, non vedeva in <strong>tanu</strong>° un effettivo riferimento alla corporeità e<br />
alla fisicità e al contrario alludeva evidentemente nelle sue parafrasi, ad es.<br />
con l’espressione «in sich aufgenommen» citata sopra, al valore <strong>di</strong> tanū-<br />
come riflessivo.<br />
<br />
elementi dottrinali profondamente alterati al fine <strong>di</strong> innestare il culto pre-zoroastriano<br />
delle Fravaši nel quadro della teologia ahurica (sulle Fravaši si veda anche Malandra<br />
1983: 102 ss).<br />
11
Paolo Milizia<br />
Il reale <strong>di</strong>fetto dell’esegesi <strong>di</strong> Barthomae sta, al contrario, <strong>di</strong>remmo,<br />
nella sua genericità ossia nel non chiarire in che senso sia possibile <strong>di</strong>re che<br />
Sraoša o Mithra sono una sola cosa con il <strong>mąθra</strong>-. Del tutto banalizzante<br />
sarebbe pensare che un’espressione che valga ‘che è una cosa sola con il<br />
<strong>mąθra</strong>-’ possa essere riferita Sraoša – che come si è ricordato personifica<br />
l’obbe<strong>di</strong>enza e non la parola – in virtù <strong>di</strong> una sorta <strong>di</strong> esagerazione o <strong>di</strong><br />
iperbole poetica, a significare semplicemente l’intimità del legame tra il <strong>di</strong>o e<br />
la parola <strong>di</strong>vina. È dunque opportuno chiedersi se non sia possibile<br />
guadagnare una esegesi del composto che meglio aderisca al quadro<br />
nozionale della teologia zoroastriana.<br />
6. Un’ipotesi esegetica<br />
Per pervenire a un’interpretazione coerente <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- occorre, a<br />
mio giu<strong>di</strong>zio, partire dall’unico dato certo, benché apparentemente generico:<br />
l’epiteto ha a che fare con la relazione tra Sraoša e il <strong>mąθra</strong>-. Ciò significa<br />
che è opportuno indagare innanzitutto quali siano le possibili modalità <strong>di</strong><br />
rapporto tra una persona, umana o <strong>di</strong>vina, e il <strong>mąθra</strong>- nel quadro dottrinale<br />
zoroastriano. Significativo a questo riguardo è quanto leggiamo nel seguente<br />
passo delle Gāθā (Y. 44.14a-c, 16b-e) 17 :<br />
<br />
17 Le traduzioni moderne <strong>di</strong> Y 44.16 (cf., per citare solo le più recenti, Insler 1975: 71,<br />
Kreyenbroek 1985: 22-24, Kellens-Pirart 1898-91, I, 153, Humbach et al. 1991, I,<br />
161) <strong>di</strong>fferiscono tra loro per <strong>di</strong>versi particolari; <strong>di</strong>amo conto pertanto della scelta<br />
esegetica qui operata, peraltro non determinante ai fini della nostra argomentazione.<br />
Nella strofa si in<strong>di</strong>viduano tre proposizioni principali: nella prima Zarathustra chiede ad<br />
Ahura Mazdā chi, in quanto vərəθrəm.jā, possa proteggere gli uomini pii; nella seconda<br />
chiede alla <strong>di</strong>vinità <strong>di</strong> mostrargli un ‘modello’ o un ‘giu<strong>di</strong>ce’; nella terza invoca la venuta<br />
<strong>di</strong> Sraoša. Nel testo il beneficiario delle richieste rivolte ad Ahura Mazdā oscilla tra ‘me’<br />
Zarathustra, ‘i viventi’ e ‘colui che tu vuoi’. Non è forse casuale, d’altra parte, che nella<br />
stessa strofa siano compresenti da un lato l’espressione vərəθrəm.jā e dall’altro<br />
l’invocazione <strong>di</strong> səraoša-. Come è stato notato (Kellens-Pirart 1989-91, I, 27), il<br />
composto vərəθrəm.jan- deve alludere a una <strong>di</strong>vinità, che prenda un posto almeno in<br />
parte analogo a quello occupato da Indra Vr̥trahan nel pantheon indoiranico originario<br />
(per J. Kellens ed É. Pirart ciò sarebbe confermato anche da una interpretazione <strong>di</strong> yōi<br />
həṇtī come retto da un partitivo implicito riferirto a kə̄: ‘chi tra coloro che sono [ossia<br />
tra le <strong>di</strong>vinità]’ – questa interpretazione ha tuttavia la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> lasciare pōi<br />
‘proteggere’ senza oggetto espresso, costringendo a sottindendere un ‘me’). D’altra parte,<br />
12
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
ta θβā pərəsā ərəš mōi vaocā ahurā:<br />
kaϑā aṣ̌āi drujə̄m <strong>di</strong>iąm zastaiiō<br />
nī hīm mərąž<strong>di</strong>iāi θβahiiā mąθrāiš sə̄ṇghahiiā<br />
[…]<br />
kə̄ vərəθrəm.jā θβā pōi sə̄ṇghā yōi həṇtī<br />
ciϑrā mōi dąm ahūm.biš ratūm cīždī<br />
a hōi vohū səraošō jaṇtū manaŋhā<br />
mazdā ahmāi yahmāi vašī kahmāicī<br />
Questo ti chiedo, <strong>di</strong>mmi chiaramente, Ahura: / in che<br />
modo potrei consegnare la Menzogna nelle mani<br />
dell’Or<strong>di</strong>ne Cosmico (aṣ̌āi) / per spazzarla via attraverso<br />
i <strong>mąθra</strong>- del tuo insegnamento (sə̄ṇgha-)?’ […] / Chi<br />
potrebbe essere colui che abbatte l’ostacolo per<br />
<br />
se è vero che l’ampliamento del pantheon attraverso la <strong>di</strong>vinizzazione <strong>di</strong> originarie<br />
nozioni astratte è un’operazione che caratterizza lo zoroastrismo dell’Avesta recente<br />
rispetto al più semplice e coerente sistema zarathustriano delle Gāθā, in questo passo<br />
gatico il sostantivo səraoša- è usato molto probabilmente già come nome proprio <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>vinità e non come nome comune dell’obbe<strong>di</strong>enza o della <strong>di</strong>sposizione all’ascolto (cf.<br />
Kreyenbroek 1985: 23 e 164 ss.). Ebbene nell’Avesta recente vərəθrajan- (variante con<br />
primo membro non flesso <strong>di</strong> vərəθrəm.jā) costituisce proprio uno <strong>degli</strong> epiteti<br />
caratteristici del <strong>di</strong>o Sraoša. Non ci sembra quin<strong>di</strong> da escludere la possibilità che proprio<br />
a Sraoša alluda il vərəθrəm.jan- <strong>di</strong> 16b. Una allusione a Sraoša potrebbe forse ravvisarsi<br />
anche nel ratu-, ‘giu<strong>di</strong>ce’ (cf. AiWb. 1498-1502) o ‘principio governante, modello’ (cf.<br />
Renou 1958:74 su r̥tú-) invocato subito dopo. In <strong>avestico</strong> recente ratu- è spesso qualifica<br />
<strong>di</strong> persona; in quest’ultima funzione il termine è inteso come ‘giu<strong>di</strong>ce’, secondo<br />
l’intepretazione tra<strong>di</strong>zionale (cf. AiWb. 1498-1502), o, secondo l’argomentazione <strong>di</strong><br />
Xavier Tremblay (1998), come ‘patrono (<strong>di</strong> una determinata porzione del cosmo)’. Se si<br />
accetta la possibilità che anche in questo passo gatico il sostantivo possa designare una<br />
persona anziché una cosa, si può ipotizzare che Sraoša sia qui qualificato come ratu-. Va<br />
ricordato in proposito che, secondo Gershevitch (1967: 239 ss.), il <strong>di</strong>o Mithra, che <strong>di</strong><br />
Sraoša è per molti aspetti un doppione, è ratu- del mondo sensibile. In realtà ci pare che<br />
una connessione logica tra ratu- e səraoša- non possa essere scartata neppure se si parte<br />
dal presupposto che in gatico ratu- debba valere sempre ‘modello, regola’ (così<br />
Tremblay 1998: 192): la capacità <strong>di</strong> ‘operare in conformità con il modello’ è infatti<br />
logicamente subor<strong>di</strong>nata alla capacità/<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> ascolto del messaggio <strong>di</strong>vino. In<br />
conclusione, pare possibile un’interprezione <strong>di</strong> Y. 44.16 che veda le prime due<br />
proposizioni come anticipazioni della terza e ultima, che contiene l’invocazione esplicita<br />
della venuta <strong>di</strong> Sraoša.<br />
13
Paolo Milizia<br />
proteggere coloro che sono, in conformità con il tuo<br />
insegnamento? / Che mi siano date (visioni) nitide 18 ! O<br />
tu che sei la cura dell’esistenza, forniscimi un principio<br />
governante; / così venga Sraoša in ragione del buon<br />
pensiero, / o Mazdā, presso colui a cui tu lo auguri,<br />
chiunque egli sia.<br />
Come è stato sottolineato da Kreyenbroek (1985:23), le strofe 12-16<br />
dello Yasna 44 sono strettamente legate: in esse Zarathustra pone ad Ahura<br />
domande sull’identità del bene e della menzogna (Druj), sul modo <strong>di</strong><br />
sconfiggere quest’ultima, e sullo scontro tra i due principî (raffigurato in Y.<br />
44.15 come una battaglia tra due eserciti).<br />
Notiamo subito come nel medesimo contesto si ritrovino tanto i<br />
<strong>mąθra</strong>- <strong>di</strong> Ahura, quanto Sraoša. I primi sono il mezzo che permetterà <strong>di</strong><br />
cancellare la Druj, il secondo è invocato nel punto culminante della<br />
sequenza, come colui la cui venuta coincide con uno stato <strong>di</strong> protezione<br />
dalle forze del male 19 . Questa comprensenza non è casuale: la <strong>di</strong>sposizione<br />
all’ascolto e l’obbe<strong>di</strong>enza, che Sraoša personifica, rappresentano infatti il<br />
prerequisito per poter accedere alla parola ahurica. Ma nel passo troviamo<br />
anche un esplicito riferimento alla modalità in cui tale accesso si realizza: i<br />
<strong>mąθra</strong>- <strong>di</strong> Ahura sono qualificati come θβahiiā sə̄ṇghahiiā ‘del tuo sə̄ṇgha-’.<br />
<br />
18 L’invocazione del ratu- e del səraoša- mi pare autorizzi a ipotizzare che nel sintagma<br />
ciϑrā mōi dąm l’aggettivo sostantivato ciϑra- riman<strong>di</strong> non tanto alla nozione generica <strong>di</strong><br />
‘brillantezza’ (in Kellens-Pirart la resa è «cadeaux remarquables», in Humbach et al. è<br />
«bright (things)» – per l’interpretazione <strong>di</strong> dąm come imperativo aoristo me<strong>di</strong>o si veda<br />
Kellens-Pirart 1989-91, III, 181, ad locum) quanto a un’idea <strong>di</strong> ‘visibilità’ associata<br />
all’apparizione delle entità <strong>di</strong>vine; in modo analogo intende Xavier Tremblay (1998:<br />
193 n. 14) che rende la frase con «Que des signes me soient donnés!». L’interpretazione<br />
<strong>di</strong> ciϑra- come ‘cosa visibile, apparizione’ è già <strong>di</strong> Bartholomae (cf. AiWb. 586) che però<br />
intende questa occorrenza come strumentale singolare («durch ein Gesicht», 1905: 63);<br />
su mpers. cihr e sul suo uso, nei testi manichei, in riferimento ad apparizioni <strong>di</strong> entità<br />
<strong>di</strong>vine si veda Alram et al. 2007: 35.<br />
19 Nell’interpretazione <strong>di</strong> Kreyenbroek la venuta <strong>di</strong> Šraosa segue l’eliminazione del male<br />
(come parrebbe accadere in Y. 43.12, cf. Kreyenbroek, op. cit., 21); in quella proposta<br />
sopra nella nota 17 Šraosa ha invece un ruolo nello stesso scontro. La <strong>di</strong>fferenza<br />
interpretativa non è comunque rilevante ai fini della nostra riflessione.<br />
14
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
I traduttori moderni rendono per lo più sə̄ṇgha- con ‘annuncio,<br />
spiegazione’ 20 . La vesione pahlavica traduce con hammōxtišn ‘insegnamento’<br />
(seguita da Kreyenbroek 1985:22-24); non si tratta <strong>di</strong> una traduzione<br />
meccanica, in quanto altrove lo stesso termine <strong>avestico</strong> è reso invece con<br />
saxwan ‘parola, <strong>di</strong>scorso’ (cf. AiWb. 1576). Se da una parte il valore <strong>di</strong><br />
‘annuncio’ è più vicino alla <strong>semantica</strong> originaria <strong>di</strong> sə̄ṇgha-, dall’altro la scelta<br />
<strong>di</strong> interpretare la parola come ‘insegnamento’ è ben comprensibile se si<br />
considera il co-testo: poiché, infatti, in Y. 44.16, sarebbe Zarathustra stesso a<br />
dare l’impulso a un annientamento della Druj ottenuto attraverso il <strong>mąθra</strong>-,<br />
è lecito dedurre che l’operazione potrà avere successo solo se quegli avrà fatto<br />
proprio, ossia avrà appreso, il <strong>mąθra</strong>- annunciato – e quin<strong>di</strong> insegnato – da<br />
Ahura Mazda 21 . Chiaro è dunque da questo testo che Zarathustra accede al<br />
<strong>mąθra</strong>- in una modalità me<strong>di</strong>ata da un processo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento.<br />
Ma se l’uomo, come Zarathustra, ha bisogno dell’annuncio <strong>di</strong>vino, nei<br />
confronti del quale deve esercitare la <strong>di</strong>sposizione all’ascolto (səraoša-), lo<br />
stesso non deve e non può valere per l’ipostasi <strong>di</strong>vina <strong>di</strong> quest’ultima: il <strong>di</strong>o<br />
Sraoša, proprio perché personifica l’ascolto e l’obbe<strong>di</strong>enza alla parola sacra,<br />
deve necessariamente avere, a <strong>di</strong>fferenza dell’uomo, un rapporto non<br />
me<strong>di</strong>ato con il <strong>mąθra</strong>-, e poiché dunque conosce la parola <strong>di</strong>vina non per<br />
appren<strong>di</strong>mento ma per sapienza connaturata egli deve avere il <strong>mąθra</strong>- ‘in se<br />
<br />
20 Kellens e Pirart (1988-91, I, 152 s.) traducono il sostantivo <strong>avestico</strong> con ‘explication’<br />
in Y. 44.16b e rendono il sintagma θβahiiā mąθrāiš sə̄ṇghahiiā in 44.14 con ‘grâce aux<br />
formules où tu expliques (comment faire)’. Nella traduzione inglese <strong>di</strong> Humbach et al.<br />
(1991: 161) il termine è reso con ‘proclamation’. Il corrispondente in<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> av.<br />
sə̄ṇgha-, ossia ved. śámsa- (cf. EWA, II, 600, sv., con riman<strong>di</strong> bibliografici), copre col suo<br />
significato un’area <strong>semantica</strong> alquanto vasta al cui centro sembra collocata comunque<br />
l’idea del parlare in modo solenne; notevole è il fatto che in ve<strong>di</strong>co parole appartenenti<br />
alla medesima famiglia lessicale in<strong>di</strong>chino la declamazione del mántra- ‘formula poetica’<br />
(cf. Watkins 1995: 90 e qui infra).<br />
21 La funzione me<strong>di</strong>atrice del sə̄ṇgha- pare implicita anche nella figura e nel nome <strong>di</strong><br />
nairiiō.saŋha-, messaggero <strong>degli</strong> dei – l’espressione ve<strong>di</strong>ca nárāśáṃsa- ‘lode <strong>degli</strong> uomini’<br />
(su cui si veda Schmitt 1967: 97-101; cf. anche Durante 1976: 50-53) non rappresenta<br />
necessariamente un prefetto equivalente semantico del nome <strong>avestico</strong>. Quanto al<br />
contenuto del sə̄ṇgha- ahurico, va ricordato come nell’Avesta recente un ruolo centrale<br />
sia assegnato alla preghiera dell’Ahunwar (Yaθā ahū vairiiō), pronunciata da Ahura<br />
Mazdā ancora prima della creazione (Y. 19.3-4).<br />
15
Paolo Milizia<br />
stesso’ e poterlo proferire ‘senza intervento esterno’, egli deve essere, in una<br />
parola, <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- 22 .<br />
L’elemento <strong>tanu</strong>- ha evidentemente, proprio come nei casi <strong>di</strong><br />
<strong>tanu</strong>.kəhrpa- e <strong>tanu</strong>.kərəta- <strong>di</strong>scussi sopra, funzione <strong>di</strong> pronome<br />
intensificatore. Caratteristica specifica <strong>degli</strong> intensificatori è quella (cf. König<br />
e Siemund 1999: 44-47) <strong>di</strong> evocare e nel contempo escludere possibili<br />
alternative al referente corrispondente al proprio focus: nel nostro caso<br />
l’alternativa è rappresentata, come abbiamo visto, dall’annuncio dello stesso<br />
Ahura Mazdā, fonte della conoscenza del <strong>mąθra</strong>- per gli uomini 23 .<br />
7. Av. <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- come attributo dell’uomo rinato e del sacerdote<br />
Significativa a questo riguardo è l’occorrenza <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>- in due<br />
sequenze aggettivali parallele, che compaiono l’una in Vidēvdād 18.51, dove<br />
l’epiteto è attribuito a un uomo che sia stato consegnato a Spenta Ārmaiti e<br />
restituito da essa nel giorno del rinnovamento finale (frašō.kərəti-), e l’altra in<br />
Yt. 5.91, in riferimento a Zarathustra in quanto sacerdote (āθrauuan-). Così<br />
il passo del Vidēvdād:<br />
āat aošéte spəṇtaiiāi ārmatəē: / spəṇta ārmaite / iməm tē narəm<br />
nisrinaomi / iməm mē narəm nisrāraiiā̊ / upa sūrąm frašō.kərətīm /<br />
vīduš.gāϑəm vīduš.yasnəm / paiti.parštō.srauuaŋhəm. mązdrəm /<br />
haδa.hunarəm <strong>tanu</strong>.mąϑrəm<br />
Allora <strong>di</strong>rà a Spenta Ārmaiti: / Spenta Ārmaiti, / quest’uomo<br />
consegno a te, / quest’uomo possa tu riconsegnare a me, / nel<br />
potente rinnovamento (frašō.kərəti-) / come un uomo che conosce<br />
<br />
22 Il ruolo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atore tra l’uomo e la parola sacra svolto dall’ascolto (səraoša-) si riflette<br />
icasticamente nel fatto che il <strong>di</strong>o Sraoša sia il primo a cantare le Gāthā (Y. 57.8), cf.<br />
infra.<br />
23 Ekkehard König e Peter Siemund (1999) <strong>di</strong>stinguono tra uso adnominale e uso<br />
avverbiale dell’intensificatore. Nel primo l’intensificatore è un mo<strong>di</strong>ficatore <strong>di</strong> un nome<br />
avente il medesimo referente (p.es. nell’inglese «The Queen herself will come to the<br />
final»); nell’uso avverbiale (p.es. nell’inglese «The president wrote that speech himself»)<br />
è un mo<strong>di</strong>ficatore <strong>di</strong> un sintagma verbale. Nel nostro caso abbiamo un uso avverbiale<br />
(non c’è nome co-referente) all’interno però – anziché <strong>di</strong> una struttura verbale – <strong>di</strong> un<br />
composto possessivo.<br />
16
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
le Gāthā, che conosce gli Yasna, / paiti.parštō.srauuah-, sapiente, /<br />
dotato <strong>di</strong> capacità, <strong>tanu</strong>.mąϑra-.<br />
La sequenza <strong>di</strong> Yt. 5.91 suona invece 24 :<br />
āϑrauuanō parštō.vacaŋhō / paiti.parštō.srauuaŋhō mązdrō /<br />
haδa.hunarō <strong>tanu</strong>.mąϑrō<br />
Occorre qui spendere qualche parola sui due termini parštō.vacah- e<br />
paiti.parštō.srauuah-, intesi comunemente come aventi entrambi il senso <strong>di</strong><br />
‘istruito’. Bartholomae traduce il primo con «der <strong>di</strong>e (heiligen) Sprüche<br />
erfragt, durch Fragen erkundet hat» (AiWb. 878) e il secondo con «der <strong>di</strong>e<br />
(heiligen) Lehren erfragt, (durch Fragen) erkundet hat» (AiWb. 832).<br />
Secondo l’interpretazione corrente, dunque, il bahuvrīhi parštō.vacah-<br />
dovrebbe equivalere letteralmente a ‘che ha la parola (vacah-) (in quanto da<br />
lui) richiesta’. Se così fosse, il primo membro del composto, che è<br />
evidentemente un participio perfetto passivo da fras- ‘chiedere’, non<br />
specificherebbe quale sia la parola posseduta ma in che modo essa sia stata<br />
acquisita. Ciò rappresenta già una piccola <strong>di</strong>fficoltà in quanto all’elemento<br />
qualificante del contenuto del sapere dell’ āθrauuan-, ossia la sua origine<br />
ahurica, non si farebbe riferimento né in modo <strong>di</strong>retto né in modo in<strong>di</strong>retto.<br />
Ma va notato, soprattutto, che nei composti con °vacah- tale elemento<br />
designa <strong>di</strong> norma la parola proferita dal soggetto cui il composto si riferisce:<br />
così, per fare qualche esempio, pāpō.vacah- significa ‘la cui parola protegge’<br />
(Y. 57.20; cf. AiWb. 888); hamō.vacah- vale ‘la cui parola è uguale, che <strong>di</strong>ce<br />
la stessa cosa’ (Yt. 13.83; cf. AiWb. 1777); āfrī.vacah- vale ‘la cui parola è<br />
bene<strong>di</strong>zione, che proferisce bene<strong>di</strong>zioni’ (Yt. 13.83; cf. AiWb. 331). D’altra<br />
parte, se è vero che l’Avesta è strutturato in gran parte come un <strong>di</strong>alogo <strong>di</strong><br />
Zarathustra con la <strong>di</strong>vinità nel corso del quale il primo interroga la seconda,<br />
è anche vero che Ahura Mazdā può mettere alla prova la competenza <strong>di</strong><br />
Zarathustra ponendo delle domande; per questo in Y. 43.10c si legge:<br />
<br />
24 Gli ultimi tre aggettivi figurano, come è atteso, al nominativo singolare, attributi della<br />
seconda persona, soggetto della frase; il sostantivo āϑrauuanō e i due aggettivi seguenti<br />
sono interpretati come forme <strong>di</strong> nominativo plurale (AiWb. 65). Se si accetta la<br />
possibilità che āϑrauuanō possa rappresentare una forma analogica recenziore <strong>di</strong> genitivo<br />
singolare, la cui forma canonica è invece (cf. Hoffmann-Forssman 2004: 145)<br />
aϑaurunō, si può forse pensare a dei genitivi singolari retti da zaoϑraiiā̊; la frase<br />
suonerebbe ‘tu berrai <strong>di</strong> questa libagione (zaoϑrā-) per me (<strong>di</strong> te/fatta da te) āϑrauuan- ’.<br />
17
Paolo Milizia<br />
pərəsācā nā̊ yā tōi ə̄hmā parštā ‘chie<strong>di</strong> a noi le cose che ci hai (già) chiesto’. Il<br />
composto parštō.vacah- può perciò significare ‘la cui parola è ciò che viene<br />
domandato’, ‘che proferisce ciò che viene domandato’, vale a <strong>di</strong>re colui che<br />
in quanto sapiente risponde a domande <strong>sulla</strong> religione.<br />
A <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto accade per vacah-, l’Avesta non documenta una<br />
serie produttiva <strong>di</strong> composti con °srauuah- come secondo membro 25 ; il<br />
lessema ha in <strong>avestico</strong> un’estensione <strong>semantica</strong> parzialmente coincidente con<br />
quella <strong>di</strong> vacah-, ma a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quest’ultimo non rimanda all’atto <strong>di</strong><br />
‘proferire parola’. Non è perciò scontato che paiti.parštō.srauuah- sia un<br />
sinonimo <strong>di</strong> parštō.vacah-. D’altra parte il primo si <strong>di</strong>stingue dal secondo<br />
anche per la presenza del preverbo paiti- nel primo membro del composto:<br />
paiti.paršta-. Difficilmente questo participio potrà essere separato<br />
dall’astratto paiti.paršti- (<strong>mąθra</strong>he spəṇtahe) che occorre in Yt. 10.33, e dal<br />
nome d’agente paiti.fraxštar- (daēnaiiāi), che è attribuito <strong>di</strong> Zarathustra in<br />
Yt. 13.91-92. Tra le varie traduzioni fornite dagli stu<strong>di</strong>osi per queste forme<br />
merita considerazione quella <strong>di</strong> Gershevitch (1959: 184) che intende<br />
paiti.paršti- come ‘interpretazione’ e paiti.fraxštar- come ‘interprete’; la<br />
plausibilità dello sviluppo semantico è confortata dal corrispondente verbo<br />
del persiano antico patiprsa-, che significa ‘leggere’ (cf. anche Bailey 1979:<br />
246, s.v. pūś-). Poiché come secondo membro compare qui °srauuah- e non<br />
°vacah-, scelta lessicale che <strong>di</strong>fficilmente potrebbe essere casuale,<br />
paiti.parštō.srauuah- va probabilmente inteso come ‘che ha la parola<br />
interpretata’, ossia ‘che è in grado <strong>di</strong> interpretare la parola (<strong>di</strong>vina)’ piuttosto<br />
che come ‘la cui parola (ossia la parola che egli proferisce) è interpretata’. In<br />
conclusione, è da pensarsi che i due composti non si riferiscano<br />
all’insegnamento ricevuto dal soggetto attraverso domande, ma piuttosto alla<br />
sua capacità <strong>di</strong> fornire risposte; va ricordato in proposito che in Y. 57.8 il <strong>di</strong>o<br />
Sraoša, <strong>sulla</strong> cui figura è parzialmente modellato l’āϑrauuan-, è detto<br />
«ma.āzaiṇtīš ma.paiti.frasā̊ », cioè ‘che possiede spiegazioni e risposte’ 26 .<br />
<br />
25 Ben noti sono invece gli antroponimi in srauuah-, come Haosrauuah- (cf. Mayrhofer<br />
1979, I/49, n. 167), nei quali il termine non ha evidentemente il significato <strong>di</strong> ‘parola’ –<br />
<strong>semantica</strong> che rappresenta un’innovazione iranica (e slava) – ma il valore ere<strong>di</strong>tato <strong>di</strong><br />
‘fama’.<br />
26 Va notato ad ogni modo che anche l’interpretazione tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> parštō.vacah- e<br />
paiti.parštō.srauuah- non è incompatibile con la nostra interpretazione <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.mąϑra-:<br />
sapere acquisito e sapere connaturato non sono tra loro incompatibili (cf. infra).<br />
18
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
Nei due luoghi avestici considerati, dunque, si elencano le virtù – e in<br />
particolare le virtù legate alla conoscenza – dell’uomo che “rinasce” con il<br />
rinnovamento escatologico (frašō.kərəti-) 27 e dell’ āθrauuan-. Si tratta <strong>di</strong> due<br />
figure che, per ragioni <strong>di</strong>verse, partecipano entrambe del “<strong>di</strong>vino” e che,<br />
proprio per questo, possiedono una conoscenza del mąϑra- che, come quella<br />
propria del <strong>di</strong>o Sraoša, è “connaturata”. È d’altra parte evidente come in<br />
questi passi, e in particolare nel caso dell’uomo rinnovato, poco<br />
comprensibile sarebbe un’interpretazione <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.mąϑra- come ‘parola<br />
incarnata’ o come ‘parola personificata’ o ancora come ‘che è una cosa sola<br />
con la parola’. Dai contesti emerge infatti chiaramente che l’aggettivo è<br />
utilizzato non per in<strong>di</strong>care una proprietà, letterale o figurata, del corpo o<br />
della sostanza del soggetto, ma per attribuirgli piuttosto, all’interno <strong>di</strong> una<br />
elencazione <strong>di</strong> qualità positive, il possesso <strong>di</strong> una particolare virtù.<br />
Discorso analogo può essere fatto per la strofa del Mihr Yašt (Yt.<br />
10.137) in cui <strong>tanu</strong>.mąϑra- è attributo dell’officiante <strong>di</strong> un rito <strong>di</strong> offerta.<br />
Significativo è che anche in questo caso il termine compaia in un contesto<br />
che fa riferimento a virtù <strong>di</strong> saggezza e <strong>di</strong> conoscenza:<br />
ušta ahmāi naire mainiiāi / uiti mrao ahurō mazdā̊ / āi aṣ̌āum<br />
zaraϑuštra / yahmāi zaota aṣǎuua / aŋhəūš dahmō <strong>tanu</strong>.mąϑrō / […]<br />
miϑrahe vaca yazāite<br />
Salute all’uomo autorevole / – così <strong>di</strong>sse Ahura Mazdā – / o giusto<br />
Zarathustra, / a beneficio del quale un officiante giusto, /<br />
conoscitore del mondo, <strong>tanu</strong>.mąϑra-, / […] compia un rito <strong>di</strong><br />
offerta con l’invocazione <strong>di</strong> Mithra.<br />
Il passo elenca le qualità che officiante deve possedere perché il suo<br />
rito sia efficace. Nella traduzione <strong>di</strong> Gershevitch (1959:143) tale sequenza è<br />
resa con «a priest who is an owner of Truth, has experience of the world and<br />
personifies the <strong>di</strong>vine word»; ora è evidente come in questa serie l’ultimo<br />
elemento sia assolutamente stonato, il ‘personificare la parola <strong>di</strong>vina’<br />
dovrebbe essere interpretato come allusione – peraltro impropria – al ruolo<br />
dell’officiante all’interno del rito, ma qui si stanno enumerando invece i prerequisiti<br />
per poter effettuare il rito, tanto che nella strofa successiva (Yt. 10.<br />
138) si <strong>di</strong>ce: ‘guai a quell’uomo (sādrəm ahmāi) […] a beneficio del quale un<br />
<br />
27 Sul significato <strong>di</strong> V. 18.51 dal punto <strong>di</strong> vista dottrinale si veda de Jong 1997: 225.<br />
19
Paolo Milizia<br />
officiante […] che sia a<strong>tanu</strong>.mąϑra- […] compia un rito <strong>di</strong> offerta’. Se<br />
inten<strong>di</strong>amo invece <strong>tanu</strong>.mąϑra- come ‘che conosce il mąϑra- per sapere<br />
connaturato’ tale <strong>di</strong>scrasia svanisce e la serie <strong>di</strong> composti risulta<br />
pragmaticamente omogenea.<br />
8. Avestico <strong>tanu</strong>.druj-<br />
Se la nostra impostazione è corretta, av. <strong>tanu</strong>.druj- andrà interpretato,<br />
parallelamente, come ‘che conosce la menzogna per sapere connaturato’.<br />
L’epiteto compare in Vidēvdād 16.18, riferito a peccatori destinati alla<br />
condanna (<strong>tanu</strong>.pərəθa-), all’interno <strong>di</strong> una catena “quasi sillogistica” <strong>di</strong><br />
asserzioni:<br />
vīspe druuaṇtō <strong>tanu</strong>.drujō / yō adərətō.kaēšō / vīspe adərətō.kaēšō / yō<br />
asraošō / vīspe asraošō / yō anaṣǎuuanō / vīspe anaṣǎuuanō / yō<br />
<strong>tanu</strong>.pərəϑō<br />
Tutti sono peccatori (druuaṇt-) <strong>tanu</strong>.druj-, quelli che non<br />
osservano l’insegnamento; / tutti non osservano l’insegmento,<br />
quelli che non hanno obbe<strong>di</strong>enza; / tutti non hanno obbe<strong>di</strong>enza,<br />
quelli che sono empi; / tutti sono empi, quelli che sono<br />
condannati.<br />
Si noterà come nei primi due versi sia affermato il principio secondo<br />
cui il non osservare l’insegnamento, ossia l’essere adərətō.kaēša-, comporta<br />
automaticamente l’essere peccatori; per essere o <strong>di</strong>ventare empi, dunque, non<br />
c’è bisogno <strong>di</strong> imbattersi in qualche essere o principio esterno che insegni<br />
positivamente il male. Significativo è infatti il comparire della nozione <strong>di</strong><br />
‘insegnamento’, espressa dal secondo membro del composto adərətō.kaēša-.<br />
Se, come si è visto, l’uomo comune può accedere alla virtù ahurica attraverso<br />
l’appren<strong>di</strong>mento, mentre l’uomo che partecipa del <strong>di</strong>vino conosce<br />
l’insegnemento ahurico per sapere connaturato, l’uomo volto al male è visto<br />
qui come colui che, trascurato l’insegnamento della religione, trova dentro <strong>di</strong><br />
sé la presenza, connaturata, della Druj. Il valore <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.druj- da noi<br />
proposto, dunque, si adatta perfettamente al contesto, mentre poco senso<br />
darebbero interpretazioni alternative come ‘che ha la Druj nel corpo/è una<br />
20
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
cosa sola con la Druj’ o come ‘che ha per corpo la Druj’ o ancora come<br />
‘posseduto dalla Druj’ 28 .<br />
9. Sapere connaturato e ispirazione poetica<br />
In favore dell’esegesi qui proposta sta la pervasiva presenza nella<br />
tra<strong>di</strong>zione zoroastriana <strong>di</strong> una contrapposizione che oppone al spontaneo e<br />
connaturato, a cui viene riconosciuto un carattere <strong>di</strong>vino, l’appren<strong>di</strong>mento,<br />
legato alla sfera del sensibile e al materiale.<br />
Sul tema ha scritto Walter Belar<strong>di</strong> (1981[=1990]) notando, tra l’altro,<br />
come nel Grande Bundahišn la <strong>di</strong>stinzione tra il sapere assoluto e spontaneo<br />
<strong>di</strong> Ohrmazd e il sapere limitato e riflesso <strong>di</strong> Ahriman sia parallela a quella tra<br />
«l’intelligenza che da sola è produttrice <strong>di</strong> conoscenza, e l’insegnamento che<br />
genera al massimo un pasdānišnīh o un gōšōsrūt xrat, un conoscere a<br />
posteriori, dopo avere visto o u<strong>di</strong>to» (1990, p. 233) 29 . Conclude Belar<strong>di</strong>:<br />
«Mentre l’intelligenza imme<strong>di</strong>ata, che non passa attraverso il gētāh, è<br />
totalmente ahurica, l’insegnamento viene in atto a trovarsi nello spazio in cui<br />
è dato ad Angramainyu esercitare le sue manovre» (1990, p. 234).<br />
Nel caso del sacro <strong>mąθra</strong>- il carattere ahurico dell’insegnamento è<br />
sicuramente salvaguardato; e infatti in Y. 25.6 si proclama la venerazione<br />
non solo della sapienza āsna- (innata) ma anche <strong>di</strong> quella gaoš̌ō.srūta-,<br />
letteralmente ‘u<strong>di</strong>ta me<strong>di</strong>ante l’orecchio’ e quin<strong>di</strong> ‘percepita attraverso una<br />
me<strong>di</strong>azione dei sensi’. D’altra parte, se da un lato, l’appren<strong>di</strong>mento resta<br />
sostanzialmente estraneo alla sfera del <strong>di</strong>vino, come nel caso <strong>di</strong> Sraoša<br />
<br />
28 D’altra parte, se è naturale che in un testo <strong>di</strong> carattere in larga parte precettistico come<br />
il Vidēvdād il male sia identificato con l’infrazione dei <strong>di</strong>vieti e con l’omissione delle<br />
prescrizioni, l’idea dell’insegnamento positivo del male non è estranea alla visione del<br />
mondo dualistica propria dello zoroastrismo: nelle Gāthā (Y. 31.18) leggiamo infatti:<br />
«mā ciš a və̄ drəguuatō mąϑrąscā gūštā sāsnā̊scā» ‘nessuno <strong>di</strong> voi ascolti il <strong>mąθra</strong>-<br />
insegnato dalla Druj (lett. i <strong>mąθra</strong>- e gli insegnamenti che sono propri della Druj)’. Così<br />
come Ahura Mazdā insegna – lo abbiamo visto sopra – il <strong>mąθra</strong>- sacro, la Druj insegna,<br />
e in questo caso il sostantivo sāsna- è assolutemente inequivoco, un anti-<strong>mąθra</strong>- daevico.<br />
29 Come estrema conseguenza <strong>di</strong> tale concezione, nei Wizīrīhā ī dēn ī weh ī māzdēsnān<br />
(‘Le decisioni della buona religione dei Mazdei’) l’insegnamento, cāštagīh, è visto come il<br />
corrispondente ahrimanico dell’intelligenza, zīrīh, considerata invece come elemento<br />
ahurico (Belar<strong>di</strong>, op. cit.).<br />
21
Paolo Milizia<br />
<strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-, dall’altro la tra<strong>di</strong>zione zoroastriana riconosce all’uomo saggio la<br />
possibilità <strong>di</strong> attingere ad entrambi i tipi <strong>di</strong> sapienza: così nel terzo libro del<br />
Dēnkard si <strong>di</strong>ce che anche gli uomini saggi (dānāg) che non hanno<br />
conosciuto il mazdeismo, perché vissuti prima del suo avvento o in paesi<br />
lontani, hanno detto «grazie alla sapienza innata (az āsnxrad)» parole<br />
«conformi alla verità della religione mazdea (abāg dēn māzdēsn rāstīh)»<br />
(Madan 1911, p. 335, rr. 12-15; cf. de Menasce 1973: 318).<br />
Nel medesimo contributo Belar<strong>di</strong> ha accostato il sapere connaturato<br />
della tra<strong>di</strong>zione zoroastriana con l’idea della poesia come «connaturazione <strong>di</strong><br />
un fenomeno <strong>di</strong>vino nella persona umana» propria del mondo omerico e ha<br />
<strong>di</strong>mostrato che a quest’ultima rimanda la qualifica <strong>di</strong> αὐτοδίδακτος – la cui<br />
corretta interpretazione è appunto ‘che sa per sapere connaturato’ – che<br />
l’aedo Femio attribuisce a se stesso in Od. 22.347.<br />
Il ragionamento <strong>di</strong> Belar<strong>di</strong> si muove in una prospettiva <strong>di</strong><br />
comparatistica culturale, senza quin<strong>di</strong> postulare una comune origine storica<br />
delle due concezioni. D’altra parte, proprio in relazione con il <strong>mąθra</strong>-, che<br />
nel quadro dottrinale della nuova religione zoroastriana è concepito come<br />
emanazione ahurica, troviamo nell’Avesta la persistenza <strong>di</strong> concetti ed<br />
espressioni che paiono ere<strong>di</strong>tati da un sistema nozionale originariamente<br />
riferito alla poesia. Così, come ha ricordato, da ultimo, Calvert Watkins<br />
(1995: 88), un’idea <strong>di</strong> ‘verità del poeta’, a sua volta legata a una concezione<br />
che attribuisce alla parola proferita il potere <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la realtà esterna, è<br />
specificamente associata nei Veda all’espressione satyá- mántra- 30 ‘vera<br />
formula’, il cui perfetto equivalente <strong>avestico</strong>, haθiia- <strong>mąθra</strong>-, si ritrova nelle<br />
Gāthā (Y. 31.6) in riferimento al <strong>mąθra</strong>- ahurico. Inoltre, tanto la<br />
declamazione del mántra- poetico dei Veda quanto quella del <strong>mąθra</strong>- ahurico<br />
dell’Avesta sono designate attraverso derivati della ra<strong>di</strong>ce ai. śas-, av. sah-, ap.<br />
θah- ‘proclamare’ (cf. supra n. 20 su sə̄ṇgha-, e Watkins 1995: 90), mentre la<br />
creazione del mántra- ve<strong>di</strong>co e del <strong>mąθra</strong>- <strong>avestico</strong> è in<strong>di</strong>cata in entrambi i<br />
corpora attraverso derivati della ra<strong>di</strong>ce ai. takṣ-, av. taš- ‘costruire’ (cf. RV<br />
7.7.6; Y. 29.7).<br />
È opportuno spendere qui qualche parola sulle occorrenze <strong>di</strong><br />
<strong>tanu</strong>.mąϑra- nel Fravardīn Yašt. Qui l’epiteto è attribuito a due personaggi:<br />
un uomo pio <strong>di</strong> nome Karsna (Yt. 13.106; cf. Mayrhofer 1979 I, 57, n. 204)<br />
<br />
30 Cf. RV 1.152.2b: satyó mántraḥ kaviśastá r̥<br />
́ghāvān ‘vera è la formula potente<br />
pronunciata dal poeta’. Si veda anche Schmitt 1967: 182.<br />
22
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
<strong>di</strong> cui poco si può sapere, e Vīštāspa (Yt. 13.99), il <strong>di</strong>nasta Kayanide<br />
protettore <strong>di</strong> Zarathustra. In entrambi i casi l’epiteto figura all’interno della<br />
sequenza formulare, flessa al caso genitivo, taxmahe <strong>tanu</strong>.mąϑrahe darṣǐ.draoš<br />
āhūiriiehe (‘potente, che conosce il mąϑra per sapere connaturato, dotato <strong>di</strong><br />
intrepido bastone, ahurico’), la stessa che troviamo all’inizio della<br />
celebrazione <strong>di</strong> Sraoša in Y.57.1. È evidente che siamo <strong>di</strong> fronte a un<br />
trasferimento <strong>degli</strong> attribuiti <strong>di</strong> Sraoša a uomini considerati pii, e tuttavia nel<br />
caso <strong>di</strong> Vīštāspa non si potrà tacere qui la circostanza che questi sia un<br />
kauui-.<br />
In in<strong>di</strong>ano kaví- in<strong>di</strong>ca il poeta-veggente dotato <strong>di</strong> prerogative<br />
sacrali 31 ; la parola è stata confrontata (cf. Watkins 1995: 88) con la glossa <strong>di</strong><br />
Esichio κοίης o κόης (ἱερεὺς Καβείρων), che in<strong>di</strong>ca un sacerdote del culto<br />
misterico dei Cabiri nell’isola <strong>di</strong> Samotracia, e con il li<strong>di</strong>o kaveś, pure<br />
in<strong>di</strong>cante una figura sacerdotale (cf. Gusmani 1975: 255 s.), e viene<br />
ricondotta alla base indo-europea *(s)keu̯H- ‘guardare’ (IEW 587 s.; cf.<br />
tedesco schauen). Il corrispondente <strong>avestico</strong> kauui- da un lato in<strong>di</strong>ca nelle<br />
Gāthā alcuni capi <strong>di</strong> comunità ostili a Zarathustra, adoratrici delle <strong>di</strong>vinità<br />
daeviche appartenenti all’antico pantheon indoiranico; dall’altro designa gli<br />
appartenenti alla cosiddetta <strong>di</strong>nastia Kayanide (denominazione derivata dal<br />
mpers. kayān < *kawyān. pl.), tra cui figura appunto Vīštāspa, protettore <strong>di</strong><br />
Zarathustra. Secondo Ehsan Yarshater «the term […] may point to the rise<br />
of a class of warrior princeps from a class which combined spiritual and<br />
temporal powers» (1983: 436). Senza voler entrare qui nella vexata quaestio<br />
relativa alla possibilità, affermata (Christensen 1932) o negata (Kellens 1976:<br />
37-49) 32 , <strong>di</strong> considerare come figure almeno in parte storiche i Kayani<strong>di</strong><br />
predecessori <strong>di</strong> Vīštāspa menzionati nell’Avesta 33 , ci limitiamo a ricordare<br />
come la figura <strong>di</strong> Kauui- Usan- (Yt. 5.45, 14.39, mpers. Kay Ūs) sembri<br />
appartenere a una tra<strong>di</strong>zione indoiranica riflessa pure nel mito in<strong>di</strong>ano <strong>di</strong><br />
Kāvya Uśanas (cf. Lommel 1939, Dumézil 1971, Pirart 1992, Skjærvø<br />
1995: 169s.).<br />
<br />
31 Sulle prerogative sacrali della figura del poeta in ambito in<strong>di</strong>ano e celtico si veda<br />
Campanile 1977: 32 ss.<br />
32 Sul tema cf. anche Gnoli 1980: 233-4; Boyce 1987: 512 e n. 6.<br />
33 Inaccettabile pare comunque l’idea <strong>di</strong> Gershevitch (1959: 185-6) secondo cui<br />
all’epoca <strong>di</strong> Zarathustra l’appellativo kauui- riservato ai <strong>di</strong>nasti Kayani<strong>di</strong> sarebbe stato<br />
soltanto un cognome del tutto desemantizzato.<br />
23
Paolo Milizia<br />
Se dunque la figura del kauui- <strong>avestico</strong> può conservare ancora tratti<br />
del *kau̯í- indoiranico, allora non può forse escludersi del tutto la possibilità<br />
– che, data la scivolosità del tema, affacciamo qui come pura ipotesi – che<br />
Vīštāspa riceva la qualifica <strong>di</strong> <strong>tanu</strong>.mąϑra-, e <strong>di</strong> conseguenza la sequela <strong>di</strong><br />
attributi in cui tale epiteto è formularmente inserito, proprio in quanto<br />
partecipe delle originarie prerogative del kauui-.<br />
Più in generale, dal momento che la testimonianza omerica ci mostra<br />
una concezione dell’attività del poeta come manifestazione <strong>di</strong> una capacità<br />
connaturata, e dal momento che il <strong>mąθra</strong>- ahurico zoroastriano si presenta<br />
per <strong>di</strong>versi aspetti come una trasfigurazione <strong>di</strong> un originario mántra- poetico,<br />
viene da chiedersi se la stessa nozione espressa dal composto <strong>tanu</strong>.mąϑra-<br />
non possa rappresentare la rifunzionalizzazione, nell’ambito del sistema<br />
dottrinale zoroastriano, <strong>di</strong> un semema ere<strong>di</strong>tato originariamente riferito – o<br />
potenzialmente riferibile – al poeta 34 e quin<strong>di</strong> effettivamente quasi-sinonimo<br />
del greco αὐτοδίδακτος 35 .<br />
I dati a nostra <strong>di</strong>sposizione non permettono probabilmente <strong>di</strong> dare<br />
una risposta definitiva al quesito; significativo resta ad ogni modo il fatto<br />
che anche Sraoša sembri poter assumere tratti propri del poeta. Nello Srōš<br />
Yašt (Yasna 57.8a-e) leggiamo: « yō paoiriiō gāϑā̊ frasrāuuaiiat̰ / yā̊ paṇca<br />
spitāmahe aṣǎonō zaraϑuštrahe / afsmaniuuąn vacastaštiuua» ‘il quale per<br />
primo declamò le Gāthā, le cinque del giusto, santo Zarathustra, secondo la<br />
<strong>di</strong>visione in unità metriche e secondo la <strong>di</strong>visione in versi (afsmaniuuąn<br />
vacastaštiuua 36 )’. Proprio nel momento in cui il <strong>di</strong>o è presentato come il<br />
<br />
34 Sulla nozione <strong>di</strong> ispirazione poetica in ambito indoeuropeo si veda Schmitt 1967: 302<br />
ss.<br />
35 Si ricorderà che lo sviluppo da parte <strong>di</strong> tan- <strong>di</strong> valore pronominale, poiché<br />
documentato tanto in in<strong>di</strong>ano quanto in iranico, è da collocarsi nella fase indoiranica.<br />
La assenza <strong>di</strong> confrontabilità, sul piano comparativo-ricostruttuvo, tra l’epiteto greco e<br />
quello <strong>avestico</strong> non rappresenta <strong>di</strong> per sé un ostacolo al confronto nozionale-culturale<br />
(su questo aspetto metodologico rimando a Campanile 1977: 21). D’altra parte, va<br />
notato, dal punto <strong>di</strong> vista della profon<strong>di</strong>tà della proiezione ricostruttiva, che il confronto<br />
tra la forma iranica e quella greca andrebbe collocato nell’ambito delle isoglosse grecoarie<br />
(non automaticamente proiettabili al livello della comunione linguistica<br />
indoeuropea preistorica).<br />
36 Se c’è concor<strong>di</strong>a tra gli esegeti moderni nel vedere nell’espressione afsmaniuuąn<br />
vacastaštiuua un riferimento alla struttura metrica, <strong>di</strong>versi sono invece i pareri su quali<br />
siano le unità metriche cui i due termini rispettivamente alludono. Sul problema si<br />
vedano Kreyenbroek 1985:80, nn. 82,3,4 e 5 e a M. de Vaan, in stampa (entrambi con<br />
ulteriori riman<strong>di</strong> bibliografici).<br />
24
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
primo ad aver cantato le Gāthā, fatto che sancisce il suo ruolo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atore<br />
tra mondo sensibile e parola sacra, si fa esplicito riferimento a quell’aspetto<br />
del testo gatico che è il più tecnicamente, e perciò il più intrinsecamente,<br />
poetico: la sua strutturazione metrica.<br />
Riferimenti bibliografici:<br />
AiWb. = Bartholomae, Christian, Altiranisches Wörterbuch, Strassburg, Trübner, 1904.<br />
Alram, Michael, Maryse Blet-Lemarquand, Prods Oktor Skjærvø (2007), Shapur King of<br />
Kings of Iranians and non-Iranians, in Rika Gyselen (cur.), Des indo-grecs aux<br />
Sassanides: données pour l’histoire et la géographie historique, Bures-sur-Yvette,<br />
Groupe pour l'etude de la civilisation du Moyen-Orient, pp. 11-40.<br />
Anderson, John M. (2007), The Grammar of Names, Oxford, Oxford University Press.<br />
Anquetil Du Perron, Abraham-Hyacinthe, Zend-Avesta, Ouvrage de Zoroastre, tomo 1,<br />
parte 2, Paris, Tilliard.<br />
Bailey, Harold W. (1979), Dictionary of Khotan Saka, Cambridge, CUP.<br />
Bartholomae, Christian (1905), Die Gathas des Avesta, Strassburg, Trübner.<br />
Belar<strong>di</strong>, Walter (1981), Il sapere e l’apprendere nella Grecia arcaica e nell’Iran<br />
zoroastriano, in: Letterature comparate. Problemi e metodo. Stu<strong>di</strong> in onore <strong>di</strong> Ettore<br />
Paratore, Bologna, Patron, pp. 1-21 (= Poesia e onniscienza, tecnica e<br />
insegnamento nella Grecia arcaica e nell’Iran zoroastriano, in: id., Linguistica<br />
generale, filologia e critica dell’espressione, Roma, Bonacci 1990, pp. 219-236).<br />
Benveniste Émile (1966), Titres et noms propres en iranien ancien, Paris, Klincksieck.<br />
Boyce, Mary (1970), Zoroaster the Priest, “BSOAS” 33/1 (In Honour of Sir Harold<br />
Bailey), pp. 22-38.<br />
Boyce, Mary (1987), Priests, Cattle and Men, “BSOAS” 50/3, pp. 508-526.<br />
Boyce, Mary (1996), A History of Zoroastrianism, vol. 1: The Early Period., 3rd ed.,<br />
Leiden, Brill.<br />
Boyce, Mary (2001), Fravaši, in Encyclopae<strong>di</strong>a Iranica, vol. 10, Costa Mesta, Mazda, pp.<br />
195-199 (online ed. http://www.iranica.com/articles/fravasi-).<br />
Burnouf, Eugène (1833), Commentaire sur le Yaçna, Tome I, Paris, Imprimerie royale.<br />
Campanile, Enrico (1977), Ricerche <strong>di</strong> cultura poetica indoeuropea, Pisa, Giar<strong>di</strong>ni.<br />
Christensen, Arthur (1932), Les Kayanides, Copenaghen, Andr. Fred. Höst & sön.<br />
Cipriano, Palmira (1990), I composti greci con φίλος, Viterbo, <strong>Università</strong> della Tuscia.<br />
Darmesteter, James (1880), The Zend-Avesta, Part I, Oxford, The Clarendon Press.<br />
Darmesteter, J. (1892-3), Le Zend-Avesta, 3 vols., Paris (ristampa Paris, Adrien-<br />
Maisonneuve1960).<br />
Dehgan, Keyvan (1982), Der Awesta-Text Srōš Yašt (Yasna 57) mit Pahlavi- und<br />
Sanskritübersetzung (Münchener Stu<strong>di</strong>en zur Sprachwissenschaft, Beiheft 11.<br />
Neue Folge), München, Kitzinger.<br />
25
Paolo Milizia<br />
de Jong, Albert (1997), Tra<strong>di</strong>tions of the Magi. Zoroastrianism in Greek and Latin<br />
Literature, Leiden, Brill.<br />
de Menasce, Jean (1973), Le troisième livre du Dēnkart (Travaux de l’Institut d’Études<br />
Iraniennes 5), Paris, Klincksieck.<br />
de Vaan, Michiel (2003), The Avestan Vowels, Amsterdam, Rodopi.<br />
de Vaan, Michiel (in stampa), The Avestan compounds in -niuuå and -niuuąn, atteso in:<br />
V. Sadovski e D. Stifter (edd.), Iranistische und indogermanistische Beiträge in<br />
memoriam Jochem Schindler (1944-1994), Wien (pre-print in<br />
www.mdevaan.nl/research/Afsmaniu.pdf [<strong>di</strong>cembre 2009]).<br />
DÉLG = Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des<br />
mots, 4 voll., Paris: Klincksieck, 1968-80.<br />
Dhabhar, B. N. (1949), Pahlavi Yasna and Visperad, Bombay.<br />
Duchesne-Guillemin, Jacques (1936), Les composés de l’Avesta, Liège, Faculté de<br />
philosophie et lettres – Paris, Librairie E. Droz.<br />
Dumézil, Georges (1971), Mythe et épopée, vol. 2: Types épiques indoeuropéens: un héros,<br />
un sorcier, un roi, Paris, Gallimard.<br />
Durante, Marcello (1976), Sulla preistoria della tra<strong>di</strong>zione poetica greca. Parte seconda:<br />
risultanze della comparazione indoeuropea, Roma, E<strong>di</strong>zioni dell’Ateneo.<br />
EWA = Mayrhofer, Manfred, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, 3 voll.,<br />
Heidelberg, Winter 1992-2001.<br />
Fick, August (1899), recensione <strong>di</strong> Justi 1895, in “Beiträge zur Kunde der<br />
indogermanischen Sprache” 24, pp. 305-316.<br />
Geldner, Karl F. (1889-96), Avesta. The Sacred Books of the Parsis, 3 voll., Stuttgart,<br />
Kohlhammer.<br />
Gershevitch, Ilya (1959), The Avestan Hymn to Mithra, Cambridge, CUP.<br />
GEW = Hjalmar Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 3 voll., Heidelberg,<br />
Winter, 1960-72.<br />
Gnoli, Gherardo (1980), Zoroaster’s time and homeland: a study on the origins of<br />
Mazdeism and related problems, Napoli, Istituto Universitario Orientale.<br />
Gusmani, Roberto (1975), Le iscrizioni poetiche li<strong>di</strong>e in Stu<strong>di</strong> triestini <strong>di</strong> antichità in<br />
onore <strong>di</strong> Luigia Achillea Stella, Trieste, Facoltà <strong>di</strong> lettere e filosofia, pp. 255-270.<br />
Harlez, Charles-Joseph de ( 2 1881), Avesta. Livre sacré du Zoroastrisme, Deuxième é<strong>di</strong>tion<br />
revue et complétée, Paris, Maisonnneuve.<br />
Haug, Martin (1853), Erklärung Persischer wörter des Alten Testamentes, “Jahrbücher der<br />
Biblischen Wissenschaft” 5 (1852-1853), Göttingen, Dieterichsche<br />
buchhandlung, pp. 154-163.<br />
Heine, Bernd (2000), Polysemy involving reflexive and reciprocal markers in African<br />
languages, in Z. Frajzyngier, T. S. Curl (eds.), Reciprocals: forms and functions,<br />
Amsterdam, Benjamins, pp. 1-29.<br />
Hertel, Johannes (1929), Beiträge zur Erklärung des Awestas und des Vedas (Abh. Sachs.<br />
Akad. Wiss. Phil.-hist. Kl. 40/2), Leipzig, S. Hirzel.<br />
26
<br />
Sulla <strong>semantica</strong> <strong>di</strong> <strong>avestico</strong> <strong>tanu</strong>.<strong>mąθra</strong>-<br />
Hoffmann, Karl, Bernhard Forssman (2004), Avestische Laut- und Flexionslehre, 2a ed.,<br />
Innsbruck, Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck.<br />
Humbach, Helmut, Josef Elfenbein, Prods O. Skjærvø (1991), The Gāthās of<br />
Zarathustra and the Other Old Avestan Texts, 2 voll., Heidelberg, Winter.<br />
IEW = Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, vol. 1, Bern, Francke<br />
1959.<br />
Insler, Stanley (1975), The Gāthās of Zarathustra (Acta Iranica 8), Leiden, Brill.<br />
Justi, Fer<strong>di</strong>nand (1895), Iranisches Namenbuch, Marburg, Elwert.<br />
KEWA = Manfred Mayrhofer, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altin<strong>di</strong>schen / A<br />
Concise Etymological Sanskrit Dictionary, 4 voll., Heidelberg, Winter 1956-1980.<br />
Kellens, Jean (1976), L'Avesta comme source historique: la liste des Kayanides, “Acta<br />
Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Budapest” 24, n. 1-4, pp. 37-50.<br />
Kellens, Jean (1984), Le verbe avestique, Wiesbaden, Reichert.<br />
Kellens, Jean, Eric Pirart (1988-91), Les textes vieil-avestiques, 3 voll., Wiesbaden,<br />
Reichert.<br />
König, Ekkehard, Peter Siemund (1999), Intensifiers and reflexives: a typological<br />
perspective, in: Z. Frajzyngier, T. S. Curl (edd.), Reflexives: form and function,<br />
Benjamins, Amsterdam, pp. 41-74.<br />
Kreyenbroek, G. (1985), Šraosa in the Zoroastrian Tra<strong>di</strong>tion, Leiden, Brill.<br />
Kulikov, Leonid (2007), The reflexive pronouns in Ve<strong>di</strong>c: A <strong>di</strong>achronic and typological<br />
perspective, “Lingua” 117, pp. 1412-1433.<br />
Lommel, Hermann (1939), Kavya Uçan in: Mélanges de linguistique offerts à Charles<br />
Bally, Genève, George et compagnie, pp. 209-14.<br />
Madan, Dhanjishah (1911), The Complete Text of the Pahlavi Dinkard, 3 voll., Bombay,<br />
Society for the promotion of researches into the Zoroastrian religion.<br />
Malandra, William W. (1983), An Introduction to Ancient Iranian Religion-Rea<strong>di</strong>ngs<br />
from the Avesta and Achaemenid Inscriptions, Minneapolis, University of<br />
Minnesota Press.<br />
Mayrhofer, Manfred (1979), Die altiranischen Namen (id. (hrsg.), Iranisches<br />
Personennamenbuch, band 1.), 3 fascc., Wien, Verlag der Österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaften.<br />
Moravcsik, E<strong>di</strong>th (1972), Some cross-linguistic generalizations about intensifier<br />
constructions, “CLS” 8, pp. 271-277.<br />
Mills, Lawrence Heyworth (1887), The Zend-Avesta, Part III, Oxford, The Clarendon<br />
Press.<br />
MW = M. Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford, Clarendon Press<br />
1899.<br />
Pirart, Éric Victor (1992), Kayân Yasn (Yasht 19.9-96). L’origine avestique des dynasties<br />
mythiques d’Iran, Barcelona, AUSA.<br />
Renou, Louis (1958), Études vé<strong>di</strong>ques et pāṇinéennes, tome IV, Paris, De Boccard.<br />
27
Paolo Milizia<br />
Schindler, Jochem (1986), Zu den homerischen ῥοδοδάκτυλος-Komposita, in Annemarie<br />
Etter (cur.), O-o-pe-ro-si: Festschrift für Ernst Risch zum 75. Geburtstag, Berlin,<br />
de Gruyter, pp. 393–401.<br />
Schladt, Mathias (1999), The typology and grammaticalization of reflexives, in Z.<br />
Frajzyngier, T. S. Curl (edd.), Reflexives: form and function, Benjamins,<br />
Amsterdam, pp. 103-124.<br />
Schmitt, Rü<strong>di</strong>ger (1967), Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit,<br />
Wiesbaden, Harrassowitz.<br />
Schmitt, Rü<strong>di</strong>ger (2005), Personal Names, Iranian – ii. Avestan Names, in Encyclopae<strong>di</strong>a<br />
Iranica Online E<strong>di</strong>tion, all’in<strong>di</strong>rizzo http://www.iranica.com/articles/personalnames-iranian-ii-avestan<br />
Skjærvø, Prods Oktor (1995), The Avesta as source for the early history of the Iranians, in<br />
George Erdosy (ed.), The Indo-Aryans of ancient South-Asia : language, material<br />
culture and ethnicity, Berlin – New York, de Gruyter, pp. 155-176.<br />
Skjærvø, Prods Oktor (2002), Ahura Mazdā and Ārmaiti, Heaven and Earth in the Old<br />
Avesta, “JAOS” 122/2 (In<strong>di</strong>c and Iranian Stu<strong>di</strong>es in Honor of Stanley Insler on<br />
his Sixty-Fifth Birthday), pp. 399-410.<br />
Skjærvø, Prods Oktor (2007), The Videvdad: its Ritual Mythical Significance, in Vesta<br />
Sarkhosh Curtis and Sarah Stewart (curr.), The age of the Parthians (The Idea of<br />
Iran, volume II), pp. 105-141.<br />
Spiegel, Friedrich (1864), Commentar über das Avesta, Erster Band, Leipzig, Engelmann.<br />
Thordarson, Fridrik (2009), Ossetic Grammatical Stu<strong>di</strong>es, Wien, Verlag der<br />
Österreichischen Akademie der Wissenschaften.<br />
Tremblay, Xavier (1998), Sur parsui du Fahrang-i-ōim, ratu-, pərətu-, pitu- et quelques<br />
autres thèmes avestiques en -u, “Stu<strong>di</strong>a Iranica” 27, pp. 187-204.<br />
Watkins, Calvert (1995), How to kill a dragon: aspects of Indo-European poetics, Oxford,<br />
Oxford University Press.<br />
West, Martin L. (2007), Indo-European Poetry and Myth, Oxford, Oxford University<br />
Press.<br />
Woolf, H. B. (1939), The Old Germanic Principles of Name-Giving, Baltimore<br />
(Maryland), Johns Hopkins Press.<br />
Yarshater, Ehsan (1983), Iranian national history, in id. (cur.), The Cambridge History of<br />
Iran, vol. 3/1, Cambridge, CUP, pp. 359–477.<br />
Zimmer, Stefan (1992), Die umgekehrten Bahuvrīhi-Komposita im Kymrischen und<br />
Indogermanischen, in Robert Beeks, Alexander Lubotsky, Jos Weitenberg,<br />
Rekonstruktion und relative Chronologie, Akten der VIII. Fachtagung der<br />
Indogermanischen Gesellschaft, Leiden, 31. August – 4. September 1987,<br />
Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, pp. 421-<br />
438.<br />
28