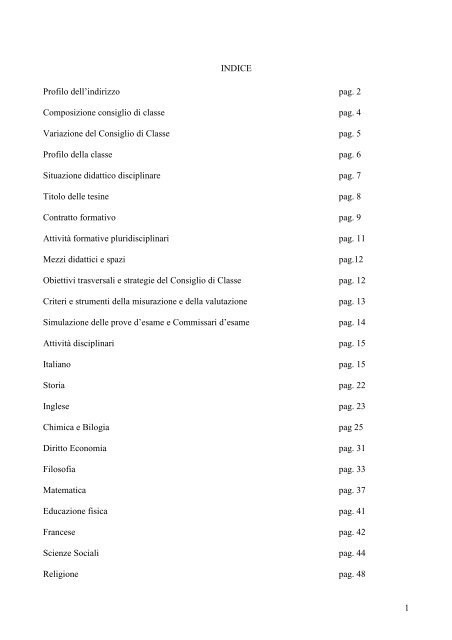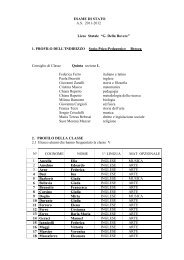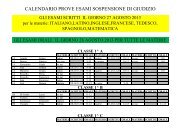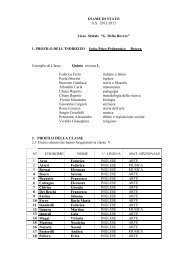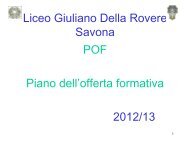Documento 15 maggio 201213_12 5 E - liceo della rovere
Documento 15 maggio 201213_12 5 E - liceo della rovere
Documento 15 maggio 201213_12 5 E - liceo della rovere
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INDICE<br />
Profilo dell’indirizzo pag. 2<br />
Composizione consiglio di classe pag. 4<br />
Variazione del Consiglio di Classe pag. 5<br />
Profilo <strong>della</strong> classe pag. 6<br />
Situazione didattico disciplinare pag. 7<br />
Titolo delle tesine pag. 8<br />
Contratto formativo pag. 9<br />
Attività formative pluridisciplinari pag. 11<br />
Mezzi didattici e spazi<br />
pag.<strong>12</strong><br />
Obiettivi trasversali e strategie del Consiglio di Classe pag. <strong>12</strong><br />
Criteri e strumenti <strong>della</strong> misurazione e <strong>della</strong> valutazione pag. 13<br />
Simulazione delle prove d’esame e Commissari d’esame pag. 14<br />
Attività disciplinari pag. <strong>15</strong><br />
Italiano pag. <strong>15</strong><br />
Storia pag. 22<br />
Inglese pag. 23<br />
Chimica e Bilogia pag 25<br />
Diritto Economia pag. 31<br />
Filosofia pag. 33<br />
Matematica pag. 37<br />
Educazione fisica pag. 41<br />
Francese pag. 42<br />
Scienze Sociali pag. 44<br />
Religione pag. 48<br />
1
_|vxÉ áàtàtÄx ÂZ|âÄ|tÇÉ<br />
WxÄÄt eÉäxÜxÊ<br />
ESAME DI STATO 20<strong>12</strong>/ 2013<br />
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
PREMESSA<br />
Il Consiglio <strong>della</strong> classe 5 a sezione E<br />
- Sulla base <strong>della</strong> programmazione didattico-educativa annuale;<br />
- in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell’indirizzo delle scienze sociali;<br />
- nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), elaborato<br />
dal Collegio dei Docenti;<br />
- in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato;<br />
elabora<br />
all’unanimità il presente documento destinato alla Commissione di Esame.<br />
Redatto a conclusione dell’anno scolastico in corso e del quinquennio liceale, esso presenta obiettivi e<br />
contenuti disciplinari, metodi e mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri e strumenti di<br />
valutazione adottati dal Consiglio di classe ed ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento<br />
degli esami.<br />
PROFILO DELL’INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI<br />
Il corso di scienze sociali si propone come obiettivo la formazione di un individuo autonomo e<br />
responsabile, in possesso di solide basi culturali sia nel settore umanistico che in quello scientifico,<br />
che gli consentiranno di seguire con profitto tutti i corsi universitari o di inserirsi con duttilità nel<br />
mondo del lavoro.<br />
Questo corso, nelle sue varie curvature , intende sviluppare la capacità di osservare e analizzare con<br />
mentalità scientifica il mondo reale, individuandone le leggi fondamentali e utilizzando i linguaggi<br />
specifici.<br />
Il corso riserva adeguata attenzione ai contenuti delle discipline umanistiche (italiano, storia,<br />
filosofia, inglese, francese, diritto), nella consapevolezza dell’importanza di tale tradizione,<br />
costantemente analizzata con rigorosa metodologia critica, curando nel contempo le capacità di<br />
relazione e comunicazione.<br />
Obiettivo importante è pertanto sviluppare negli studenti una adeguata sensibilità nell’integrare le<br />
discipline scientifiche con il sapere umanistico. A tal fine l’indirizzo mette in primo piano in tutti<br />
gli ambiti disciplinari il metodo scientifico, inteso come il prodotto storico più rilevante <strong>della</strong><br />
cultura occidentale, indagando criticamente le radici storiche <strong>della</strong> scienza contemporanea, il suo<br />
sviluppo nel corso del tempo, senza trascurare le problematiche etiche che tale processo oggi<br />
implica.<br />
2
L’opzione sanitaria delle scienze sociali è un indirizzo a carattere biologico/sanitario che unisce la<br />
componente educativo/culturale allo sviluppo di una formazione specifica. Le discipline scientifiche<br />
(Fisica, Chimica, Biologia) sono state sviluppate anche con l’ausilio di attività laboratoriali, la<br />
programmazione dei contenuti ha tenuto nella dovuta considerazione gli argomenti dei test di<br />
accesso alle facoltà medico-sanitarie; il curricolo è stato potenziato di 2 ore alla settimana per le<br />
Scienze in tutti i 5 anni scolastici, il che ha consentito (a differenza dell’impianto di base del Liceo<br />
delle scienze sociali) l’introduzione e l’approfondimento <strong>della</strong> Chimica.<br />
L’insegnamento <strong>della</strong> Fisica si è reso possibile potenziando il curricolo di Matematica e Fisica con<br />
l’aggiunta di 1 ora settimanale in terza e quarta.<br />
L’opzione sanitaria dovrebbe offrire agli studenti ,al termine del quinquennio, una solida cultura di<br />
base che consenta un’idonea preparazione a tutte le facoltà universitarie,in particolare ai corsi di<br />
laurea con sbocchi professionali nell’ambito sanitario/ospedaliero.<br />
L’attenzione che il nostro <strong>liceo</strong> pone circa l’approccio che deve essere messo in atto per la<br />
componente sanitaria,riveste un carattere di priorità in ambito di alternanza scuola-lavoro<br />
Il significato dello stage per questo indirizzo può essere sintetizzato in alcuni punti esplicativi:<br />
1) conoscenza del mondo del lavoro e attenzione alle dinamiche organizzativo/istituzionali;<br />
2) attenzione alle relazioni che intercorrono nell’organizzazione sanitaria in merito alle conoscenze<br />
e capacità che devono essere messe in atto;<br />
3) conoscenza diretta delle relazioni che caratterizzano il rapporto paziente malato;<br />
4) attivazione di percorsi che mirino a dare una serie di input e/o dati e conoscenze in merito alle<br />
discipline sanitarie;<br />
5) approccio al mondo complesso dell’istituzione sanitaria al fine di conoscerne le dinamiche<br />
interne.<br />
In particolare per questa classe lo stage è stato organizzato in tre fasi:<br />
A.S. 2010/2011: Progetto: “L’Industria fito-farmaceutica” presso lo Stabilimento<br />
ABOCA di San Sepolcro. Percorsi tematici mirati all’approfondimento e la conoscenza<br />
delle erbe officinali e il loro uso per la cura di malattie.<br />
Tutor Prof.ssa Franca Foresto<br />
Obiettivi specifici:<br />
- conoscenza dei metodi di impiego delle erbe medicinali nell’antica tradizione popolare<br />
- analisi dei diversi processi di trasformazione ai quali sono sottoposte le erbe prima di<br />
diventare dei veri e propri preparati medicinali.<br />
- conoscenza dei diversi mutamenti storici, culturali e tecnologici che hanno caratterizzato la<br />
conoscenza e l’impiego delle piante medicinali.<br />
3
- conoscenza <strong>della</strong> scienza e <strong>della</strong> tecnica erboristica attraverso le diverse tappe: la medicina<br />
popolare, la magia e la stregoneria, la medicina monastica , la prima medicina ufficiale.<br />
A.S. 2011/20<strong>12</strong>: SOCCORSO SICURO (in collaborazione ed attuato grazie alla Croce<br />
Rossa Italiana e professionisti del 118)<br />
Tutor Prof.ssa Franca Foresto<br />
Obiettivi specifici:<br />
- conoscenza di nozioni mediche di base su come intervenire e comportarsi di fronte ad incidenti<br />
accorsi nella vita quotidiana<br />
- conoscenza di pratiche di primo soccorso e rianimazione<br />
A.S. 20<strong>12</strong>/2013 :LA SCUOLA IN OSPEDALE (collaborazione con l’ASL n°2)<br />
Tutor Prof.ssa Laura Bragantini<br />
Obiettivi specifici:<br />
- conoscenza delle istituzioni connesse alla sanità del nostro territorio<br />
- conoscenza dell’organigramma<br />
- analisi delle singole funzioni<br />
- conoscenza del bacino di utenza e diversificazione del servizio<br />
- introduzione agli aspetti chimico-biologici <strong>della</strong> professione e loro ricaduta<br />
Composizione del Consiglio di Classe<br />
Consiglio di Classe: 5 a Sez. E<br />
Elenco docenti<br />
VIVALDA Silvia Italiano<br />
VIVALDA Silvia Storia<br />
JERI Alessandro Diritto ed Economia<br />
MAIULLARI Patrizia Filosofia<br />
GHIO Maurizio Scienze sociali<br />
BRAGANTINI Laura Chimica e Biologia<br />
MACCO Cristina Matematica<br />
CERRUTI Alessandra Lingua francese<br />
POLVICINO Lia Lingua inglese<br />
ALTOMARE Angela Educazione fisica<br />
VINCALLI Giovanni Religione<br />
Coordinatrice di classe Prof.ssa Silvia Vivalda<br />
Segretaria del Consiglio di classe Prof.ssa Alessandra Cerruti<br />
Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Rosso<br />
4
Variazione nel consiglio di classe<br />
DISCIPLINE ANNI CLASSI<br />
CURRICOLO CORSO III° IV° V°<br />
Italiano 3°- 4° - 5°<br />
Storia 3°- 4° - 5°<br />
Diritto – Economia 3°- 4° - 5°<br />
Filosofia 3°- 4° - 5°<br />
Scienze sociali 3°- 4° - 5° * *<br />
Lingua francese 3°- 4° - 5° *<br />
Lingua inglese 3°- 4° - 5°<br />
Matematica 3°- 4° - 5°<br />
Biologia e Chimica 3°- 4° - 5° *<br />
Educazione fisica 3°- 4° - 5°<br />
Religione 3°- 4° - 5°<br />
L’asterisco indica l’anno in cui vi è stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente.<br />
5
PROFILO DELLA CLASSE:<br />
Elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V E<br />
1 CAPOZZI Roberta<br />
2 CASARINO Fabio<br />
3 COLANDREA Corrado<br />
4 DAMONTE Ivana<br />
5 FALCO Martina<br />
6 FRANZONE Nicole<br />
7 GIOVINAZZO Giulia<br />
8 GRASSO Chiara<br />
9 GRASSO Laura<br />
10 GRECO Laura<br />
11 GUXHA Xhesika<br />
<strong>12</strong> LESKAJ Xhemile<br />
13 RINALDI Giulia<br />
14 SCARAMELLI Alessia<br />
<strong>15</strong> SECCI Agnese<br />
16 TRAVISI Valentina<br />
17 YMERI Hekuran<br />
VARIAZIONE DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO<br />
Numero complessivo degli studenti candidati all’esame 17<br />
Numero di studenti regolari (per anno di nascita) 13<br />
Numero di ripetenti nel triennio 1<br />
FREQUENZA<br />
La tabella che segue precisa per fasce le percentuali delle ore di assenza calcolate sul numero ufficiale<br />
delle ore di lezione svolte nel periodo compreso fra il 17/09/20<strong>12</strong> ed il 30/04/2013.<br />
1.<br />
Sotto il 9%<br />
5<br />
2.<br />
3.<br />
Dal 9,1%<br />
al 20% 10<br />
Dal 20,1%<br />
al 24,9 % 2<br />
6
SITUAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA CLASSE<br />
Frequenza Interesse Impegno Capacità/<br />
Competenze<br />
Regolare per<br />
una parte,<br />
saltuaria per<br />
alcuni.<br />
Da buono a<br />
ottimo a<br />
seconda<br />
delle<br />
discipline e<br />
degli<br />
argomenti<br />
trattati<br />
Da regolare a<br />
ottimo a<br />
seconda delle<br />
discipline e<br />
dei singoli<br />
allievi.<br />
Da buone a<br />
ottime, in<br />
relazione ai<br />
singoli allievi.<br />
Partecipazione<br />
al dialogo<br />
educativo<br />
Mediamente da<br />
regolare a buona.<br />
Ottima per talune<br />
discipline.<br />
Risultati<br />
conseguiti<br />
Da<br />
globalmente<br />
sufficienti a<br />
ottimi a<br />
seconda delle<br />
discipline.<br />
Indicatori: saltuario, sufficiente, discreto, regolare, buono, ottimo<br />
Profilo <strong>della</strong> classe<br />
La classe 5E, composta da 14 femmine e da 3 maschi è il risultato <strong>della</strong> selezione avvenuta nel<br />
quinquennio. La situazione di partenza <strong>della</strong> classe risultava nel complesso soddisfacente, pur nella<br />
necessità , per qualche elemento, di consolidare e potenziare le competenze e il metodo di studio.<br />
L’interesse e la partecipazione, che nei trascorsi anni scolastici apparivano alterni e non omogenei ,<br />
sono sensibilmente migliorati ed hanno raggiunto un buon livello, anche se non nella stessa misura<br />
per tutte le discipline; lo studio domestico è apparso tendenzialmente più costante, si sottolinea<br />
l’impegno dimostrato durante lo stage ospedaliero.<br />
Nella classe è venuto ad evidenziarsi un piccolo gruppo di allievi dotato di ottime capacità<br />
intellettive, particolarmente attenti e diligenti, che si fanno apprezzare per l’impegno e il<br />
comportamento maturo e consapevole. Altri alunni si sono distinti per senso di partecipazione attiva<br />
alla vita scolastica ed hanno conseguito, attraverso il potenziamento dell’attenzione, delle capacità<br />
di osservazione, di analisi e di sintesi, un grado di sviluppo apprezzabile sia dal punto di vista<br />
culturale che formale.<br />
Nel complesso la classe, in relazione alla situazione di ingresso, ha conseguito un livello di<br />
preparazione e di formazione adeguato.<br />
I rapporti interni al gruppo classe sono sereni ed improntati alla civile convivenza, anche il rapporto<br />
docenti/alunni, ha raggiunto un buon equilibrio, fondato sul reciproco ascolto e rispetto.<br />
I lavori presentati in sede d’esame sono frutto dell’impegno individuale degli allievi, e solo in parte<br />
sono stati seguiti dagli insegnanti.<br />
7
TITOLO DELLE TESINE<br />
CAPOZZI Roberta PROPAGANDA FASCISTA: IL CONTROLLO DELLE MENTI<br />
CASARINO Fabio L’ACQUA COME RISORSA E FONTE DI VITA<br />
COLANDREA Corrado LA MAFIA E IL SUO SVILUPPO NELLA SOCIETA’ITALIANA<br />
DAMONTE Ivana IL 68 E I GIOVANI D’OGGI<br />
FALCO Martina IL BAMBINO E’ LA FORMA PIU’ PERFETTA DELL’ESSERE UMANO<br />
FRANZONE Nicole L’ASSISTENTE SOCIALE: UNA PROFESSIONE AFFASCINANTE<br />
GIOVINAZZO Giulia VENUTO AL MONDO<br />
GRASSO Chiara UN ADOLESCENZA NEGATA<br />
GRASSO Laura IL PIU’ SOLIDO PIACERE DI QUESTA VITA E’ IL PIACERE VANO DELLE<br />
ILLUSIONI<br />
GRECO Laura L’IMPERO DEL SOL LEVANTE UN MONDO NUOVO<br />
GUXHA Xhesika TRA FAME E DISPERAZIONE…L’IMMIGGRAZIONE<br />
LESKAJ Xhemile MEMORIA E IDENTITA’ CULTURALE NEL RISPETTO DELLA<br />
DIFFERENZA<br />
RINALDI Giulia LA CHIMICA A SERVIZIO DELLA GUERRA<br />
SCARAMELLI Alessia LA SESSUALITA’: LA BASE DI OGNI AZIONE UMANA<br />
SECCI Agnese SOLO CON LO STUDIO DEL PATOLOGICO SI ARRIVA A CAPIRE IL<br />
NORMALE<br />
TRAVISI Valentina IL SOGNO<br />
YMERI Hekuran IL GIAPPONE E L’OCCIDENTE : DUE REALTA’ DIFFERENTI<br />
8
CONTRATTO FORMATIVO<br />
LICEO STATALE “GIULIANO DELLA ROVERE” SAVONA a. s. 20<strong>12</strong>-2013<br />
Gli insegnanti e gli allievi <strong>della</strong> classe 5E del <strong>liceo</strong> delle Scienze Sociali opzione Sanitario<br />
sottoscrivono il seguente Contratto formativo<br />
La scuola si prefigge di:<br />
- Rispondere alle nuove esigenze di formazione poste dallo sviluppo culturale, sociale ed<br />
economico<br />
- Orientare gli studenti per valorizzare le specifiche inclinazioni e attitudini<br />
- Creare un ambiente di lavoro in cui abbiano rilevanza i valori <strong>della</strong> socialità, <strong>della</strong> legalità, <strong>della</strong><br />
cittadinanza e <strong>della</strong> responsabilità.<br />
- Realizzare il successo scolastico mediante il ricorso a metodologie e strumenti adeguati al contesto<br />
<strong>della</strong> classe, quali percorsi individualizzati, attività di recupero e di potenziamento<br />
I docenti s’impegnano a:<br />
- Discutere e condividere con la classe il percorso di lavoro.<br />
- Illustrare le modalità di verifica e di valutazione.<br />
- Correggere tempestivamente le verifiche.<br />
- Rendere nota la valutazione all’interessato registrandola anche sull’apposito libretto .<br />
- Offrire possibilità di recupero e potenziamento.<br />
- Far acquisire efficaci tecniche di studio.<br />
- Aiutare gli studenti a conoscere le proprie risorse e i propri limiti.<br />
- Ascoltare gli alunni in difficoltà, offrendo percorsi il più possibile individualizzati.<br />
- Programmare le attività in modo che gli studenti siano impegnati nella stessa mattinata in una<br />
sola verifica scritta, salvo casi particolari da concordare tra le componenti alunni e docenti.<br />
- Trascrivere sul registro di classe compiti e verifiche.<br />
- Non affrontare nuovi argomenti in caso d’assenze superiori alla metà degli iscritti.<br />
Gli allievi s’impegnano a:<br />
- Conoscere e condividere gli obiettivi da raggiungere.<br />
- Fare proposte relative al percorso didattico.<br />
- Dimostrare attenzione e partecipazione durante le attività didattiche.<br />
- Rispettare il regolamento d’Istituto.<br />
- Mantenere un comportamento disciplinato e corretto.<br />
- Rispettare le persone e le cose.<br />
- Frequentare i corsi di recupero e le attività di potenziamento.<br />
- Evitare i ritardi alla prima ora di lezione<br />
- Utilizzare in modo proficuo l’assemblea di classe, dandosi un regolamento per la discussione,<br />
individuando i problemi del gruppo e redigendo un verbale da consegnare al coordinatore di<br />
classe.<br />
In particolare dal regolamento d’Istituto:<br />
OBBLIGHI<br />
- Frequentare regolarmente le lezioni<br />
- Essere puntuali<br />
- Giustificare le assenze tempestivamente<br />
- Fare i compiti<br />
- Portare il materiale scolastico<br />
- Partecipare alle attività pomeridiane programmate<br />
- Rispettare le scadenze imposte dalle circolari scolastiche<br />
- Rispettare gli orari di ricevimento <strong>della</strong> segreteria<br />
9
DIVIETI<br />
- Danneggiare il materiale e le attrezzature scolastiche<br />
- Uscire dall’aula senza autorizzazione<br />
- Uscire dalla classe durante i cambi dell’ora<br />
- Mangiare in classe al di fuori dell’intervallo<br />
- Fumare a scuola<br />
- Usare il cellulare.<br />
I genitori s’impegnano a:<br />
- Controllare la frequenza alle lezioni<br />
- Giustificare le assenze e i ritardi con sollecitudine tramite l’apposito libretto<br />
- Controllare il libretto dei voti<br />
- Partecipare assiduamente ai colloqui con gli insegnanti<br />
- Stimolare autonomia e senso di responsabilità nello studio.<br />
10
ATTIVITÀ FORMATIVE PLURIDISCIPLINARI<br />
Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento-approfondimento delle conoscenze,<br />
sono stati offerti agli studenti progetti formativi trasversali e attività extracurriculari, che<br />
hanno fornito ulteriori strumenti e occasioni di impegno e di riflessione. Queste attività,<br />
deliberate dal Consiglio di classe e dal Collegio dei Docenti, hanno ulteriormente potenziato<br />
la formazione degli allievi, supportandone, tra l’altro, le capacità di orientamento motivato e<br />
consapevole agli studi universitari.<br />
INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE<br />
Tra le varie opportunità dell’offerta formativa del Liceo, la classe ha usufruito delle seguenti:<br />
<br />
Attività di orientamento universitario (Visita ad alcune Facoltà, visita del Campus universitario<br />
di Savona, classe IV).<br />
Visita al Salone di Genova per l'orientamento post diploma (classe V)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Visite d’istruzione (ABOCA di San Sepolcro classe III e Mostra del Museo del Cinema a<br />
Torino, visita a Strasburgo classe IV e Praga classe V) .<br />
Spettacoli teatrali (Programma teatrale per le scuole superiori classi III-IV-V).<br />
Progetto "Giovani e web" in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova (classe<br />
IV)<br />
Progetto “Il manuale di sopravvivenza”, la violenza sulle (classe IV)<br />
Stage estivi (quattro allievi, classe IV)<br />
Stage universitario al Campus di Savona, Facoltà di Scienze Infermieristiche <strong>della</strong> durata di una<br />
settimana (due allievi, classe III Giovinazzo Giulia e Rinaldi Giulia)<br />
Stage alla casa di riposo presso Vado Ligure, “Vada Sabazia” ( quattro allievi partecipanti<br />
classe IV Giovinazzo Giulia, Grasso Laura, Scaramelli Alessia, Capozzi Giulia).<br />
Progetto AVO (classe V, sette allievi partecipanti Franzone Nicole, Giovinazzo Giulia, Grasso<br />
Chiara, Greco Laura, Leskaj Xhemile, Scaramelli Alessia) )<br />
Conferenza sui temi dell’economia sostenibile (classe III)<br />
Conferenza "Ciak si dona" a cura dell'AVIS (classe IV)<br />
Conferenza dell’Associazione Libera (classe IV)<br />
Conferenza con il personale medico e amministrativo <strong>della</strong> RSA "Vada Sabatia" (classe IV)<br />
Conferenza presso il Comune di Savona per la giornata dedicata alla violenza sulle donne<br />
11
MEZZI DIDATTICI E SPAZI<br />
Fonte principale e punto di riferimento costante nello studio di tutte le discipline sono stati i libri di<br />
testo, ma è apparso decisamente importante favorire l’approfondimento delle conoscenze attraverso<br />
la consultazione di altre fonti, purché rispondenti all’organizzazione dei contenuti e all’efficacia<br />
<strong>della</strong> trattazione. Inoltre si è fatto ricorso a sussidi multimediali e ad ulteriore materiale<br />
bibliografico per integrare la conoscenza dei nuclei tematici di <strong>maggio</strong>re interesse o per rispondere<br />
alla curiosità degli allievi più motivati.<br />
Il lavoro è stato svolto prevalentemente in aula. I docenti delle discipline scientifiche hanno anche<br />
operato nei laboratori informatico e scientifico.<br />
Interventi didattici integrativi<br />
Gli interventi didattici integrativi si sono articolati come segue:<br />
- in classe durante il normale svolgimento delle lezioni per gli allievi con lievi difficoltà<br />
- attività guidate dall’insegnante e svolte autonomamente a casa per quegli allievi<br />
con non gravi lacune pregresse;<br />
- attività di recupero pomeridiane per colmare lacune anche pregresse.<br />
OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
Obiettivi comportamentali<br />
• Motivazione seria allo studio<br />
• Partecipazione attiva alla vita scolastica<br />
• Capacità di progettazione e realizzazione sul<br />
piano operativo<br />
• Disponibilità alla collaborazione con i<br />
compagni<br />
• Rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto<br />
• Puntualità, precisione, disinvoltura nei rapporti<br />
interpersonali.<br />
Strategie<br />
• Didattica flessibile e volta a sollecitare gli studenti<br />
ad operare scelte consapevoli, responsabili ed<br />
autonome.<br />
• Progettazione di percorsi formativi mirati a<br />
stimolare la ricerca e l’operatività.<br />
Obiettivi cognitivi<br />
• Capacità critiche<br />
• Capacità di analisi ed interpretazione dei testi<br />
• Capacità di connessioni logiche ed<br />
argomentative<br />
• Capacità di utilizzare i linguaggi specifici<br />
• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari<br />
• Capacità di rielaborazione e di sintesi<br />
Strategie<br />
• Problem–solving: valorizzazione <strong>della</strong> discussione<br />
e dell’argomentazione attraverso domande di tipo<br />
problematico volte ad incoraggiare la riflessione e<br />
il ragionamento.<br />
• Lezioni frontali, lezioni partecipate, lezionilaboratorio,<br />
lavori di ricerca.<br />
• Attività di riflessione ed esegesi testuali<br />
• Costruzione di percorsi pluridisciplinare<br />
• Invito e guida all’approfondimento critico dei<br />
contenuti curriculari ed extracurriculari<br />
<strong>12</strong>
CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE<br />
Le verifiche scritte sono state organizzate in maniera diversa a seconda delle<br />
discipline, utilizzando prevalentemente la scala di valutazione in decimali. Le<br />
prove scritte sono state articolate in forma più o meno strutturata, alcune simili alle prove d’esame.<br />
All’orale si state oggetto di valutazione sia le interrogazioni che le micro verifiche;sono state tenute<br />
in considerazione ai fini <strong>della</strong> valutazione anche le prove espositive di lavori di ricerca, individuali<br />
o di gruppo, è si è altresì valutata la capacità di intervenire in maniera pertinente e logica in merito<br />
agli argomenti oggetto di discussione.<br />
Punteggio<br />
in decimi<br />
Giudizio<br />
sintetico<br />
Obiettivi realizzati in termini di<br />
conoscenza – competenza - capacità<br />
1 Insufficienza<br />
gravissima<br />
2 Insufficienza<br />
gravissima<br />
3 Insufficienza<br />
grave<br />
Mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi<br />
Completo disinteresse per i percorsi formativi<br />
Assenza di conoscenze e competenze<br />
Scarsa disponibilità all’ascolto<br />
Incapacità di relazionare anche su contenuti di tipo elementare<br />
Conoscenze gravemente lacunose<br />
Gravi incongruenze concettuali<br />
Linguaggio specifico carente<br />
4 Insufficienza Conoscenze lacunose dei contenuti fondamentali<br />
Disordine e confusione concettuali<br />
Difficoltà Espositive<br />
5 Mediocre Conoscenze incomplete e frammentarie o soltanto nozionistiche<br />
Comprensione parziale delle strutture fondamentali<br />
Controllo incerto delle forme linguistiche<br />
6 Sufficiente Conoscenza dei dati fondamentali<br />
Comprensione globale dei contenuti di base<br />
Lessico essenziale<br />
7 Discreto Conoscenze precise ed abbastanza documentate<br />
Competenze analitiche lineari<br />
Linguaggio corretto e generalmente elaborato<br />
8 Buono Conoscenze solide ed approfondite<br />
Capacità di connessione logica<br />
Proprietà ed efficacia espositiva<br />
9 Ottimo Conoscenze organiche e complete<br />
Disinvolte capacità logico - argomentative<br />
Padronanza dei mezzi espressivi<br />
10 Eccellente Pienamente raggiunti tutti gli obiettivi<br />
Livello di apprendimento altamente significativo<br />
13
SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME<br />
Simulazione <strong>della</strong> prima prova.<br />
È stata effettuata una simulazione di prima prova in data 27 febbraio 2013.<br />
Il testo <strong>della</strong> prova e le griglie di valutazione utilizzate sono inserite negli allegati del documento,<br />
tempo di svolgimento <strong>della</strong> prova 6 ore.<br />
Simulazione <strong>della</strong> seconda prova.<br />
È stata realizzata una simulazione di seconda prova in data 26 marzo 2013.<br />
Il testo <strong>della</strong> prova e le griglie di valutazione utilizzate sono inserite negli allegati del documento,<br />
tempo di svolgimento <strong>della</strong> prova 6 ore.<br />
Simulazione <strong>della</strong> terza prova<br />
Il Consiglio di Classe ha scelto la tipologia B ed ha interpretato la direttiva ministeriale in<br />
relazione alla classe, strutturando la consegna su quattro materie, con due domande aperte e dieci<br />
righe circa di risposta.<br />
E’ stata effettuata in data 20 marzo 2013 una simulazione <strong>della</strong> terza prova d’esame così<br />
strutturata:<br />
MATERIE :Filosofia, Lingua e civiltà inglese, Biochimica, Diritto;<br />
tipologia B tempo massimo di svolgimento <strong>della</strong> prova 2 ore.<br />
Il testo <strong>della</strong> prova è inserito negli allegati del documento.<br />
La seconda simulazione è stata attuata in data 17 aprile così articolata:<br />
MATERIE : Storia, Filosofia, Lingua e civiltà francese, Matematica.<br />
tipologia B tempo massimo di svolgimento <strong>della</strong> prova 2 ore<br />
Il testo <strong>della</strong> prova è inserito negli allegati del documento.<br />
In allegato è riportata la griglia di valutazione utilizzata.<br />
Docente<br />
COMMISSARI D’ESAME INTERNI<br />
Materia__________________<br />
Prof. ssa Silvia Vivalda Italiano e storia<br />
Prof. ssa Laura Bragantini Biologia e chimica<br />
Prof. ssa Lia Polvicino Lingua inglese<br />
14
ATTIVITA' DISCIPLINARI<br />
Prof.ssa Silvia Vivalda<br />
ITALIANO<br />
Ore di lezione effettuate:<br />
Primo quadrimestre: 48 ore<br />
Secondo quadrimestre: 61 ore (presunte fino al 8 giugno)<br />
TESTO IN ADOZIONE : G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria “La letteratura”,<br />
vol. 4 (il Romanticismo), vol. 5 (la Scapigliatura, il Verismo, il Decadentismo), vol. 6<br />
(il primo Novecento e il periodo tra le due guerre), vol. 7 (dal dopoguerra ai nostri giorni),<br />
ed. Paravia<br />
RISULTATI RAGGIUNTI<br />
La classe possiede i contenuti del lavoro svolto in modo non del tutto omogeneo, con differenze<br />
in rapporto alla costanza dell’impegno e alla preparazione pregressa.<br />
Un gruppo di alunni, dotati di buone capacità e motivazione, ha raggiunto risultati buoni, avendo<br />
conseguito una esauriente conoscenza critica dei fenomeni letterari, per il cui apprendimento ha<br />
fatto ricorso, oltre che ai normali strumenti didattici, anche a letture ed approfondimenti<br />
personali. Un ulteriore gruppo, che potremmo definire intermedio, pur non raggiungendo<br />
risultati esaltanti, ha comunque ottenuto una preparazione discreta in ogni aspetto <strong>della</strong> disciplina.<br />
Rimane infine un esiguo numero di alunni che, per poca determinazione e serietà nello studio,<br />
nonché forse per poco interesse o diverse attitudini, ha raggiunto risultati appena accettabili .<br />
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:<br />
CONOSCENZE<br />
● il contesto storico–culturale dei singoli autori proposti, dei movimenti, delle correnti letterarie<br />
● la biografia, le opere, la poetica, l’ideologia, lo stile degli autori<br />
● le caratteristiche dei generi letterari e i modi <strong>della</strong> loro evoluzione<br />
COMPETENZE<br />
● riconoscere gli elementi caratteristici di un testo<br />
● riconoscere lo stile dell’autore<br />
● condurre un’analisi del testo nei suoi aspetti contenutistici, formali, stilistici<br />
● operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso autore, tra opere di<br />
analoga tematica anche se di autori diversi<br />
● competenze analitiche, sintetiche, argomentative, linguistico-espressive<br />
CAPACITA’<br />
● contestualizzare<br />
● valutare criticamente e rielaborare in modo personale<br />
VERIFICHE E VALUTAZIONE<br />
Le verifiche hanno tenuto conto degli obiettivi e dei contenuti svolti e sono state diversificate nel<br />
corso dell’anno sulla base delle diverse tipologie previste dagli Esami di Stato. Hanno costituito<br />
oggetto di valutazione colloqui individuali, mappe concettuali, analisi testuali, saggi brevi, articoli,<br />
relazioni, recensioni, trattazioni sintetiche, questionari.<br />
<strong>15</strong>
La valutazione è stata espressa con voto numerico <strong>della</strong> scala decimale (3-10).<br />
Articolazione dei contenuti<br />
Due gli ambiti correlati dell’insegnamento: l’Educazione linguistica e lo Studio <strong>della</strong> letteratura<br />
italiana.<br />
Lo studio letterario è avvenuto a partire dalla lettura del “testo” , tessuto ricco di rinvii a serie<br />
storiche, sociali, ideologiche, e terreno fertile anche per la riflessione sulla potenzialità espressiva<br />
<strong>della</strong> lingua; per ogni autore si è ricostruito il profilo biografico ed intellettuale, in rapporto al<br />
contesto storico-culturale.<br />
Nel panorama molto vasto di movimenti ed autori presenti nel programma di quinta, sono state<br />
compiute alcune scelte, finalizzate a portare a conoscenza degli studenti realtà esemplari di<br />
contesti, generi, tendenze.<br />
Si è seguito un percorso fondamentalmente diacronico, ma sono stati segnalati anche percorsi per<br />
generi e temi, anche con la lettura di brani di autori non contemplati nel programma, ma proposti<br />
nella prospettiva dell’intertestualità.<br />
Contestualmente è stato perseguito il consolidamento delle strategie analitiche.<br />
Per quanto attiene all’ educazione linguistica, i contenuti sono stati organizzati in unità didattiche di<br />
lungo periodo che si sono sviluppate per l’intero anno scolastico, sia relativamente alla scrittura, sia<br />
per quanto riguarda l’educazione all’oralità, anche in preparazione alle richieste dell’Esame di<br />
Stato.<br />
Metodi, strumenti e mezzi<br />
Si è cercato di favorire un’operatività il più possibile interattiva e di indicare agli studenti<br />
l’esperienza scolastica come occasione di crescita ed espressione delle inclinazioni e potenzialità<br />
individuali. La lezione frontale come introduzione tematica e/o metodologica è stata sempre seguita<br />
dal coinvolgimento diretto degli allievi nel dialogo, al fine di potenziare le competenze linguistiche,<br />
e in attività autonome di analisi e rielaborazione, in classe e per casa. . Strumenti fondamentali<br />
sono stati i testi in adozione, affiancati da integrazioni antologiche o critiche.<br />
Per le prove orali sono stati adottati i seguenti criteri:<br />
- conoscenza dell’argomento<br />
- capacità di elaborare percorsi pertinenti cogliendo i nessi tematici e operando opportuni<br />
collegamenti<br />
- capacità di commentare e analizzare un testo cogliendone i rapporti col contesto storico –<br />
culturale<br />
- coerenza espositiva e uso del lessico<br />
CONTENUTI<br />
Unità 1<br />
Giacomo Leopardi<br />
Conoscenze: conoscere la vita, la formazione culturale, il rapporto con il nascente movimento romantico in Italia, le<br />
opere principali, l’evoluzione <strong>della</strong> poetica, la concezione del compito dell’intellettuale; conoscere i concetti di “vago” e di<br />
“indefinito”, di pessimismo “storico” e “cosmico”.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
La vita Volume 4<br />
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
Il pensiero<br />
La natura benigna,<br />
Il pessimismo storico<br />
16
Le opere: i Canti<br />
Le Operette morali<br />
La natura malvagia,<br />
Il pessimismo cosmico<br />
Le Canzoni<br />
Gli idilli<br />
T2 L’infinito,<br />
T6 A Silvia<br />
T8 La quiete dopo la tempesta<br />
T9 Il sabato del villaggio<br />
T11 Il passero solitario<br />
Il ciclo di Aspasia<br />
T13 A se stesso<br />
La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso<br />
T14 La ginestra o il fiore del deserto<br />
Le Operette morali e l’«arido vero»<br />
T<strong>15</strong> Dialogo <strong>della</strong> Natura e di un Islandese<br />
Unità 2<br />
Giovanni Verga<br />
Conoscenze: conoscere la vita di Verga, i generi letterari da lui praticati e le principali opere; conoscere l’evoluzione <strong>della</strong><br />
sua poetica e le ragioni ideologiche che lo fanno avvicinare al Verismo; conoscere il significato del termine “Verismo”, la<br />
teoria dell’“impersonalità”e quella dell’eclissi dell’autore, “l’artificio <strong>della</strong> regressione”, lo “straniamento”.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
La vita Volume 5<br />
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
L’adesione al Verismo<br />
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista<br />
M2 Il discorso indiretto libero,<br />
T2 “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina,<br />
L’ideologia verghiana,<br />
Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano,<br />
Le opere veriste: le novelle Vita dei campi,<br />
T6 Rosso Malpelo,<br />
T7 La lupa<br />
M7 Lo straniamento,<br />
Novelle rusticane,<br />
T14 La roba<br />
Le opere veriste: i romanzi Lettura integrale de "I Malavoglia"<br />
M9 La struttura dell’intreccio<br />
M10 Il tempo e lo spazio nei Malavoglia<br />
Il Mastro-don Gesualdo<br />
T16 La morte di Mastro Don Gesualdo<br />
Unità 3<br />
Il Decadentismo<br />
Conoscenze: conoscere l’origine e il significato del termine “Decadentismo”, le diverse accezioni e i denominatori comuni<br />
che assume a seconda dell’area geografica, gli estremi cronologici, le poetiche dominanti, i temi più frequenti, le opere e<br />
gli esponenti significativi.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
Il Decadentismo Volume 5<br />
L’origine del termine<br />
La poetica<br />
L’estetismo<br />
L’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive<br />
I temi e i miti<br />
Decadenza, lussuria e crudeltà, la malattia e la morte, gli eroi<br />
Il «fanciullino» e il superuomo<br />
Baudelaire, il decadente ante Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
litteram<br />
I fiori del male<br />
T1 Corrispondenze<br />
T2 L'albatro<br />
17
Unità 4<br />
Gabriele D’Annunzio<br />
Conoscenze: conoscere la vita di D’Annunzio, la sua partecipazione alla vita politica e culturale del tempo, il suo<br />
rapporto con il pubblico e le leggi del mercato, l’evoluzione <strong>della</strong> sua poetica, i vari generi letterari da lui praticati, le<br />
opere più significative, il significato di “estetismo”, “edonismo”, “superomismo” e “panismo”.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
La vita Volume 5<br />
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
I romanzi<br />
Il piacere e la crisi dell’estetismo<br />
T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti,<br />
T3 Il programma politico del superuomo da Le vergine delle rocce<br />
Le opere in versi<br />
Alcyone<br />
T7 La sera fiesolana<br />
T9 La pioggia nel pineto<br />
T<strong>12</strong> Nella belletta<br />
T13 I pastori<br />
Unità 5<br />
Giovanni Pascoli<br />
Conoscenze: conoscere la vita di Pascoli, la sua poetica e il significato di “fanciullino”, i temi e le soluzioni formali delle<br />
sue raccolte poetiche, l’ideologia politica.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
La vita Volume 5<br />
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
La visione del mondo<br />
La crisi <strong>della</strong> matrice positivistica, i simboli<br />
La poetica<br />
Il fanciullino<br />
L’ideologia politica<br />
L’adesione al socialismo, dal socialismo alla fede umanitaria,la mitizzazione del piccolo<br />
proprietario rurale, Il nazionalismo,<br />
La produzione poetica<br />
I temi <strong>della</strong> poesia pascoliana,Il tema del «nido»,le soluzioni formali<br />
Le raccolte poetiche:<br />
Caratteri generali,<br />
Struttura e contenuto,<br />
Myricae<br />
T3 Arano<br />
T4 X Agosto<br />
T6 L’assiuolo<br />
T7 Novembre<br />
T<strong>12</strong> Italy<br />
I Canti di Castelvecchio<br />
Struttura e contenuto,<br />
T14 Il gelsomino notturno,<br />
Unità 6<br />
Movimenti di avanguardia in Italia e in Europa nel primo Novecento<br />
Conoscenze: conoscere i movimenti di avanguardia che in Italia ed in Europa nei primi anni del Novecento propongono<br />
un rinnovamento non solo artistico, ma anche ideologico e politico; conoscere il significato di “avanguardia”,<br />
“avanguardia storica”, “Futurismo”<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
Il contesto storico Volume 6<br />
Le coordinate,<br />
Lo scenario italiano<br />
La situazione storica e sociale, l’ideologia<br />
Il Futurismo in Italia<br />
Il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti<br />
Il fondatore: Filippo Tommaso Marinetti<br />
T1 Manifesto del Futurismo<br />
18
T3 Bombardamento<br />
T2 Manifesto tecnico <strong>della</strong> letteratura futurista<br />
Unità 7<br />
Italo Svevo<br />
Conoscenze: conoscere la vita di Svevo, la sua formazione culturale e le sue opere, il significato di “inetto”, “malattia” ,<br />
“psicoanalisi”, “coscienza”.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
La vita Volume 6<br />
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
I primi romanzi<br />
Una vita,<br />
T1 Le ali del gabbiano,<br />
Senilità,<br />
T3 «Il male avveniva, non veniva commesso»,<br />
L’opera principale<br />
La coscienza di Zeno lettura integrale<br />
La psicoanalisi nella Coscienza di Zeno<br />
Unità 8<br />
Luigi Pirandello<br />
Conoscenze: conoscere la vita di Pirandello, la sua formazione culturale, la visione del mondo e l’evoluzione <strong>della</strong> sua<br />
poetica, la molteplicità dei generi da lui trattati, le innovazioni formali e contenutistiche delle sue opere, il significato di<br />
“umorismo”, “sentimento del contrario”, “vita e forma”, “maschera”, “teatro nel teatro”, “quarta parete”.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
La vita Volume 6<br />
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
La visione del mondo<br />
La poetica<br />
La produzione poetica e<br />
novellistica<br />
I romanzi<br />
La produzione teatrale<br />
Unità 9<br />
Umberto Saba<br />
Le poesie e le novelle<br />
T3 Ciàula scopre la luna<br />
T10 C’è qualcuno che ride<br />
Il fu Mattia Pascal lettura integrale<br />
Uno, nessuno e centomila<br />
Il «teatro nel teatro»<br />
Sei personaggi in cerca d’autore<br />
Conoscenze: conoscere la vita di Saba, la formazione letteraria, le ragioni dello pseudonimo, la poetica, l’incontro con la<br />
psicoanalisi, l’opera poetica e la produzione in prosa, la struttura del Canzoniere, i temi e le soluzioni formali delle liriche<br />
che ne fanno parte.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
La vita Volume 6<br />
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
La produzione poetica: il<br />
Canzoniere<br />
Unità 10<br />
Giuseppe Ungaretti<br />
La struttura,la poetica, i temi principali, le caratteristiche formali<br />
T1 A mia moglie<br />
T2 La capra<br />
T3 Trieste<br />
T5 Mia figlia<br />
T6 Goal<br />
T8 Il teatro degli Artigianelli<br />
T9 Amai<br />
19
Conoscenze: conoscere la vita e le opere di Ungaretti, la sua poetica, i temi e le soluzioni formali delle sue raccolte, il<br />
programma che sottende Vita di un uomo.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
La vita Volume 6<br />
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
La produzione poetica: L’allegria La funzione <strong>della</strong> poesia,l’analogia e la poesia come illuminazione<br />
Gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo, la struttura e i temi<br />
T2 In memoria<br />
T4Veglia<br />
T5 I fiumi<br />
T6 San Martino del Carso<br />
T10 Soldati<br />
Unità 11<br />
Eugenio Montale<br />
Conoscenze: conoscere la vita e le opere di Montale, l’evoluzione <strong>della</strong> sua poetica, la sua concezione del ruolo<br />
dell’intellettuale e il suo atteggiamento nei confronti <strong>della</strong> società, la poetica degli oggetti e il “correlativo oggettivo”, il<br />
significato <strong>della</strong> formula “male di vivere”.<br />
Struttura<br />
Contenuti<br />
La vita Volume 6<br />
Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />
La produzione poetica: Ossi di La edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale<br />
seppia<br />
Il titolo e il motivo dell’aridità<br />
La crisi dell’identità, la memoria e l’«indifferenza»<br />
La poetica e le soluzioni stilistiche<br />
T1 I limoni,<br />
T2 Non chiederci la parola,<br />
T3 Meriggiare pallido e assorto,<br />
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato<br />
La poetica degli oggetti<br />
Le occasioni<br />
La donna salvifica<br />
T<strong>12</strong> La casa dei doganieri<br />
T13 La primavera hitleriana<br />
La bufera e altro<br />
Unità <strong>12</strong><br />
Opere di narrativa italiana dl novecento<br />
Conoscenze: conoscere la produzione narrativa italiana degli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra<br />
mondiale nelle sue linee generali e alcune opere in particolare; conoscere i dati biografici degli autori considerati;<br />
conoscere il significato di “Neorealismo”.<br />
Struttura<br />
Il contesto storico, politico-sociale e<br />
culturale<br />
Contenuti<br />
Volume 6<br />
Le coordinate<br />
Gli indifferenti<br />
Agostino<br />
La casa in collina<br />
Volume 7<br />
L’autore: Alberto Moravia<br />
Struttura e contenuto delle opere, lettura integrale<br />
L’autore: Cesare Pavese<br />
Struttura e contenuto dell' opera, lettura integrale<br />
20
I sentieri dei nidi di ragno<br />
Il partigiano Jonny<br />
Se questo è un uomo<br />
L’autore: Italo Calvino<br />
Struttura e contenuto dell' opera, lettura integrale<br />
L’autore: Beppe Fenoglio<br />
Struttura e contenuto dell' opera, lettura integrale<br />
L’autore: Primo Levi<br />
Struttura e contenuto dell' opera, lettura integrale<br />
DANTE lettura, analisi e commento dei seguenti canti: del Paradiso: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII.<br />
21
STORIA<br />
Insegnante Silvia Vivalda<br />
La classe ha conseguito un livello di conoscenze, competenze e capacità che si colloca globalmente tra il<br />
discreto e il buono.Un gruppo di studenti si segnala in particolare per profitto, partecipazione attiva alle<br />
lezioni, impegno nello studio e significativi apporti personali. Si è riscontrato un interesse marcato,<br />
soprattutto per la storia del Novecento e per gli argomenti di <strong>maggio</strong>re rilevanza attuale, interesse che si è<br />
sostanziato in una partecipazione attenta e costante e in interventi puntuali, caratterizzati da significativi<br />
apporti critici e personali, che a più riprese hanno occasionato dibattiti collettivi.<br />
Ore effettuate 82 di cui 20 di compresenza<br />
Contenuti disciplinari<br />
MODULO 1: L'Italia tra Ottocento e Novecento<br />
1.Sviluppo e crisi i governi <strong>della</strong> sinistra<br />
2.Il rovesciamento delle alleanze e la politica coloniale<br />
3.L'età giolittiana<br />
MODULO 2: La grande guerra e la Rivoluzione russa<br />
1.La prima guerra mondiale<br />
2.La fine <strong>della</strong> guerra. L'Europa ridisegnata<br />
3.La Rivoluzione russa e la nascita dell'URSS<br />
4.La crisi degli imperi coloniali<br />
5.Declino europeo e primato americano<br />
MODULO 3:I regimi totalitari europei<br />
1.L'ascesa del fascismo in Italia<br />
2.La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa<br />
3.La dittatura fascista in Italia<br />
4.La Germania dalla crisi al nazismo<br />
5.L'URSS di Stalin<br />
MODULO 4: La seconda guerra mondiale<br />
1.LHitler aggredisce l'Europa<br />
2.Il mondo in guerra. URSS,USA e Giappone nel conflitto<br />
3.La fine <strong>della</strong> guerra<br />
MODULO 5: Il mondo bipolare<br />
1.Il mondo diviso<br />
2.Le due Europe<br />
3.L'Italia ricostruita<br />
4.Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica<br />
MODULO 6: Colonialismo al tramonto:i nuovi equilibri mondiali<br />
1.Asia e America Latina<br />
2.Africa e Medio Oriente<br />
3.Il sessantotto<br />
MODULO 7: Le grandi potenze tra XX e XXI secolo<br />
1.Lo sviluppo dell'Occidente europeo<br />
2.1989: la caduta del muro<br />
3.La fine dell'Impero sovietico e la crisi del bipolarismo<br />
Testo in adozione: Vivere la storia volume 3, M. Montanari Editore Laterza.<br />
22
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE<br />
Insegnante: Prof. Lia Polvicino<br />
Libro di testo in uso :” New Surfing the world” di M. G. Dandini – ed. Zanichelli<br />
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 20<strong>12</strong>/2013 n. ore 76 ( entro il <strong>15</strong> <strong>maggio</strong>.)<br />
Obiettivi programmati:<br />
-Potenziare le quattro abilità <strong>della</strong> lingua e favorirne le interconnessioni.<br />
-dare completezza e sistematicità al bagaglio linguistico acquisito nei precedenti anni di corso anche<br />
alla luce delle nuove acquisizioni.<br />
-cogliere il senso dei testi orali e scritti<br />
-sostenere conversazioni adeguate per registro, coerenza, coesione e lingua<br />
-ampliare le conoscenze sul mondo anglofono e migliorare le conoscenze linguistiche<br />
Obiettivi conseguiti:<br />
-Comprensione analitica dei testi scritti;<br />
-acquisizione del linguaggio specifico;<br />
-Produzione di testi orali di tipo argomentativo con chiarezza e precisione lessicale;<br />
-Produzione di testi scritti coerenti e funzionali all’obiettivo comunicativo.<br />
Si sottolineano differenze nel raggiungimento di detti obiettivi da parte dei singoli alunni.<br />
Metodologia:<br />
-L’impostazione didattica ha avuto come obiettivo l’acquisizione e il rafforzamento delle abilità di<br />
base seguendo un taglio funzionale-comunicativo.<br />
Circa la produzione orale si è cercato di migliorare la capacità espositiva e di rielaborazione dei<br />
contenuti .<br />
Per quanto riguarda la produzione scritta si sono proposte attività di scrittura diversificata,<br />
specialmente di natura espositiva e argomentativa.<br />
Lo sviluppo delle quattro abilità è stato il più possibile equilibrato alla realtà classe.<br />
Mezzi e strumenti di lavoro:<br />
Ci si è avvalsi del materiale didattico scolastico.<br />
Contenuti:<br />
THE UNITED STATES OF AMERICA.<br />
The Country<br />
Government and politics.<br />
The Presidential elections<br />
The Americans<br />
The Five Regions :<br />
The North East ( New England, the Mid Atlantic States, New York City )<br />
The Midwest<br />
Famous people from the Midwest : Henry Ford<br />
The South<br />
The Southwest<br />
The West ( The Rocky Mountain States, The Pacific Coast States, S.Francisco )<br />
Alaska<br />
Hawaii<br />
23
History<br />
American Indians<br />
The Pilgrim Fathers<br />
The War of Indipendence<br />
The Conquest of the West<br />
The American Civil War<br />
Segregation<br />
Slavery in the Southern States<br />
The Civil Rights Movement:<br />
Martin Luther King , Malcom X<br />
A Land of immigrants<br />
Italian immigrants<br />
The Roaring Twenties<br />
Proibition, Poverty and Segregation<br />
The Wall Street Crash and the Great Depression<br />
President Roosevelt and the New Deal<br />
World War I<br />
World War II<br />
The Fifties<br />
The Cold War<br />
The Vietnam War.<br />
AUSTRALIA<br />
The Island Continent :<br />
geographical features , the climate, major towns<br />
The Government<br />
The Commonwealth<br />
The Aborigines<br />
The Aussies<br />
Ayers Rock<br />
24
LICEO DELLE SCIENZE UMANE “ G. DELLA ROVERE “ – SAVONA<br />
Anno Scolastico : 20<strong>12</strong>/2013<br />
<strong>Documento</strong> Esame di Stato classe V^E<br />
Materie : CHIMICA E BIOLOGIA-Indirizzo sanitario<br />
Docente : Prof. BRAGANTINI LAURA<br />
La classe ,che conosco solo da quest’anno ,si può suddividere in tre fasce:<br />
a)Alunni/e dotati di buone capacità logico-deduttive, precisi nell’esposizione e che mostrano di<br />
possedere un metodo di lavoro organico ed autonomo, per cui apprendono con velocità e<br />
sicurezza.<br />
b)Altri che, pur non mancando di capacità, si applicano in modo più frammentario e superficiale, o<br />
troppo mnemonico e meccanico, presentando di conseguenza un profitto più saltuario ma comunque<br />
globalmente positivo(è la situazione più diffusa).<br />
c)Un piccolo gruppo , infine, denuncia <strong>maggio</strong>re lentezza nei ritmi d’apprendimento, unita a<br />
difficoltà di esposizione e, in alcuni casi, a mancanza di studio.<br />
.<br />
La frequenza è stata regolare(salvo poche eccezioni).<br />
Non si registrano problemi disciplinari perché tutti gli allievi hanno sempre mostrato un<br />
atteggiamento amichevole,collaborativo e rispettoso nei confronti dell’insegnante.<br />
Nell’impostare l’attività didattica sono partita, oltre che dalla realtà del gruppo classe,<br />
da un’attenta lettura dei teoritest di preparazione alle prove di selezione preliminare delle facoltà di<br />
Medicina e Chirurgia,Odontoiatria,Veterinaria,Logopedia,Fisioterapia ecc.<br />
Globalmente, la classe ha mostrato buona disponibilità nei confronti delle mie discipline;soprattutto<br />
rispetto ai nuovi argomenti trattati in Biologia gli alunni, opportunamente stimolati,hanno dato<br />
prova di crescente interesse. Gran parte <strong>della</strong> classe ha partecipato con regolarità alle lezioni e ha<br />
dato prova di continuità nell’applicazione e nello studio, ma il metodo di lavoro rimane per alcuni<br />
non abbastanza organico ed accurato, per altri ancora troppo mnemonico,superficiale e dispersivo.<br />
Di conseguenza, accanto agli elementi di spicco che presentano un’ottima acquisizione culturale dei<br />
contenuti, accompagnata da soddisfacenti capacità di rielaborazione personale, altri colgono solo in<br />
parte gli aspetti più salienti e significativi delle discipline(in modo particolare per quanto riguarda la<br />
Chimica ) ed operano con difficoltà / solo se guidati collegamenti opportuni fra gli argomenti<br />
proposti. Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti, ma alcuni solo parzialmente: infatti la<br />
fascia più bassa <strong>della</strong> scolaresca presenta ancora un profitto non sempre soddisfacente ;inoltre la<br />
trattazione <strong>della</strong> Chimica organica è stata ridotta per limiti di tempo ed ho ritenuto opportuno<br />
svilupparla,come potenziamento,soltanto con gli alunni più continui nel rendimento.<br />
-CHIMICA:<br />
Per quanto riguarda le finalità del corso di chimica(2 ore settimanali), la programmazione di<br />
questa disciplina, prevista a partire dal triennio, ha richiesto un’attenzione particolare . La<br />
complessità del libro in adozione(“Chimica”di M.Bosia,Ed.Paravia), che richiede particolari<br />
capacità di interpretazione e di sintesi da parte degli alunni e soprattutto conoscenze di base in<br />
campo matematico e fisico, ha comportato una guida costante nella lettura, comprensione e<br />
rielaborazione dei contenuti, mediata dal confronto con altri testi e documenti scientifici;spesso ho<br />
fornito materiale integrativo, vuoi sotto forma di dispense, vuoi curando personalmente la redazione<br />
di appunti e fotocopie.<br />
25
Il lavoro svolto nel corso dell’anno ha cercato di sviluppare un percorso preferenziale, adattato in<br />
sede di C.d.C., e volto al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:<br />
-La comprensione del Metodo Sperimentale : osservare – trarre dalle osservazioni alcune<br />
elementari conclusioni – suddividere ordinatamente in gruppi i fatti ed i fenomeni osservati –<br />
abituarsi alla verifica, sperimentale o indiretta delle ipotesi formulate.<br />
- La crescita culturale,attraverso lo studio dell’apporto che la Chimica ha<br />
dato,storicamente,all’evoluzione del sapere umano.<br />
-Lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità logiche e linguistiche.<br />
Per il raggiungimento, almeno parziale, di tali finalità ho ritenuto indispensabili i seguenti obiettivi<br />
cognitivi specifici :<br />
-Acquisire consapevolezza che la gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in<br />
trasformazioni chimiche ed energetiche.<br />
-Recepire che tali trasformazioni sono interpretabili facendo riferimento alla natura ed al<br />
comportamento di molecole, atomi, ioni.<br />
-Correlare denominazione e formule dei composti, riconoscendo che la combinazione degli<br />
atomi è determinata da regole di valenza.<br />
-Correlare la varietà ed il numero elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche del<br />
carbonio.<br />
-Riconoscere che il comportamento chimico delle sostanze organiche è determinato dalla<br />
presenza di alcuni gruppi funzionali.<br />
-Descrivere le proprietà chimiche di alcuni composti organici con rilevante interesse<br />
tecnologico o biologico.<br />
Metodi, mezzi, strumenti e spazi di lavoro :Come in tutte le classi ho individuato i principali<br />
contenuti idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati, articolandoli poi in semplici unità<br />
didattiche, segmenti di apprendimento omogeneo.<br />
La trattazione degli argomenti cercava di stimolare nei ragazzi l’osservazione personale e le<br />
capacità riflessive ed analitiche, sollecitando domande, discussioni e dibattiti che facessero luce sui<br />
loro interessi .<br />
La lezione frontale è stata privilegiata, alternandola con letture di articoli e dati statistici,<br />
l’osservazione di plastici, lucidi, fotografie, l’utilizzo di sussidi audiovisivi, tavole schematiche e<br />
materiale di laboratorio.<br />
Strumenti di verifica:le verifiche sono state quanto più possibile frequenti (anche se non<br />
necessariamente esaustive), in modo da accertare, man mano che le U.D. venivano completate, il<br />
livello di conoscenza e di comprensione degli argomenti proposti.<br />
Il controllo del raggiungimento degli obiettivi ha utilizzato i seguenti strumenti:<br />
a)Verifiche scritte, contenenti : reazioni , quesiti del tipo vero/falso o a scelta multipla, problemi,<br />
quesiti del tipo a completamento, domande a risposta aperta, quesiti del tipo a corrispondenza,.<br />
b)Verifiche orali, sotto forma o di colloquio breve esteso a più soggetti (in modo da evitare un<br />
impiego eccessivo di tempo, la distrazione dei non interrogati, la prevedibilità dell'interrogazione, la<br />
tensione emotiva del singolo) o di interrogazioni programmate, concordate con la classe.<br />
Nella valutazione, espressa in decimi o in quindicesimi, ho considerato i seguenti punti:<br />
-Comprensione del quesito.<br />
-Conoscenza corretta e completa dei contenuti.<br />
-Capacità di collegamento.<br />
-Esposizione, con utilizzo di termini specifici.<br />
-Interesse individuale all’apprendimento<br />
26
Gli obiettivi didattici minimi sono stati i seguenti:<br />
a)conoscenza essenziale dei contenuti previsti nei diversi moduli<br />
b)capacità di sapersi orientare,con l’aiuto dell’insegnante,sulle conoscenze man mano acquisite,in modo<br />
da effettuare gli opportuni collegamenti<br />
c)acquisizione accettabile del lessico specifico<br />
Ho considerato raggiunto il livello minimo se sono stati realizzati tutti e tre gli obiettivi<br />
Contenuti del corso di chimica:<br />
U.D. I – I LEGAMI CHIMICI-(Ripasso ed approfondimento)(settembre/ottobre)<br />
-Energie di legame, potenziale di ionizzazione, affinità per l’elettrone, elettronegatività-Formule di<br />
Lewis- – Legame omeopolare puro e legame dipolare(legame sigma e legame pi greco) – Legame<br />
ionico:struttura reticolare e caratteristiche dei composti ionici – Legame dativo o di<br />
coordinazione:esempio dell’ossigeno come accettore e del cloro come datore – Legame metallico<br />
:reticoli metallici(esempi)-Le leghe–La risonanza-Legame ad elettroni delocalizzati:l’anello del<br />
benzene e dei composti aromatici-Ibridizzazione degli orbitali(sp3,sp2,sp,angoli di legame<br />
corrispondenti)-I legami molecolari:forze di adesione e di coesione- Molecole polari e apolari –<br />
Legame ione-dipolo(l’acqua ed i complessi di solvatazione)-Legame dipolo-dipolo - Dipoli indotti-<br />
Teoria VSEPR e geometria delle molecole(cenno) – Forze di Van der Waals/di London – Legame<br />
(o ponte) H.<br />
U.D.II-SOLUZIONI E LORO PROPRIETA’(approfondimento)(Novembre)<br />
Caratteristiche di un miscuglio omogeneo ed eterogeneo-Soluzioni vere/molecolari(con particolare<br />
riferimento alle soluzioni acquose)-Soluzioni colloidali-Effetto Tyndall-Il processo di<br />
dissoluzione:solubilità e fattori che influenzano la velocità di dissoluzione-Concentrazione(o<br />
titolo)di una soluzione:frazione percentuale,molalità,molarità.-Definizione di elettrolita e di grado<br />
di dissociazione-Dissociazione elettrolitica di acidi ,basi e Sali-Acido e base secondo Arrenhius-<br />
Proprietà colligative delle soluzioni:abbassamento <strong>della</strong> tensione di vapore,innalzamento<br />
ebullioscopio,abbassamento crioscopico,pressione osmotica-Le proprietà colligative di soluzioni<br />
elettrolitiche:calcolo del coefficiente di Van’t Hoff e formule conseguenti-<br />
U.D.III–ENERGIA TERMICA NELLE REAZIONI CHIMICHE(Dicembre)<br />
Sistema chimico e ambiente-Primo principio <strong>della</strong> termodinamica-Reazioni endotermiche e reazioni<br />
esotermiche:la combustione-Una nuova funzione di stato:l’entalpia-Calore di reazione-Legge di<br />
Hess-Il secondo principio <strong>della</strong> termodinamica e la spontaneità delle reazioni:l’entropia ed il<br />
disordine(terzo principio <strong>della</strong> termodinamica)-Energia libera ed equazione di Gibbs-<br />
U.D. IV – LA CINETICA CHIMICA(Gennaio/Febbraio)<br />
Reazioni chimiche:aspetti dinamici-Che cos’è e come si misura la velocità di una reazione-Fattori<br />
che influenzano la velocità delle reazioni:natura e concentrazione dei reagenti,temperatura,stato di<br />
suddivisione dei reagenti solidi-L’energia di attivazione,la teoria delle collisioni,i catalizzatori-<br />
Reazioni irreversibili e reversibili-L’equilibrio chimico: le condizioni di equilibrio e il rendimento<br />
di una reazione-La costante di equilibrio ed il suo significato-Legge dell’azione di massa-La<br />
costante di equilibrio in fase gassosa-Principio dell’equilibrio mobile( Le Chatelier):aggiunta o<br />
sottrazione di componenti,variazione <strong>della</strong> pressione,variazione <strong>della</strong> temperatura-Il prodotto di<br />
solubilità-<br />
U.D. V– L’EQUILIBRIO ACIDO-BASE(Marzo/Aprile)<br />
I limiti <strong>della</strong> teoria di Arrhenius -Reazione di neutralizzazione acido/base - La teoria di Bronsted e<br />
Lowry:coppie acido/base coniugata(esempi)-La teoria di Lewis(esempi)-<br />
27
Le costanti di acidità e di basicità di una soluzione-Relazione fra costante di ionizzazione e forza<br />
dell’acido/<strong>della</strong> base-Prodotto ionico dell’acqua- pH e pOH- Gli indicatori e il punto di viraggio-<br />
L’idrolisi salina(esempi)-Le soluzioni tampone-<br />
U.D.VI– LE REDOX-ELETTROCHIMICA(Maggio)<br />
Ossidazione e riduzione-Calcolo del numero di ossidazione-Reazioni redox e relativo<br />
bilanciamento(esempi)-Reazioni di dismutazione(esempi)-Energia chimica ed energia elettrica:scala<br />
dei potenziali di riduzione-Le soluzioni elettrolitiche,conduttori di seconda specie-Conduttanza<br />
specifica di una soluzione elettrolitica-La pila Daniell-la pila di Volta(cenno)-Il processo di<br />
elettrolisi e le leggi di Faraday-Esempi:elettrolisi dell’acqua,elettrolisi dell’idrato di sodio fuso o in<br />
soluzione acquosa-Applicazioni tecniche dell’elettrolisi: cenni su raffinazione dei<br />
metalli,galvanostegia,elettroforesi.<br />
U.D. VII–CENNI ALLA CHIMICA DEL CARBONIO(Maggio/Giugno)<br />
Particolari caratteristiche del carbonio: tipi di ibridizzazione dell’atomo di carbonio(esempi)-Cenno<br />
agli idrocarburi saturi ed insaturi(alcani,alcheni,alchini)-Il legame ad elettroni delocalizzati:l’anello<br />
del benzene(cenno ai composti aromatici)—Principali gruppi funzionali e classi di composti<br />
organici corrispondenti (cenni) – Isomeria (esempi) -Biomolecole: carboidrati (monosaccaridi,<br />
disaccaridi, polisaccaridi) – lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi) - amminoacidiproteine(struttura<br />
primaria,secondaria,terziaria e quaternaria)-acidi nucleici-<br />
BIOLOGIA(2 ore settimanali)<br />
FINALITA’ DEL CORSO :<br />
Il lavoro che ho svolto nel corso dell’anno si proponeva di sviluppare un percorso preferenziale,<br />
adattato in sede del C.d.C. e volto al conseguimento dei seguenti OBIETTIVI :<br />
a) La consapevolezza del valore delle Scienze quale componente culturale fondamentale per la<br />
lettura e l’interpretazione <strong>della</strong> realtà quotidiana.<br />
b) Il recupero e la sistemazione in un quadro unitario coerente di alcune conoscenze biologiche<br />
precedentemente acquisite (evitando un’eccessiva frammentazione del sapere) .<br />
c) Una valutazione più critica ed autonoma delle informazioni fornite dai mass-media su<br />
argomenti e problemi scientifici.<br />
d) L’acquisizione di un comportamento più consapevole e responsabile nella tutela <strong>della</strong> salute<br />
(propria ed altrui) .<br />
e) Approfondire la conoscenza e la riflessione su alcune caratteristiche specifiche dell’uomo-<br />
Spiegare i meccanismi <strong>della</strong> ereditarietà, con particolare riferimento alla Genetica umana ed<br />
alla Genetica molecolare.<br />
f) Far acquisire la capacità di reperire autonomamente e criticamente informazioni<br />
specifiche consultando fonti opportune..<br />
g) Individuare caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi, ai diversi livelli di organizzazione.<br />
h) Illustrare per sommi capi le classi dei componenti molecolari e macromolecolari che<br />
caratterizzano gli organismi viventi.<br />
i) Far acquisire un lessico specifico sufficientemente corretto, chiaro e preciso<br />
l) Fornire spunti e stimoli per un raccordo con strutture sanitarie e facoltà<br />
paramediche del territorio(anche in relazione allo stage triennale)<br />
Metodi, mezzi, strumenti e spazi di lavoro:vedi programmazione di chimica-<br />
Strumenti di verifica :vedi programmazione di chimica-<br />
28
Contenuti del corso di biologia<br />
U.D.I - GENETICA UMANA ( con richiami alla Genetica classica )(settembre/dicembre)<br />
Genotipo e Fenotipo-.Richiamo agli studi di Mendel.- Cariotipo umano : autosomi ed<br />
eterocromosomi – Cromosomi omologhi ed alleli – Omozigosi ed eterozigosi -<br />
Legge <strong>della</strong> dominanza e <strong>della</strong> recessività. Dominanza incompleta/intermedia ,<br />
dominanza irregolare, codominanza-Ereditarietà poligenica/polifattoriale-<br />
Pleiotropia- – Significato ed importanza <strong>della</strong> meiosi –Aploidia e diploidia,<br />
gametogenesi e determinismo del sesso nella specie umana –- Legge <strong>della</strong><br />
segregazione e dell’assortimento indipendente (richiami a Mendel e Sutton) –<br />
Probabilità applicata a Genetica –Esempi di incroci;quadrato di Punnet– Linkage e<br />
Crossing-over-Mappatura del DNA- – Malattie ereditarie autosomiche, dominanti o<br />
recessive (modalità di trasmissione, esempi : nanismo acondroplastico, morbo di<br />
Bourneville, neurofibromatosi, corea di Hungtington, albinismo, fenilchetonuria,<br />
morbo di Tay-Sachs, anemia mediterranea –La malaria e la superiorità<br />
dell’eterozigote portatore rispetto all’omozigote sano) - Consanguineità –<br />
Esperimenti di Morgan e Bridges- Malattie diaginiche (caratteristiche <strong>della</strong><br />
ereditarietà, esempi: daltonismo, emofilia, distrofia muscolare progressiva tipo<br />
Duchenne, adrenoleucodistrofia.) – Sindromi da non disgiunzione meiotica :<br />
trisomie(sindrome di Down, trisomia D, trisomia E, sindrome di Klynefelter, trisomia<br />
X), monosomie(sindrome di Turner), aberrazioni cromosomiche (delezioni,<br />
traslocazioni) – Ereditarietà dei gruppi sanguigni (Sistema ABO – Sistema Rh) –<br />
Malattia emolitica del neonato – Applicazioni medico-legali dei gruppi<br />
sanguigni(ricerca di paternità)- Analisi prenatali – La gemellarità: gemelli monodizigoti,<br />
frequenza del parto gemellare, gemellarità multipla, gemelli siamesi – Gli<br />
alberi genealogici-Ereditarietà e ambiente-<br />
U.D.II – GENETICA MOLECOLARE E SINTESI PROTEICA (gennaio/marzo)<br />
Struttura di un alfa amminoacido: gruppi funzionali caratteristici- Condensazione di due aa. e<br />
formazione del legame peptidico- Struttura primaria, secondaria, ternaria e quaternaria delle<br />
proteine- Definizione di organismo procariote ed eucariote- Ciclo vitale di una cellula eucariote-<br />
Eterocromatina ed eucromatina- Struttura del DNA(modello di Watson e Crick) : struttura dei<br />
nucleotidi, ponti H e legami fosfodiestere, complementarità delle basi azotate- Possibili spiegazioni<br />
<strong>della</strong> “ridondanza del DNA”- Proteine nucleari(istoniche e non istoniche) associate al DNA degli<br />
Eucarioti e loro significato funzionale- RNA nucleare- Esperimenti che provano come il DNA sia<br />
portatore del codice genetico: Avery, Chase, Chargaff- Duplicazione semiconsevativa del DNA<br />
(ipotesi di Watson e Crick, verifica sperimentale di Meselson e Sthal)- Cenno alle modalità di<br />
azione <strong>della</strong> DNA polimerasi- Duplicazione del DNA virale a catena singola- La trascrizione del<br />
messaggio genetico: sintesi dell’RNA, azione dell’RNA polimerasi (cenno)- Tipi diversi di RNA(<br />
HRNA, messaggero, ribosomiale, transfert) e loro struttura- Messaggeri mono / policistronici-<br />
Traduzione del codice genetico, sintesi proteica e sua regolazione: ribosomi e loro sub-unità;<br />
reticolo endoplasmatico liscio o ruvido, differenziamento funzionale delle proteine sintetizzate dai<br />
polisomi o dai ribosomi associati al reticolo- Meccanismo di crescita <strong>della</strong> catena peptidica in<br />
formazione: sticky points, codice d’inizio( ruolo <strong>della</strong> formilmetionina), codice degenerato e basi<br />
“ballerine”, codici di termine- Manipolazioni post-ribosomiche delle proteine sintetizzate( es.<br />
dell’insulina)- Teoria dell’”un gene,un enzima”(richiamo al concetto di catalisi enzimatica)-<br />
29
Errori innati del metabolismo- Le mutazioni: definizione di de Vries- Mutazioni puntiformi<br />
missense(es.: anemia falciforme)- Mutazioni non-sense, mutazioni somatiche- Agenti mutageni-Le<br />
nuove frontiere <strong>della</strong> genetica:le moderne biotecnologie(l’ingegneria genetica,il DNA<br />
ricombinante,la clonazione,gli organismi transgenici)-<br />
U.D.III- EVOLUZIONE- (aprile/<strong>maggio</strong>)-<br />
Le teorie fissiste e creazioniste: Aristotele e la “Scala Naturae”, Linneo, Cuvier e la teoria delle<br />
catastrofi- Le teorie evolutive prima di Lamarck( Anassimandro, Buffon, E. Darwin)- Lo studio dei<br />
fossili e l’età <strong>della</strong> terra( cenno ai processi di fossilizzazione)- Il finalismo di Lamarck: punti nodali<br />
<strong>della</strong> teoria e suoi limiti- L’attualismo di Hutton, gli studi di William Smith, Lyell e Malthus- Il<br />
viaggio del brigantino Beagle e le osservazioni di Darwin –Capisaldi dell’evoluzionismo:<br />
variabilità, lotta per l’esistenza, selezione naturale- Evoluzione convergente, evoluzione divergente;<br />
fattori che condizionano la speciazione- Un esempio di microevoluzione: Biston Betularia-<br />
Macroevoluzione: prova embriologica del collegamento evolutivo fra le varie classi di Vertebrati;<br />
“fossili viventi”( Dipnoi, Necturus)- Il neodarwinismo e la teoria sintetica dell’evoluzione- Cenno<br />
alla genetica di popolazione( definizione di popolazione e di pool genico,fonti <strong>della</strong> variabilità<br />
genetica la deriva genetica)-<br />
Savona,<strong>15</strong> <strong>maggio</strong> 2013<br />
Laura Bragantini<br />
30
Indirizzo Scienze sociali, Socio-Sanitario<br />
Classe V sez. E A.S. 20<strong>12</strong>/2013<br />
--- PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA ---<br />
GLI ORGANI COSTITUZIONALI<br />
- Il Parlamento<br />
- Il Governo<br />
- Il Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
- La Magistratura<br />
- La Corte costituzionale<br />
Docente: Prof. Sandro Jeri<br />
DIRITTO<br />
ECONOMIA POLITICA<br />
NOZIONI ECONOMICHE ESSENZIALI RECUPERATE<br />
- I sistemi economici: generalità<br />
- Il sistema economico capitalista<br />
- Il sistema economico collettivista<br />
- Il sistema misto<br />
- L’attività economica<br />
- I soggetti economici<br />
- I fattori <strong>della</strong> produzione<br />
- Il mercato: nozione, il punto di equilibrio<br />
NOZIONI DI MACROECONOMIA<br />
- La Contabilità Nazionale<br />
- Il P.I.L.<br />
- La domanda e l’offerta globali<br />
- keynes<br />
LE POLITICHE ECONOMICHE<br />
- La politica economica<br />
- La spesa pubblica nella teoria keynesiana<br />
- Il finanziamento <strong>della</strong> spesa pubblica<br />
3 – APPROFONDIMENTI (nelle lezioni di compresenza)<br />
31
- La crisi economica mondiale del 1929 e la teoria generale di Keynes<br />
Obbiettivi di apprendimento programmati:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Conoscenza degli aspetti fondamentali e comprensione <strong>della</strong> ratio degli istituti giuridicocostituzionali<br />
ed economici del nostro ordinamento, al fine di utilizzare le nozioni apprese come<br />
strumenti applicabili alle varie e mutevoli situazioni che si presenteranno nella vita quotidiana.<br />
Capacità di cogliere l'evoluzione storica delle regole giuridiche in rapporto all'evoluzione <strong>della</strong><br />
società.<br />
Capacità di individuare la rilevanza giuridica di fatti ed atti <strong>della</strong> vita quotidiana e delle diverse<br />
formazioni operanti <strong>della</strong> società.<br />
Capacità di consultare le fonti di cognizione del diritto.<br />
Capacità di esporre con un linguaggio tecnico-giuridico i concetti appresi.<br />
Metodologia:<br />
Lezione frontale integrata con procedure atte a favorire l'intervento dei singoli componenti <strong>della</strong><br />
classe, sia attraverso la rappresentazione di esperienze individuali, familiari e scolastiche<br />
collegate ai problemi giuridici affrontati, sia attraverso la richiesta di approfondimenti e<br />
chiarimenti.<br />
Collegamenti e richiami storici in particolare alla legislazione a partire dalla seconda metà<br />
dell'Ottocento, per favorire la capacità di comprendere la ragione sociale e storica degli istituti<br />
giuridico-economici, e la capacità di collegamento con altre discipline.<br />
Mezzi e strumenti didattici:<br />
<br />
<br />
Libro di testo, semplificato<br />
Appunti annotati dagli allievi durante le lezioni, ad integrare e\o sintetizzare argomenti<br />
riportati dal testo di adozione.<br />
Obbiettivi raggiunti:<br />
Comprensione dei fondamenti degli specifici istituti del Diritto Costituzionale e <strong>della</strong><br />
Macroeconomia; acquisizione sia di un metodo di studio il più possibile organizzato e razionale, sia<br />
<strong>della</strong> capacità di sporre i concetti appresi in un linguaggio tecnico sufficientemente adeguato.<br />
La classe si presenta articolata su due livelli:<br />
alcuni allievi dotati di buone capacità personali, impegnati e partecipi, hanno acquisito un<br />
livello di valutazione pienamente discreto;<br />
tra gli altri che hanno, invece, conseguito una preparazione mediamente appena sufficiente,<br />
c'è chi ha approfondito <strong>maggio</strong>rmente alcune tematiche, reputate più interessanti.<br />
Libro di testo: “Fondamenti di diritto – economia”<br />
Collana diretta da Federico del Giudice<br />
a cura <strong>della</strong> Redazione Simone.<br />
Prof. Sandro Jeri<br />
32
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI<br />
“G. Della Rovere”<br />
Classe 5^ E<br />
DOCENTE: PATRIZIA MAIULLARI<br />
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA<br />
ANNO SCOLASTICO 20<strong>12</strong>/2013<br />
Libro di testo: “ Il Nuovo protagonisti e testi <strong>della</strong> filosofia”<br />
Ed. Paravia<br />
Vol. 2B - Vol. 3A e 3B<br />
Ore di lezione effettuate<br />
82 di cui 19 compresenza<br />
Prerequisiti<br />
• Conoscenza e comprensione dei problemi <strong>della</strong> filosofia<br />
• Conoscenza e comprensione dell’atmosfera filosofico - scientifica di razionalismo ed empirismo<br />
• Capacità di leggere e comprendere più tipologie testuali<br />
• Capacità di analisi di un testo<br />
• Capacità di prendere appunti e di rielaborarli con organicità, coerenza e pertinenza<br />
• Capacità elementare di valutare un argomento razionale<br />
• Capacità di esporre un pensiero con coerenza e pertinenza<br />
• Capacità di produrre una rielaborazione autonoma con coerenza e pertinenza<br />
Obiettivi minimi<br />
• Collocare storicamente gli autori affrontati<br />
• Sintetizzare il pensiero e il problema negli aspetti rilevanti<br />
• Focalizzare i nuclei teorici delle diverse posizioni<br />
• Utilizzo di un linguaggio specifico<br />
Obiettivi<br />
• Capacità di problematizzare conoscenze, idee e credenze attraverso il riconoscimento <strong>della</strong> loro storicità<br />
• Collocare storicamente gli autori affrontati e contestualizzare i testi analizzati<br />
• Focalizzare i nuclei teorici delle diverse posizioni<br />
• Analizzare e confrontare le diverse soluzioni proposte al problema individuando lo schema argomentativo<br />
( distinguere le tesi e i motivi a supporto)<br />
• Sintetizzare il problema negli aspetti rilevanti (sia in forma orale che scritta)<br />
• Acquisire un linguaggio specifico e avviare all’utilizzo del lessico filosofico<br />
• Analizzare il problema, conferendogli una dimensione storico-sociale<br />
Metodologia<br />
• Lezioni frontali<br />
• Discussioni guidate<br />
• Lettura individuale, collettiva o di gruppo di testi filosofici (opere o sezioni di opere)<br />
• Visione di film o filmati significativi per esplicitare le problematiche proposte<br />
Mezzi e strumenti<br />
• Libro di testo<br />
• Testi filosofici specifici (opere o sezioni di opere)<br />
• Appunti dell’insegnante<br />
33
• Materiali audiovisivi<br />
Valutazioni e osservazioni<br />
• Scritte : Prove scritte a risposta sintetica<br />
Simulazioni di terze prove<br />
• Orali : Sondaggio su domande specifiche<br />
Colloqui<br />
Griglia di valutazione con riferimento ai criteri di valutazione<br />
• Comprensione e conoscenza dei contenuti<br />
• Capacità espositiva<br />
• Capacità di analisi e di sintesi<br />
• Utilizzo di un linguaggio specifico<br />
• Capacità di stabilire collegamenti all’interno <strong>della</strong> disciplina e a livello interdisciplinare<br />
• Capacità di rielaborare autonomamente e criticamente le problematiche affrontate<br />
Criteri per la corrispondenza tra voti elivelli di conoscenza/capacità<br />
Livello Voto Obiettivi<br />
Nullo 2 Non perseguiti<br />
Grav.insuff. 3 Perseguiti in modo superficiale e limitato<br />
Insuff. 4/5 Perseguiti in modo superficiale<br />
Suff. 6 Perseguiti<br />
Discreto 7 Perseguiti in modo quasi completo<br />
Buono 8 Perseguiti in modo completo<br />
Distinto 9 Perseguiti “ “ e approfondito<br />
Ottimo 10 Perseguiti in modo approfondito e con apporti<br />
personali<br />
Nella valutazione periodica verranno presi in considerazione la disponibilità a partecipare al proprio percorso didattico e<br />
l’impegno nell’approccio sistematico, scientifico, personale e originale alla disciplina.<br />
Modalità di recupero<br />
• In itinere e nel tempo curricolare sono stati dedicati momenti e opportunità di recupero individuali, secondo<br />
l’articolazione oraria concordata a livello di Consiglio di Classe e secondo le esigenze dell’insegnante<br />
vengono concordati incontri pomeridiani con i ragazzi che lo richiedono.<br />
Contenuti<br />
Modulo 1: Kant e il suo programma<br />
1. I limiti del razionalismo e dell’emprirismo<br />
2. Concetti fondamentali <strong>della</strong> filosofia Kantiana: criticismo, trascendentale, rivoluzione copernicana, fenomeno,<br />
noumeno, giudizi sintetici a priori, io penso e schematismo trascendentale, imperativo categorico, sentimento<br />
del bello e del sublime…<br />
3. Il problema <strong>della</strong> conoscenza: La Critica <strong>della</strong> ragion pura<br />
• Estetica trascendentale<br />
• Analitica trascendentale<br />
• Dialettica trascendentale<br />
4. l problema <strong>della</strong> morale: La Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
34
• Realtà e assolutezza <strong>della</strong> legge morale<br />
• Imperativo categorico<br />
• Formalità <strong>della</strong> legge e dovere kantiano<br />
• Rivoluzione copernicana morale<br />
• Postulati pratici<br />
• Primato <strong>della</strong> ragion pratica<br />
5. Il problema dell’estetica: La Critica del Giudizio<br />
• Analisi del bello e caratteri del giudizio estetico<br />
• Universalità del giudizio estetico<br />
• Rivoluzione copernicana estetica<br />
• Il sublime e il bello<br />
• Giudizio teleologico e il finalismo connaturato alla nostra mente<br />
6. La storia e la politica<br />
Modulo 2: Verso l’idealismo Hegeliano<br />
1. I concetti fondamentali dell’idealismo: l’Infinito, l’Assoluto, il processo dialettico scandito in tesi, antitesi e<br />
sintesi, la Fenomenologia dello Spirito…<br />
2. I capisaldi <strong>della</strong> filosofia hegeliana<br />
3. La Fenomenologia dello Spirito:<br />
• Coscienza, autocoscienza e ragione<br />
• Spirito, religione e sapere assoluto<br />
4. La Logica<br />
5. La Filosofia <strong>della</strong> natura<br />
6. La Filosofia <strong>della</strong> Storia<br />
7. Lo Spirito soggettivo<br />
8. Lo Spirito oggettivo<br />
9. Lo Spirito Assoluto<br />
Modulo 3: La reazione all’idealismo<br />
1. Schopenhauer:<br />
Il mondo come rappresentazione: il velo di Maya, la scoperta <strong>della</strong> via di accesso alla cosa in sè<br />
Il mondo come volontà di vivere<br />
Il dolore <strong>della</strong> vita: il pessimismo<br />
Le vie di liberazione dal dolore attraverso la noluntas: l’arte, l’etica <strong>della</strong> pietà e l’ascesi<br />
2. Kierkegaard e la fede come paradosso:<br />
Nuclei fondamentali del suo pensiero<br />
Le categorie dell’esistenza: la singolarità, la scelta, la possibilità, l’angoscia, la disperazione e la fede<br />
La scelta e gli stadi dell’esistenza: stadio estetico, etico e religioso<br />
Modulo 4: La sinistra hegeliana<br />
1. Marx oltre Feuerbach: dall’alienazione religiosa all’alienazione economico-politica<br />
La critica del misticismo logico di Hegel<br />
La critica <strong>della</strong> civiltà moderna e del liberalismo; emancipazione politica e umana<br />
La critica dell’economia borghese (alienazione)<br />
Il materialismo storico tra lavoro, struttura e sovrastruttura, dialettica <strong>della</strong> storia<br />
L’analisi e la critica dello Stato borghese<br />
(Argomento trattato anche nelle Scienze Sociali)<br />
Modulo 5: Crisi <strong>della</strong> modernità e nuovi modelli di razionalità, demistificazione delle illusioni <strong>della</strong> tradizione<br />
1. Nietzsche e il pensiero <strong>della</strong> crisi<br />
La decadenza del presente e l’epoca tragica dei Greci<br />
Apollo e Dioniso<br />
Morte <strong>della</strong> tragedia e nascita <strong>della</strong> filosofia<br />
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche<br />
Il metodo genealogico<br />
L’oltre-uomo e l’eterno ritorno<br />
La tra svalutazione dei valori<br />
La volontà di potenza<br />
Il problema del nichilismo<br />
2. Freud e la rivoluzione psicoanalitica ( argomento trattato anche nelle Scienze Sociali)<br />
35
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi<br />
L’inconscio e i metodi per accedervi<br />
La struttura <strong>della</strong> psiche<br />
La nevrosi e la terapia psicoanalitica: sogni, atti mancati e sintomi nevrotici<br />
La teoria <strong>della</strong> sessualità e il complesso edipico<br />
La religione e la civiltà<br />
Modulo 6: L’analisi <strong>della</strong> condizione umana nelle filosofie dell’esistenza<br />
1. L’esistenzialismo: le radici e i nuclei fondamentali<br />
2. L’analisi dell’esistenza in Heidegger :<br />
Essere ed esistenza<br />
L’essere nel mondo<br />
L’esistenza inautentica<br />
L’esistenza autentica<br />
La temporalità dell’esserci<br />
L’incompiutezza di Essere e tempo<br />
Durante le compresenze sono stati approfonditi alcuni argomenti di natura interdisciplinare tra<br />
Filosofia e Scienze Sociali, attraverso la lettura di testi tratti da opere di alcuni autori ritenuti di<br />
significativa importanza.<br />
Un modulo di compresenza è stato dedicato al tema <strong>della</strong> Bioetica<br />
( Per quanto riguarda la specificazione di temi e testi si rimanda al Programma di Scienze Sociali)<br />
L’insegnante<br />
…………………………………………………………………….<br />
I rappresentanti di classe<br />
…………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………<br />
36
MATEMATICA<br />
CLASSE 5^E LICEO SCIENZE SOCIALI - SOCIOSANITARIO<br />
Insegnante: prof. Cristina Macco<br />
Unità orarie di lezione effettuate nell’anno scolastico 20<strong>12</strong>/2013: n. 83 unità su 90 previste dal<br />
piano di studi (entro il <strong>15</strong> <strong>maggio</strong>)<br />
Obiettivi programmati<br />
• la conoscenza e l’utilizzo di tecniche e procedure relative a limiti e derivate;<br />
• il rigore espositivo e l’uso corretto del lessico del simbolismo specifico;<br />
• la capacità di affrontare semplici situazioni problematiche di varia natura utilizzando<br />
consapevolmente metodi, strumenti e modelli matematici in ambiti diversi potenziando le<br />
capacità di astrazione e di formalizzazione;<br />
• lo sviluppo <strong>della</strong> capacità di ragionamento coerente e argomentato;<br />
• il potenziamento delle capacità di analisi e sintesi.<br />
Obiettivi conseguiti<br />
Ho questa classe dalla 1^ e alla fine del quinto anno insieme mi sento di poter fare un bilancio,<br />
sicuramente molto positivo per un ristretto numero di alunni che ho visto crescere e maturare nel<br />
corso degli anni, ma mi sento anche di evidenziare le difficoltà incontrate, per motivi diversi, con<br />
alcuni alunni.<br />
Molti allievi non hanno dedicato un impegno adeguato per migliorare la propria preparazione, a<br />
partire dalla partecipazione alle lezioni che, per un certo numero di essi, avrebbe dovuto essere più<br />
attenta, assidua e soprattutto motivata.<br />
Spesso mi è sembrato di lavorare solo con una parte di alunni perché la classe risulta spaccata in<br />
due sia per l’impegno a scuola e a casa, che per i risultati.<br />
I problemi di concentrazione ed apprendimento, hanno portato alcuni componenti la classe ad un<br />
uno studio puramente mnemonico <strong>della</strong> matematica. Alcuni alunni risultano pertanto conoscere<br />
parte del programma svolto in modo approssimativo.<br />
Per fortuna in alcuni casi ho assistito ad uno sforzo continuo nell’affrontare lo studio di una materia<br />
ritenuta all’inizio quasi incomprensibile.<br />
Le molte assenze, talvolta strategiche, hanno rallentato lo svolgimento del programma. Lo stesso è<br />
successo per i molteplici impegni, decisi dal consiglio di classe, che sono troppo spesso caduti però<br />
il venerdì, giorno in cui avevo le due ore consecutive di lezione.<br />
La preparazione di base <strong>della</strong> classe risulta quindi non completamente omogenea ma generalmente<br />
sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:<br />
• la capacità di classificare una funzione e di determinare il campo di esistenza delle funzioni<br />
algebriche;<br />
• la conoscenza dei termini (dominio o campo di esistenza, codominio, simmetrie, zeri di una<br />
funzione, limiti, asintoti,derivata, continuità, crescenza, concavità), delle regole e delle<br />
tecniche per calcolare limiti e derivate;<br />
• la capacità di calcolare semplici limiti che si presentano nelle forme indeterminate introdotte<br />
∞ 0<br />
( ∞ − ∞; ; ); ∞ 0<br />
37
• la capacità di analizzare l’andamento del grafico di una funzione, valutando gli elementi di<br />
continuità e di tendenza;<br />
• la capacità di applicare le regole di derivazione in semplici esercizi.<br />
E’ opportuno osservare che lo studio di funzione è stato svolto relativamente alle sole funzioni<br />
razionali intere o fratte e che i teoremi inerenti il programma sono stati enunciati (senza<br />
dimostrazione).<br />
Per facilitare lo studio <strong>della</strong> materia sono stati utilizzati prevalentemente due accorgimenti:<br />
• i risultati nelle verifiche sono stati quasi sempre numeri interi o comunque non contenenti<br />
radicali;<br />
• le disequazioni o equazioni sono state quasi sempre di 1° o 2° grado.<br />
Metodo di insegnamento<br />
I vari temi sono stati introdotti in forma problematica, partendo soprattutto da situazioni adeguate<br />
sia al livello delle esperienze conoscitive degli allievi sia alle loro precedenti conoscenze.<br />
Le lezioni sono state proposte con lezione frontale.<br />
Il consolidamento delle conoscenze si è attuato attraverso esercizi svolti in classe o assegnati per<br />
compito e successivamente corretti in classe.<br />
Per favorire le diverse modalità di apprendimento presenti all’interno <strong>della</strong> classe e per aiutare la<br />
visualizzazione dei concetti proposti è stato molto spesso utilizzato il colore il cui uso è stato<br />
permesso anche nelle verifiche. Per lo stile di scrittura nelle verifiche non è stato utilizzato il Times<br />
New Roman per la <strong>maggio</strong>r difficoltà riscontrata dagli alunni DSA (stili utilizzati Arial o Verdana).<br />
Mezzi e strumenti di lavoro<br />
Libro di testo adottato: Bergamini Trifone Barozzi Corso base verde di matematica volume 4<br />
PLUS Zanichelli<br />
Strumenti di verifica<br />
Il controllo del processo di apprendimento è avvenuto attraverso:<br />
1. l’osservazione sistematica dei comportamenti <strong>della</strong> classe e dei singoli alunni;<br />
2. la registrazione puntuale degli interventi, atta stimolare un attivo coinvolgimento<br />
dell’alunno;<br />
3. interrogazioni orali, importanti per controllare anche le capacità espositive, per chiarire<br />
eventuali dubbi e per comprendere il processo logico seguito nell’applicazione e nella<br />
rielaborazione dei contenuti;<br />
4. prove scritte di vario tipo: quesiti a risposta singola, verifiche tradizionali, verifiche di<br />
recupero.<br />
Le valutazioni assegnate hanno spesso tenuto conto dell’impegno volto a superare le naturali<br />
difficoltà per la matematica da parte di alcuni alunni; a questo proposito bisogna considerare che<br />
l’indirizzo <strong>della</strong> scuola non è di tipo prettamente scientifico e perciò occorre evidenziare gli<br />
innegabili progressi che alcuni allievi hanno compiuto nel corso dell’anno.<br />
La scala decimale usata è stata da 2 a 10 (il 2 è stato utilizzato per prove lasciate in bianco oppure<br />
quando gli allievi si sono rifiutati di farsi interrogare).<br />
La prova è stata valutata in modo sufficiente quando gli allievi ne hanno svolto correttamente<br />
almeno il 51%.<br />
Le prove di verifica proposte nel corso dell’anno prevedevano domande di diversa tipologia alle<br />
quali veniva attribuito un peso differente in relazione alle difficoltà.<br />
38
Contenuti<br />
Unità 1<br />
Ripasso programma degli anni precedenti<br />
Equazioni di 2° grado, disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte, sistemi di disequazioni, sistemi<br />
di equazioni, disequazioni di grado <strong>maggio</strong>re del 2° riconducibili a disequazioni di 2° grado<br />
utilizzando il raccoglimento a fattor comune totale.<br />
Unità 2<br />
Funzioni reali di variabile reale<br />
Rappresentazione di intervalli nell’insieme dei numeri reali. Concetto di funzione. Dominio e<br />
condominio di una funzione.<br />
Classificazione delle funzioni: algebriche (razionali ed irrazionali) intere e fratte, cenni alle funzioni<br />
trascendenti.<br />
Ricerca del dominio di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali e trascendenti.<br />
Simmetrie delle funzioni: funzioni pari e dispari. Segno di una funzione.<br />
Unità 3<br />
Limiti e continuità<br />
Limiti delle funzioni numeriche reali. Concetto intuitivo di limite di una funzione: f ( x) l<br />
lim = (nei<br />
x → a<br />
vari casi: l ed a finiti, l finito ed a infinito, l infinito ed a finito, l ed a infiniti), limite destro e limite<br />
sinistro, operazioni sui limiti: somma, differenza, prodotto e quoziente (senza dimostrazione),<br />
∞ 0<br />
calcolo di limiti nelle forme indeterminate del tipo: ∞ − ∞; ; . ∞ 0<br />
Funzioni continue. Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo. Punti di<br />
discontinuità di una funzione e classificazione dei punti di discontinuità. Ricerca degli asintoti di<br />
una funzione: asintoti orizzontali, verticali e obliqui.<br />
Unità 4<br />
Derivate e calcolo differenziale<br />
Definizione e significato geometrico <strong>della</strong> derivata. Derivata di alcune funzioni elementari:<br />
n<br />
f x = k, f x = x, f x = x con n ∈ Ν, f x =<br />
( ) ( ) ( ) ( ) x<br />
x<br />
( x) = ln x,<br />
f ( x) = e , f ( x) = sin x,<br />
f ( x) = cos x .<br />
f<br />
Le operazioni relative alla derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione,<br />
derivata <strong>della</strong> somma di due funzioni, derivata <strong>della</strong> differenza di due funzioni, derivata del<br />
quoziente di due funzioni.<br />
Applicazioni allo studio di una funzione: esistenza di punti di massimo e minimo relativi ed assoluti<br />
e di punti di flesso a tangente orizzontale.<br />
Cenni alla derivata seconda ed all’applicazione nello studio di funzione.<br />
Unità 5<br />
Studio delle funzioni e loro diagramma<br />
Schema generale per lo studio di una funzione e relativo diagramma. Studio delle funzioni<br />
algebriche razionali intere e fratte. Applicazioni allo studio di una funzione: massimi e<br />
minimi assoluti e relativi. Analisi del grafico di una funzione valutando continuità e limiti<br />
negli estremi del dominio<br />
39
MATEMATICA<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA<br />
1 Dimostra di possedere una conoscenza degli argomenti<br />
completa, accompagnata da una rielaborazione concettuale<br />
rigorosa e da una ottima padronanza del linguaggio specifico<br />
2 Dimostra di possedere una conoscenza completa degli<br />
argomenti, che espone in modo chiaro e con linguaggio<br />
specifico adeguato<br />
3 Dimostra di possedere una conoscenza abbastanza ampia<br />
degli argomenti proposti, nonostante leggere imprecisioni di<br />
linguaggio e qualche errore od omissione non gravi<br />
4 Dimostra di conoscere gli elementi essenziali degli argomenti<br />
proposti, con qualche imprecisione di linguaggio e/o qualche<br />
lacuna<br />
5 Pur conoscendo gli elementi essenziali degli argomenti<br />
proposti, commette qualche errore ed espone con linguaggio<br />
approssimato<br />
6 Dimostra di possedere una conoscenza approssimata degli<br />
argomenti proposti e commette errori concettuali<br />
7 La conoscenza degli argomenti è lacunosa e scorretta, con<br />
prevalenza di oscurità o errori<br />
14-<br />
<strong>15</strong><br />
13<br />
11-<br />
<strong>12</strong><br />
10<br />
8-9<br />
6-7<br />
3-4-<br />
5<br />
8 La conoscenza degli argomenti è pressoché nulla 1-2<br />
9 Le domande hanno uguale punteggio ciascuna punti 5<br />
VOTO<br />
Savona <strong>15</strong>/05/2013<br />
Cristina Macco<br />
40
EDUCAZIONE FISICA<br />
Docente: Angela Altomare<br />
Testo adottato: “Per vivere in perfetto equilibrio” di Del Nista, Parker, Tasselli Ed. D’Anna<br />
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 20<strong>12</strong>/2013<br />
n. ore 42 su n. ore 60 previste dal piano di studi (entro il <strong>15</strong> <strong>maggio</strong>)<br />
Obiettivi conseguiti:<br />
Gli obiettivi sottoelencati risultano conseguiti dagli alunni più motivati e desiderosi di apprendere.<br />
Sono stati parzialmente conseguiti da quelli che hanno dimostrato scarso interesse e impegno<br />
settoriale:<br />
- Hanno consapevolezza del percorso da effettuare per conseguire il miglioramento<br />
delle capacità di resistenza, forza, velocità e mobilità.<br />
- Sanno coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.<br />
- Sanno utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse<br />
esperienze e ai vari contenuti tecnici.<br />
- Sanno organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati.<br />
Contenuti:<br />
- Stretching: conoscenza delle posizioni ed esecuzione dei principali esercizi di allungamento<br />
- Attività sportive di squadra: pallavolo - pallacanestro<br />
- Percorso misto comprendente i gesti tecnici acquisiti e tutti i grandi attrezzi usati nel corso<br />
del triennio<br />
• ARGOMENTI TEORICI :<br />
La resistenza muscolare<br />
La forza<br />
Energia muscolare<br />
Metodi<br />
La metodologia è stata basata sull’organizzazione di attività “in situazione”. Spesso si è ricorsi<br />
al metodo analitico specialmente per l’apprendimento delle diverse tecniche dei gesti sportivi.<br />
Si è sempre seguito il criterio <strong>della</strong> gradualità nella progressione di lavoro e sulla continua indagine,<br />
individuazione e correzione autonoma dell’errore. In diverse attività si è cercato di dare spazio al<br />
contributo creativo e di elaborazione di ciascun allievo, nella progettazione, organizzazione e<br />
realizzazione dei percorsi operativi da adottare.<br />
Per ciò che riguarda le informazioni sulla teoria del movimento si sono individuati i temi più<br />
importanti che sono stati sviluppati con l’ausilio del libro di testo e ricerche on-line.<br />
Il tipo di lezione più comunemente utilizzata è stata quella frontale per ciò che ha riguardato i<br />
contenuti teorici e la lezione “stimolo” per la parte pratica.<br />
Tempi:<br />
Mediamente ogni modulo pratico ha avuto una durata di circa 8/10 ore<br />
Valutazione:<br />
L’Educazione Fisica è una disciplina operativa che coinvolge e mette in gioco tutta la persona<br />
dell’alunno e le prestazioni di carattere cognitivo che essa può richiedere devono essere funzionali a<br />
questa sua peculiarità.<br />
Conseguentemente la valutazione deve tenere conto <strong>della</strong> situazione iniziale dello studente ed è<br />
basata sulla continua e sistematica osservazione e verifica da parte dell’insegnante.<br />
41
Liceo Statale “G. Della Rovere” - Savona<br />
ESAME DI STATO 2013<br />
Classe 5 sez. E<br />
Materia: Francese<br />
Prof. Alessandra Cerruti<br />
Presentazione <strong>della</strong> classe<br />
La classe è composta da 17 alunni (3 ragazzi e 14 ragazze). La frequenza è stata nel complesso<br />
piuttosto regolare, il comportamento corretto, l’atteggiamento aperto e abbastanza collaborativo.<br />
Per quanto concerne la partecipazione al dialogo educativo e i risultati conseguiti, alcuni allievi,<br />
dotati di buone potenzialità e impegno, hanno ottenuto un profitto di livello medio-alto; altri<br />
studenti si sono dimostrati meno interessati ed attivi e, nonostante i risultati comunque sufficienti,<br />
non hanno espresso appieno le loro possibilità; un gruppo ristretto di allievi è riuscito solo in parte a<br />
superare le difficoltà di base e a conseguire gli obiettivi minimi.<br />
Programma svolto(e/o da svolgere entro il 03/06/2013)<br />
Libri di testo<br />
BELLANO, GHEZZI, Palmarès 2, LANG<br />
VIETRI, Fiches de grammaire, EDISCO<br />
MOURLHON-DALLIES, TOLAS, Santé-médicine.com, CLE International<br />
1. Revisione e consolidamento delle strutture linguistiche, lessico e morfosintassi (in particolare<br />
uso dei modi e tempi verbali)<br />
2. Dal testo Santé-médicine.com:<br />
Comment ça va?<br />
Patients et médecins<br />
Les médicaments<br />
L’hôpital<br />
Profession infirmière<br />
3. Civilisation:<br />
Les Institutions françaises<br />
Les nouveaux défis de la société française<br />
Les atouts de la France<br />
Approfondissements personnels des élèves sur des sujets d’actualité<br />
Strumenti e metodi didattici<br />
Strumenti: libri di testo e fotocopie da altri testi e/o documenti autentici; materiale audiovisivo e<br />
supporti multimediali.<br />
Metodologie prevalenti: lezione frontale e lezione interattiva; lavoro di gruppo e individuale.<br />
42
Obiettivi disciplinari (realmente raggiunti)<br />
Al termine dell’anno tutti gli allievi sono in grado di comprendere con sufficiente sicurezza<br />
contenuti e aspetti formali di testi scritti di qualsiasi tipo, così come il significato generale di<br />
messaggi orali di varia natura e origine. Un buon numero di allievi riesce a comunicare oralmente<br />
su argomenti conosciuti, con coerenza logica e sufficiente correttezza formale, di intonazione e<br />
pronuncia. La produzione di testi scritti adeguati alle richieste, con correttezza linguistica e<br />
coerenza espositiva è un obiettivo che crea ancora qualche difficoltà ad alcuni allievi, soprattutto<br />
per quanto concerne l’aspetto <strong>della</strong> correttezza ortografica e grammaticale.<br />
I risultati generalmente conseguiti sono da dirsi soddisfacenti, considerato anche il monte ore<br />
settimanale (2 moduli da 50 minuti), ulteriormente ridotto da cause contingenti (calendario<br />
scolastico, assenze dell’insegnante etc). Le ore effettivamente svolte sono state 53 su 66 previste.<br />
Strumenti di valutazione<br />
Tipologia delle prove<br />
Interrogazioni orali 3<br />
Comprensioni scritte/analisi del testo 2<br />
Tipologia B 2<br />
Esercizi (grammatica, lessico etc) 2<br />
Criteri di valutazione (specifici per la disciplina)<br />
Numero degli interventi<br />
Indicatori per la valutazione delle prove scritte<br />
Sono ritenuti validi in generale per la valutazione di una prova di produzione scritta<br />
- Comprensione del testo e/o delle richieste.<br />
- Conoscenza ed acquisizione dei contenuti.<br />
- Correttezza grammaticale e formale.<br />
- Uso di un lessico appropriato.<br />
- Coesione e fluidità dell’esposizione.<br />
- Capacità di collegare i contenuti e di rielaborarli in modo personale.<br />
Indicatori per la valutazione delle orali.<br />
Sono ritenuti validi in generale per il colloquio<br />
Padronanza <strong>della</strong> terminologia specifica.<br />
Chiarezza e correttezza dell’esposizione.<br />
Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento.<br />
Capacità di esprimere giudizi personali.<br />
Savona, 6 <strong>maggio</strong> 2013<br />
Firma del docente:<br />
43
Materia: SCIENZE SOCIALI<br />
Prof. Maurizio Ghio<br />
testi in uso Biblioteca di scienze sociali, vol. 7, 8, 9, 10 di Adele Bianchi e Parisio Di<br />
Giovanni, PARAVIA.<br />
Materiali didattici<br />
Uso del testo-manuale<br />
Dispense integrative<br />
Fonti e/o classici<br />
Uso degli appunti<br />
Utilizzo del computer e delle tecnologie informatiche<br />
Biblioteca<br />
Metodologie prevalenti<br />
- Lezione frontale di tipo classico sui contenuti programmatici, con l’utilizzo <strong>della</strong> lavagna per<br />
esemplificazioni, mappe concettuali e schematizzazioni riassuntive.<br />
- Discussione-dibattito su argomenti di attualità, o su proposte degli studenti, concernenti la<br />
programmazione.<br />
- Lezione dialogata: costruita attraverso un dialogo guidato in cui si utilizzano le<br />
conoscenze di base dello studente.<br />
- Analisi-commento di testi : si faranno letture, concernenti i contenuti programmatici, di<br />
autori classici o di attualità, e si forniranno agli studenti modelli interpretativi.<br />
- Laboratorio : si richiederà l’applicazione pratica dei contenuti<br />
studiati.<br />
Le competenze in uscita saranno le seguenti in termini generali<br />
- Passaggio da una visione ingenua a approssimativa dei “fatti sociali” (elaborata solo nei<br />
termini del “senso comune”) all’assunzione del “punto di vista” specifico delle discipline.<br />
- Acquisizione dell’idea di “scienza” applicata ai fatti sociali e problematizzazione del<br />
concetto di “scientificità”.<br />
- Acquisizione di un lessico elementare <strong>della</strong> disciplina<br />
- Identificazione dell’origine storica delle scienze sociali con semplici riferimenti alle correnti<br />
teoriche più importanti<br />
- Conoscenza di alcune nozioni di base sui processi psichici, sensibilizzando attraverso di esse<br />
alla complessità <strong>della</strong> persona sotto l’aspetto funzionale e relazionale<br />
- Conoscenza di alcuni fondamenti metodologici e lessicali delle discipline per saper decodificare<br />
messaggi e contenuti linguistici in ambito socio-psicologico.<br />
- Conoscenza di alcune nozioni di base sui processi sociali, sul pensiero sociale, e sull’interazione<br />
sociale sensibilizzando alla complessità <strong>della</strong> società<br />
- Capacità di applicare i contenuti appresi, di utilizzare le metodologie di ricerca, di progettare<br />
Studi e ricerche nell’ambito delle scienze sociali.<br />
- Sensibilizzazione alle diversità culturali e sociali<br />
- Capacità di cogliere criticamente ed analizzare un fenomeno sociale in ambito socioantropologico<br />
44
Obiettivi trasversali, formativo-affettivi, cognitivi. Faccio riferimento a quanto determinato dal<br />
Dipartimento, dal Consiglio di classe e dal POF.<br />
Obiettivi disciplinari. In relazione alla programmazione curricolare saranno conseguiti i seguenti<br />
obiettivi in termini di conoscenze/contenuti:<br />
Modulo 1: La Politica<br />
U.D. 1: Lo studio <strong>della</strong> politica nelle scienze sociali<br />
I diversi approcci all’oggetto “Politica”<br />
Definizione <strong>della</strong> politica<br />
Il potere politico<br />
Sociologia politica: Tocqueville, Marx, Weber.<br />
Antropologia politica: le forme di organizzazione politica non statali.( Morgan, Evans-Pritchard)<br />
Scienza politica: il sistema politico (T.Parsons, D.Easton)<br />
Geografia politica: posizione, dimensioni, morfologia del territorio.<br />
Psicologia politica: Politica e Personalità (Lasswell, Adorno).<br />
U.D. 2: Lo Stato<br />
Che cos’è lo stato<br />
Sottomissione allo stato<br />
Stati moderni e stati tradizionali<br />
Origine dello stato<br />
Espansione, sviluppo e crisi dello stato<br />
U.D. 3: I regimi non democratici<br />
Il Totalitarismo<br />
Ideologia totale e mito<br />
Critiche al concetto di totalitarismo<br />
L’autoritarismo<br />
Regimi di dominio personale<br />
Regimi post-totalitari<br />
L’obbedienza all’autorità<br />
U.D. 4: I regimi democratici<br />
Che cos’è la democrazia<br />
Tipologie di democrazia<br />
Democratizazione e sviluppo economico<br />
Critiche alla democrazia<br />
La posizione di K.Popper sulla democrazia<br />
U.D. 5: Comunicazione Politica<br />
- Influenza <strong>della</strong> <strong>maggio</strong>ranza e <strong>della</strong> minoranza<br />
- Il fenomeno del populismo<br />
Modulo 2: Psicologia dello sviluppo<br />
U.D. 1 Psicologia dello sviluppo e dell’arco di vita<br />
U.D. 2 Sviluppo del linguaggio<br />
- Le tappe dell’acquisizione del linguaggio<br />
- Lo sviluppo dell’uso del linguaggio<br />
- Lo sviluppo <strong>della</strong> comunicazione<br />
- Meccanismi di sviluppo<br />
- Codice elaborato e codice ristretto [Bernstein]<br />
U.D. 3 Sviluppo Cognitivo<br />
- Lo sviluppo cognitivo [Piaget]<br />
- Il rapporto tra pensiero e linguaggio<br />
45
U.D. 4 Sviluppo <strong>della</strong> personalità<br />
- Erikson: psicologia dell’arco di vita<br />
- L’adolescenza<br />
Modulo 3: Socializzazione e Formazione<br />
U.D. 1 Socializzazione<br />
- Il termine socializzazione nella tradizione occidentale<br />
- Il processo di socializzazione<br />
- Socializzazioni devianti: come si diventa consumatori di marijuana.<br />
- Tipi di socializzazione:<br />
a) Primaria, anticipatoria, secondaria<br />
b) Risocializzazione: i prigionieri dei lager nazisti, la psicoterapia<br />
c) Socializzazione alla rovescia<br />
U.D. 2 Agenzie di socializzazione<br />
- Famiglia<br />
- Scuola<br />
- Mass media<br />
- Gruppo di pari<br />
U.D. 3 La formazione<br />
- Formazione, socializzazione, educazione<br />
- Le azioni formative<br />
- Il processo formativo<br />
- Apprendimento e formazione<br />
- La motivazione<br />
- Intelligenza e creatività<br />
Modulo 4: La società globale<br />
U.D.1: I Media e la loro influenza<br />
- Definizione dei media<br />
- L’influenza dei media<br />
- I primi studi: Toqueville, La democrazia in America<br />
- Lippmann: la realtà mediata<br />
- Lasswell: la bullet theory<br />
- La scuola di Yale<br />
- La scuola di Lazarsfeld<br />
- Lewin: i tagli di carne<br />
- La svolta cognitiva<br />
- Approcci teorici ai mass media:<br />
a) Funzionalismo<br />
b) Teorie critiche: la scuola di Francoforte<br />
c) Althusser: teoria <strong>della</strong> riproduzione socio-culturale<br />
d) McLuhan: il villaggio globale<br />
- L’immagine <strong>della</strong> donna in televisione<br />
U.D. 2 :Nuovi stili di vita nella società multiculturale<br />
- Società globale, Società multiculturale (Amselle: logiche meticce)<br />
- Pluralismo culturale e multiculturalismo<br />
- Margareth Mead e l’evoluzione delle forme di trasmissione culturale<br />
- Serge Latouche: la globalizzazione ed i suoi effetti<br />
U.D.3: L’educazione oltre la scuola<br />
- L’educazione degli adulti<br />
46
- L’educazione permanente<br />
- Ivan Illich: descolarizzare la società<br />
- Educazione interculturale<br />
Modulo 5: Freud e la Psicoanalisi<br />
U.D. 1: Sigmund Freud e la scoperta dell’inconscio<br />
Il clima storico ed accademico<br />
Dall’isteria alla scoperta dell’inconscio: il caso di Anna O.<br />
Caratteristiche dei contenuti inconsci<br />
U.D.2: Le interpretazioni <strong>della</strong> psiche<br />
-topica<br />
-dinamica<br />
-economica<br />
-strutturale<br />
U.D. 3: Lo sviluppo sessuale<br />
La teoria <strong>della</strong> libido<br />
- Fase orale<br />
- Fase anale<br />
- Fase fallica: complesso edipico ed identità<br />
- Fase di Latenza<br />
- Fase genitale<br />
U.D. 4: L’emergere dell’inconscio<br />
L’interpretazione dei sogni<br />
Psicopatologia <strong>della</strong> vita quotidiana: gli atti mancati ed il sorriso<br />
U.D. 5 La Metapsicologia<br />
Totem e Tabù: religione e civiltà<br />
Eros e Thanatos<br />
Psicoanalisi del genio: l’interpretazione psicoanalitica dell’arte<br />
Modulo 6: Compresenza con Filosofia<br />
U.D.1 Lettorato sullo schematismo trascendentale di Kant<br />
Gli a-priori <strong>della</strong> conoscenza<br />
Schemi cognitivi<br />
Schemi percettivi<br />
La processualità <strong>della</strong> conoscenza<br />
Il problema del codice del pensiero<br />
U.D. 2 Lettorato sulla Filosofia <strong>della</strong> Storia di Hegel<br />
La nascita dell’antropologia<br />
L’evoluzionismo antropologico<br />
La Globalizzazione<br />
Il ruolo dell’ambiente nell’antropologia e nella storia<br />
U.D. 3 Karl Popper<br />
Scienze e Pseudoscienze<br />
Il metodo di ricerca: Verificazionismo e Falsificazionismo<br />
La critica alle ideologie ed al totalitarismo<br />
L’elogio <strong>della</strong> democrazia<br />
La validità di una ricerca scientifica<br />
U.D. 4: Bioetica<br />
I principali problemi di bioetica<br />
47
DISCIPLINA :INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA<br />
A.S. 20<strong>12</strong>-2013<br />
Docente: Giovanni Vincalli<br />
Contenuti:<br />
L’uomo, elementi di antropologia cristiana (ottobre\novembre)<br />
La coscienza (dicembre\febbraio)<br />
La libertà (marzo)<br />
Un progetto per la vita. Uomo e natura, uomo ed economia. Temi di teologia<br />
morale e dottrina sociale. (aprile)<br />
Obiettivi raggiunti: Rapportarsi con la realtà per scoprire i valori morali e confronto con il<br />
messaggio cristiano<br />
Confrontare il personale progetto di vita con il modello cristiano.<br />
Sapere effettuare una corretta rielaborazione personale in vista di scelte responsabili.<br />
Maturare giudizi critici razionalmente fondati.<br />
In particolare: Obiettivo comune curare connessioni interdisciplinari, ma con particolare<br />
attenzione agli aspetti etico problematici piuttosto che culturali - storici.<br />
La classe 5 a E è caratterizzata, per la stragrande <strong>maggio</strong>ranza degli alunni<br />
avvalentisi, da un approccio con la materia ed i temi proposti, piuttosto vivace<br />
ed esigente. Si è cercato, pertanto, di offrire stimoli alla riflessione<br />
privilegiando il confronto diretto basato sul “vissuto” degli studenti<br />
valorizzandone le esperienze personali.<br />
In sintesi, devo rilevare che il rapporto con l’I.R.C. è stato piuttosto positivo. I ragazzi hanno<br />
risposto con interesse alle sollecitazioni che prevedeva il programma loro destinato. La figura<br />
dell’uomo, la sua dignità, la possibilità ed il diritto alle scelte fondamentali dell’esistenza, collegati<br />
all’uso di materiali multimediali adeguati, hanno generato una risposta attenta, critica e, debbio<br />
ammettere, anche, in alcuni casi, inaspettata. Solo in quest’ultimo scorcio d’anno scolastico, a causa<br />
dell’imminente esame di fine corso, le preoccupazioni ad esso collegate, hanno un poco allentato<br />
questo trend positivo. Posso comunque affermare che sono stati ampiamente raggiunti gli obiettivi<br />
che ci eravamo prefissati.<br />
Il rapporto con gli allievi, globalmente, è stato positivo: la ricerca del contatto diretto ed<br />
individuale è stata per me prioritaria. D'altronde l’esperienza dei precedenti anni mi ha confermato<br />
nell’idea che il giovane, quando se ne ravvisa la necessità, deve ottenere da parte del docente<br />
l’attenzione diretta che richiede. Ritengo, a tal proposito, che, nonostante i tempi limitati, sia uno<br />
dei compiti specifici dell’insegnante di religione. Questo non certo a causa di qualche particolare<br />
carisma ma per la posizione <strong>maggio</strong>rmente vicina all’ascolto che la disciplina prevede. Sono, infatti,<br />
privilegiati i momenti di intervento diretto, spontaneo, non obbligato che permettono all’alunno di<br />
esporsi e di partecipare quando veramente sente di poterlo fare. Questo è l’inizio del dialogo<br />
personale, anche se inserito nell’ambito di molte altre situazioni simili nelle classi. Sta<br />
all’insegnante saper riconoscere quando è possibile instaurare questo rapporto individuale senza<br />
mai forzare la volontà dell’alunno.<br />
In conclusione posso affermare che l’esperienza didattica di quest’anno scolastico può<br />
considerarsi sostanzialmente positiva. Con queste prerogative il rapporto docente – alunni ha potuto<br />
avvalersi di connotazioni più precise e gli interventi sono sicuramente stati più efficaci e mirati.<br />
Prof. Giovanni Vincalli<br />
48