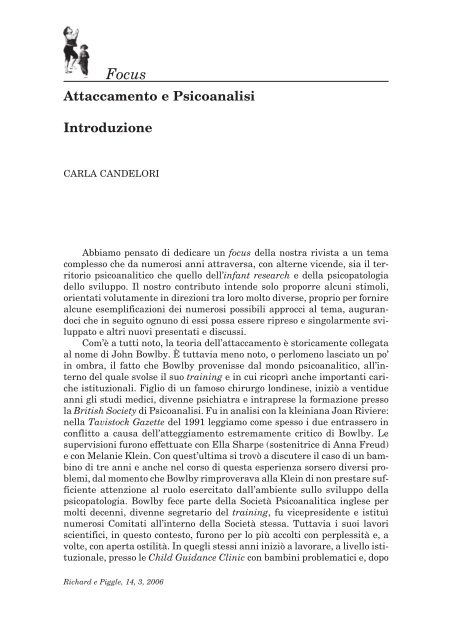08 candelori - Richard & Piggle
08 candelori - Richard & Piggle
08 candelori - Richard & Piggle
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Focus<br />
Attaccamento e Psicoanalisi<br />
Introduzione<br />
CARLA CANDELORI<br />
Abbiamo pensato di dedicare un focus della nostra rivista a un tema<br />
complesso che da numerosi anni attraversa, con alterne vicende, sia il territorio<br />
psicoanalitico che quello dell’infant research e della psicopatologia<br />
dello sviluppo. Il nostro contributo intende solo proporre alcuni stimoli,<br />
orientati volutamente in direzioni tra loro molto diverse, proprio per fornire<br />
alcune esemplificazioni dei numerosi possibili approcci al tema, augurandoci<br />
che in seguito ognuno di essi possa essere ripreso e singolarmente sviluppato<br />
e altri nuovi presentati e discussi.<br />
Com’è a tutti noto, la teoria dell’attaccamento è storicamente collegata<br />
al nome di John Bowlby. È tuttavia meno noto, o perlomeno lasciato un po’<br />
in ombra, il fatto che Bowlby provenisse dal mondo psicoanalitico, all’interno<br />
del quale svolse il suo training e in cui ricoprì anche importanti cariche<br />
istituzionali. Figlio di un famoso chirurgo londinese, iniziò a ventidue<br />
anni gli studi medici, divenne psichiatra e intraprese la formazione presso<br />
la British Society di Psicoanalisi. Fu in analisi con la kleiniana Joan Riviere:<br />
nella Tavistock Gazette del 1991 leggiamo come spesso i due entrassero in<br />
conflitto a causa dell’atteggiamento estremamente critico di Bowlby. Le<br />
supervisioni furono effettuate con Ella Sharpe (sostenitrice di Anna Freud)<br />
e con Melanie Klein. Con quest’ultima si trovò a discutere il caso di un bambino<br />
di tre anni e anche nel corso di questa esperienza sorsero diversi problemi,<br />
dal momento che Bowlby rimproverava alla Klein di non prestare sufficiente<br />
attenzione al ruolo esercitato dall’ambiente sullo sviluppo della<br />
psicopatologia. Bowlby fece parte della Società Psicoanalitica inglese per<br />
molti decenni, divenne segretario del training, fu vicepresidente e istituì<br />
numerosi Comitati all’interno della Società stessa. Tuttavia i suoi lavori<br />
scientifici, in questo contesto, furono per lo più accolti con perplessità e, a<br />
volte, con aperta ostilità. In quegli stessi anni iniziò a lavorare, a livello istituzionale,<br />
presso le Child Guidance Clinic con bambini problematici e, dopo<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 14, 3, 2006
C. Candelori: Attaccamento e Psicoanalisi 259<br />
la seconda guerra mondiale, ricevette l’incarico di sviluppare presso la Tavistock<br />
Clinic il dipartimento infantile. Ciò gli consentì anche di istituire,<br />
insieme con Esther Bick, il training per la psicoterapia infantile.<br />
Gli anni cinquanta segnarono una tappa importante per la produzione<br />
scientifica di Bowlby: fu edito il suo rapporto, commissionato dall’Organizzazione<br />
Mondiale della Sanità, sulla salute mentale dei bambini abbandonati<br />
(1951) e iniziarono a essere pubblicati i suoi primi articoli riguardanti<br />
il legame del bambino con la figura materna e gli effetti della separazione<br />
(1952, 1956, 1958). Fu così che cominciarono a porsi le basi per quella che si<br />
sarebbe configurata come la “teoria dell’attaccamento”.<br />
Ci siamo riferiti alla formazione psicoanalitica di Bowlby, ma non si può<br />
prescindere dal considerare il ruolo di una serie di altre esperienze che lo<br />
influenzarono profondamente: il contatto con le difficili realtà familiari dei<br />
bambini e degli adolescenti problematici, la collaborazione con Hinde e,<br />
soprattutto, la scoperta dell’etologia. Egli fu molto colpito dalla lettura de<br />
“L’anello di Re Salomone” di Lorenz (1949) e, in particolare, dalla descrizione<br />
del comportamento delle piccole oche che seguono la madre (o un suo<br />
surrogato), mostrando una sorta di stato d’angoscia se separate da lei. Così<br />
come si mostrò vivamente interessato alle ricerche di Harlow (1958) sulle<br />
piccole scimmie rhesus, separate dalla loro madre e allevate ricorrendo a<br />
strutture di “madri-fantoccio”. Sia nel caso di Lorenz che in quello di Harlow<br />
veniva dimostrato, secondo Bowlby, che il nutrimento non costituiva la<br />
base del legame, permettendo di ipotizzare un sistema di attaccamento primario<br />
che si discostava dalla teoria pulsionale di Freud. La ricerca di vicinanza<br />
alla madre (o ad un suo sostituto), l’effetto “base sicura” (espressione<br />
utilizzata per la prima volta da Mary Ainsworth per indicare quel legame<br />
tra madre e bambino che consente a quest’ultimo di esplorare e di trovare in<br />
lei conforto nei momenti ansiogeni;1982) e la protesta per la separazione<br />
costituiscono per Bowlby le tre caratteristiche basilari delle relazioni d’attaccamento.<br />
Sarebbe troppo lungo addentrarsi in tutti i numerosi e articolati aspetti<br />
che connotano la teoria dell’attaccamento bowlbiana. Un concetto, tuttavia,<br />
ci sembra imprescindibile, quello di modello operativo interno (internal<br />
working model), che Bowlby esportò dal noto testo di Kenneth Craik, The<br />
Nature of Explanation (1943), intendendo con esso una sorta di mappa rappresentazionale<br />
costruita nell’ambito delle esperienze affettive significative,<br />
che permette di orientarsi e di fare predizioni riguardanti sé e il mondo<br />
esterno.<br />
È proprio facendo riferimento ai modelli operativi interni che molti<br />
studi e ricerche si sono potuti sviluppare, apportando nuovi contributi all’interno<br />
di tale cornice teorica.<br />
Occorre innanzitutto fare riferimento al lavoro pionieristico di Mary<br />
Ainsworth, collaboratrice di Bowlby, agli inizi, che mise a punto una specifica<br />
procedura di laboratorio, la Strange Situation (1978), in cui genitore e<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 14, 3, 2006
260 C. Candelori: Attaccamento e Psicoanalisi<br />
bambino (a circa un anno d’età) si trovano ad affrontare, in un ambiente per<br />
entrambi nuovo, brevi momenti di separazione e riunione. Tenendo conto<br />
delle specifiche reazioni dei bambini, la Ainsworth sostenne che era possibile<br />
identificare tre tipologie di attaccamento: 1) Sicuro (Secure; B ); il bambino,<br />
prima che il genitore si allontani, esplora la stanza e i giochi con interesse.<br />
Sente la mancanza del genitore, dopo la separazione, e spesso piange, però,<br />
una volta ristabilito il contatto, si rassicura e torna a giocare; 2) Evitante<br />
(Avoidant; A ); il bambino non piange alla separazione dal genitore e tende<br />
ad ignorarlo al suo ritorno, la sua reazione appare anaffettiva. È sempre<br />
piuttosto concentrato sui giochi o sull’ambiente; 3) Resistente o Ambivalente<br />
(Resistant or Ambivalent; C); il bambino all’inizio esplora poco ed è piuttosto<br />
teso. È molto preso dal genitore, protesta alla separazione e non riesce a<br />
calmarsi nel corso della riunione, continuando a concentrarsi sul genitore.<br />
A queste categorie in seguito se ne aggiunse un’altra (Main, 1990), relativa<br />
all’attaccamento Disorganizzato/Disorientato (Disorganized/Disoriented;<br />
D). Il bambino in alcuni momenti manifesta comportamenti disorganizzati<br />
e/o disorientati, come ad esempio una sorta di trance o di<br />
congelamento (freezing) o movimenti bizzarri e improvvisi, facendo ipotizzare<br />
un momentaneo crollo delle strategie comportamentali. Questa categoria<br />
può coesistere con una delle tre principali.<br />
L’altro importante strumento che occorre prendere in considerazione è<br />
l’Adult Attachment Interview (A.A.I.), un’intervista semistrutturata messa<br />
inizialmente a punto da Mary Main e collaboratori (1984) per valutare i<br />
modelli operativi genitoriali. Con essa lo “stato della mente” relativo all’attaccamento<br />
può essere riferito a quattro specifiche categorie (in analogia a<br />
quelle riscontrabili nella Strange Situation): sicuro/autonomo, distanziante,<br />
preoccupato, irrisolto/disorganizzato (si parlerà più ampiamente dell’A.A.I.<br />
in uno dei lavori presentati).<br />
Facendo riferimento a questi due strumenti, è stato portato avanti un<br />
numero davvero considerevole di studi e ricerche, volti a esplorare meglio le<br />
caratteristiche dei modelli d’attaccamento, la loro continuità/discontinuità e<br />
la possibile trasmissione intergenerazionale. E in relazione a questi e a tanti<br />
altri temi che in anni recenti si sono sviluppati, ha trovato fertile terreno per<br />
il dibattito culturale e scientifico proprio quell’area tematica riguardante il<br />
rapporto tra psicoanalisi e attaccamento. Qui le posizioni si sono molto<br />
diversificate. Una parte del mondo psicoanalitico, così come accadeva<br />
quando Bowlby ne faceva parte, ha continuato a mostrarsi critico, sostenendo<br />
l’inconciliabilità della teoria freudiana dell’Inconscio con il metodo<br />
osservativo e sperimentale (tra questi Green, 1996, e Woff, 1996). Altri<br />
hanno individuato possibili punti di contatto. Ad esempio Seligman (1993)<br />
si richiama proprio a Freud, ricordando la sua interpretazione del famoso<br />
“gioco del rocchetto” (1920), sottolineandone la caratteristica di esperienza<br />
osservativa, relativamente alla quale, proprio partendo da una situazione<br />
comportamentale, furono effettuate delle inferenze riguardanti il funziona-<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 14, 3, 2006
C. Candelori: Attaccamento e Psicoanalisi 261<br />
mento mentale di un bambino piccolo (si potrebbe anche aggiungere che<br />
Freud esortò sempre i suoi colleghi a effettuare osservazioni sui bambini).<br />
Ma è soprattutto intorno al tema dell’attaccamento “disorganizzato” che<br />
sono state prodotte approfondite riflessioni che hanno in parte riavvicinato<br />
la clinica alla teoria dell’attaccamento.<br />
Sono probabilmente noti al lettore gli studi di Giovanni Liotti (1992)<br />
sull’attaccamento e i disturbi funzionali dello stato di coscienza, in cui si ipotizza<br />
che l’esperienza precoce di sé-con-l’altro dei bambini con attaccamento<br />
disorganizzato possa predisporre a tale patologia, tenendo anche conto degli<br />
eventi traumatici non elaborati, come i lutti, nella storia personale delle loro<br />
figure di attaccamento. Diana Diamond, in un recente articolo dal titolo<br />
“L’attaccamento disorganizzato: l’incontro tra la teoria dell’attaccamento e<br />
la Psicoanalisi” (2004), si muove, in parte, sullo stesso terreno. Nel suo<br />
lavoro descrive come molti bambini piccoli con attaccamento disorganizzato<br />
presentino più tardi, intorno ai sei anni d’età, fantasie catastrofiche di morti<br />
violente, annichilimento e distruzione. Ciò, afferma, ha stimolato nei ricercatori<br />
un rinnovato interesse per i costrutti psicoanalitici di fantasia, rappresentazione<br />
e processi di internalizzazione: la Diamond, al fine di avvicinare<br />
il vertice psicoanalitico alla teoria dell’attaccamento, opera alcuni<br />
confronti, prendendo in considerazione la teoria di Freud sul trauma e l’angoscia<br />
traumatica e la teoria kleiniana dell’identificazione proiettiva e delle<br />
posizioni schizoparanoide e depressiva. Come valutare il suo tentativo? Ci<br />
sembrerebbe complessivamente apprezzabile, tranne un particolare rilevante:<br />
i suoi riferimenti alla psicoanalisi sono talora piuttosto imprecisi,<br />
come si può vedere, ad esempio, quando accosta la posizione depressiva kleiniana<br />
alla categoria d’attaccamento “irrisolto”.<br />
Anche Fonagy prende in considerazione il modello kleiniano, nel suo<br />
volume del 2001 (che ha per titolo il tema del nostro focus), in cui viene effettuata<br />
una rassegna delle principali scuole di psicoanalisi al fine di sottolineare<br />
eventuali punti di contatto o di differenza con la teoria dell’attaccamento.<br />
Pur essendo indubbiamente debitori a Fonagy per il suo costante e<br />
lucido sforzo di trovare possibili convergenze, nella distinzione delle basi<br />
epistemologiche, degli obiettivi e dei metodi d’indagine, occorre dire che sentiamo<br />
talora il peso di alcune forzature che riguardano la rilettura delle<br />
diverse teorie psicoanalitiche. Ad esempio, per restare nell’ambito kleiniano,<br />
scissione, negazione e riparazione maniacale sono riferite rispettivamente,<br />
in maniera un po’ troppo meccanica (anche se suggestiva), alla categoria<br />
distanziante, all’incapacità a ricordare e all’idealizzazione,<br />
riscontrabili nell’ambito della codifica dell’Adult Attachment Interview.<br />
Pensiamo che uno dei meriti principali di Fonagy sta stato quello di aver<br />
fatto riferimento all’area della conoscenza metacognitiva (Main, 1991), per<br />
sviluppare la sua teorizzazione riguardante la cosiddetta “funzione riflessiva”,<br />
intesa come la capacità di interpretare il proprio e l’altrui comportamento<br />
come prodotti di stati mentali quali intenzioni, credenze, pensieri ed<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 14, 3, 2006
262 C. Candelori: Attaccamento e Psicoanalisi<br />
emozioni. In questo quadro sarebbe proprio la relazione d’attaccamento<br />
bambino-caregiver a costituire la matrice di sviluppo della funzione riflessiva<br />
(soprattutto attraverso il rispecchiamento degli stati emotivi infantili).<br />
Ciò, in linea con quanto già sottolineato dalla Main, permette di estendere<br />
l’attenzione dalle strategie comportamentali regolatrici dell’attaccamento al<br />
livello dei processi rappresentazionali connessi alle esperienze affettive,<br />
avvicinandoci maggiormente, in tal modo, alle linee portanti del paradigma<br />
psicoanalitico e stabilendo, al contempo, un certo distanziamento dagli<br />
assunti bowlbiani.<br />
Una valorizzazione di Bowlby (e in particolare del suo contributo sul<br />
lutto), è, d’altra parte, effettuata dalla Lyons-Ruth che, in quanto psicoanalista<br />
e ricercatrice, “ha lavorato”, come afferma Fonagy (2001,p.131) “sui due<br />
versanti dell’abisso, tanto sullo strato tettonico della psicoanalisi quanto su<br />
quello della teoria dell’attaccamento”. La Lyons-Ruth (1999), oltre ad aver<br />
esplorato approfonditamente la natura, le cause e le conseguenze dell’attaccamento<br />
disorganizzato nell’infanzia, ha proposto un proprio modello, quello<br />
della diatesi (o predisposizione) relazionale, aggiornando la teorizzazione<br />
bowlbiana sul lutto e ricollegandosi al contributo di Freud sul lutto e la<br />
melanconia. Rilevante ci sembra, soprattutto, il fatto che la Lyons-Ruth, non<br />
fermandosi al mero dato comportamentale, ci fornisca specifiche ipotesi<br />
riguardanti le esperienze emozionali disorganizzanti.<br />
Il suo contributo, insieme a quello di molti altri che, per ragioni di spazio,<br />
non ci è possibile segnalare, ha promosso un buon avanzamento di questa<br />
interessante e articolata area di studio a cui il focus della nostra rivista<br />
è dedicato.<br />
Come inizialmente accennavamo, abbiamo scelto di presentare un<br />
“assaggio” di filoni di studio e ricerca tra loro diversi (e con la consapevolezza<br />
che alcuni di essi potranno sembrare piuttosto lontani dal lettino analitico<br />
o dalla stanza di gioco per la psicoterapia dei bambini…).<br />
Il primo lavoro della nostra rassegna, di Francesca Ortu e Riccardo Williams,<br />
autori con Chiara Pazzagli, di una recente e aggiornata pubblicazione<br />
sull’attaccamento (2005), ha la funzione di mostrare lo “stato dell’arte”,<br />
anche geografico, relativo al nostro argomento.<br />
Il saggio di Tomas Geyskens, studioso e psicoanalista belga, è a carattere<br />
teorico e storico: introdotto dall’utile nota della nostra collega Silva<br />
Oliva, si colloca in un’area pre-bowlbiana, presentando alcuni aspetti della<br />
teorizzazione dello psicoanalista ungherese Imre Hermann. Questi, nell’analisi<br />
delle “patologie dell’attaccamento” (depressione, ninfomania, tossicomania)<br />
individuò una fantasia originaria relativa alla “rottura forzata della<br />
relazione madre-bambino”, descrivendo tre posizioni ad essa correlate<br />
(aggrappamento, ricerca, spinta alla separazione) che rimandano ai successivi<br />
sviluppi bowlbiani.<br />
Il terzo contributo è tratto da uno dei due numeri che la rivista Psychoanalytic<br />
Inquiry ha dedicato, nel 1999, a “La ricerca sull’attaccamento e<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 14, 3, 2006
C. Candelori: Attaccamento e Psicoanalisi 263<br />
la Psicoanalisi”. L’autrice è una psicoterapeuta, Alicia Lieberman, che si colloca<br />
nella cornice degli interventi di psicoterapia genitore-bambino ispirati<br />
al lavoro pionieristico di Selma Fraiberg. Viene da lei presentata un’ interessante<br />
situazione clinica, riguardante la relazione di una giovane madre<br />
con la propria figlia di tredici mesi, in cui è posto in primo piano il ruolo delle<br />
“attribuzioni materne” negative (da lei intese come la manifestazione cognitivamente<br />
organizzata dell’identificazione proiettiva). La Lieberman sottolinea<br />
la necessità di includere all’interno della nozione di modello operativo<br />
interno non solo il riferimento alle regole e alle aspettative relative al<br />
legame di attaccamento, ma anche alla sessualità e all’aggressività, intese<br />
come forze motivazionali primarie.<br />
Il quarto lavoro, infine, che è nostro, in collaborazione con Antonio<br />
Ciocca, si propone di affrontare un possibile confronto tra ambito di ricerca<br />
e ambito clinico, effettuando una riflessione sul tema e fornendo un breve<br />
esempio relativo all’esperienza psicoterapeutica.<br />
Ci auguriamo che questi iniziali stimoli, volti ad esplorare questa interessante<br />
e articolata area di studio e di ricerca, possano promuovere riflessioni<br />
e ulteriori contributi di pensiero da parte dei nostri lettori.<br />
Bibliografia<br />
Ainsworth M D S, Blehar M C, Waters E, Wall S (1978). Patterns of Attachment: A Psychological<br />
Study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ. : Erlbaum.<br />
Ainsworth M D S (1982). Attachment: retrospect and prospect. In: Parkes C M, Stevenson-Hinde<br />
J (edited by), The place of Attachment in Human Behaviour. London:<br />
Tavistock.<br />
Bowlby J (1951). Cure materne e igiene mentale del fanciullo. Trad. it., Firenze: Giunti Barbera,<br />
1957.<br />
Bowlby J, Robertson J, Rosenbluth D (1952). A two-year-old goes to hospital. The Psychoanalytic<br />
Study of the Child, VII: 82-94.<br />
Bowlby J, Ainsworth M, Boston M, Rosenbluth D (1956). The effects of mother-child separation:<br />
a follow-up study. British Journal of Medical Psychology, XXIX: 211-247.<br />
Bowlby J (1958). The nature of the child’s tie to his mother. International Journal of Psycho-<br />
Analysis, 39: 350-373.<br />
Bowlby J (1991). The role of the psychotherapist’s personal resources in the therapeutic situation.<br />
Tavistock Gazette (autumn).<br />
Craik K (1943). The nature of Explanation. Cambridge: Cambridge University Press.<br />
Diamond D (2004). Attachment disorganization. The Reunion of Attachment Theory and Psychoanalysis.<br />
Psychoanalytic Psychology, 2: 276-299.<br />
Fonagy P (2001). Psicoanalisi e teoria dell’attaccamento. Trad. it., Milano: Cortina, 2002.<br />
Freud S (1920). Al di là del principio di piacere. OSF: 9. Torino: Boringhieri, 1977.<br />
Green A (1996). Quale ricerca per la psicoanalisi? Trad. it., <strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 3: 291-295, 1997.<br />
Harlow H F (1958). The nature of love. American Psychologist, 13: 673-685.<br />
Liotti G (1992). Disorganizzazione dell’attaccamento e predisposizione allo sviluppo di disturbi<br />
funzionali della coscienza. In: Ammaniti M, Stern D N (a cura di) Attaccamento e Psicoanalisi.<br />
Bari: Laterza, 1992.<br />
Lorenz K (1949). L’anello di re Salomone. Trad. it., Milano: Adelphi, 1967.<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 14, 3, 2006
264 C. Candelori: Attaccamento e Psicoanalisi<br />
Lyons-Ruth K, Bronfman E, Atwood G ( 1999). A relational diathesis model of hostile-helpless<br />
states of mind. Expressions in mother-infant interaction. In: Salomon J, George C (edited<br />
by), Attachment disorganization. New York: Guilford Press.<br />
Main M, Goldwyn R (1984). Adult Attachment Scoring and Classification System, Manoscritto<br />
non pubblicato. Berkeley: University of California.<br />
Main M (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth<br />
Strange Situation. In: Greenberg M, Cicchetti D, Cummings E M (edited by), Attachment<br />
during the Preschool Years: Theory, Research and Intervention. Chicago: University<br />
of Chicago Press, 121-160.<br />
Main M (1991). Conoscenza metacognitiva, monitoraggio metacognitivo e modello di attaccamento<br />
unitario (coerente) vs modello di attaccamento multiplo (incoerente): dati e indicazioni<br />
per la futura ricerca. In: P Harris, Stevenson-Hinde J, Parkes C (a cura di ) L’Attaccamento<br />
nel ciclo della vita. Trad. it.: Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 1995.<br />
Main M, Goldwyn R (1998). Interview-based adult attachment classifications: related to infantmother<br />
and infant-father attachment. Manoscritto non pubblicato. Berkeley: University<br />
of California.<br />
Ortu F, Pazzagli C, Williams R (2005). La psicologia contemporanea e la teoria dell’attaccamento.<br />
Roma: Carocci.<br />
Seligman S (1993). Infant observation and psychoanalytic theory. Psychoanalytic Quarterly,<br />
LXII: 274-278.<br />
Wolff P H (1996). L’irrilevanza delle osservazioni infantili per la psicoanalisi. Trad. it. In: Bonaminio<br />
V, Fabozzi P, Quale ricerca per la psicoanalisi?. Trad. it.. Milano: Franco Angeli,<br />
2002.<br />
Carla Candelori, psicoterapeuta, membro didatta dell’Associazione Italiana di Psicoterapia<br />
Psicoanalitica Infantile (AIPPI), docente di Psicologia Dinamica presso la Facoltà di Psicologia<br />
dell’Università “G. D’Annunzio” (Chieti).<br />
Indirizzo per la corrispondenza/Address for correspondence:<br />
Via Vincenzo Picardi, 4<br />
00197 Roma<br />
c.<strong>candelori</strong>@unich.it<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 14, 3, 2006