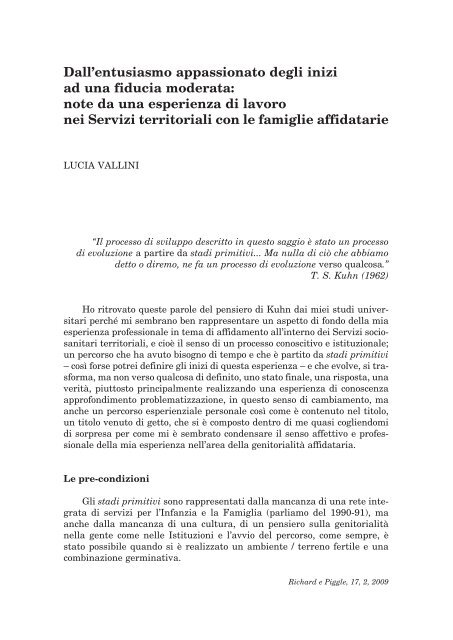You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dall’entusiasmo appassionato degli inizi<br />
ad una fiducia moderata:<br />
note da una esperienza di lavoro<br />
nei Servizi territoriali con le famiglie affidatarie<br />
LUCIA VALLINI<br />
“Il processo di sviluppo descritto in questo saggio è stato un processo<br />
di evoluzione a partire da stadi primitivi... Ma nulla di ciò che abbiamo<br />
detto o diremo, ne fa un processo di evoluzione verso qualcosa.”<br />
T. S. Kuhn (1962)<br />
Ho ritrovato queste parole del pensiero di Kuhn dai miei studi universitari<br />
perché mi sembrano ben rappresentare un aspetto di fondo della mia<br />
esperienza professionale in tema di affidamento all’interno dei Servizi sociosanitari<br />
territoriali, e cioè il senso di un processo conoscitivo e istituzionale;<br />
un percorso che ha avuto bisogno di tempo e che è partito da stadi primitivi<br />
– così forse potrei definire gli inizi di questa esperienza – e che evolve, si trasforma,<br />
ma non verso qualcosa di definito, uno stato finale, una risposta, una<br />
verità, piuttosto principalmente realizzando una esperienza di conoscenza<br />
approfondimento problematizzazione, in questo senso di cambiamento, ma<br />
anche un percorso esperienziale personale così come è contenuto nel titolo,<br />
un titolo venuto di getto, che si è composto dentro di me quasi cogliendomi<br />
di sorpresa per come mi è sembrato condensare il senso affettivo e professionale<br />
della mia esperienza nell’area della genitorialità affidataria.<br />
Le pre-condizioni<br />
Gli stadi primitivi sono rappresentati dalla mancanza di una rete integrata<br />
di servizi per l’Infanzia e la Famiglia (parliamo del 1990-91), ma<br />
anche dalla mancanza di una cultura, di un pensiero sulla genitorialità<br />
nella gente come nelle Istituzioni e l’avvio del percorso, come sempre, è<br />
stato possibile quando si è realizzato un ambiente / terreno fertile e una<br />
combinazione germinativa.<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009
170 L. Vallini: Dall’entusiasmo appassionato degli inizi ad una fiducia moderata<br />
Una riorganizzazione strutturale nell’assetto dei Servizi sociali e sanitari<br />
presso i quali lavoravo portò nuovi impulsi e risorse, ed anche un assistente<br />
sociale con funzioni di Dirigente, incaricato di organizzare e promuovere iniziative<br />
e servizi nell’area della tutela dei diritti e della risposta al disagio dei bambini<br />
e delle famiglie, col quale si è realizzato un incontro davvero costruttivo.<br />
Ci ha avvicinato un certo modo di guardare ai bambini e ai loro genitori,<br />
di pensare il disagio e la sofferenza dei figli in stretta connessione con<br />
la qualità delle relazioni affettive genitoriali, così come la genitorialità<br />
come un processo maturativo dell’individuo già adulto e della coppia coniugale.<br />
E ci ha avvicinato anche la convinzione che a questi temi bisogna<br />
guardare con la necessaria crudezza, senza troppi sentimentalismi, facili<br />
quanto lontani dall’esperienza vissuta di ognuno.<br />
“L’amore di una madre è una cosa molto informe. C’è in esso una sfumatura<br />
di senso del possesso, perfino di avidità, vi sono anche generosità,<br />
sensazione del proprio potere e umiltà. Ma il sentimentalismo è completamente<br />
assente: è una cosa che le madri rifiutano” (Winnicott, 1949, p. 92).<br />
L’esperienza di lavoro sul campo, nelle situazioni di disagio infantile –<br />
dagli stati di trascuratezza al maltrattamento ai problemi di emarginazione<br />
– imponeva di mettere lo sguardo e la mente in quell’area dell’esperienza<br />
umana tradizionalmente difesa dentro la privacy della famiglia, con l’obiettivo<br />
di promuovere comprensione e conoscenza dei fenomeni anziché<br />
atteggiamenti moralistici sostanzialmente evacuativi, di far crescere attenzione<br />
e sensibilità verso questi temi e, perché no, anche la disponibilità ad<br />
avvicinarsi di più (l’ipotesi di ricorrere all’Istituto dell’Affidamento cadeva<br />
ogni volta rovinosamente di fronte al deserto delle disponibilità).<br />
Iniziammo un lavoro intenso e capillare di incontri, conferenze, spazi<br />
di confronto e dibattito (nelle scuole con genitori ed insegnanti, nelle Sale<br />
Consiliari dei Comuni con la popolazione e le associazioni), teso a far crescere<br />
nel territorio e nelle istituzioni una cultura ed un pensiero sulla genitorialità<br />
come processo maturativo che rende la coppia capace di fare spazio<br />
ad un terzo e di farsi usare dal processo di sviluppo con tutto il proprio<br />
bagaglio affettivo di fantasie desideri aspettative fantasmi; ed una riflessione<br />
sui figli non come possesso (tutti i figli in realtà sono “in affidamento”)<br />
ma come soggetti dotati di bisogni e di diritti verso i quali ripensare e<br />
riconoscere la genitorialità come un impegno di responsabilità e presenza,<br />
contributo fondante per la crescita personale.<br />
Del resto è proprio da questo modo di intendere il processo di crescita<br />
dell’essere umano, come una interrelazione continua e complessa di aspetti<br />
costituzionali / affettivo relazionali / esperenziali, che deriva la necessità<br />
e le indicazioni per / di un Istituto come quello dell’Affidamento etero familiare;<br />
e questa è stata la cornice del nostro pensiero di operatori del servizio,<br />
consapevoli che quando ci si occupa di questi ambiti non è come insegnare<br />
qualcosa che è così e basta, come dice Winnicott “... non ci sono istruzioni<br />
da prendere così come sono e alla fine l’unico consiglio che vi si potrà<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009
L. Vallini: Dall’entusiasmo appassionato degli inizi ad una fiducia moderata 171<br />
dare sarà quello di fare come vi sentite. L’unica cosa è che voi possiate arricchirvi<br />
conoscendo altre situazioni simili a quella in cui vi trovate e anche<br />
che siate in grado di poter capire sempre meglio ciò che state facendo e perché<br />
lo fate”. (Winnicott, 1950, p. 35).<br />
Accanto al lavoro di sensibilizzazione decidemmo poi di proporre la<br />
costituzione di un gruppo mensile per genitori adottivi e affidatari, come<br />
spazio – tempo di contenimento, confronto, elaborazione delle esperienze<br />
personali, un accompagnare ma anche un entrare dentro l’esperienza là<br />
dove questa è già realtà.<br />
Il gruppo dei genitori<br />
Si optò per un accesso al gruppo facoltativo e non vincolante, riservato<br />
alle coppie che già stavano facendo l’esperienza dell’adozione e/o dell’affidamento,<br />
alle quali venivano spediti gli inviti come informazione circa questa<br />
occasione di incontro e confronto, che ognuno poteva liberamente scegliere<br />
di cogliere oppure no.<br />
La risposta ci sembrò convincente, non tanto per il numero quanto<br />
soprattutto per la frequenza dei genitori che divenne subito assidua e<br />
costante, ampliandosi sempre di più negli anni. Quando poi, di lì a poco,<br />
abbiamo avuto una sede nel costituito “Centro Bambini e Famiglie” si è<br />
potuto prevedere la disponibilità di un educatore e delle strutture del<br />
Centro per estendere l’invito anche ai bambini.<br />
Questo, secondo me, è stato un passaggio significativo e vivificamente<br />
per i lavori del gruppo: la presenza concreta dei bambini nel loro andare e<br />
venire dalle attività di gioco alla stanza dove gli adulti stavano insieme a<br />
parlare, se pure rendeva più movimentata la situazione, e a tratti un po’<br />
frammentato il discorso dei grandi, costituiva però anche una esperienza in<br />
presa diretta del lavoro di crescere come del lavoro di genitori.<br />
Era chiara fin dall’inizio la problematicità di tenere insieme due esperienze<br />
certo molto affini, ma anche profondamente diverse, come l’affidamento<br />
e l’adozione; e per di più la realtà degli affidamenti in corso era<br />
numericamente molto inferiore a quella delle adozioni e stentava a decollare<br />
anche per la scarsa disponibilità di risorse umane (famiglie, coppie,<br />
singles disponibili). La maggior parte degli affidi in corso erano affidamenti<br />
familiari, il che voleva dire nel nostro territorio per lo più figli di tossicodipendenti<br />
affidati ai nonni, in genere nonni materni: una realtà nella<br />
realtà, esperienze fuori controllo se non nel momento in cui diventavano<br />
esplicitamente problematiche (fallimenti scolastici, tendenze antisociali,<br />
conflittualità adolescenziale...), perché tutte dentro quella cultura del figlio<br />
sangue del mio sangue, dunque prima di tutto appartenente alla famiglia,<br />
per definizione ritenuta abile; cultura assai lontana dal nostro modo di<br />
intendere i bisogni di un bambino che cresce, e che cosa vuol dire “una suf-<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009
172 L. Vallini: Dall’entusiasmo appassionato degli inizi ad una fiducia moderata<br />
ficiente capacità genitoriale”, ma ancora molto presente allora nella operatività<br />
dei Tribunali per minorenni.<br />
Quando abbiamo avuto le risorse per costituire uno spazio specifico,<br />
differenziato per i genitori affidatari, il gruppo era fortemente sbilanciato<br />
in questo senso, e questo condizionava non poco il suo funzionamento.<br />
Proprio in quanto meno tenute, meno lavorate dai servizi, queste situazioni<br />
riversavano nel gruppo una concretezza di fatti, di realtà (es. il ritorno dal<br />
carcere del genitore tossicodipendente, oppure la decisione della Comunità<br />
terapeutica che è arrivato il tempo per il genitore ex tossicodipendente di<br />
riprendersi i figli), difficilmente elaborabili in quella sede, anche se c’era<br />
comunque un effetto di contenimento, come dimostrato dalla diminuzione<br />
di “agiti”, dal minore deterioramento delle dinamiche familiari, da una<br />
diversa capacità di contatto e di uso dei/con i Servizi.<br />
L’esperienza del gruppo, un luogo e un tempo, per parlare insieme, sentirsi<br />
ascoltati ma anche confrontarsi con le impressioni degli altri, con la loro<br />
solidarietà ed il loro punto di vista, è una occasione arricchente e potenzialmente<br />
trasformativa dell’esperienza personale anche se certo da sola non<br />
basta. È un’altra strada – accanto a quella di un lavoro più personale e privato<br />
– per dialogare in un modo non solo di testa con ciò che si sente, si vive,<br />
si pensa. Nell’esperienza del ripetersi degli incontri si crea una sorta di<br />
familiarità sufficientemente intima, da fornire secondo me quel terreno fertile,<br />
l’ambiente mentale necessario proprio per quel lavoro di confronto/integrazione<br />
fra le motivazioni iniziali, spesso di testa, e l’esperienza dal vivo che<br />
diventa sempre una esperienza di pancia; come mi sono trovata spesso ad<br />
osservare non senza un certo stupore, di fronte alla passione, alla partecipazione,<br />
alla sofferenza che si mobilitano comunque nei vissuti dei genitori<br />
affidatari rispetto alle vicende, ai fatti, ai comportamenti dei figli affidati.<br />
La famiglia: integrità psicosomatica/intrusione/estraneità<br />
L’esperienza ci conferma che le buone intenzioni e l’amore non bastano,<br />
quando poi l’altro, il diverso, l’estraneo entrano dentro davvero; qui è la<br />
pancia che entra in gioco, nel senso di emozioni, sensazioni, affetti viscerali<br />
che risuonano e vengono inaspettatamente mobilitati.<br />
L’organo trapiantato ha bisogno di essere amato sì, ma soprattutto di<br />
essere riconosciuto e accolto come diverso e altro: non qualcosa che prende<br />
il posto dell’originario cancellandone la memoria, ma qualcosa che arriva in<br />
soccorso, accompagna e sostiene tutta l’esperienza di ciò che non c’è o che si<br />
sta cercando. Un lavoro psichico fondamentale e necessario perché si realizzi<br />
una capacità vera di accogliere e integrare ma anche di operare e mantenere<br />
adeguate differenziazioni, per esempio fra estraneo e intruso, come<br />
sottolinea Moroncini nel suo bell’articolo “Tecnica dei trapianti e cultura<br />
dell’ospitalità” (2002).<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009
L. Vallini: Dall’entusiasmo appassionato degli inizi ad una fiducia moderata 173<br />
“Il fatto che con il trapianto parti di un altro entrino nel corpo costituisce<br />
una difficoltà che necessita di tempo per essere metabolizzata. Il tempo<br />
dell’atto chirurgico del trapianto è veloce, quello dell’accettazione lento”.<br />
(Ferruta, 2002, p. 88).<br />
Mi sembra che, con le dovute differenze e cautele, questa immagine del<br />
trapianto possa costituire una sorta di metafora di ciò che succede e si<br />
mobilita nell’esperienza di una genitorialità diversa: la famiglia è un gruppo<br />
(organismo) che include dentro di sé elementi differenti che conservano<br />
distinzione e individualità, ma che funziona anche come unità autonoma;<br />
ciò che permette lo svolgersi di questa funzione – dice Anzieu (1976, p. 53)<br />
– è: “...la dimensione dello spazio psichico fra gli individui che ne fanno<br />
parte, che istituisce un sentimento di libertà favorevole agli scambi e alla<br />
costruzione di una temporalità storica”.<br />
Diventare genitori è comunque una esperienza che tocca affetti emozioni<br />
fantasmi molto intimi e profondi, potenzialmente perturbanti, e una<br />
genitorialità diversa è un po’ come consentire la perforazione dell’unità,<br />
l’intrusione concreta di un altro, sovente (data l’età dei bambini) un altro<br />
che come un organo presenta un alto grado di strutturazione, ed è importante<br />
domandarsi quanto l’estraneo – intruso è percepito come qualcosa che<br />
agisce su, o su cui si deve agire, e quanto invece come elemento che interagisce<br />
sinergicamente (voglio dire che ci si deve preparare ad un processo<br />
non immediato e con vaste risonanze in tutto il sistema).<br />
Ci vogliono spazio e tempo per il divenire dei processi di metabolizzazione<br />
di fronte all’esperienza di penetrazione e intrusione dell’integrità psicosomatica<br />
del soggetto trapiantato, e lo strumento gruppale risulta essere<br />
una risorsa molto utile per la costituzione di un ambiente mentale atto alla<br />
nascita di un pensiero onirico, di una possibilità di pensare/rappresentare<br />
l’impensabile.<br />
L’esperienza di questi anni di lavoro mi ha portato a ritenere che non<br />
ci sono affatto soluzioni semplici, e ancor meno risposte precostituite, o<br />
indicazioni manualistiche, anche se mi sembra aver evidenziato l’importanza<br />
di alcuni elementi: per esempio l’importanza di un lavoro coraggioso<br />
di riconoscimento e consapevolezza dei bisogni e della ricerca che si esprimono<br />
con il desiderio di adottare o prendere in affidamento un figlio, non<br />
perché ci sia bisogno di genitori “selezionati”, perfetti e/o ideali ma piuttosto<br />
in quanto il quando, come, perché nascono questa idea e questo progetto<br />
costituiscono il terreno da arare-dissodare perché diventi davvero una<br />
base sufficientemente fertile per una buona semina.<br />
E non è importante solo il da dove si parte (le motivazioni all’affidamento<br />
– i traumi del bambino) ma anche il come si procede nel viaggio,<br />
come ci si può attrezzare di volta in volta per far fronte alle esperienze che<br />
il viaggio propone...<br />
Non esistono genitori, famiglie giusti, sani, maturi; il giusto – sano –<br />
maturo sono equilibri da conquistare ogni volta, e forse l’unico strumento<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009
174 L. Vallini: Dall’entusiasmo appassionato degli inizi ad una fiducia moderata<br />
davvero importante è la disposizione a mettersi in gioco, a risuonare con<br />
l’altro ed anche con se stessi, non perché certi di avere risposte e soluzioni<br />
ma piuttosto perché non troppo spaventati di doverne costruire – trovare<br />
ogni volta di nuove e appropriate.<br />
L’Affido non è una soluzione che basta da sé; non è una pasticca che<br />
una volta ingerita farà il suo lavoro senza che noi dobbiamo occuparcene<br />
più di tanto; l’azione terapeutica dell’affido è un processo che ha bisogno di<br />
essere “accudito”: accompagnato, sostenuto, promosso. C’è bisogno di tanta<br />
cura e di tanto lavoro intorno e dentro una situazione di affidamento.<br />
Forse queste considerazioni possono risuonare un po’ pessimistiche,<br />
personalmente le sento più vicine ad un processo di disillusione: dall’entusiasmo<br />
appassionato... ad una fiducia moderata... nel potere riparativo<br />
delle relazioni, nella trasformabilità dei vissuti, nelle potenzialità taumaturgiche<br />
di una sufficientemente buona genitorialità.<br />
... una storia<br />
Sulla scia di queste considerazioni e con la storia dei sigg. G. vorrei cercare<br />
di mettere a fuoco un altro aspetto, che credo non sia affatto infrequente<br />
nelle esperienze di affidamento prolungato, e che riguarda certe<br />
situazioni che definirei di stallo, nelle quali il blocco evolutivo, la stagnazione<br />
delle esperienze sia per i genitori affidatari che per un sano processo<br />
maturativo dei bambini, certo si possono ricondurre al passato, ma anche<br />
nascono lì, ora, in quella dinamica familiare ed in quella relazione affidataria...<br />
Mi chiedo se in questi casi la tendenza ad attribuire tutto o quasi<br />
tutto al prima del bambino, alle esperienze traumatiche subite, alle distorsioni<br />
relazionali e morali vissute nella famiglia naturale, non possa costituire<br />
uma massiccia manovra difensiva che colloca in un altrove qualcosa<br />
che invece sta proprio qui, ora, e che nasce dagli incontri-incastri relazionali<br />
attuali.<br />
Conosco i signori G. quando si rivolgono all’ambulatorio dell’Unità<br />
Operativa di Psicologia per una consultazione psicodiagnostica relativa a L.<br />
la maggiore delle due sorelline che da qualche tempo sono state loro affidate,<br />
e che presenta difficoltà scolastiche (frequenta la 5° elementare). Al<br />
primo appuntamento si presentano la madre affidataria e L., una ragazzina<br />
di <strong>10</strong> anni, pubere, evidentemente obesa, con l’aria timida e impacciata.<br />
In questa prima consultazione lascio che la madre affidataria mi accenni<br />
solo a grandi linee alle vicende dell’affidamento, imputando la genericità<br />
del suo discorso a un aspetto di delicatezza e tatto data la presenza di L.,<br />
anche se mi annoto nella mente la necessità di approfondire la qualità del<br />
dialogo fra loro su questo tema (quanto c’è di taciuto o non dicibile fra<br />
loro?). Osservo anche come diventi molto più precisa e dettagliata nel<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009
L. Vallini: Dall’entusiasmo appassionato degli inizi ad una fiducia moderata 175<br />
descrivere le difficoltà scolastiche: L. è indietro negli apprendimenti, è<br />
molto timida e introversa, inibita e passiva; è obbediente ed accetta di impegnarsi<br />
nello studio ma appare confusa e del tutto non autosufficiente. A<br />
scuola è piuttosto isolata, non ha legato con nessuno in particolare, e del<br />
resto la situazione non è facile: lei è arrivata questo anno, in V elementare,<br />
con la benevolenza di tutti colpiti dalla sua storia che – se pur conosciuta a<br />
grandi linee – mobilita sentimenti di compassione e disponibilità, ma che<br />
ancor più la rende estranea. Non è facile, L. ha paura di sbagliare e così...<br />
com’è nel suo stile... aspetta. Anche qui ora con me L. mantiene un atteggiamento<br />
silenzioso e passivo, ogni tentativo di renderla più partecipe, di<br />
interessarsi alle sue opinioni riguardo a ciò che la madre affidataria sta<br />
dicendo la trovano come impreparata, vuota e confusa.<br />
I sigg. G. sono una famiglia di ceto medio, con due figli già grandi ma<br />
sempre in casa: la primogenita laureanda in medicina, descritta come<br />
determinata e strutturata in questo progetto professionale, fidanzata con<br />
un uomo più grande di lei, medico specialista con una professione già avviata;<br />
il secondogenito anche lui studente universitario un po’ a rilento, lavora<br />
e allo stesso tempo fa esami, appare ancora in cerca di una propria<br />
dimensione e più in difficoltà rispetto ad un processo maturativo di differenziazione<br />
e autonomia dalla famiglia. La coppia non mi sembra molto<br />
disponibile ad approfondire il discorso dell’affidamento: l’esperienza va<br />
bene, soprattutto con la piccola che ha 5 anni ed è molto affettuosa, cerca<br />
sempre le coccole e vuole stare in braccio. Anche con L. va bene, se non fosse<br />
per il problema della scuola, e poi anche questo suo essere così chiusa e taciturna,<br />
è sempre d’accordo su tutto, ma non prende mai una iniziativa; si è<br />
legata molto con la loro figlia con la quale a volte si confida, aspetta con<br />
ansia il suo rientro a casa dall’Università e la ammira molto.<br />
Sanno che è stata proprio una confidenza di L. alla sua maestra a far<br />
precipitare la situazione, determinando la decisione del Servizio Sociale di<br />
allontanare le due bambine dalla famiglia d’origine, nonostante gli interventi<br />
di assistenza domiciliare già in corso. Le bambine sono state “prelevate”<br />
un giorno all’uscita dalla scuola e portate in un Istituto di Suore... poi<br />
sono arrivati loro...<br />
Da quel periodo ho perso di vista i Sigg. G., fin quando 5-6 anni dopo<br />
sono “ricomparsi” al Gruppo dei Genitori Affidatari.<br />
Sono contenta di rivederli, anche se penso/temo che il motivo di questo<br />
ritorno forse sarà dovuto a qualcosa che non va bene: una certa mestizia<br />
nello sguardo di lei sembra confermare questo mio pensiero; lui è come al<br />
solito più sereno, anche se la sua presenza stessa potrebbe preludere a<br />
qualcosa di serio.<br />
Partecipano silenziosi e rispettosi degli altri nel gruppo, mentre io mi chiedo<br />
quando e se daranno voce ai loro pensieri e a ciò che li ha portati qui oggi.<br />
È la signora G. che si inserisce in questo discorso, totalmente schierata<br />
dalla parte degli adulti: genitori esauriti e delusi dalla continua scon-<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009
176 L. Vallini: Dall’entusiasmo appassionato degli inizi ad una fiducia moderata<br />
tentezza e insoddisfazione per questi figli, e feriti nella immagine di sé<br />
come genitori oblativi, compensativi di tutte le mancanze, i vuoti, le dissonanze<br />
della situazione naturale.<br />
La riconosco nel suo modo di parlare controllato e composto, quasi un<br />
fotografare una situazione senza poterla penetrare/interpretare così che tutto<br />
pare nascere dal niente, all’improvviso, del tutto inaspettato e inspiegabile.<br />
Il problema è A. (11 anni, la più piccola delle due sorelle) che è diventata<br />
ribelle e oppositiva, provocatoria e distruttiva verso tutta la vita familiare,<br />
dalla quale si esclude e che rigetta come non corrispondente ai propri<br />
desideri. Ha delle reazioni violente e incontrollate, lancia oggetti, li rompe,<br />
ma anche si ferisce negando dolore e bisogno di cure. Al di fuori di queste<br />
vere e proprie esplosioni, A. ha un atteggiamento apatico e annoiato, sempre<br />
sdraiata sul divano davanti alla TV. Loro non sanno più che cosa fare,<br />
a questo punto non le dicono più niente, pensano davvero che l’affidamento<br />
non possa andare avanti.<br />
L’impatto di queste comunicazioni sul gruppo è forte. Dietro questo suo<br />
racconto logico e composto, quasi freddo e distaccato, si sente un dolore<br />
sordo, nascosto e assolutamente taciuto, ma che pure arriva, si rivela attraverso<br />
certe smorfie e contratture del viso, come attraverso una sorta di grigia<br />
tristezza del suo sguardo; l’intensità degli affetti in campo tocca tutti e<br />
mobilita reazioni di comprensione e solidarietà.<br />
Le tensioni e gli scontri sono soprattutto con C., la madre affidataria,<br />
alla quale A. dice sempre di no e con la quale rifiuta ogni contatto e vicinanza;<br />
con il padre va un po’ meglio, ora lui è in pensione dunque più presente<br />
e disponibile, ma spesso A. rifiuta ogni aiuto e/o proposta che lui fa<br />
per sottrarla alla sua vuota apatia. Anche gli appuntamenti con la psicologa<br />
che la segue in terapia diventano pretesti per scenate di rifiuto e di propositi<br />
espulsivi/distruttivi verso la terapia stessa ed ogni altra cosa (la palestra<br />
come la scuola, una vacanza come gli impegni, le visite alla famiglia<br />
naturale come il legame con la famiglia affidataria).<br />
Il padre O. è meno esasperato, ma altrettanto impotente e frustrato,<br />
per entrambi i membri della coppia questa esperienza sembra proprio essere<br />
diventata più grande e complessa di quanto immaginato, va a toccare<br />
aree nodali di sé e della loro relazione.<br />
La moglie è sempre stata così dice O. “anche con i nostri figlioli... lei è<br />
rigida e prescrittiva, per lei tutto diventa qualcosa di concreto da risolvere<br />
e gestire con la logica e la praticità...”. Ma con A. la situazione è diventata<br />
davvero invivibile, anche la sua terapeuta è un po’ scoraggiata: A. salta<br />
spesso le sedute, è molto silenziosa e chiusa in se stessa. Stanno pensando<br />
di rinunciare a questo affidamento, “non è vita questa”!<br />
Vorrebbe esserci solo rabbia e voglia di sollevarsi da un peso, in questa<br />
comunicazione, ma io sento anche un dolore più profondo, l’interruzione<br />
dell’affidamento non sarebbe solo il fallimento di un’esperienza, c’è in gioco<br />
molto di più.<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009
L. Vallini: Dall’entusiasmo appassionato degli inizi ad una fiducia moderata 177<br />
Penso che l’attenzione è ancora messa solo sui singoli separatamente,<br />
prima L. ora A., mai la coppia; d’altra parte i sigg. G. sono così difesi, così<br />
poco accessibili..., chiedono interventi per le figlie affidate, ma non possono<br />
riconoscere un bisogno proprio, né concepire la possibilità di un lavoro su di<br />
sé, sui propri vissuti, le proprie dinamiche intime come co-autori della<br />
situazione che stanno vivendo, e neppure concepire la dimensione dello spazio<br />
psichico fra individui, per la costruzione di una “temporalità storica”,<br />
per riprendere la citazione da Anzieu (1976).<br />
A. era la coccolina di casa, con lei hanno potuto vivere anche le parti<br />
più regressive e infantili. Com’è possibile, mi domando, che questo tempo<br />
non abbia potuto fornire una base diversa (per es. da quella vissuta con<br />
L.) per poter fronteggiare la complessità del vivere quotidiano e la conflittualità<br />
del crescere? Anche con A – penso – come era per L., il discorso si<br />
è ristretto tutto nell’ambito dei buoni comportamenti... le regole... C’è<br />
qualcosa che sta fallendo ora nella funzione genitoriale, che non riesce a<br />
costituirsi come spazio e tempo trasformativo dell’esperienza; questo<br />
assetto affettivo relazionale della coppia perpetua il generarsi di situazioni<br />
esplosive, distorte e patologiche, che non possono che produrre una<br />
escalation di agiti.<br />
Sulla scia di queste impressioni/riflessioni nasce il mio pensiero di una<br />
terapia familiare come setting e strumento più idoneo per questa situazione;<br />
uno spazio ed un lavoro psichico che mentre definisce e struttura le singole<br />
individualità, focalizza l’attenzione sulla qualità e sugli stili delle relazioni<br />
e degli scambi. Un setting che prenda dentro per definizione (e non per<br />
bisogno) anche questa coppia, fornendo forse nella giusta dose la possibilità<br />
e il coraggio di guardare a se stessa e alle proprie modalità di funzionamento<br />
psichico.<br />
Ci vorrà un po’ di tempo perché questa indicazione possa essere preparata,<br />
offerta e praticata, ma alla fine va in porto. I sigg. G. sono ancora i<br />
genitori affidatari di L. e A., non certo perché la situazione sia diventata<br />
semplice o felice, ma forse perché si è potuto sostenere – garantire uno spazio<br />
per sopravvivere alle emozioni dolorose senza espellerle ... uno spazio<br />
per pensare.<br />
Riassunto<br />
Attraverso le fasi di un intenso lavoro di formazione e organizzazione di Servizi<br />
Territoriali per la Tutela del Diritto dei Bambini ad una Famiglia, l’articolo si propone<br />
di focalizzare la necessità di un lavoro di contenimento, elaborazione e sostegno<br />
di tutta l’esperienza dell’Affidamento Etero-Familiare.<br />
Viene riportata l’esperienza di lavoro con gruppi di genitori affidatari: essa non<br />
fa che confermare la grande complessità e la mancanza di soluzioni semplici nei casi<br />
di Affido, ma consente anche di maturare alcuni elementi negli affidatari affinché<br />
questo Provvedimento possa davvero esplicare tutta la propria efficacia.<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009
178 L. Vallini: Dall’entusiasmo appassionato degli inizi ad una fiducia moderata<br />
Parole chiave: Affidamento familiare, gruppi di famiglie affidatarie nelle istituzioni,<br />
integrazione nel corpo familiare, stallo esperienziale, patologia nella relazione.<br />
Bibliografia<br />
Anzieu D (1976). Il gruppo e l’inconscio. Trad. it., Roma: Borla, 1990.<br />
Ferruta A (2002). Uno spazio per alterità e estraneità. Riv. Psicoanalisi e Metodo, II/2002.<br />
Freud S (1919). Il Perturbante. OSF: 9. Torino: Boringhieri, 1977.<br />
Kuhn TS (1962). La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Trad. it., Torino: Einaudi, 1969.<br />
Moroncini B (2002). Tecnica dei trapianti e etica dell’ospitalità. Riv. Psicoanalisi e Metodo,<br />
II/2002.<br />
Winnicott D W (1949). Lo svezzamento. In: Il bambino e la famiglia (1957). Trad. it., Firenze:<br />
Giunti Barbera, 1973.<br />
Winnicott D W (1950). Ma come si fa a sapere che è vero? In: Bambini. Trad. it., Milano: Cortina<br />
1997.<br />
Lucia Vallini, Psicologa clinica, Psicoterapeuta, Membro Ordinario SIPsIA.<br />
Indirizzo per la corrispondenza/Address for correspondence:<br />
Via Volterrana, 17<br />
56020 La Serra (Pisa)<br />
E-mail: lucia<strong>vallini</strong>@virgilio.it<br />
<strong>Richard</strong> e <strong>Piggle</strong>, 17, 2, 2009