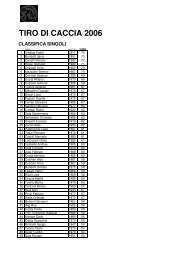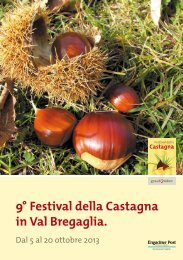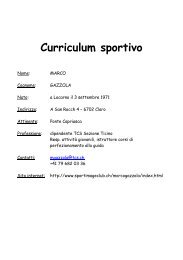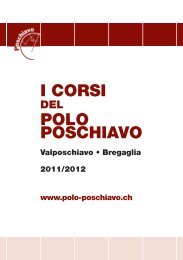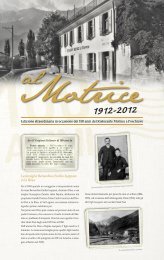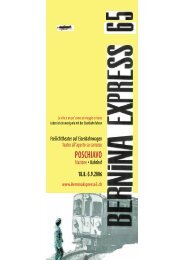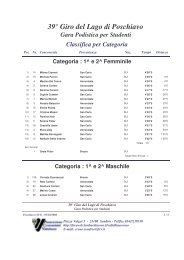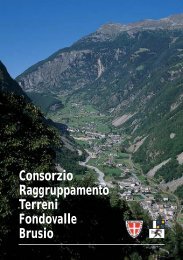Orfeo e Euridice - il bernina
Orfeo e Euridice - il bernina
Orfeo e Euridice - il bernina
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
libretto 8 spettacolo 05#136200 3-03-2006 8:38 Pagina 4<br />
concreto sullo strapotere dei cantanti,<br />
divi del belcanto virtuosistico in un<br />
assieme innaturale, poco preoccupato<br />
della verità drammatica. Essendoci di<br />
mezzo la musica, che di per sé naturale<br />
non è, la naturalezza poteva essere<br />
più o meno relativa.<br />
Per ottenerne una dose più abbondante<br />
Gluck e Calzabigi cancellarono<br />
parecchie convenzioni, ad esempio -<br />
fondamentale - la suddivisione in recitativi<br />
ed arie; soprattutto eliminarono i<br />
recitativi “secchi”, accompagnati soltanto<br />
dal cembalo e dal gruppo del<br />
“basso continuo” a favore di una continuità<br />
dove l’orchestra suona sempre,<br />
assume maggiore importanza e <strong>il</strong> coro<br />
si fa personaggio.<br />
Era una rivoluzione a metà, non ancora<br />
una vera riforma, anche perché erano<br />
mantenuti alcuni degli elementi più<br />
tradizionali e meno “naturali”: la lingua<br />
italiana, convenzionale nel melodramma<br />
serio imperante, la voce di<br />
soprano o di contralto (evirato) per un<br />
personaggio masch<strong>il</strong>e (<strong>Orfeo</strong>), la forma<br />
dell’aria con “dacapo”, però senza<br />
variazioni virtuosistiche, <strong>il</strong> modo maggiore<br />
in brani di intenzione non lieta (la<br />
famosa aria di dolore “Che farò senza<br />
<strong>Euridice</strong>”). Molto più di questo conta<br />
l’esser nato da quella intenzione un<br />
autentico capolavoro dove la semplicità<br />
nuova raggiunge i suoi scopi.<br />
Al momento non ci furono seguaci;<br />
Gluck stesso compose ancora qualche<br />
opera tradizionale. Perché <strong>il</strong> messaggio<br />
sia raccolto ad alto livello, occorrerà<br />
aspettare Cherubini, Spontini e<br />
Berlioz, dunque nell’ambito francese<br />
dove Gluck nel frattempo aveva riversato<br />
le sue ispirazioni sia nella nuova<br />
versione francese di <strong>Orfeo</strong> ed <strong>Euridice</strong><br />
(1764, con voce di tenore per <strong>Orfeo</strong>),<br />
sia nell’ Alceste (1776) - vero manifesto<br />
della “riforma” -, in Iphigénie en<br />
Aulide (1774), Iphigénie en Tauride<br />
(1779) e Armide (1777). Notevole fu<br />
lo scontro a Parigi tra i sostenitori di<br />
Gluck e quelli di Piccinni, chiamato<br />
come campione dello st<strong>il</strong>e italiano (lui<br />
invece cercò di battersi facendo in<br />
realtà <strong>il</strong> gluckiano).<br />
Poca fu l’influenza evidente su Mozart,<br />
forse nei cori dell’ Idomeneo; lui sapeva<br />
creare in alto senza abbandonare la<br />
via ricca di st<strong>il</strong>e italiano che gli permise<br />
i capolavori ben noti.<br />
Il tutto confluì nell’opera francese (poi<br />
grand-opéra), nel melodramma italiano<br />
intessuto di tradizioni e di novità, compresi<br />
Rossini, Donizetti e Verdi, fino a<br />
quel Wagner che, com’era naturale date<br />
le sue idee a loro volta riformatrici,<br />
ammirò moltissimo Gluck, ne scrisse, lo<br />
diresse e ne fece revisioni e integrazioni.<br />
alf. mand.