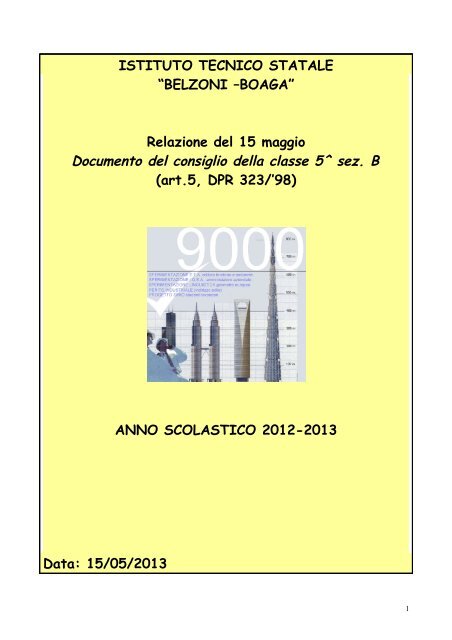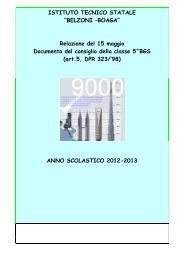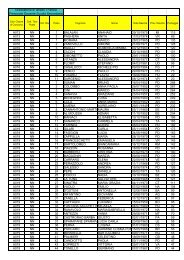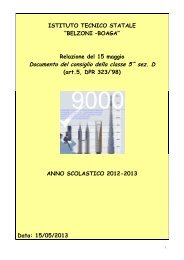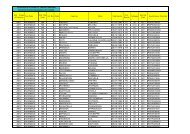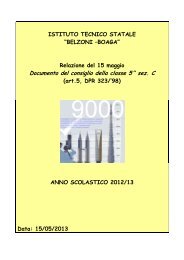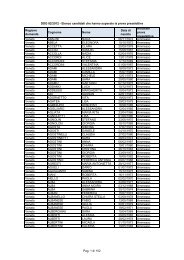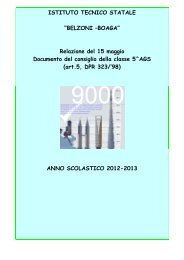Download - Istituto Tecnico Statale Belzoni Boaga
Download - Istituto Tecnico Statale Belzoni Boaga
Download - Istituto Tecnico Statale Belzoni Boaga
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ISTITUTO TECNICO STATALE“BELZONI –BOAGA”Relazione del 15 maggioDocumento del consiglio della classe 5^ sez. B(art.5, DPR 323/’98)ANNO SCOLASTICO 2012-2013Data: 15/05/20131
esterni accreditati e settimana di lavoro nel mese di febbraio presso studi di architettura oagenzie di compravendita)Il comportamento in quest’ultimo anno è apparso corretto dal punto di vista del rispetto dellenorme scolastiche e, più in generale, delle regole di convivenza civile. Il rapporto tra studenti,migliorato in questo ultimo anno scolastico, è stato determinato da un sufficiente clima dicorrettezza che ha favorito il regolare svolgimento delle lezioni. Metodo di studio, impegnodomestico e rielaborazione personale non sono stati per tutti adeguati e solo un gruppo dialunni è riuscito ad ampliare e approfondire i contenuti proposti nelle varie disciplinePer quanto riguarda i livelli medi di profitto appaiono, allo stato attuale, più che sufficienti.Alcuni alunni si sono distinti per risultati apprezzabili, altri hanno dimostrato poca puntualitànell’esecuzione dei compiti per casa e poca costanza nello studio. Vi è infine da segnalare unpiccolo gruppo di allievi che, pur partecipando all’attività didattica, presenta ancora lacunepregresse non pienamente colmate.2 – SVILUPPO DEI PROGRAMMI hannoI programmi non hannosubito rallentamenti.3 – METODOLOGIE E TECNICHE DI LAVORO - Moduli ed Unità didattiche - Lavoro di gruppo - Conversazione guidata - Lezione frontale - Stage - Attività pluridisciplinari - Problem-solving - Compresenza - Avviamento all’autovalutazione4 – STRUMENTI - Libro di testo - riviste specializzate ? - Audiovisivi4
- Attrezzature informatiche e multimediali - Appunti e dispense predisposte dal docente - Altro: fotocopie5 – VALUTAZIONE STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE - Interrogazione individuale frontale - Elaborato scritto - relazione orale - Riproduzione pratica di apprendimenti - Interrogazione di gruppo - Relazione scritta - Prova strutturata - Prova semistrutturata CRITERI DI VALUTAZIONELe normative vigenti, prevedono l’istituzione di percorsi individualizzati atti al passaggio initinere ad altri ordini di scuola, o ai C. F. P., o all’eventuale accesso all’<strong>Istituto</strong> da altreprovenienze, che consentano i passaggi di cui sopra e nello stesso tempo permettano didefinire percorsi individualizzati .Percorsi di questo genere hanno imposto una riflessione sul significato e sul valore degliobiettivi dei moduli, nella misura in cui concorrono alla formazione delle competenze.Le programmazioni modulari contengono sia obiettivi formativi socio – affettivi, sia obiettivicognitivi:• i primi vengono valutati collegialmente dai Consigli di Classe sulla base degli accordi assuntiall’inizio dell’anno, mentre la valutazione degli obiettivi cognitivi deriva dagli accordi assunti insede di Coordinamento per Materia, sia riguardo la definizione dei livelli minimi diaccettabilità, sia riguardo l’individuazione degli strumenti di misurazione.Gli obiettivi contenuti nei moduli sono per definizione minimi, tanto che:• il loro conseguimento parziale comporta attività di recupero, i cui esiti negativideterminano il debito formativo o addirittura la non promozione;Da quanto sopra esposto emerge comunque la necessità di individuare criteri generali divalutazione che consentano di formulare equi ed omogenei giudizi di fine corso. Perché ciò siareso possibile nel rispetto del principio di collegialità, previsto dalla normativa vigente, lavalutazione finale scaturisce dall’attenta considerazione:• dei livelli di partenza e dei percorsi individuali;5
• della motivazione allo studio ed al lavoro e del senso di responsabilitàLa valutazione formativa (in itinere) e quella sommativa, pur mantenendo caratteri distinti,sono interdipendenti e la prima comunque informa la seconda6- OBIETTIVI GENERALI FORMATIVIA) - GENERALI SOCIO-AFFETTIVIEducazione alla motivazione, allo studio ed al lavoro;Educazione al senso di responsabilità;Fornire agli studenti strumenti di “saperi” polivalenti e flessibili chepermettano di adattarsi rapidamente a diverse situazioni professionaliEducazione alla collaborazione ed all’impegno nel lavoro comune.Stimolare gli studenti a formarsi una personalità autonoma e sicuraB) – GENERALI COGNITIVIUso dei linguaggi specifici;Conoscenza e utilizzo delle tecnologie specifiche;Individuazione e creazione dei collegamenti;Riformulazione dei nuclei concettuali e delle acquisizioni individuali;Stesura di progetti.Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua stranieraUtilizzare in maniera consapevole e adeguata le nuove tecnologiestrumentali ed informatiche.7– RECUPEROMODALITA’ - recupero in itinereTutte le disciplineDISCIPLINE8 – ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTOn. Alunni Titolo Discipline coinvolte nell’esperienza1 Andrunache I prefabbricati Tecnologia delle costruzioni, storia, diritto2 Barison La fotografia futurista e il mondo contemporaneo Italiano, storia, topografia3 Candiago Effetti del sisma sugli edifici tecnologia delle costruzioni, costruzioni, diritto4 Crescente Recupero urbano dell’area delle ex caserme di via tecnologia delle costruzioni, topografia, dirittoChiesanuova con progetto stradale5 Dalla Torre Bonifica integrale: la fondazione di Sabaudia tecnologia delle costruzioni, estimo, storia6
6 D'Aniello La sicurezza nel cantiere: struttura e norme tecnologia delle costruzioni, costruzioni, diritto7 Giuffrida Dagli edifici rurale agli edifici per la produzione Storia, italiano, tecnologia delle costruzioniindustriale: il lingotto di Torino8 Goldoni Musica e contestazione giovanile negli anni ‘60 Storia, italiano9 Homcenco Atlantropa storia, topografia, costruzioni, estimo10 Martinello La casa del fascio di Rubano Storia, italiano, tecnologia delle costruzioni11 Mazzucato Il “movimento dei sette” Storia, tecnologia delle costruzioni12 Pilotto Ristrutturazione e riqualificazione energetica di un tecnologia delle costruzioni, costruzioni, estimoappartamento13 Pizzo La pianificazione urbanistica tecnologia delle costruzioni, estimo, diritto14 Sacconi Il miracolo cinese Storia, tecnologia delle costruzioni15 Segato Il carbonio tecnologia delle costruzioni, costruzioni16 Schiavon Isolamento tecnologia delle costruzioni, costruzioni, diritto17 Schivardi Gli anni Settanta a Padova Storia, italiano, tecnologia delle costruzioni, diritto18 Visentin L'edilizia popolare a Padova nel dopoguerra Storia, italiano, tecnologia delle costruzioni, diritto9 – ATTIVITA’ INTEGRATIVE AL CURRICOLO SCOLASTICO• Partecipazione a visite guidate e al viaggio d’istruzione:- Visita guidata a Biennale di architettura a Venezia- Visita guidata a cantiere di ristrutturazione del Palazzo del Bo'- Visita guidata ai ponti della città• Visione di proiezioni cinematografiche in sala:- Film documentario « Sfiorando il muro » di S. Giralucci• Partecipazione a manifestazioni, gare e concorsi culturali:EXPO Scuola (D’Aniello, Dalla Torre, Segato, Pilotto, Barison, Giuffrida)• Incontri di approfondimento con esperti:- Esodo giuliano e dalmata (prof.; Riflessi della guerra fredda in Germania (prof. K.Mueller); La memoria della Shoah (prof. Gadi Luzzatto Voghea); Gli anni Settanta:terrorismo, stragismo e riforme (M. Gotor); L'eccidio di Cefalonia attraverso latestimonianza diretta; Educazione alla legalità e cittadinanza attiva: incontro con itestimoni (P. Grasso e don Ciotti)- Prove tecniche di impresa: la stesura del curriculum vitae; Orientamento post diploma;Edilizia sostenibile; gli strumenti Urbanistici del territorio comunale (I. Rossi);- Educazione alla salute: prevenzione andrologica• Partecipazione a manifestazioni sportive:7
XI Torneo Internazionale di Tchouk ball allievi: D’Aniello, Dalla Torre, Segato, Barison,Giuffrida, Sacconi,Visentin10 - SCHEDE DISCIPLINARI CLASSE 5^ sez. BRELAZIONE FINALE DEL DOCENTEDocente Materia classe anno scolasticoFIORIANI MARIO RELIGIONE CATTOLICA 5 b 2012/13Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE ECAPACITA’Conoscenze :La classe in generale espone i contenuti trattati in modo globalmente corretto. Gli allievi dimostrano di averappreso in maniera più che soddisfacente gli argomenti proposti e che sono maggiormente vicini al lorovissuto, sensibilità ed interessi.Competenze :Gli studenti sono in grado di effettuare analisi parziali delle diverse tematiche affrontate.Capacità :La classe sa applicare le conoscenze acquisite in compiti semplici senza commettere gravi errori. Alcunisoggetti presentano una maggiore capacità critica nel rielaborare i contenuti acquisiti.Contenuti disciplinari([1]) in forma di unità didattiche, moduli o percorsi formativi, approfondimentiUnità didattiche e/o Percorsi formativi e/o– Moduli /ApprofondimentiConoscenza della classe e presentazione dell’ora di Religione e del programma annuale. 2IDENTITA’ DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI SUOI DOCUMENTI FONDANTI 2LA PRASSI DI VITA PROPOSTA DAL MESSAGGIO EVANGELICO 1LA CONCEZIONE CRISTIANO-CATTOLICA DELLA FAMIGLIA 4MATRIMONIO SECONDO LA CHIESA CRISTIANA CATTOLICA 2LA RELIGIONE NELLA SOCIETA DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE ALLA SOCIETA’Ore dedicateCONTEMPORANEALA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 2LE PROBLEMATICHE DEI RAPPORTI UMANI SECONDO LA VISIONE EVANGELICA 2ANALISI DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA MALATTIA – AL DOLORE – ALLAMORTEIL RAPPORTO TRA CHIESA E MONDO CONTEMPORANEO 2MORALE DELLA VITA PRIVATA – PUBBLICA –ETICA DEL CONPORTAMENTO SOCIALE 413Totale ore effettivamente svolte dal docente 25Metodologie didattiche seguite(lezione frontale, gruppi di lavoro, percorsi individualizzati, risoluzione di casi o problemi)Lezione frontale, dibattito, approfondimento personale con la lettura di testi. Questa metodologia usata si èmostrata efficace per una più immediata comprensione dei contenuti e per il coinvolgimento dei ragazzi nelleattività proposte.Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali, tecnologie ecc..)Testo adottato: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, vol. unico, ed SEI, Torino, 2003.Fotocopie fornite dal docente ad integrazione del testo.Aula multimediale: proiezione di documenti visivi.Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazioneverifiche orali in itinere e questionari scritti. La valutazione degli allievi ha tenuto conto della loropartecipazione alla vita scolastica, della disponibilità al dialogo, dell’impegno profuso e dei progressi nellivello di acquisizione di conoscenze e di abilità.ValutazioneCriteri, strumenti e metodi di valutazione8
(indicatori e descrittori dell’apprendimento; individuazione dei livelli, distribuzione dei punteggi;corrispondenze voto-giudizio)Gli studenti/esse saranno valutati secondo la tabella qui di seguito riportata:LIVELLO DICONOSCENZANessuna conoscenza degliargomentiConoscenza superficiale eframmentariaConoscenza argomentifondamentaliConosce e sa applicare icontenuti e padroneggia tutti gliargomenti senza erroriPadroneggia tutti gli argomentisenza erroriLIVELLO DI ABILITA'Non ha conseguito le abilità richiesteQualche abilità utilizzata conincertezzaVOTO AGGETTIVO1,2,3,4GravementeinsufficienteNOTA DIVALUTAZIONEGravementeinsufficiente5 Insufficiente InsufficienteAbilità nel risolvere problemi semplici 6 Sufficiente SufficienteDimostra abilità nelle procedure conqualche imprecisione. Organizzaautonomamente le conoscenze insituazioni nuoveAnalizza e valuta criticamentecontenuti e procedure; usa lamicrolingua in modo attento e correttoPadova 15 maggio 2013 doc. Mario Fioriani7/8Discreto/BuonoMolto9;10 Ottimo Moltissimo9
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTEDocente Materia classe anno scolasticoPaola Lega Italiano e storia 5B 2012-2013Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE ECAPACITA’OBIETTIVI MINIMI PREVISTI - ITALIANOa – IN TERMINI DI CONOSCENZEl’alunno deve dimostrare di conoscere in relazione a:- i movimenti letterari : il quadro storico-cronologico del periodo considerato, gli aspetti ideologici eculturali fondamentali ed i principali autori;- ciascuno degli autori più significativi : la biografia e il contesto storico-culturale, le diverse fasi di produzioneartistica e le principali opere, gli elementi fondamentali della poetica;- i generi letterari : i principali caratteri strutturali, alcuni esempi significativi di opere appartenenti al generee l’evoluzione nel tempo di alcuni temi e forme;- le caratteristiche formali : le principali strutture narratologiche (in particolare narratore, focalizzazione,tecniche di rappresentazione di pensieri e parole) e le principali figure retoriche (di suono, dell’ordine, di significato);- la produzione scritta: le procedure generali di stesura di un testo scritto (progettazione, pianificazione, stesurae revisione), le tipologie della prova dell’esame di stato e i loro aspetti strutturali.b – IN TERMINI DI CAPACITA’l’alunno deve essere in grado di:- collocare in modo corretto i movimenti culturali, gli autori e le opere letterarie nel loro contesto sto -rico-cronologico;- individuare i temi fondamentali di un testo mettendoli in relazione con la corrente letteraria e la poeticadell’autore;- riconoscere nei testi proposti le strutture del genere a cui appartengono;- riconoscere nei testi proposti le principali caratteristiche formali e stilistiche;- utilizzare modelli di scrittura derivati da altri testi (in particolare l’articolo di giornale).c – IN TERMINI DI COMPETENZEl’alunno deve essere in grado di:- operare collegamenti di carattere generale tra movimenti culturali e autori diversi, individuando elementidi continuità e differenze;- cogliere gli apporti personali e il punto di vista di un autore rispetto al contesto storico-culturale incui opera;- operare opportuni raffronti tra opere appartenenti allo stesso genere, individuando permanenze e variazioniin epoche e contesti letterari diversi;- produrre testi chiari, coerenti e conformi alle consegne;- utilizzare forme di scrittura diverse, in funzione delle diverse situazioni comunicative.OBIETTIVI MINIMI PREVISTI - STORIAa – IN TERMINI DI CONOSCENZEl’alunno deve dimostrare di conoscere:- termini e concetti fondamentali propri del linguaggio storiografico;- gli eventi principali dei periodi trattati e la loro collocazione cronologica;10
- le principali forme istituzionali, economiche, sociali relative ai periodi trattati;- le principali ideologie politiche relative ai periodi trattati.b – IN TERMINI DI CAPACITA’l’alunno deve essere in grado di:- usare con sufficiente proprietà termini e concetti propri del linguaggio storiografico;- collocare correttamente nel tempo e nello spazio gli eventi trattati;- evidenziare i nessi di causa ed effetto tra i fenomeni considerati;- riconoscere i legami tra fatti storici e mutamenti ideologici, economici e sociali.c – IN TERMINI DI COMPETENZEl’alunno deve essere in grado di:- operare collegamenti e raffronti tra fenomeni di epoche diverse;- sintetizzare i concetti appresi in modo coerente, enucleandone i nodi concettuali più significativi;- effettuare collegamenti e raffronti tra passato e presente.RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO NELLA CLASSELa classe, da me seguita negli ultimi due anni, è composta da 18 alunni e proviene interamente, dalla quartadell’anno passato.Per quel che riguarda l’approccio generale alle materie gli allievi si sono dimostrati sufficientementepartecipi o, comunque, diligenti e rispettosi. Il grado di attenzione durante le lezioni è stato in generesoddisfacente ma l'impegno a casa non è stato per tutti adeguato.Il livello della classe è mediamente sufficiente: un gruppo di alunni dimostra di aver acquisito conoscenze eabilità soddisfacenti, altri presentano qualche lacuna, un ultimo ristretto gruppo, infine, rivela ancoraproblemi connessi con un metodo di lavoro poco efficace (lo studio tende ad essere mnemonico e manca larielaborazione personale), lacune pregresse e difficoltà espressive, soprattutto nell’esposizione scritta.OBIETTIVI CONSEGUITI - ITALIANO• in termini di conoscenze: ad eccezione delle conoscenze relative alle caratteristiche formali dei testi (inparticolare le figure retoriche), in cui parecchi tuttora dimostrano incertezze, negli altri ambiti una partedella classe dimostra di aver raggiunto almeno gli obiettivi minimi e in qualche caso il livello è discreto.Alcuni presentano invece conoscenze un po’ lacunose o superficiali e pertanto non del tuttosoddisfacenti. L’ultima fascia è composta da qualche allievo il cui livello è decisamente scarso.• in termini di capacità: nella maggior parte dei casi gli allievi sono in grado di contestualizzaremovimenti, autori e testi, ma non appaiono ancora del tutto autonomi nell’analisi testuale e riescono acompiere tale operazione solo con la guida dell’insegnante. Per quanto riguarda la produzione scritta,non da tutti appaiono pienamente acquisite, neppure in linea teorica, le tecniche di utilizzazione deidocumenti e di redazione dell'articolo di giornale e del saggio breve.• in termini di competenze: in questo ambito si sono evidenziate le difficoltà maggiori. Molti allievi nonsono in grado di operare autonomamente collegamenti e raffronti e riescono a farlo solo se guidati daldocente. Una buona componente della classe, poi, incontra ancora difficoltà nel progettare e realizzareforme di scrittura funzionali alle varie situazioni comunicative utilizzando documenti dati. In molti casi,infine, l’esposizione scritta risulta poco corretta dal punto di vista formale.OBIETTIVI CONSEGUITI - STORIA• in termini di conoscenze: una parte della classe nel complesso ha raggiunto un soddisfacente livello dimemorizzazione e comprensione dei contenuti proposti; in particolare alcuni alunni si sono impegnaticon continuità conseguendo buoni risultati. In altri casi, in ragione di un impegno più scarso, le cono -scenze rimangono frammentarie e, talvolta, gravemente lacunose.11
• in termini di capacità: gli allievi che possiedono una sufficiente conoscenza dei contenuti sono anchein grado di compiere tutte le operazioni indicate, alcuni con una certa disinvoltura, altri limitandosi a individuarealmeno i caratteri peculiari dei periodi e dei fatti storici trattati.• in termini di competenze: solo una piccola parte della classe sa sintetizzare in modo coerente ed è ingrado di rielaborare in modo personale i contenuti appresi. La maggior parte degli allievi non è in gradodi operare autonomamente collegamenti e raffronti e riesce a farlo solo con l’aiuto del docente.Contenuti disciplinari in forma di unità didattiche, moduli o percorsi formativi, approfondimentiITALIANOTitolo moduloOreL’età del Positivismo (modulo su contesto) 6Giovanni Verga (modulo su un autore) 8Il simbolismo (modulo su genere): i poeti maledetti 6L’età del Decadentismo (modulo su un contesto) 4Giovanni Pascoli (modulo su un autore) 6Gabriele D'annunzio (modulo su autore) 6Luigi Pirandello (modulo su un autore) 8La coscienza di Zeno di Italo Svevo (modulo su un’opera) 6La poesia italiana tra le due guerre (modulo su un genere): Ungaretti e Montale 8La narrativa italiana dagli anni Venti agli anni Cinquanta (modulo su un genere) 4Il romanzo del dopoguerra: Calvino e la Morante 6Produzione di testi scritti 24Ore svolte al 4 maggio78Ore previste dopo il 4 maggio14TOTALE ORESTORIATitolo moduloL’età dell’imperialismo 6L’Italia nell’età giolittiana 6La prima guerra mondiale 6La rivoluzione russa 3Il fascismo in Italia 4I totalitarismi:nazismo e stalinismo 6La seconda guerra mondiale 4Il dopoguerra 6La guerra fredda e il bipolarismo 3L’Italia dalla ricostruzione agli anni Novanta 6Ore svolte al 4 maggio42Ore previste dopo il 4 maggio8TOTALE ORE 5092oreMetodologie didattiche seguiteB) Lezione frontaleC) Esercitazioni in classe e individuali per la stesura dei testi12
D) Esercitazioni in classe e individuali per la comprensione e l’analisi testualeE) Pratica (prevalentemente orale) del riassunto e della parafrasiF) Analisi e costruzione di mappe concettuali e schemiG) Eventuale visione e commento di materiali audiovisiviH) Lettura individuale di opere prevalentemente, ma non esclusivamente, di narrativaI) Produzione e presentazione di power pointSi è fatto principalmente ricorso alla lezione frontale per le spiegazioni di carattere generale su unargomento, stimolando comunque l’intervento degli alunni e la discussione.Per quel che riguarda l’italiano, la programmazione ha avuto carattere modulare e si è articolata mediante latrattazione di quadri storico – culturali di carattere generale per ogni periodo, su cui si sono poi innestati ivari moduli tematici (su generi o autori). In taluni casi il punto di partenza è stato offerto dalla lettura edall’interpretazione dei testi, effettuate in classe o individualmente. I concetti generali sono poi emersi comesintesi, guidata dall’insegnante, del materiale letto e utilizzato.Particolare attenzione è stata riservata alla produzione scritta, nell’ambito della quale sono state prese inconsiderazione tutte le tipologie delle prove d’esame, che sono state analizzate nei loro aspetti strutturali nelcorso di lezioni teoriche e, successivamente, oggetto di esercitazioni in classe o domestiche. Nel corsodell’anno sono state effettuate due simulazioni di prova d’esame, in cui sono state proposte agli alunni tuttele tipologie.Per quanto riguarda la storia, si è impostato lo svolgimento del programma seguendo la struttura del libro ditesto e approfondendo alcuni temi storiografici in esso contenuti.Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali, tecnologie ecc..)Libri di testo in adozione, principalmente per i testi: M. Magri V. Vittorini, Tre- Storia e testi dellaletteratura , vol. 3, Paravia,Fossati, Luppi, Zanette, Parlare di storia, vol 2 e 3, B. Mondadori;appunti e fotocopie fornite dall’insegnante, materiale multimediale, aula LIM.Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazioneProve scritte (due a quadrimestre), interrogazioni orali (due a quadrimestre), prove strutturate o semistrutturatealla fine di alcuni moduli di particolare rilevanza.Letteratura:domande aperte e chiuse sul programmaanalisi del testo oraliinterrogazioniScrittura:simulazione di 1° prova (2: una nel primo e una nel secondo quadrimestre)scrittura di testi secondo tipologia d’esameValutazionePer quanto riguarda i criteri generali di valutazione ci si rifà alle griglie di cui si allega copia.Nelle prove scritte di italiano, tipologie previste dall’Esame di stato, si è tenuto conto dei seguenti indicatori:correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana, capacità di costruzione di un discorso organico ecoerente nel rispetto delle tecniche di composizione adeguate alla tipologia testuale prescelta, pertinenza espessore del contenuto, capacità di rielaborazione e di offrire contributi personali e originali. Per lavalutazione di tali prove si utilizzerà la griglia in allegato.Nelle interrogazioni orali e scritte sono state considerate la pertinenza e la completezza delle risposte, lacorrettezza, la chiarezza e l’organicità dell’esposizione, la capacità di utilizzare un registro e un lessicoadeguati, la capacità di effettuare collegamenti, anche interdisciplinari, e di formulare giudizi personali.Attività integrativeConferenze su: La creazione del consenso nella Germania nazista (prof. Mueller); Foibe, pulizia etnica,esodo: la tragedia degli italiani del confine orientale (prof A.Ivanov), La memoria della Shoah (prof. Gadi-Luzzatto Voghera); L'eccidio di Cefalonia; Gli anni Settanta: stragismo e riforme incontro con Gotor;legalità e cittadinanza incontri con Grasso e don Ciotti; visione del documentario della Giralucci “Sfiorandoil muro”.13
MODULI( argomento generale)ITALIANO: PROGRAMMA SVOLTOSVILUPPO ANALITICO(argomenti/testi)TEMPIIl romanzo:caratteristiche e sviluppoIl Naturalismo franceseIl VerismoIl SimbolismoIl DecadentismoGiovanni PascoliGabriele D’Annunzio:Le caratteristiche generali; il romanzo storico; il romanzo socialeLa cultura positivisticaZola, Brano antologico del Romanzo sperimentale; De Goncourt,Prefazione a Germaine LecertauxGiovanni Verga: cenni biografici e il percorso letterario e la poeticaLettura ed analisi delle novelle:Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria;Novelle Rusticane: Libertà (confronto con Sciascia e letturaarticolo”La mistificazione di Verga in nome dell’arte e dellapatria”), La robaPrefazione a L’amante di GramignaLettura integrale de I Malavoglia (individuale con analisi in classe)Caratteristiche del simbolismo franceseanalisi delle seguenti liriche:Baudelaire, Albatro e Corrispondenze,Rimbaud, Vocali, Mallarmè, Brezza marina, Verlaine, Arte poeticaDefinizione e periodizzazionecenni biografici, percorso letterario e poetica; la poetica delfanciullinoAnalisi delle seguenti liricheMyricae:L’assiuolo, Il lampo, Il temporale, Novembre, X AgostoCanti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno.Settembre 3 oreSettembre 2 oreSettembreottobre 12 oreOttobrenovembre 6 oreNovembre 1 oraNovembredicembre 8 oreIl Futurismo e leavanguardieLuigi Pirandellocenni biografici, percorso letterario e poetica (estetismo, panismo esuperomismo);Analisi delle seguenti opere: Il Piacere (lettura di alcuni passisull’educazione dell’esteta) il romanzo decadenteda Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.Caratteri generali, lettura del Manifesto di Marinetti e delmanifesto di San’Elia sull’architettura futurista; espressionismo,surrealismo, dadaismo; i crepuscolaricenni biografici, percorso letterario e poetica; la poeticadell’umorismoNovelle per un anno:La signora Frola e il signor Ponza, La patente, Il treno ha fischiato,Lettura individuale e analisi in classe de “Il fu Mattia Pascal”Il teatro di Pirandello: lettura individuale di “Sei personaggi incerca di autore”.Dicembregennaio 8 oreGennaiofebbraio 5 oremarzo aprile 10oreItalo Svevo14
Cenni biografici, percorso letterario e poeticaAnalisi brani de’ “La coscienza di Zeno”La premessa del dottor S., Il preambolo di Zeno Cosini , Lapsicoanalisilettura integrale de Il Fumo (individuale)aprile6 oreLa poesia italiana nelNovecentoGiuseppe UngarettiEugenio MontaleLa narrativa italianapoesia pura e poesia metafisica; linea novecentista eantinovecentista; l'Ermetismocenni biografici, percorso letterario, l’innovazione stilisticaAnalisi de L’Allegria: I Fiumi , In Memoria, Il porto sepolto,Commiato,Veglia, Fratelli e Soldati.Cenni biografici, percorso letterario, la poetica dell’oggettoda “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola, Spesso il male divivere ho incontrato, I Limoni, Meriggiare pallido e assortoda “Le occasioni” : Non recidere forbice quel voltoda “Satura”: La storiaIl discorso di Montale alla consegna del Nobel (estratto)cenni sulle caratteristiche della narrativa tra le due guerre e diquella del secondo dopoguerra. Il Neorealismomaggio 2 oremaggio 2 oremaggio 4 oreMaggio 2 oreLa scrittural’analisi del testo: la tipologia A caratteristiche e modalità distesuraLa scrittura documentata. (Tipologia B: articolo di giornale;saggio breve)Caratteristiche fondamentali dell’articolo e del saggio breveAnalisi di articoli e saggi breviProduzione di testi (simulazioni prove d’esame)Tipologia Ce D: caratteristiche strutturali e modalità di stesura diun tema storico e di un tema di carattere generaleNel corsodell’annoscolastico16 oreMODULI( argomento generale)La società di massae l’imperialismoL’Italia liberaleSTORIA: PROGRAMMA SVOLTOSVILUPPO ANALITICO(argomenti)Che cos’è la società di massa; partiti moderni e ideologie(cattolici, socialisti); il nazionalismo; il sionismo e le teorierazziste dell’Ottocento.La nuova Italia e la Destra storica; il governo della sinistra e l’etàdi Crispi; il decollo industriale e la crisi di fine secolo; l’etàgiolittiana, il liberalismo incompiutoTEMPISettembreottobre4 oreOttobre 3 ore15
La Grande guerraLa rivoluzione russaIl FascismoNazismo e StalinismoTra le due guerreLa Seconda guerramondialeLa guerra fredda e ilbipolarismoL’Italia repubblicanaVerso la guerra: le cause; l’Italia dalla neutralità all’intervento; losvolgimento del conflitto; la svolta del 1917; l’Italia e il disastrodi Caporetto; i trattati di pace; l’eredità della guerra; l’economiamondiale tra sviluppo e crisiBolscevichi e menscevichi; La rivoluzione di febbraio; larivoluzione di ottobreI problemi del dopoguerra, cattolici, socialisti e nazionalisti, la“vittoria mutilata” e l’impresa fiumana; le agitazioni sociali e leelezioni del 1919; il fascismo agrario e le elezioni del ’21; lamarcia su Roma; verso lo stato autoritario; il delitto Matteotti; ilregime; la guerra di LibiaLa repubblica di Weimar; il regime nazista (incontro sullacreazione del consenso);L’unione sovietica negli anni ’20 e l’ascesa di Stalin; il regime diStalinLa crisi del 1929; il new deal americano; l’alternativademocratica: la Gran Bretagna e la FranciaVerso la guerra: Le aggressioni hitleriane e lo scoppio delconflitto; gli eventi e la svolta del 1942; l’Italia in guerra; laresistenza italiana;Il lungo dopoguerra; lo scenario politico; il mondo bipolare finoagli anni della distensione; la conferenza di Postdam, laconferenza di Yalta; il GATTLa ricostruzione; gli anni cinquanta e il miracolo economico;dagli anni Sessanta alla seconda repubblica.Novembre6 oreDicembregennaio 10 oreFebbraio marzo 6oreaprile 4 oremaggio 4 oreInterrogazioni di ripasso su tutto il programma svolto e presentazione lavori diapprofondimentoMaggioLavori diapprofondimentoGli alunni hanno approfondito individualmente e presentato inpower-point alla classe uno dei seguenti argomenti:primo quadrimestre: (la Grande Guerra) La guerra sottomarina;La spedizione punitiva; La battaglia degli altipiani; la disfatta diCaporetto; la battaglia di Vittorio Veneto; la battaglia di Ypres; Ilgenerale Diaz; il radioso maggio italiano.Secondo quadrimestre (il secondo dopoguerra):Nato e patto di varsavia : la politica dei blocchi contrapposti (finoal crollo del muro di berlino); Crisi di Berlino 1948-49 e secondacrisi del 1956; Guerra di corea 1950-53; La politica di KennedyVietnam e Cecoslovacchia: come USA e URSS hanno affrontatola crisi del sistema bipolare; I miti del 68; Il mondo postcoloniale: america latina; Movimento femmista e diritti delledonne; Il welfare svedese; Lo shock petrolifero del 1973; Nixonpolitica economica estera il low profile; Il crollo del muro diBerlino; il miracolo cineseNovembre emarzo-aprile16
CRITERI DI VALUTAZIONEVOTO(1/10) CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’1 Nessuna Nessuna Nessuna2 Gravemente errate,Non sa cosa fareNon si orientaespressione sconnessa3 Conoscenze frammentarie egravemente lacunose4 Conoscenze carenti, conerrori ed espressioneimpropria4 1/2 Conoscenze carenti,espressione difficoltosa5 Conoscenze superficiali.Improprietà di linguaggio5 1/2 Conoscenze complete conimperfezioni, esposizione avolte imprecisa6 Conoscenze complete, manon approfondite,esposizione semplice, macorretta6 1/2 Conoscenze complete, pocoapprofondite, esposizionecorretta7 Conoscenze complete, quandoviene guidato sa approfondire,esposizione corretta conproprietà linguistica8 Conoscenze complete,qualcheapprofondimento autonomo,esposizione corretta conproprietà linguistica9 Conoscenze complete conapprofondimento autonomo,esposizione fluida con utilizzodel linguaggio specifico10 Conoscenze complete,approfondite e ampliate,esposizione fluida con utilizzodi un lessico ricco eappropriatoApplica le conoscenze minimesolo se guidato, ma con gravierroriApplica le conoscenze minimesolo se guidatoApplica le conoscenze minimeanche autonomamente, ma congravi erroriApplica autonomamente leconoscenze minime con qualcheerroreApplica autonomamente leconoscenze minime conimperfezioniApplica autonomamente ecorrettamente le conoscenzeminimeApplica autonomamente leconoscenze anche a problemi piùcomplessi, ma con erroriApplica autonomamente leconoscenze anche a problemi piùcomplessi, ma con imperfezioniApplica autonomamente leconoscenze anche a problemi piùcomplessi, in modo correttoApplica in modo autonomo ecorretto anche a problemicomplessi le conoscenze: quandoguidato trova soluzioni miglioriApplica in modo autonomo ecorretto le conoscenze anche aproblemi complessi, trova da solosoluzioni miglioriCompie analisi errate, nonsintetizza, commette erroriQualche errore, analisiparziali, sintesi scorretteQualche errore, analisi esintesi parzialiAnalisi parziali, sintesiimpreciseImprecisioni, analisi corrette,difficoltà nel gestire semplicisituazioni nuoveCoglie il significato, esattainterpretazione di sempliciinformazioni, analisicorrette, gestione di semplicisituazioni nuoveEsatta interpretazione deltesto, sa definire un concetto,gestisce autonomamentesituazioni nuoveCoglie le implicazioni,compie analisi complete ecoerentiCoglie le implicazioni,compie correlazioni conimprecisioni, rielaborazionecorrettaCoglie le implicazioni,compie correlazioni esatte eanalisi approfondite,rielaborazione corretta,completa e autonomaSa rielaborare correttamente eapprofondire in modoautonomo e critico situazionicomplesse17
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTEDocente Materia classe anno scolasticoEmanuela Rossi Lingua e Civiltà Inglese 5B 2012/13OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITICONOSCENZE- Conoscere le strutture grammaticali, le funzioni comunicative e le nozioni spazio/temporali in modoessenzialmente corretto- Conoscere la microlingua tecnica delle materie d’indirizzo, avendone assimilato i contenuti ed i temiin L1 nelle singole discipline- Conoscere l’uso del dizionario bilingue.Gli obiettivi nel livello soglia dello standard minimo si possono dire raggiunti dalla totalità deglistudentiCOMPETENZE- Saper utilizzare con sufficiente padronanza le strutture linguistiche approfondite in conversazioni suargomenti relativi al settore di indirizzo specifico- Saper produrre in modo elementare ma con sufficiente correttezza, pur in presenza di alcuni errorinon gravi, testi orali e scritti legati all’ambito settoriale, utilizzando il linguaggio specifico delladisciplina con accettabile precisione terminologica- Saper leggere e capire in modo globale testi e messaggi orali riguardanti problemi di attualità nonchédi carattere specifico, rispondendo a domande in modo comprensibile e con accettabile pertinenza,pur in presenza di qualche errore- Saper cogliere le idee principali di un testo e alcuni dettagli e collegare le idee generali con l’uso diconnettori in un semplice riassunto del testo stesso- Saper trasporre in lingua italiana con accettabile precisione testi scritti su argomenti di attualità dicarattere generale, scientifico e tecnologico.Gli obiettivi nel livello soglia dello standard minimo si possono dire raggiunti da tutti gli studenti. Inparticolare, le competenze legate alle abilità recettive sono state maggiormente interiorizzate mentre leabilità produttive,sia nello scritto che nell’orale, sono risultate maggiormente difficili da raggiungere:il30% del gruppo le ha raggiunte a livelli discreti,pur rimanendo, in alcuni casi, una inadeguataaccuratezza grammaticale, la rimanente parte a livelli di sufficienza/quasi sufficienza , così come sonodefiniti dalla griglia di valutazione del Dipartimento d’Inglese d’<strong>Istituto</strong> riportata in seguito.E’ da tenere in considerazione il fatto che, in questo Indirizzo di Studio, sia nel quarto che nel quintoanno , solo due ore sono dedicate alla lingua straniera.CAPACITA’• Saper esprimere valutazioni in modo talvolta personale sugli argomenti, utilizzando in modoessenzialmente corretto le conoscenze acquisite e mettendole in relazione tra di loro all’interno dellediscipline di riferimento con sufficiente efficacia.L’obiettivo è stato raggiunto da circa il 20% degli studenti.CONTENUTI del PROGRAMMA e SCANSIONE MODULAREMODULO 1 Ripasso e rinforzo – Building Materials – Public WorksBuilding Materials: natural materials and man-made materials; sustainable materials –Public Works: Bridges: structural principles; bridge types; Roads: road pavement, roaddesign and construction - Energy Efficient HomesSettembreOttobre11 oreMODULO 2Town Planning18
The City of the Past: Cities of Ancient Lands- The ancient Greek City - The Classic City– The Roman City – The Medieval Town – The Neo-Classic City – The Baroque City –The Industrial CityOttobreNovembreDicembre8 oreThe City of the present: The loss of human dimension in modern cities – Functions andGoals of the Master Plan – The Garden City - Ideal CitiesMODULO 3Architectural StylesGreek Architecture – Roman Architecture: building materials, design, temples, theatresand amphitheatres, residential architecture – Romanesque Architecture – GothicArchitecture - Renaissance Architecture - Baroque Architecture-Neoclassicism-Regency ArchitectureDicembreGennaio6 oreGennaioFebbraioMarzo13 oreMODULO 4Masters of ArchitectureTwentieth century Architecture: Art Nouveau,Bauhaus,Organic architecture,Deconstructivism, High-Tech –Post-ModernismMasters of Architecture:Antoni Gaudì – Le Corbusier – Frank Lloyd Wright – FrankGehry – Renzo Piano*- Richard Rogers* - Norman Foster*MarzoAprileMaggio15 oreCurriculum Vitae: how to write a good CV – The European Curriculum Vitae∗Ripasso e approfondimenti ∗Ore effettivamente svolte nell’intero anno scolastico∗ L’asterisco indica gli argomenti che si prevede di affrontare dopo il 4 maggioMaggio2 oreMaggioGiugno6 ore61 oreMETODO DI LAVOROL’analisi del testo è stato lo strumento fondamentale per la riflessione su ogni parte del sistema linguistico.L’abilità comunicativa è stata stimolata con particolare riguardo al settore di specializzazione ed è statamirata all’acquisizione di un bagaglio di termini specialistici. L’abilità di scrittura è stata sviluppataattraverso il riassunto o la composizione di brevi testi di carattere specialistico e attraverso la rielaborazionedi appunti o key sentences estrapolate da altri testi.Le attività adottate sono state il pair-work, il group-work. L’approccio ai testi, e così pure alle discussioni, èavvenuto tramite la presentazione di griglie, rappresentazioni grafiche, questionari, slides, foto, immagini.Nel primo quadrimestre sono state effettuate 10 ore curricolari di potenziamento linguistico in compresenzadi una lettrice di madrelingua inglese. Attraverso l’approccio con un parlante nativo, gli studenti hanno avutola possibilità di mettere alla prova la padronanza dei propri strumenti espressivi e di comprensione e dimotivare maggiormente il loro atteggiamento verso la disciplina.Durante tutto l’anno scolastico hanno avuto largo spazio le attività di esercitazione ai fini di comprendere ilsignificato generale di testi descrittivi (comprensione), di praticare la ricerca di alcune informazioni precise eparticolari (analisi) e riformulare parole e concetti. Da queste hanno preso avvio le attività di relazionescritta ed orale sugli argomenti di indirizzo.19
STRUMENTI DI LAVOROLibro di testo in adozione: Ilaria Piccoli, A Brick in the Wall, editrice san marco; dizionario bilingue;materiale autentico riguardante argomenti tecnici o di attualità; materiale da web;presentazioni in powerpoint; fotocopie da altri testi di microlingua settorialeTIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATESono stati effettuati due tipi di verifica : formativa e sommativa. La verifica formativa è stata attuatamediante il controllo delle attività assegnate, prove strutturate e semistrutturate, questionari, brevi domandeper valutare il grado di preparazione del singolo e della classe.Le verifiche sommative sono state effettuate attraverso due colloqui orali e tre prove scritte nel primoquadrimestre, due prove orali e quattro prove scritte nel secondo quadrimestre ( tre di queste sono statesimulazioni di terza prova)Le verifiche orali si sono basate essenzialmente sulla comprensione e analisi di testi di carattereprofessionale, su domande a risposta aperta o brevi esposizioni su argomenti di micro lingua affrontati.Per quanto riguarda le verifiche scritte sono state somministrate varie tipologie di prove : domande dicomprensione di un testo proposto, quesiti a risposta singola, prove semistrutturate, trattazione sintetica diargomenti.VALUTAZIONEPer la valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti indicatori:• Conoscenza dei contenuti• Comprensione dei testi• Pertinenza della risposta• Appropriatezza lessicale, correttezza grammaticale ed ortograficaPer il colloquio orale:• Pertinenza delle informazioni• Chiarezza espositiva• Correttezza formaleSi è fatto uso della seguente scala di valutazione corrispondenza livelli-voti in termini diJ) CONOSCENZEK) COMPETENZEL) CAPACITA’Giudizio Voto Descrizione livelliNEGATIVO 1-3 1 Non possiede le nozioni più elementari2 E’ totalmente incapace di cogliere il senso globale3 E’ totalmente incapace di affrontare una situazione comunicativaSCARSO 4 1 Non sa riconoscere le funzioni degli elementi di base2 Non comprende il senso globale né della forma né del contenuto3 Non riesce a utilizzare le conoscenze né le competenzeINSUFFICIENTE 5 1 Conosce in modo frammentario e lacunoso2 Comprende in maniera generica il senso globale, ma ha difficoltànel cogliere il senso specifico3 Utilizza in modo frammentario le conoscenze e le competenzeacquisiteSUFFICIENTE 6 1 Conosce in modo essenzialmente corretto le nozioni e le funzioni2 Coglie il senso globale e anche alcuni aspetti particolari3 Utilizza in modo elementare ma corretto le conoscenze e lecompetenze20
DISCRETO 7 1 E’ in possesso delle conoscenze nei vari ambiti e sa orientarsi2 Coglie il senso globale e gli aspetti particolari dei fenomeni3 Sa utilizzare le conoscenze e le competenze in modo corretto eprecisoBUONO 8 1 Conosce in modo chiaro e dettagliato dimostrando scioltezza esicurezza2 Coglie perfettamente e autonomamente il senso globale e gliaspetti particolari3 Utilizza le conoscenze in modo preciso e completo e le sarielaborareOTTIMO 9-10 1 Conosce e approfondisce in modo personale gli elementi2 Comprende in maniera completa e approfondita e si appropria delleconoscenze in maniera precisa e personale3 Utilizza le conoscenze in maniera precisa e completa,rielaborandole in altri contesti con valutazioni personali.Per la valutazione delle simulazioni di terza prova si è fatto uso della seguente griglia:I.T.S.G. “G.B.<strong>Belzoni</strong>-<strong>Boaga</strong>” Padovaa.s. 2011/2012GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVAdegli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superioreLINGUA INGLESECANDIDATO: CLASSE 5 AGIUDIZIO PUNTIScarsoGravi lacune13Conoscenze degli argomentiQualche lacuna5.5Sufficiente6.5BuonoOttimo e approfondito78ScarsoInsufficiente11.5Competenza linguistica e uso del linguaggio tecnicoQuasi sufficiente2Sufficiente2.5BuonoOttimo34Capacità argomentativa e di collegamento delle conoscenzeInsufficienteSufficienteBuono0.512Capacità di rielaborazione critica Personale 1PUNTEGGIO COMPLESSIVO /1521
Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo dei risultati delle prove, ma anche dell'impegno,dell'interesse, della volontà, del grado di partecipazione al dialogo educativo, senza tuttavia prescindere dalraggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.4 maggio 2013 Prof.ssa Emanuela Rossi<strong>Istituto</strong> <strong>Tecnico</strong> <strong>Statale</strong> per Geometri “<strong>Belzoni</strong>” - PadovaAnno scolastico: 2011/2012Materia: Lingua IngleseInsegnante: Emanuela RossiProgramma svoltoModule 1 Revision - Building Materials – Public WorksBuilding materials: natural and man-made materials. Sustainable materialsEnergy-efficient HomesPublic Works: Bridges. Origins. Structural Principles. Bridge TypesRoads: Road Pavement. Road design and constructionModule 2 Town PlanningThe City of the Past: The Ancient Greek City. The Classic City. The Roman City. The Medieval Town.The Neo-Classic City. The Baroque City. The Industrial City. ( materiale in fotocopia)The living environment: the Garden City ( fotocopia )The City of the Present: The modern city and the loss of human dimensions. City Planning. ZoningOrdinances and Master Plans.Ideal Cities: Howard, Wright, Le Corbusier ( fotocopia )Module 3 Architectural StylesGreek Architecture : temples. Roman Architecture: building materials, design, temples, theatres andamphitheatres, residential architecture. Romanesqe Architecture. Gothic Architecture. RenaissanceArchitecture. Baroque Architecture. Neoclassicism. Regengy ArchitectureModule 4 Masters of ArchitectureIntroduction.: Modern and Contemporary Architecture. Masters of Architecture: Antoni Gaudì: Casa Calvet,Park Guell, Casa Batllo, Casa Milà, Temple de la Sagrada Familia. Le Corbusier: Ville Savoye, UnitéD’Habitation. Frank Lloyd Wright: Robie House, Falling Water, The Guggenheim Museum in New York.Frank Gehry: the Guggenheim in Bilbao. Renzo Piano: the Pompidou Centre, Maison Hermès. RichardRogers: Lloyd’s of London, The Millennium Dome. Norman Foster (fotocopia)How to write a good Curriculum Vitae ( fotocopia )Testo in adozione: Ilaria Piccoli, A Brick in the Wall, editrice san marco22
Docente Materia classe anno scolasticoClaudia Nizzola costruzioni 5°B 2012-2013presentazione della classeGli studenti della classe sono dotati nel complesso di normali capacità, in genere abbastanzainteressati alla materia e partecipi al dialogo educativo, anche se non tutti si applicano con costanza.L'apprendimento degli studenti è accettabile, anche se non tutti hanno raggiunto una preparazionesufficiente; ci sono anche risultati di livello soddisfacente.Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe in termini di CONOSCENZE,COMPETENZE E CAPACITA’Conoscenze Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettarli e dimensionarlicorrettamente; Conoscere le principali caratteristiche meccaniche dei materiali da costruzione e le tecnicheesecutive, sapersi orientare nella progettazione strutturale di una costruzione, sia essa un edificio oun muro di sostegno , un ponte o un’opera idraulica; Saper disegnare, leggere, interpretare correttamente le rappresentazioni esecutive di elementistrutturali; Valutare un’opera progettata, attraverso la redazione del computo metrico estimativo; Conoscere la problematica relativa al problema della sicurezza nei cantieri; Conoscere le basi dell’uso del PC , con l’utilizzo di programmi dedicati come Autocad , excel eword, saper navigare in internet.Nella classe quasi tutti gli alunni hanno raggiunto questi obiettivi ( 80%).Abilità saper adottare le soluzioni più valide nella progettazione strutturale di una costruzione, sia essa unedificio o un muro di sostegno , un ponte o un’opera idraulica; conoscere le idee che stanno alla base dei problemi teorici, anche se non sempre si potrannosviluppare dal punto di vista matematico, perché troppo complesse.Nella classe solo una parte degli alunni hanno raggiunto questi obiettivi (60%).Competenze• comprendere il comportamento statico di una struttura ,e, nel dimensionamento e nel calcolo, sapervalutare le possibili soluzioni adottando quella più opportuna in relazione ai costi .• sapersi destreggiare agevolmente nell’uso del PC , con l’utilizzo di programmi dedicati comeAutocad word, excel, nella navigazione in internet .• Sviluppare capacità di sintesi e di analisi , paragonando ed integrando le conoscenze ottenute datutte le discipline.Nella classe solo alcuni alunni hanno raggiunto questi obiettivi (30%).Obiettivi formativi e non cognitivi e modalità operative per il conseguimento Nel corsodell’anno sono stati perseguiti i seguenti obiettivi formativi:• Saper tenere un atteggiamento corretto verso le persone e rispettoso delle cose, apprendere la civileconvivenza nei rapporti interpersonali con le varie componenti operanti nell’ambito scolastico, nelrispetto delle idee degli altri ed esprimendo pacatamente le proprie;• L’educazione alla collaborazione ed alla solidarietà;• La capacità di relazionarsi nel lavoro di gruppo;• Lo sviluppo della capacità di rispettare gli impegni;• L’educazione alla legalità ed al rispetto delle regole;• L’acquisizione di elementi indispensabili per un ordinato metodo di studio;• Lo sviluppo di competenze nella comprensione dei testi e delle letture;23
• Saper utilizzare in maniera consapevole, adeguata e creativa le nuove tecnologie informatiche,trasversalmente rispetto alle discipline di studio;• Saper organizzare le informazioni, confrontare i fenomeni, riconoscere le relazioni significative, peressere sempre in grado di trovare soluzioni nuove a problemi nuovi, in una realtà in continuocambiamento;• La versatilità e la propensione culturale al continuo aggiornamento.Contenuti disciplinari 1 in forma di unità didattiche, moduli o percorsi formativi,approfondimentiUnità didattiche e/o Percorsi formativi e/o– Moduli /Ore dedicateApprofondimenti1 il calcestruzzo armato – completamento – metodo semiprobabilistico agli stati 24limite2 Progetto strutturale e pc 263 Contabilità dei lavori 184 Sicurezza nei cantieri 165 Muri di sostegno 306 Costruzioni idrauliche 267 ponti 208 Strutture a grandi luci 8Totale ore effettivamente svolte dalla docente 168Metodologie didattiche seguiteSi è impostato il lavoro puntando su quanto acquisito negli anni precedenti, approfondendo l’aspettocantieristico-pratico della materia e organizzando in pratica tutti i concetti fondamentali, per dareuno strumento versatile che permetta agli alunni di destreggiarsi di fronte a problematiche simili.Sono state adottate di volta in volta diverse strategie metodologiche, attraverso la lezione frontale,seguita dallo sviluppo di esercizi alla lavagna, ma anche nel confronto tra pari organizzati in gruppidi lavoro.Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali, tecnologieecc..)La materia è stata trattata in modo applicativo. Largo spazio è stato dato agli esercizi in classe diproblemi diretti e inversi per costringere l’alunno al ragionamento.Le lezioni del mese di giugno verranno dedicate al ripasso del programma.Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazioneProve scritte del tipo “problem solving” : una al meseProve orali : ( colloquio) : 2 al quadrimestreEsercitazioni: redazione di elaborati progettuali grafici e tecnici.Da febbraio: esercitazioni in vista della terza prova scritta d’esameRecupero: non è stato necessario.Valutazione124
votoLivello diValutazioneapprendimento10 Eccellente Conoscenza ottima, comprensione approfondita,rielaborazione originale e critica con apportiinterdisciplinari, espressione ricca, articolata eprecisa.9 Ottimo Conoscenza coordinata e ampia, comprensioneapprofondita, espressione fluida e sicura,inquadramento dei contenuti in un ampio contestodi collegamenti anche interdisciplinari e sintesipersonali.8 Buono Conoscenza completa, comprensione di tutti gliargomenti trattati, espressione appropriata conadeguata padronanza delle terminologiespecifiche, analisi chiare e sintesi organiche.7 Discreto Apparato informativo sostanzialmente completo,comprensione corretta con limitinell’approfondimento, espressione appropriata manon sempre precisa nell’uso delle terminologiespecifiche, apprezzabili capacità di analisi e6/7 Più chesufficientesintesi.Conoscenza puntuale dei contenuti fondamentali,comprensione consapevole degli elementi nodali,sufficiente proprietà di linguaggio, analisi correttama non approfondita, sintesi accettabili, anche sesemplificate.6 Sufficiente Conoscenze limitate agli elementi basilari,comprensione essenziale, espressione correttama elementare, analisi non approfondite emodeste, ma orientate abilità di sintesi.5/6 Non del tuttosufficienteConoscenza non completa degli elementifondamentali , comprensione approssimativa,espressione non sempre chiara e corretta, analisisuperficiali e sintesi non sempre adeguata.5 Insufficiente Conoscenza superficiale e mnemonica,comprensione approssimativa, espressionespesso poco chiara e corretta, analisi parziali esintesi difficoltose.4/5 Nettamenteinsufficiente4 Gravementeinsufficiente3 /4, 3e 2/3NegativoConoscenza frammentaria, espressione limitata,scarsa proprietà di linguaggio, analisi parziali escorrette, sintesi confuse.Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti,comprensione marginale, espressione scorretta,confuso il lavoro di analisi e sintesi.Conoscenza di qualche nozione isolata e priva disignificato; le risposte presentano qualche aspettoapparentemente positivo, derivante dacoincidenze, fraintendimenti, casualità, plagi,suggerimenti.2 del tuttoConoscenza nulla, risposte prive di significato,negativoincomprensibili, incoerenti, illeggibili.1 nullo L’alunno rifiuta di svolgere la prova o non forniscerisposte.E’ stata seguita la griglia di valutazione soprariportata.Di seguito vengono riportati i “saperi minimi” per il raggiungimento di una preparazionesufficiente:M) compilare computi metriciN) calcolare semplici sezioni in c.a.O) saper calcolare un muro di sostegnoP) saper calcolare semplici passerelle pedonaliQ) conoscere i concetti fondamentali dell’idraulicaPROGRAMMA MODULARE SVOLTOIl programma previsto è stato rispettato nei contenuti e nei tempi.25
Primo quadrimestreMODULO n.1 IL CALCESTRUZZO ARMATO : COMPLETAMENTO – calcolosemiprobabilistico agli stati limiteProgetto, verifica e collaudo di travi in altezza, in spessore solaio, in semplice e doppia armatura.Dimensionamento e verifica di solai in latero-cemento, con il metodo delle tensioni ammissibili.Diagramma di momenti resistenza e taglio dei ferri. Progetto e verifica a taglio. Fondazioni concalcolo dell’armatura. Disegno esecutivo.Analisi di carico secondo la teoria degli stati limite. Calcolo di verifica di pilastri e travi in semplicearmatura con la teoria degli stati limite.MODULO n.2 PROGETTAZIONE STRUTTURALE E PCcalcoli strutturali manuali di solai su semplice appoggio ed in continuità in c.a., travi ed architravi insemplice appoggio, pilastri, con l’analisi dei carichi, il dimensionamento delle sezioni e dellearmature e le verifiche complete delle sezioni a momento e a taglio, nonché la rappresentazione deidiagrammi di momento resistente. Predisposizione di semplici programmi in excel dei calcolistrutturali ( metodo tensioni ammissibili)MODULO n.3 : CONTABILITA’ DEI LAVORIFigure tecniche in edilizia - compito del progettista ,del direttore dei lavori, del collaudatore -permesso di costruire e DIA - procedure per l’ottenimento del loro permesso, documentazione perla presentazione di un progetto . Computo metrico estimativo - analisi dei prezzi - capitolatid’appalto - contratti di appalto - verbali - varianti - revisioni - contabilità dei lavori - collaudostatico ed amministrativo. Stesura dettagliata del computo metrico di un piccolo fabbricatoresidenziale, con particolare attenzione rivolta alla scelta delle voci di capitolato. Guida allaconsultazione del prezziario edile della provincia di Padova: classificazione delle voci di elencoprezzi . Le scelte tipologiche del progettista nella stesura del computo metrico.MODULO n.4 : LA LEGGE 494/96 SULLA SICUREZZA DEI CANTIERILa problematica della sicurezza dei cantieri : compiti e responsabilità delle nuove figure tecnicheistituite dalla legge, il piano della sicurezza, il fascicolo dell’opera, il POS. Coordinatore per laprogettazione e per l’esecuzione nella sicurezza dei cantieri edili. Problema della caduta dall’alto.Le attrezzature e i DPI all’interno del cantiere edile, i ponteggi etc.MODULO n.5: MURI DI SOSTEGNOSpinta delle terre : attiva e passiva - angolo di natural declivio e angolo di rottura- la teoria diCoulomb- calcolo del coefficiente Ka- dimostrazione con superficie orizzontale e paramentoverticale- spinta dei terreni immersi in acqua - spinta con terreni di diversa natura - spinta consovraccarico - formula generale di Coulomb con parametri qualsiasi - esercitazioni: muri a gravità aparete verticale e terreno immerso in acqua , con sovraccarico, con strati di terreno concaratteristiche diverse; muri a gravità con intradosso ed estradosso inclinati; muri a gravità conparamento obliquo, terreno inclinato ed angolo di attrito terra-muro con il calcolo del Ka con laformula di Coulomb generalizzata; muro a gravità con fondazione esternaPareti di sostegno e tipologia di calcolo - verifiche a ribaltamento, scorrimento, schiacciamento,slittamento terra-muro ( verifica grafica con individuazione del cerchio critico)- progetto e verificadi muri di sostegno a gravità rettangolari e trapezi , disegni esecutivi - progetto e verifica di muri disostegno in c.a. a sbalzo, con calcolo dell’armatura della parete e della fondazione , disegniesecutivi, con il diagramma dei momenti resistenti. Esercizi applicativi. Dimensionamento di muridi sostegno a scorrimento con l’inclinazione della base della fondazione: individuazionedell’angolo, progetto e verifica per i muri a gravità ed in c.a..Secondo quadrimestreMODULO n.6 : COSTRUZIONI IDRAULICHEgeneralità - idrostatica - principio di Pascal - pressione idrostatica e spinta idrostatica nel caso diparete verticale, orizzontale ed obliqua ; pareti di vasche soggette a pressioni idrostatiche - principiodi Archimede - sottopressioni -calcolo di argini , verifiche di stabilità - pareti di contenimento inc.a. : vasche fuori e dentro terra, scelta del carico più gravoso in relazione al calcolo delle armature -dimensionamenti. Idrodinamica - ipotesi semplificative della scienza sperimentale - portata di unacorrente - equazione di continuità - dimostrazione della equazione di Bernoulli ideale e reale-calcolo delle perdite localizzate e distribuite per le condotte in pressione: verifica della portata o26
della velocità con tubazioni di vari materiali ; canali a pelo libero - formula pratica per il calcolo:verifica di canali di scolo a sezione rettangolare e trapezia, con richiesta di portata e di pendenza.Tipologie dei canali in relazione al loro utilizzo ed alla consistenza delle loro pareti.Impianti di acquedotti e di fognatura, depurazione.MODULO n.7: I PONTIGeneralità - tipologie dei ponti - analisi dei carichi - carichi mobili - distribuzione dei carichi sullasoletta - ponti in legno con trave principale a campata unica . Calcolo di passerella pedonale inlegno.MODULO n.8: STRUTTURE A GRANDI LUCIEsame della tipologia a grandi luci in c.a. Sviluppo di progetto di autofficina.Dopo il 15 maggio:ripassoVISITE E USCITENel corso dell’anno scolastico :R) Visite a cantieriS) Curriculum vitaeT) Visita alla Cassa di risparmio.COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARICon tecnologia delle costruzioni è stato curato il progetto di una autofficina.Il docenteProf. Claudia NizzolaI rappresentanti degli studentiDocente Materia classe anno scolasticoDino Calore Topografia 5°B 2012-2013COMPOSIZIONE DELLA CLASSELa classe è composta da 18 alunni, tutti maschi. Gli allievi nel corso del corrente anno scolastico hannomantenuto un comportamento corretto, anche se non sempre disponibili nelle relazioni interpersonali.La classe si è dimostrata un po’ alterna nella partecipazione e nell’attenzione alle lezioni, infatti è statonecessario richiamarla affinché l’impegno e l’applicazione fossero più adeguati. Complessivamente unamaggiore attenzione e concentrazione in aula avrebbero certamente giovato per ottenere risultati piùsoddisfacenti. In una parte degli alunni si sono rilevate alcune lacune nella preparazione dei programmiprecedenti; tuttavia nel corso del presente anno scolastico hanno evidenziato un miglioramento, dimostratonelle frequenti prove, sia orali che scritte.OBIETTIVIObiettivi dell’anno scolastico 2012/2013 sono quelli di conseguire le conoscenze tecniche per:U) comprendere le tecniche per valutare i lavori per la sistemazione di terreni con piani orizzontali einclinati con o senza compenso;V) la redazione di una progettazione stradale;W) l’esecuzione di divisioni di aeree e rettifiche dei confini in terreni di eguale valenza analizzandole casistiche che più frequentemente si possono presentare nello svolgimento di una attivitàtecnico-professionale.CONOSCENZE27
L’alunno deve conoscere le più importanti nozioni tecniche per la redazione di un progetto stradale, di unospianamento con piano orizzontale, di un calcolo e divisione di un’area o rettifica di confine, ovvero esserein grado di affrontare le più ricorrenti problematiche che possono caratterizzare la vita professionale di ungeometra.COMPETENZEL’alunno deve essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in modo da riuscire a cogliere l’aspettotecnico degli argomenti trattati sapendo anche eseguire opportuni collegamenti con altre materie.CAPACITA’Realizzare in modo significativo un intervento progettuale che preveda la fase di rilevamento e larestituzione analitica e grafica.Saper contestualizzare le norme di legge applicandole nei casi più significativi in modo corretto.LA PROGRAMMAZIONE MODULARENumero Titolo ore %1 Metodo di lavoro e motivazioni, patto formativo. 22 Agrimensura: misura, divisione delle aree, spostamento e rettifica confini 58 37%3 Determinazione di volumi di terra e di invasi di spianamento 39 25%4 Opere civili: progetto stradale 49 31%5 Fotogrammetria: conoscere i principi generali della fotogrammetria. 11 7%Totale 157MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICAEssenzialmente l’attività didattica si è svolta attraverso la lezione frontale, nel corso della quale si è cercatodi incentivare gli interventi degli studenti, al fine di promuovere un interessamento attivo per la materia.Gran parte dell’attività scolastica è stata dedicata alla fase teorica del programma, cercando tuttavia didedicare il maggior tempo possibile alle verifiche orali, per accertare il livello di conoscenza raggiunto dallaclasse per ogni tema proposto. Alla conclusione di ogni modulo è stata effettuata una verifica scritta e, nelcorso dell’anno sono state eseguite due simulazioni di terza prova di Topografia. Per l’elaborazione delprogetto stradale, i tre gruppi di alunni hanno autonomamente redatto un proprio progetto. Come strumentididattici si è ricorso ai testi in uso o a dispense fornite dal docente.VALUTAZIONELa valutazione ha fatto riferimento alle capacità operative di applicazione e di comprensione dei concettifondamentali della disciplina.Si è considerato nella valutazione il conseguimento degli obiettivi socio-affettivi, la partecipazione el’interesse degli studenti e la puntualità nell’assolvimento degli impegni.Altri indicatori sono stati: il comportamento, il metodo di studio, la conoscenza, la comprensione, le capacitàdi analisi e di sintesi.Nella riunione programmatica dell’area tecnica si sono considerate preminenti le categorie qui di seguitoriportate cui sono stati assegnati i relativi pesi:• conoscenze 30%; comprensione 20%;• espressione 20%;• capacità di analisi 15%;B) capacità di sintesi 15%.28
La valutazione si è basata su una serie integrata di interventi: appropriate domande poste dagli studenti obrevi interventi su domande occasionali poste dal docente o verifiche in itinere sullo sviluppo di esercizi edesercitazioni, hanno consentito di verificare l’interesse e la continuità della partecipazione e dell’impegnodello studente.Sono stati svolti dei compiti in classe alla fine di ogni modulo, per la cui valutazione si è seguita una lineaorientativa basata sulla scheda elaborata, indicata di seguito:CRITERI DI VALUTAZIONEVOTO(1/10) CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’1 Nessuna Nessuna Nessuna2 Gravemente errate,Non sa cosa fareNon si orientaespressione sconnessa3 Conoscenze frammentarie egravemente lacunoseApplica le conoscenze minimesolo se guidato, ma con graviCompie analisi errate, nonsintetizza, commette errori4 Conoscenze carenti, conerrori ed espressioneimpropria4 1/2 Conoscenze carenti,espressione difficoltosa5 Conoscenze superficiali.Improprietà di linguaggio5 1/2 Conoscenze complete conimperfezioni, esposizione avolte imprecisa6 Conoscenze complete, manon approfondite, esposizionesemplice, ma corretta6 1/2 Conoscenze complete, pocoapprofondite, esposizionecorretta7 Conoscenze complete,quando viene guidato saapprofondire, esposizionecorretta con proprietàlinguistica8 Conoscenzecomplete,qualcheapprofondimento autonomo,esposizione corretta conproprietà linguistica9 Conoscenze complete conapprofondimento autonomo,esposizione fluida conutilizzo del linguaggiospecifico10 Conoscenze complete,approfondite e ampliate,erroriApplica le conoscenze minimesolo se guidatoApplica le conoscenze minimeanche autonomamente, ma congravi erroriApplica autonomamente leconoscenze minime con qualcheerroreApplica autonomamente leconoscenze minime conimperfezioniApplica autonomamente ecorrettamente le conoscenzeminimeApplica autonomamente leconoscenze anche a problemi piùcomplessi, ma con erroriApplica autonomamente leconoscenze anche a problemi piùcomplessi, ma con imperfezioniApplica autonomamente leconoscenze anche a problemi piùcomplessi, in modo correttoApplica in modo autonomo ecorretto anche a problemicomplessi le conoscenze: quandoguidato trova soluzioni miglioriApplica in modo autonomo ecorretto le conoscenze anche aQualche errore, analisiparziali, sintesi scorretteQualche errore, analisi esintesi parzialiAnalisi parziali, sintesiimpreciseImprecisioni, analisi corrette,difficoltà nel gestire semplicisituazioni nuoveCoglie il significato, esattainterpretazione di sempliciinformazioni, analisi corrette,gestione di semplicisituazioni nuoveEsatta interpretazione deltesto, sa definire un concetto,gestisce autonomamentesituazioni nuoveCoglie le implicazioni,compie analisi complete ecoerentiCoglie le implicazioni,compie correlazioni conimprecisioni, rielaborazionecorrettaCoglie le implicazioni,compie correlazioni esatte eanalisi approfondite,rielaborazione corretta,completa e autonomaSa rielaborare correttamente eapprofondire in modo29
esposizione fluida conutilizzo di un lessico ricco eappropriatoproblemi complessi, trova da solosoluzioni miglioriautonomo e critico situazionicomplesseLIVELLO DELLA CLASSEIl livello della classe è eterogeneo: complessivamente ha ottenuto risultati sufficienti, mentre non si puòomettere come una parte, anche se esigua, abbia riportato una preparazione lacunosa, dovuta sia adincertezze ereditate dagli anni precedenti, sia a scarsa applicazione scolastica che domestica.PROGRAMMA SVOLTO:MODULO N. 1 MISURA E DIVISIONE DELLE AREE1) CALCOLO DI AREE:Metodi numerici-formula del camminamento-formule di Gauss-per coordinate polariMetodi grafico numerici-formula di Bezout-formula di Cavalieri-SimpsonMetodi grafici-riduzione di poligoni in triangoli equivalenti-integrazione graficaMetodi meccanici-reticole di Bamberg e Barthélemy-planimetro polare di Amsler.2) DIVISIONE DELLE AREE:Aree di uguale valenza:TRIANGOLO:-dividenti uscenti da un vertice-dividenti uscenti da un punto su un lato-dividenti uscenti da un punto interno dell’appezzamento-dividenti con assegnazione assegnata parallela o perpendicolare ad un latoQUADRILATERO:-problema del trapezio-dividenti uscenti da un punto su un lato-dividenti con direzione assegnata.MODULO N. 2 SPOSTAMENTO E RETTIFICA DI CONFINIConfini fra terreni con valore unitario uguale-spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato-rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato-rettifica di un confine bilatero per un punto assegnato-rettifica di un confine trilatero con direzione assegnataMODULO N. 3 SPIANAMENTI DEI TERRENI-formule dei volumi30
-spianamenti orizzontali su piani quotati-spianamento con soli scavi-spianamento con soli riporti-spianamento misto con scavi e riporti-spianamento con compenso tra scavi e riportiMODULO N. 4 STRADE-elementi che influiscono sul dimensionamento di una strada-studio definitivo del tracciato sul piano a linee di livello. Planimetria-velocità di progetto, pendenza massima, raggio minimo delle curve circolari-curva circolare monocentrica: elementi geometrici, relazioni fondamentali-picchettamento circolare per ordinate alla tangente-picchettamento circolare per ordinate alla corda-picchettamento circolare per coordinate polari-picchettamento per ordinate al prolungamento delle corde successive-picchettamento per direzioni al centro-picchettamento col metodo del quarto-profilo longitudinale e tracciamento delle livellette-sezioni trasversali-misura della zona di occupazione-aree delle sezioni trasversali-calcolo dei volumi dei solidi stradali-diagramma delle masse o profilo delle aree-diagramma Brùckner o dei momenti di trasporto.PROGETTO STRADALEElaborati da eseguirsi- studio di un progetto stradale composto da:-planimetria-profilo longitudinale-sezioni trasversali-area di occupazione-diagramma delle masse-diagramma di Brùckner.MODULO N. 5 FOTOGRAMMETRIA-suddivisione, principi teorici-camere da presa aeree-presa fotogrammetrica aerea.Padova 2 maggio 2013Il docenteProf. Calore Dino31
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTEDocente Materia classeCannone Fernando-C. Estimo 5 B 2012 - 2013Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE ECAPACITA’ConoscenzeMatematica finanziaria applicata all’EstimoEstimo generale: aspetti economici, metodo e procedimenti di stima. La relazione di stima, il principiodell’ordinarietà. I requisiti del perito.Estimo rurale: caratteristiche del mercato dei terreni e degli affitti. Le stime nei fondi rustici; i fruttipendenti; i miglioramenti fondiari; il riparto dei contributi consortili, arboreti e stime relativeEstimo civile: le caratteristiche del mercato immobiliare. Le stime nei fabbricati; le aree edificabili;lacessione di cubatura edificabile, i condomini, la sopraelevazione.Estimo legale: le espropriazioni per pubblica utilità; le servitù prediali; l’usufrutto; le successioni per causadi morte; le stime dei danni da incendio e il contratto di assicurazione.Estimo catastale: il Nuovo Catasto Terreni; il Catasto Fabbricati.Gli obiettivi minimi di conoscenza rispetto ai contenuti proposti sono stati mediamente raggiunti sia purecon differenze in termini quantitativi riconducibili a predisposizioni individuali diverse. La maggior partedella classe ha conseguito esiti di profitto sufficienti, con alcune punte di discreto/buono per gli alunni chesi sono distinti per partecipazione, impegno personale ed interesse anche all'approfondimento personale.Per pochi elementi, i quali hanno partecipato all’attività didattica in modo non soddisfacente, studiato pocoe in modo saltuario e superficiale, il profitto permane appena sufficiente.CompetenzeIn ambito generale: individuare i possibili aspetti economici dei beni sottoposti a stima, applicare iprocedimenti di stima svolgendo le fasi in sequenza; applicare regole e formule nelle stime, rispettando iprincipi della matematica finanziaria.Saper reperire i dati economici necessari alle stime e saperli utilizzare nell’ambito dell’ordinarietàCompilare una relazione di stima dividendola in parti da descrivere con adeguata terminologia.In ambito rurale saper applicare i procedimenti di stima tenendo presente le peculiarità del mercatofondiario.In ambito civile: saper applicare i procedimenti di stima tenendo presente le peculiarità del mercatoimmobiliare urbano e saper applicare regole e formule in relazione alle normative giuridiche e urbanistiche.In ambito legale: saper applicare regole e principi previsti dalle normative specifiche esplicitando le norme inelementi economici ed estimativi.In ambito catastale: saper applicare i metodi di determinazione delle tariffe d’estimo, saper leggere,individuare e compilare i modelli catastali tenendo presenti anche le procedure informatizzate.Nella classe la maggior parte degli studenti ha raggiunto le competenze sopra indicate; essi sono in grado diorganizzare le informazioni, di riconoscere le relazioni significative e di risolvere semplici quesiti di stimaalla luce delle principali normative, sapendo contestualizzare il bene ,oggetto di valutazione, nel mercato chegli compete e nel territorio circostante. Alcuni studenti, inoltre, sanno esporre adeguatamente le conoscenzeacquisite con un linguaggio corretto sotto l’aspetto lessicale e puntuale dal punto di vista tecnico, per altripermangono difficoltà di comunicare oralmente con scioltezza, chiarezza e proprietà di linguaggio economico-estimativo.CapacitàNell’estimo generale: sapere individuare l’aspetto economico e il procedimento di stima idoneo piùrispondente alla risoluzione di uno specifico quesito di stima.32
Nell’estimo rurale: sapere individuare il procedimento di stima adatto al quesito proposto alla luce anchedelle difficoltà di reperimento dei dati. Sapere utilizzare lo strumento economico - estimativo del bilancioaziendale e saper impiegare i principali redditi aziendali nei giudizi di convenienza.Nell’estimo civile: sapere individuare il procedimento di stima adatto al quesito proposto. Essere in grado diinserire l’immobile nel tessuto urbanistico, legandolo al territorio e all’ambiente sapendone valutare tutte lecaratteristiche estrinseche, intrinseche e giuridiche.Nell’estimo legale: riuscire ad avere una visione dell’origine e dell’evoluzione storica delle normativetrattate legandole all’effetto pratico (ricaduta).Saper stimare indennità, diritti, danni ed una massa dividendaapplicando i giusti criteri per la formazione delle quote di diritto e di fatto.Nell’estimo catastale:avere una visione storica della formazione e dell’evoluzione del Catasto ed essere ingrado di analizzare criticamente i cambiamenti avvenuti, alla luce della riforma tuttora in atto.Mediamente gli allievi, pur se potenzialmente sarebbero in grado di effettuare analisi e sintesi, devono essereguidati sia in fase di esposizione che di rielaborazione delle conoscenze. Pochi alunni dimostrano capacità diapprofondimento critico e di organizzazione autonoma sia del discorso che del proprio lavoro; altri,mostrano ancora delle difficoltà ad operare collegamenti e a cogliere relazioni tra discipline diverse.Contenuti disciplinari in forma di unità didattiche, moduli o percorsiformativi, approfondimentiTipologia: unità didatticheRipasso di matematica finanziaria: il concetto di capitalizzazione, il trasporto dei capitali neltempo, il valore potenziale. Verifica. RipassoEstimo generale: i fondamenti economici, il giudizio di stima, i requisiti del perito, gli aspettieconomici dei beni, il metodo di stima, i procedimenti di stima. Il perito nel processo civile.Verifiche. RipassoEstimo civile: le stime nei fabbricati, le aree edificabili, i condomini, la sopraelevazione, lacessione di cubatura edificabile. VerificaEstimo rurale: le stime nei fondi rustici , i frutti pendenti, i miglioramenti, il riparto deicontributi consortiliPeriodo/oreSettembreSettembre -OttobreNovembre -DicembreGennaioEstimo legale: espropriazioni, servitù, usufrutto, vitalizio. Verifiche. Febbraio -MarzoIl Catasto terreni. storia,formazione, conservazione, modulistica.Il Catasto Fabbricati: storia,formazione, conservazione, modulistica.Ripasso finale e verifiche.Marzo - AprileAprileMaggio-GiugnoTotale ore effettivamente svolte dalla docente( previste al 15 maggio) 130Metodologie didattiche seguiteIl metodo di insegnamento seguito è stato quello tradizionale, svolto attraverso le lezioni frontali partecipatecon coinvolgimento degli alunni attraverso:• domande stimolo• scoperta guidata: lettura, analisi e commento in classe di parti del testo particolarmente difficili e di altreriviste specializzate• problem solving: risoluzione di casi elementari o di semplici problemi estimativi con applicazione concretadelle conoscenze acquisitecostruzione di scalette argomentative e di schemi sintetici di unità didattiche complesse33
Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aulespeciali, tecnologie ecc..)Ho seguito il libro di testo dotato di un buon prontuario ed eserciziario. Sono stati distribuiti aggiornamentied esercizi da svolgere, talvolta già svolti. L’utilizzo di fonti di informazione, di dati tecnici ed economiciattraverso la rete è stato fatto dai singoli studenti utilizzando siti consigliati dall’insegnante.Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazioneLe verifiche sono state abbastanza frequenti soprattutto nella forma scritta di esercizi, questionari, relazioni.Meno frequente la verifica orale , che è stata però utilizzata nell’ultima parte dell’anno scolastico perabituare gli studenti al colloquio d’esame.ValutazioneColloquio docente-discente per accertare via via conoscenze e abilità acquisiteVerifiche orali come momento formale volto a valutare conclusivamente il grado di competenza disciplinareconseguito dall’alunno al termine di una o più unità didattiche, al termine del quadrimestre e al terminedell’anno scolasticoPer la valutazione del colloquio orale si sono adottati i seguenti parametri:• conoscenza degli argomenti richiesti livello di acquisizione delle conoscenze• capacità di utilizzare e collegare sul piano argomentativo le conoscenze acquisite• capacità di approfondire gli argomenti proposti con autonomia critica e di partecipare alle dinamiche relazionalidel colloquio• correttezza e proprietà linguistica ed uso della terminologia giuridica, competenze linguistiche, espressiveQuestionari per verificare sia il livello di conoscenza in itinere sia il raggiungimento degli obiettivi altermine di una o più unità didatticheQuesiti a risposta singola utilizzati nelle simulazioni di terza provaSoluzione di semplici casiCRITERI DI VALUTAZIONEVOTO1/1 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’01 Nessuna Nessuna Nessuna2 Gravemente errate, espressione Non sa cosa fareNon si orientasconnessa3 Conoscenze frammentarie egravemente lacunoseApplica le conoscenze minime solose guidato, ma con gravi erroriCompie analisi errate,non sintetizza, commetteerrori4 Conoscenze carenti, con erroried espressione impropriaApplica le conoscenze minime solose guidatoQualche errore, analisiparziali, sintesi scorrette4 1/2 Conoscenze carenti, Applica le conoscenze minime anche Qualche errore, analisi eespressione difficoltosa5 Conoscenze superficiali.Improprietà di linguaggio5 1/2 Conoscenze complete conimperfezioni, esposizione avolte imprecisa6 Conoscenze complete, manon approfondite,esposizione semplice, macorrettaautonomamente, ma con gravi erroriApplica autonomamente leconoscenze minime con qualcheerroreApplica autonomamente leconoscenze minime con imperfezioniApplica autonomamente ecorrettamente le conoscenzeminimesintesi parzialiAnalisi parziali, sintesiimpreciseImprecisioni, analisicorrette, difficoltà nelgestire semplici situazioninuoveCoglie il significato,esatta interpretazione disemplici informazioni,analisi corrette, gestionedi semplici situazioninuove6 1/2 Conoscenze complete, poco Applica autonomamente le Esatta interpretazione del34
approfondite, esposizionecorretta7 Conoscenze complete, quandoviene guidato sa approfondire,esposizione corretta conproprietà linguistica8 Conoscenze complete, qualcheapprofondimento autonomo,esposizione corretta conproprietà linguistica9 Conoscenze complete conapprofondimento autonomo,esposizione fluida con utilizzodel linguaggio specifico10 Conoscenze complete,approfondite e ampliate,esposizione fluida con utilizzodi un lessico ricco eappropriatoconoscenze anche a problemi piùcomplessi, ma con erroriApplica autonomamente leconoscenze anche a problemi piùcomplessi, ma con imperfezioniApplica autonomamente leconoscenze anche a problemi piùcomplessi, in modo correttoApplica in modo autonomo ecorretto anche a problemi complessile conoscenze: quando guidato trovasoluzioni miglioriApplica in modo autonomo ecorretto le conoscenze anche aproblemi complessi, trova da solosoluzioni miglioritesto, sa definire unconcetto, gestisceautonomamente situazioninuoveCoglie le implicazioni,compie analisi complete ecoerentiCoglie le implicazioni,compie correlazioni conimprecisioni,rielaborazione correttaCoglie le implicazioni,compie correlazioni esattee analisi approfondite,rielaborazione corretta,completa e autonomaSa rielaborarecorrettamente eapprofondire in modoautonomo e criticosituazioni complesse35
ANNO SCOLASTICO 2012-2013PROGRAMMA CLASSE 5 a sez. B GEOMETRI EstimoTesto in adozione: “Corso estimo” con prontuario Stefano Amicabile Edizioni HoepliESTIMO GENERALELa funzione e i caratteri dell’estimo:• il giudizio di stima;• i requisiti professionali del perito;• gli aspetti economici dei beni.Il metodo e i procedimenti di stima:• il metodo di stima consiste nella comparazione;• le stime sintetiche (parametriche, a vista, storiche, per valori tipici);• la stima analitica e la capitalizzazione del reddito.L’ordinarietà:• il concetto di ordinarietà;• le caratteristiche che influenzano il valore di un immobile;• le aggiunte e detrazioni al valore normale.ESTIMO RURALELa stima dei fondi rustici• le indagini per la determinazione del valore di mercato dei fondi rustici;• le condizioni influenti sul valore dei fondi rustici;• le stime sintetiche;• la stima analitica in relazione ai modi di conduzione (economia diretta, affitto);• stima di un fondo suscettibile di miglioramentoLa stima dei frutti pendenti, delle anticipazioni colturali e dei residui di fertilità.Le stime relative ai miglioramenti fondiari:• i giudizi di convenienza;• il valore potenziale di un fondo;• l’indennità per miglioramenti eseguiti su fondi altrui.Il riparto delle spese nei consorzi:• i criteri di ripartizione delle spese nei consorzi di bonifica, di difesa, stradali e di irrigazione.Arboreti da frutto-definizioni economiche-stima del valore terra-stima in un anno intermedio del ciclo-stima del soprassuolo-prezzo di macchiaticoESTIMO LEGALELa stima delle indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità: richiamo delle leggi precedenti al testo unico che hanno influenzato il testo stesso ( legge fondamentale, leggedi Napoli, legge 865 e Bucalossi) DPR n.327 del 8/6/2001” Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioneper pubblica utilità.” applicato alla ricerca della stima dell’indennità di espropriazione nelle diverse situazioni. Modifiche apportate al DPR precedente dalla Finanziaria 2008 art.2 commi 89 e 90Le stime relative alle servitù prediali coattive:
• la determinazione dell’indennità per il passaggio coattivo;• la determinazione dell’indennità per il passaggio di acquedotto coattivo;• la determinazione dell’indennità di elettrodotto coattivo;• la determinazione dell’indennità di metanodotto.Le servitù personali:• il valore dell’usufrutto e il valore della nuda proprietà.Le stime dei danni:• il contratto di assicurazione;• la stima dei danni causati ai fabbricati da incendio.Le stime per successioni ereditarie:• i momenti della successione;• la successione legittima;• la successione necessaria;• la successione testamentaria;• la collazione;• la divisione ereditaria.ESTIMO CIVILELa stima dei fabbricati:• descrizione del fabbricato: caratteristiche estrinseche, intrinseche, aspetti legali e catastali;• la stima dei fabbricati rurali;• la stima dei fabbricati civili: valore di mercato, di costruzione e ricostruzione, di trasformazione,complementareLa stima delle aree fabbricabili:• la stima del più probabile valore di mercato;• la stima del più probabile valore di trasformazione• la stima di piccole aree edificabili.L’amministrazione del condominio:• il regolamento di condominio, l’amministratore e l’assemblea;• la formazione delle quote millesimali di proprietà in base alla superficie virtuale e in base al valore monetario;• la ripartizione delle spese di condominio;• diritto ed indennità di sopraelevazione (art. 1127 del C.C.).ESTIMO CATASTALECenni storici.Il catasto dei terreni o rustico:• la formazione: operazioni topografiche ed estimative;• la pubblicazione;• l’attivazione e la meccanizzazione degli atti catastali;• la conservazione: variazioni nell’intestazione, variazioni nello stato e nel reddito, frazionamento di unaparticella, edificazione di una particella, le procedure di trattamento dei documenti tecnici di aggiornamento;• la consultazione degli atti catastali e la certificazione.Il catasto fabbricati:• la formazione: rilievo geometrico, operazioni estimative, la formazione delle tariffe;vecchi e nuovi criteri;• la pubblicazione;• l’attivazione e la meccanizzazione degli atti catastali;• la conservazione: variazioni nell’intestazione, le mutazioni nello stato delle unità immobiliari, le dichiarazionidi nuove unità immobiliari;• le consultazioni degli atti catastali e la certificazione.prof. Fernando Cannone37
tecnologia delle costruzioniDocente Materia classe annoscolasticoAntonelli Ester Tecnologia delle Costruzioni V^ B 2012/2013Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe in termini diCONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ :ConoscenzeIn relazione agli obiettivi prefissati in sede di programmazione preliminare, la conoscenza dei percorsiformativi ha raggiunto, nella quasi totalità degli alunni, un livello sufficiente. Permangono, tuttavia, inalcuni casi, alcune incertezze relative ad un metodo di applicazione delle conoscenze non pienamenteautonomo. Il metodo di lavoro svolto ha riguardato sia l’aspetto teorico-conoscitivo della disciplinaattraverso la teoria della progettazione architettonica, la storia dell’architettura moderna e contemporaneae la disciplina degli strumenti urbanistici, sia l’aspetto pratico-grafico attraverso la sviluppo di temiprogettuali di edilizia pubblica. I contenuti tecnico-teoricii sono stati analizzati ed approfonditi qualesupporto fondamentale alla progettazione architettonica. I livelli di competenza raggiunti sono tali daconsentire sia la capacità applicativa necessaria alla completa risoluzione delle proposte progettuali, sia lacapacità di rielaborazione e di sintesi dei principi teorici. Le conoscenze della materia risultanocomplessivamente sufficienti.OBIETTIVI:Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi cognitivi generali della materia: Capacità di intervenire in un contesto urbanisticamente definito Saper organizzare il percorso risolutivo per un tema progettuale assegnato Saper redigere gli elaborati definitivi di un progetto edilizio Saper riconoscere la struttura urbana e l’aspetto degli edifici individuandone le caratteristiche funzionali,distributive, tecnologiche e figurative; Conoscenza degli elementi fondamentali dell’analisi territoriale Conoscenza dei fondamenti giuridici che presiedono all’attività edilizia e della diversificazione dellecompetenze dell’ordinamento istituzionale per la gestione del territorio.CompetenzeIl gruppo classe ha dimostrato di possedere una discreta capacità di applicazione delle conoscenzeacquisite e di rielaborazione delle differenti tipologie progettuali. La classe ha raggiunto, nella media, unsufficiente grado di autonomia nell’interpretazione, nello svolgimento e nella rielaborazione delleproposte progettuali. Per alcuni alunni permangono alcune oggettive difficoltà in parte conseguenza dilacune pregresse, accumulate nel corso degli anni. Nel complesso il gruppo classe ha evidenziatocompetenze piuttosto buone e quasi sempre in grado di stabilire opportuni collegamenti nei vari ambitidella disciplina. L’impegno e l’applicazione sistematica, hanno, per alcuni alunni, potenziato e fattoemergere capacità di risoluzione e di autonomia nella gestione e nell’ applicazione delle conoscenze.CapacitàNell’insieme, il gruppo classe ha dimostrato di essere capace di riconoscere gli elementi che stanno allabase dell’attività di progettazione e di analisi di un problema progettuale.e di saper applicare le conoscenze della disciplina urbanistica in un contesto urbano reale.38
Contenuti disciplinari 2 in forma di unità didattiche, moduli o percorsi formativi,approfondimentiMODULO n.1 METODO DI LAVORO, MOTIVAZIONI, PATTO FORMATIVO Impostazione del metodo di lavoro Spiegazione dei programmi Analisi dei punti fondamentali del patto formativo.MODULO n.2 TEORIA DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA la composizione modulare studio del modulo: il modulo strutturale ipotesi aggregative in funzione di superficie e cubatura studio delle aggregazioni del modulo strutturali analisi e applicazioni di riferimenti studio di contestualizzazioni urbaneMODULO n.3 : TRASFORMAZIONE EDILIZIA E DEL TERRITORIO DALLA PRIMARIVOLUZIONE INDUSTRIALE FINO AL CONTEMPORANEO- L’urbanistica e l’architettura di fronte all’industria- la progettazione architettonica e i nuovi materiali: ferro, vetro, cemento armato- La rivoluzione industriale, le utopie di fine secolo, le avanguardie storiche e figurative-Bruno Taut, Adolf Loos- Peter Beherens e la fabbrica Fagus- La nascita del Movimento Moderno e i suoi più noti rappresentanti- Walter Gropius e il Bauhaus- Ludwig Mies van der Rohe e l’affermazione del moderno in architettura- Le Corbusier costruttore e teorico: l’organizzazione dei C.I.A.M.- Frank Lloyd Wright- Roma, Firenze, Torino, l’esperienza del moderno in Italia- il razionalismo italiano: Giuseppe Terragni, Michelucci- l’esperienza dell’EUR 42, Piacentini e l’architettura della propaganda politicaMODULO n.4 : ELEMENTI DI ANALISI TERRITORIALE E STRUMENTAZIONEURBANISTICA GENERALE ED ESECUTIVA INQUADRATA NELLA NORMATIVANAZIONALE E REGIONALE.- Uso del suolo urbano ed extra urbano.- Principi fondamentali della legislazione urbanistica vigente.- Strumenti urbanistici generali ed esecutivi e normativa urbanistica- Strumenti urbanistici della Regione del VenetoMODULO n.5 : REDAZIONE DI UN PROGETTO INTESO COME SINTESIINTERDISCIPLINARE DEI CONTENUTI AFFERENTI ALLE VARIE DISCIPLINE- Computo e verifica del volume costruito- Planivolumetrici e calcolo degli indici urbanistici- analisi estemporanea- Elaborati grafici definitivi- lettura di elaborati grafici239
- Relazione tecnica illustrativaLo svolgimento delle lezioni è stato di tipo frontale (lezione dialogo) coadiuvato da strumenti come PowerPoint, schemi alla lavagna, appunti e schede progettuali integrative, dispense specifiche di alcuni argomentidi particolare importanza.La materia soprattutto per quanto concerne la programmazione dell’ultimo anno è stata trattata in modocompleto, affiancando alla teoria la pratica applicativa. Sono state predilette le esercitazioni in classe diproblemi diretti e inversi per costringere l’alunno al ragionamento. Sono state affrontate differentitipologie architettoniche legate ad edifici di destinazione pubblica. Le prove sono state strutturate in modotale da consentire a tutti una corretta e ampia risoluzione con la possibilità di spaziare nello svolgimentofra le varie soluzioni tipologiche note.Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali,tecnologie ecc..)C) Testo adottato: Elementi di Urbanistica, Franceso OgnibeneTipologie costruttiveD) Per il corretto svolgimento del corso sono stati utilizzati oltre al libro di testo molti altri supportiteorici ritenuti idonei ed integrativi al corretto sviluppo di alcune conoscenze.E) Sono stati forniti agli alunni opuscoli e dispense preparate dall’insegnante inerenti ad alcuniargomenti oggetto di particolare approfondimento. Si sono utilizzati inoltre tutti gli strumentinecessari per una completa ed esauriente proposta didattica.Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazioneLe prove di verifica utilizzate sono state: verifiche scritte di tipo progettazione estemporanea esercitazioni scritto-grafiche assegnate a casa con particolare valenza risolutiva; esercitazioni scritte- orali consuntive di più moduli; interrogazioni orali di presentazione delle opere architettoniche in elencoSIMULAZIONE II PROVAMATERIA: TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONIPiano Urbanistico residenzialeIn una città capoluogo di Provincia, progettare un piano urbanistico residenziale di tipo misto per 250abitanti, secondo i seguenti dati:lotto di forma rettangolare di 10.000 mq;indice territoriale 2,5 mc/mqH max 17,5 m;linee di confine nord e sud adiacenti a strade comunali di larghezza pari a 10,00 mOltre a tutte le considerazioni necessarie allo svolgimento del tema, il candidato, calcolati secondo glistandard urbanistici le superfici e i volumi da destinare a:residenze di tipo mistoservizi di quartiereistruzioneparcheggiverde pubblicoviabilità carrabile e pedonale40
disponga i seguenti elaborati:zonizzazione compositivasistemazione dell’area in scala adeguatapiante del piano tipo ove previste tipologie a torre o in lineasviluppo del modulo a schiera (se previsto)una sezione significativa dell’edifico con maggiore sviluppo in altezzail prospetto complessivo del lato nord dell’intero lottoIl candidato, a sua scelta, approfondisca uno dei seguenti temi:-dettaglio costruttivo di un elemento strutturale inserito nella progettazione;-relazione tecnico-descrittivaSIMULAZIONI DELLA II PROVAMATERIA: TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONIIn un lotto a forma rettangolare di circa 3000 Mq, confinante con il lato più lungo con una stradacomunale di larghezza pari a 10,00m, progettare un complesso residenziale per anziani (numero di ospitiprevisti 50), dove saranno presenti, tra l’altro: hall, reception, servizi, zona pranzo, dispensa-magazzino,sala soggiorno, area fitness, spogliatoio.L’alloggio tipo sarà di due tagli da 20Mq e da 16Mq (inserire almeno due alloggi per portatore dihandicap).L’area esterna sarà dotata di parco alberato e percorso ginnico attrezzato oltre ad un parcheggio per 25posti auto di cui tre per portatore di handicap.Il candidato, definiti tutti i parametri utili alla progettazione, esegua i seguenti elaborati: planimetria generale del lotto piante, prospetti e sezioni del fabbricato piante tipo dell’alloggio A/B in scala 1:50 relazione tecnico illustrativaValutazioneCRITERI DI VALUTAZIONE CONCORDATI IN COORDINAMENTOI criteri di valutazione adottati e i “saperi minimi” richiesti sono quelli che sono stati discussi e concordati nelleriunioni di dipartimento.Di seguito vengono riportati i “saperi minimi” per il raggiungimento di una preparazione sufficiente:• Saper applicare i metodi della teoria della progettazione• saper progettare un edificio destinato a pubblici servizi• saper applicare le normative vigenti in materia di edilizia• saper conoscere le tematiche strutturali connesse con le tipologie edilizie.CRITERI DI VALUTAZIONEVOTO(1/10) CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’1 Nessuna Nessuna Nessuna2 Gravemente errate, espressione Non sa cosa fareNon si orientasconnessa3 Conoscenze frammentarie egravemente lacunoseApplica le conoscenze minime solo seguidato, ma con gravi erroriCompie analisi errate, non sintetizza,commette errori4 Conoscenze carenti, con errori edespressione impropriaApplica le conoscenze minime solo seguidatoQualche errore, analisi parziali,sintesi scorrette4 1/2 Conoscenze carenti, espressionedifficoltosaApplica le conoscenze minime ancheautonomamente, ma con gravi erroriQualche errore, analisi e sintesiparziali5 Conoscenze superficiali. Improprietàdi linguaggioApplica autonomamente le conoscenzeminime con qualche erroreAnalisi parziali, sintesi imprecise41
5 1/2 Conoscenze complete conimperfezioni, esposizione a volteimprecisa6 Conoscenze complete, ma nonapprofondite, esposizione semplice,ma corretta6 1/2 Conoscenze complete, pocoapprofondite, esposizione corretta7 Conoscenze complete, quando vieneguidato sa approfondire, esposizionecorretta con proprietà linguistica8 Conoscenze complete,qualcheapprofondimento autonomo,esposizione corretta con proprietàlinguistica9 Conoscenze complete conapprofondimento autonomo,esposizione fluida con utilizzo dellinguaggio specifico10 Conoscenze complete, approfondite eampliate, esposizione fluida conutilizzo di un lessico ricco eappropriatoApplica autonomamente le conoscenzeminime con imperfezioniApplica autonomamente ecorrettamente le conoscenze minimeApplica autonomamente le conoscenzeanche a problemi più complessi, ma conerroriApplica autonomamente le conoscenzeanche a problemi più complessi, ma conimperfezioniApplica autonomamente le conoscenzeanche a problemi più complessi, in modocorrettoApplica in modo autonomo e correttoanche a problemi complessi leconoscenze: quando guidato trovasoluzioni miglioriApplica in modo autonomo e corretto leconoscenze anche a problemi complessi,trova da solo soluzioni miglioriImprecisioni, analisi corrette,difficoltà nel gestire semplicisituazioni nuoveCoglie il significato, esattainterpretazione di sempliciinformazioni, analisi corrette,gestione di semplici situazioninuoveEsatta interpretazione del testo, sadefinire un concetto, gestisceautonomamente situazioni nuoveCoglie le implicazioni, compie analisicomplete e coerentiCoglie le implicazioni, compiecorrelazioni con imprecisioni,rielaborazione correttaCoglie le implicazioni, compiecorrelazioni esatte e analisiapprofondite, rielaborazione corretta,completa e autonomaSa rielaborare correttamente eapprofondire in modo autonomo ecritico situazioni complesseElementi di valutazione delle esercitazioni e compiti in decimi:Abilità considerate:Peso percentuale:Impostazione 10%Sviluppo parti esplicative del procedimentoRilevazione dati e conteggi10-30% (in relazione al quesito)60-80% (in relazione al quesito)ANALISIAbilità Giudizio Valutazione PunteggioattribuitoSviluppo della parte Sviluppo nullo Nullo- 1esplicativa del Conoscenza pressocchè nulla con Gravemente2procedimento indicazioni prive di significatonegativoConoscenza di qualche nozione isolata Negativo 3ma priva di significato nel contestologico di sviluppoGravi lacune con espressione confusa Gravemente4insufficienteConoscenza approssimativaInsufficiente 5dell’argomentoConoscenza essenziale Sufficiente- 6Conoscenza essenziale con uso adeguato Discreto 7della terminologia tecnicaConoscenza ampia ed approfondita Buono - 8Conoscenza ampia ed approfondita con Ottimo 9uso appropriato della terminologiatecnicaConoscenza ottima con elementi di Eccellente 10Competenza nellarilevazione dei dati ecorrettezza nellosviluppo deiconteggi o deicontenutirielaborazione critica e/o originaleIncapacità a costruire una procedurarisolutivaConoscenza pressocchè nulla conindicazioni prive di significatoConoscenza di qualche nozione isolatama priva di significato nel contestologico di sviluppoSviluppo frammentario con errori gravi elacuneSviluppo approssimato con pochi errorigravi sostanzialiSviluppo essenziale con errori marginalie non più di uno graveNullo 1Gravemente2negativoNegativo 3Gravemente4insufficienteInsufficiente 5Sufficiente 6Peso%Punteggio42
Sviluppo con errori marginali Discreto 7Sviluppo corretto Buono 8Sviluppo corretto ed approfondito Ottimo 9Sviluppoa ottimo con elementi di Eccellente 10rielaborazione critica e/o originaleImpostazione Sviluppo nullo Nullo 1Sviluppo pressocchè nullo conDel tutto negativo 2indicazioni prive di significatoSviluppo di qualche passaggio isolato ma Negativo 3privo di significato nel contesto logico disviluppoConfusa e disordinata e incompleta Gravemente4insufficienteConfusa ed approssimata Insufficiente 5Adeguata, con qualche carenza Sufficiente 6Completa Discreto 7Articolata, chiara ,ordinata e completa. Buono 8Articolata, chiara ,ordinata e completa, Ottimo 9con buona forma espositivaArticolata, chiara ,ordinata e completa,con ottima forma espositivaEccellente 10PROGRAMMA SVOLTOMETODO DI LAVORO, MOTIVAZIONI E PATTO FORMATIVO:- presentazione dei programmi- analisi dei punti fondamentali del patto formativoTEORIA DELLA PROGETTAZIONE:- studio e analisi delle funzioni in un problema progettuale- metodi di aggregazione compositiva- applicazione di progettazione modulare- applicazioni di sistemi modulari strutturali- metodi di analisi delle distribuzioni interne delle superfici- ipotesi aggregative in funzione di superfici e cubatura- analisi del contesto: rilevazioni dell’intorno e metodi di evidenziazione di punti efficaci dicorresponsione progettuale tra nuovo ed esistenteSTORIA DELL’ARCHITETTURA: la costruzione del linguaggio moderno: i nuovi materiali da costruzione, il ferro e il vetro, nuove tipologiee nuove funzioni l’architettura tra funzione, forma e struttura Bruno Taut Adolf Loos Peter Beherens Gropius e il Bauhaus Le Corbusier e l’abitazione come macchina per l’abitare Mies van der Rohe; Frank Lloyd Wright e l’architettura organica Le linee di tendenza in Italia: le origini del razionalismo, Giacomo Mattè Trucco, Stabilimento FiatLingotto, Michelucci e la Stazione di S. Maria Novella a Firenze Terragni e il razionalismo italiano L’esperienza dell’EUR 42; Giovanni PiacentiniLEGISLAZIONE URBANISTICA:43
Principi fondamentali della legislazione urbanistica vigente Legge urbanistica nazionale n°1150/1942 Legge n°765/1968 (legge Ponte) e Decreti Attuativi D.M. 1444/ 1968 1404/1968 Legge Regionale del Veneto n°11/2004esercizi di progettazione estemporanea sui temi:1) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI CENTRO CIVICO DI QUARTIERE E SALEESPOSITIVE (analisi funzionale, dimensionale, tavole estemporanee, schema strutturale esviluppo del volume attraverso il plastico)2 ) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI UNA BIBLIOTECA PER 4000 VOLUMI(analisi funzionale, dimensionale, tavole estemporanee, sviluppo funzionale delle aree esterne)3) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA PERTRE SEZIONI (analisi funzionale, dimensionale, applicazione degli standard urbanistici, tavoleestemporanee)4) RECUPERO ARCHITETTONICO DI ANNESSO RUSTICO (trasformazione di funzione,sviluppo di volumi a doppia altezza)5) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI UN ALBERGO IN LOCALITA’ MARINA DI25 CAMERE FRONTEMARE (analisi funzionale, dimensionale, tavole estemporanee, sviluppofunzionale delle aree esterne)6) ESERCITAZIONE DI URBANISTICA: analisi e sviluppo degli indici urbanistici per un nuovoinsediamento abitativo di 800 abitanti; progettazione dei moduli in linea, a torre, a schiera.- svolgimento dei temi assegnati alle prove d’esame delle sessioni precedentiProgetto di riqualificazione urbana: da un percorso di analisi conoscitiva degli strumentiurbanistici attuativi del Comune di Padova da cui l’analisi del PAT e degli obiettivi strategicidella carta delle nuove centralità, sono emerse nel tessuto urbano aree dismesse tra cui la zonadelle ex caserme in via Chiesanuova. Gli alunni hanno svolto, in gruppo e successivamente informa autonoma i progetti di: ipotesi di nuova viabilità, analisi dei fabbricati esistenti, proposte diinserimento di nuovi volumi edilizi in sostituzione dei volumi dismessi con le seguenti tipologie,ricucitura del tessuto urbano abitativo, ampliamento dell’area destinata a parco pubblico conchiosco per la ristorazione e nuove funzionalità, centro sportivo, scuola dell’infanzia, tipologieabitative modulari progettazione secondo i criteri della casa passiva, piazza per mercato rionale.Padova, 6.05.2013L’nsegnanteprof. Ester Antonelligli allievi rappresentanti44
Docente Materia classe annoscolasticoBENTIVOGLI EVANS EDUCAZIONE FISICA 5 B 2012/13Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE ECAPACITA’Conoscenze :La classe in generale presenta i contenuti trattati in modo globalmente corretto. Gli allievi dimostrano di averappreso in maniera più che soddisfacente gli argomenti proposti.Competenze :Gli studenti sono in grado di effettuare gli esercizi nelle diverse tipologie affrontate.Capacità :La classe sa applicare le conoscenze acquisite in compiti semplici senza commettere gravi errori.Contenuti disciplinari( 3 ) in forma di unità didattiche, moduli o percorsi formativi, approfondimentiUnità didattiche e/o Percorsi formativi e/o Moduli /ApprofondimentiOre dedicateConoscenza della classe e presentazione del programma annuale 1Effettuazione di test di efficienza psicomotoria di inizio e fine anno scolastico 6Esercizi di streathching 4Esercizi di miglioramento qualità condizionali (forza,velocità,resistenza) 14Teoria e didattica dei giochi non convenzionali 12Teoria e didattica dei giochi convenzionali 10Teoria di anatomia e fisiologia 5Totale ore effettivamente svolte dal/dalla docente 52Metodologie didattiche seguiteLezione frontale in palestra ed alcune ore in classeMateriali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali, tecnologie ecc..)Testo adottato: TESTO ILLUSTRATO DI EDUCAZIONE FISICA. ED. CAPITELLOTipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazioneValutazioneLa valutazione per la materia di ed. fisica è data soprattutto dall’impegno, dalla partecipazione edall’atteggiamento/comportamento dimostrato durante le lezioni e non dimostrato dalle sole capacità fisiche.345
Gli studenti/esse saranno valutati secondo la tabella qui di seguito riportata:LIVELLO DI LIVELLO DI ABILITA' VOTO AGGETTIVO NOTA DICONOSCENZAVALUTAZIONENessuna conoscenza degliargomentiNon ha conseguito le abilitàrichieste1,2, 3,4 GravementeinsufficienteConoscenza superficiale eframmentariaConoscenza argomentifondamentaliConosce e sa applicare icontenuti e padroneggiatutti gli argomenti senzaerroriPadroneggia tutti gliargomenti senza erroriQualche abilità utilizzata conincertezzaAbilità nel risolvere problemisempliciDimostra abilità nelleprocedure con qualcheimprecisione. Organizzaautonomamente le conoscenzein situazioni nuoveAnalizza e valuta criticamentecontenuti e procedure; usa lamicrolingua in modo attento ecorretto5 Insufficiente6 Sufficiente7/8 Discreto/Buono9;10 OttimoLa classe è formata da 18 alunni. Li ho portati dalla terza alla quinta, per cui posso dire che nel corso degli anni honotato un progressivo impegno e miglioramento nella materia, sia da un punto di vista motorio,checomportamentale. Per quanto riguarda questo ultimo anno debbo dire che mi hanno tutti seguito con impegno edisciplina, partecipando con entusiasmo ad ogni tipo di attività proposta, ottenendo risultati molto soddisfacenti. Inultimo volevo sottolineare il fatto che sette alunni hanno partecipato al torneo internazionale di tchouk ball che sisvolge ogni anno a Viserba di Rimini.L’insegnante di educazione fisicaEvans Bentivogli46
Docente Materia classe annoscolasticoP. Pozzi Diritto 5 B 2012/1347
Allievi iscritti n.18, allievi frequentanti n.18.Presentazione della classe.La classe si presenta come un gruppo di studenti, nel complesso assidui e disponibili al lavoro, però solo una parteè sempre diligente, pronta ad approfondire e studiare, mentre un gruppetto fatica ad applicarsi nello studiodomestico, risultando in difficoltà. Gli allievi provengono dalla classe quarta, anche se lo scorso anno scolasticoavevano un'altra insegnante.Il comportamento degli studenti è stato abbastanza corretto, anche se per un piccolo gruppo risulta difficilepartecipare correttamente, nel senso che non partecipano attivamente alle lezioni, mentre va rilevata una buonaparte che è risultata sempre disponibile al lavoro e alla partecipazione.Nel complesso la classe appare non sempre eterogenea per capacità, conoscenze, impegno, attenzione epartecipazione al dialogo educativo, anche se spronandoli al loro dovere e ripetendo più volte gli argomenti, siriescono ad ottenere dei risultati positivi anche per molti di loro.Obiettivi specifici disciplinari conseguiti dalla classe in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE ECAPACITA’Conoscenze Gli allievi conoscono, ad un livello individuale e diversificato, i lineamenti generalisull'organizzazione amministrativa dello Stato, amministrazione diretta ed indiretta, gli enti pubblici non territoriali( Regione, Provincia,Comune), gli atti amministrativi, la giustizia amministrativa, la giustiziaamministrativa (Tar), la legislazione urbanistica, la legge urbanistica RegioneVeneto, PAT, PATI,PI, PRG, VIA, VAS, SCIA.I diritti reali di godimento su cosa altrui, il contratto, l'invalidità e la risoluzione del contratto, i principali contrattitipici.Il diritto successorio.Gli organi costituzionali.La docente ha dato particolare rilievo alle varie problematiche riguardanti lalegislazione di settore e le sue implicazioni dato il tipo di scuola.Competenze Gli studenti, nel complesso, sono in grado di utilizzare in concreto le conoscenze assimilate edacquisite con lo studio.Sono in grado di operare alcuni collegamenti tra i diversi argomenti.Capacità La classe ha raggiunto, nella sua totalità, discreti risultati anche se le capacità non sono state sempresfruttate al massimo. Non va dimenticata una certa difficoltà nella rielaborazione e nella critica delle conoscenze,dato l'esigua applicazione circa le ore dedicate allo studio della disciplina in oggetto.Va rilevato che alcuni allievi si sanno organizzare in modo molto autonomo, ottenendo ottimi risultati.PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO.Testo adottato: Bobbio, Gliozzi, Lenti “ Corso di diritto per geometri”ed. Scuola & Azienda Vol. unico.Il Diritto Amministrativo.La Pubblica Amministrazione: attività politica e attività amministrativa;la Pubblica Amministrazione in senso oggettivo e soggettivo.I principi fondamentali che regolano l'attività amministrativa e i principi dell'organizzazione amministrativa.L'organizzazione della Pubblica Amministrazione.Amministrazione diretta centrale: gli organi attivi ( Presidente della Repubblica,Presidente del Consiglio, Consiglio dei Ministri, Ministri).Amministrazione diretta periferica: il Prefetto e il Sindaco.Le Regioni e gli enti locali.Amministrazione indiretta: la riforma degli Enti territoriali ( Comune, Provincia,Città Metropolitana, Regione).48
Autonomia e poteri degli enti territoriali.La potestà normativa della Regione ex art.117 Cost.Poteri e funzionamento degli organi degli Enti Territoriali: Consiglio, Giunta, Presidente/Sindaco.L'attività della Pubblica Amministrazione.Atti e provvedimenti amministrativi; elementi e caratteri dell'atto amministrativo.L'invalidità dell'atto amministrativo.Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi L. n.241/90 sulla trasparenzaamministrativa.La giustizia amministrativa.I vizi di legittimità e i rimedi contro gli atti amministrativi.I Diritti reali di godimento su cosa altrui.Nozioni generali. La superficie, l'usufrutto, le servitù prediali, le servitù coattive.Il contratto.Definizione, elementi essenziali ed elementi accidentali.L'invalidità e la risoluzione del contratto.L'invalidità del contratto, la nullità, l'annullabilità, la rescissione, la risoluzione.I principali contratti tipici.Contratti tipici e atipici; la vendita: nozione e obbligazioni delle parti.La locazione: in particolare la locazione di immobili urbani; l'appalto. L'assicurazione.Il Diritto successorio.La successione in generale; tipi di successione: la successione legittima, la successione testamentaria,la successionenecessaria; l'acquisto dell'eredità e del legato; la tutela dei legittimari; rappresentazione e accrescimento.Il Diritto urbanistico. Il sistema della legislazione urbanistica.Concetto di urbanistica e caratteri fondamentali.Le principali leggi in materia urbanistica.La pianificazione urbanistica.La potestà legislativa in materia di governo del territorio ( art.117 Cost)I piani urbanistici: livelli di pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza.Legge urbanistica regione Veneto n.11/2004: obiettivi della legge, strumenti di pianificazione ( P.R.C.- P.A.T. EP.I.- P.A.T.I.)La disciplina dell'attività edilizia.L'abusivismo edilizio e le sanzioni in materia urbanistica.Il condono edilizio (cenni).Gli organi costituzionali.Il Parlamento: organizzazione e funzioni.Il Governo: organizzazione e funzioni.Il Presidente della Repubblica: ruolo e poteri.La Corte Costituzionale: ruolo e poteri.49
I Componenti del Consiglio di Classe• I DOCENTI:Mario Fioriani………………………………………..………….Paola Lega……………….……………………….………….Emanuela Rossi………………………………………………….Fernando Cannone …………………………………………………..Claudia Nizzola…….…………………….………………….…..Ester Antonelli……………………………………………….....Dino Calore …………………………………………………Piera Pozzi…………………………………………………Evans Bentivogli ……………………………………………….…• I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI:Giacomo Schivardi …………………………………………………….Luca Giuffrida…………………………………………………….Padova, 15 Maggio 2013IL DIRIGENTE SCOLASTICOVincenzo Amato___________________________________________50