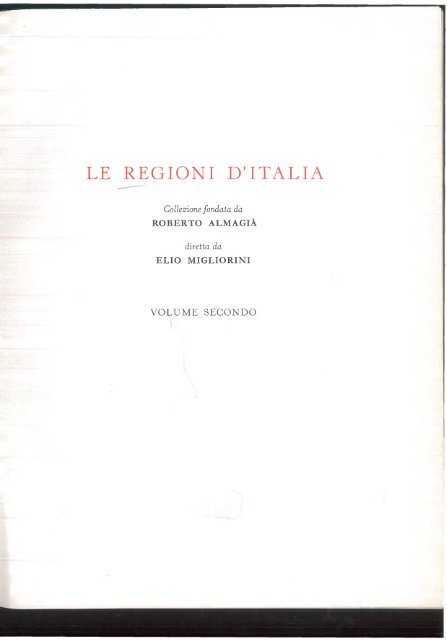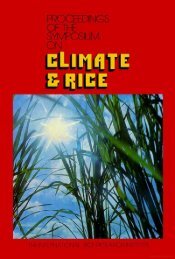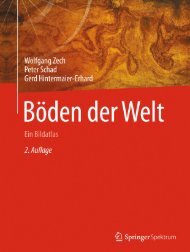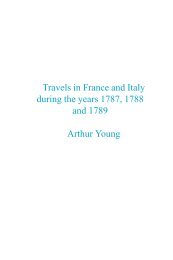Pracchi - 1971 - Lombardia
Pracchi - 1971 - Lombardia
Pracchi - 1971 - Lombardia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LE REGIONI D’ITALIA<br />
Collezione fondata da<br />
R O B E R T O A L M A G IÀ<br />
diretta da<br />
E L IO M IG L IO R IN I<br />
V O I^ U M E S E C O N D O
La Regione, che in Italia è, si può dire, quasi ovunque consacrata da una lunga tradizione<br />
storico-culturale ed ha radici ben salde anche nell'uso e nella coscienza popolare,<br />
ha oggi acquistato una sua fisonomia che si esprime anche nel campo politico-economico<br />
ed è riconosciuta dalle leggi costituzionali della Repubblica. La Unione Tipografico-Editrice<br />
Torinese si è pertanto accinta alla nobile iniziativa di offrire agli Italiani una nuova collezione<br />
completa di monografie regionali, che, sostituendosi alla antica collezione «La Patria»<br />
ormai esaurita, si inspiri tuttavia a concetti originali e sia definita da caratteristiche particolari,<br />
predisposte in base ad un piano organico accuratamente studiato.<br />
Assunta, per desiderio dell’ U.T.E.T., la direzione della Collezione, ho fatto ricorso<br />
alla collaborazione di colleghi già maturi e di ben nota fama, a miei antichi allievi diventati<br />
anch’essi docenti universitari ed anche a giovani studiosi. Tutti hanno risposto prontamente<br />
al mio appello, onde io porgo loro, già in queste righe di presentazione, un vivo e<br />
cordiale ringraziamento.<br />
Ogni collaboratore — uno ed uno solo per ciascun volume — ha redatto la propria<br />
monografia in modo che essa possa essere intesa facilmente da qualsiasi persona colta :<br />
si è perciò evitato il più possibile uno stretto tecnicismo e si è fatto uso di un linguaggio e di<br />
uno stile chiari e vivaci, così da rendere attraente la lettura. Questo fu infatti, sin dalla<br />
sua prima concezione, un criterio essenziale della Collezione.<br />
Ciascuna monografia è poi inspirata al concetto di mettere in vista le caratteristiche<br />
fondamentali della regione descritta; quelle cioè che nel campo fisico, umano, economico,<br />
storico, artistico, ne individuano la peculiare fisonomia e le danno lineamenti propri. Il<br />
paesaggio naturale e il paesaggio umanizzato sono entrambi alla base della esposizione;<br />
si mette anzi particolarmente in luce quanto l’uomo abbia operato ed operi nel trasformare<br />
il quadro naturale, con particolare riguardo alle attività più recenti.<br />
Larghissimo si è desiderato il corredo di fotografie, cartine, grafici. Le fotografie sono<br />
trascelte con cura da materiali originali copiosissimi e si compenetrano quasi col testo<br />
descrittivo, costituendone un espressivo e suggestivo complemento.<br />
E opportuno infine avvertire che questa Collezione si riconnette ad un’opera generale<br />
sull’Italia testé pubblicata, che è stata redatta dallo scrivente e mira invece a mettere<br />
in rilievo la fisonomia complessiva del nostro Paese.<br />
t R oberto A lmagià.<br />
Ili
ROBERTO PRAGGHI<br />
Ordinario di geografia nell’Università di Pavia<br />
L O M B A R D I A<br />
Seconda edizione riveduta e aggiornata<br />
Con una carta geografica e 8 tavole a colori fuori testo,<br />
36s figure e 36 cartine geografiche nel testo<br />
UNIO NE<br />
TIPO G RA FIC O - E D IT R IC E T O R IN E SE<br />
Uì
--VT*- ?••' ^ í,г,- -<br />
íy'v'Pf',-<br />
-••Ѵ.--'^.;.- - г*-:'-<br />
\ Гг-^<br />
'-'Wv<br />
■ д<br />
/<br />
;Х ,<br />
© <strong>1971</strong> Unione Tipografico-Editrice Torinese<br />
corso Raffaello 28 - 10125 Torino<br />
Tipografia Sociale Torinese<br />
corso Monte Cucco 108 - 10141 Torino<br />
) Й
Ringrazio il prof. A lfio N a t a le, direttore dell’Archivio storico di Milano, per avere<br />
cortesemente consentito di collaborare al paragrafo della sintesi storica, e il prof. A ugusto M a r i<br />
n o n i, docente di storia della lingua nell’Università cattolica di Milano, per il paragrafo sui<br />
dialetti lombardi.<br />
Ringrazio inoltre i numerosi enti che con informazioni о con illustrazioni hanno agevolato<br />
il lavoro, e in particolare; l’Ufficio idrografico del Po, l’Ispettorato provinciale di Agricoltura<br />
di Milano, le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, l’Ente Provinciale del Turismo<br />
di Bergamo, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, l’Ente Nazionale Idrocarburi,<br />
l’Azienda Elettrica Municipale di Milano, la Dalmine.<br />
Ringrazio infine il prof. G iu seppe N a n g ero n i, il prof. L uciano M oser, il professor<br />
A lfredo C o rti, il signor F ed e l e Sa n e l l i ed altri amici e conoscenti per aver concesso la<br />
riproduzione di loro fotografie.
INDICE<br />
Pag.<br />
III<br />
C apitolo P rim o. — Il nome e il territorio ........................<br />
Origine e vicende del nome .................................<br />
I limiti re g io n a li...........................................................<br />
La posizione...................................................................<br />
C apito lo S econdo. — Le vicende storiche.............................<br />
I primi a b ita to ri..........................................................<br />
Dalla conquista romana alle dominazioni straniere<br />
II sorgere dei Comuni ..............................................<br />
La Signoria dei Visconti e degli S fo r z a .................<br />
Dal dominio spagnolo all’unità d’I t a l i a .................<br />
C apitolo T erzo. — Il rilievo: montagne e pianure . . .<br />
Cenni geom orfologici...................................................<br />
I gruppi montuosi a l p i n i ..........................................<br />
Le grandi v a lla te ...........................................................<br />
La zona p r e a lp in a .......................................................<br />
La zona della c o llin a ...................................................<br />
La pianura........................................................................<br />
L ’Oltrepò p a v e se ...........................................................<br />
) I<br />
)> 1<br />
)) 4<br />
)) i6<br />
)) 19<br />
» 19<br />
) 23<br />
)> 29<br />
)) 33<br />
)) 43<br />
)) 49<br />
)) 49<br />
» 57<br />
)) 71<br />
)) 78<br />
) 87<br />
) 90<br />
) 94<br />
C apito lo Q uarto. — Le acque....................................................<br />
Caratteristiche g e n e ra li..............................................<br />
I gh iacciai.......................................................................<br />
I lagh i................................................................................<br />
I fiumi................................................................................<br />
I fo n ta n ili........................................................................<br />
C apito lo Q uin to. — Il clima e la vita vegetale ed animale<br />
La temperatura...............................................................<br />
Le precipitazioni...........................................................<br />
I venti ............................................................................<br />
) 95<br />
) 95<br />
» 97<br />
)) 99<br />
)) 114<br />
)) 133<br />
)) 137<br />
)> 138<br />
» 146<br />
)) 154<br />
В — L e Regioni d ’Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
IX
IMÜIL.LLUUW,<br />
La vegetazione.....................................................................................................................Pag. 157<br />
La fauna ............................................................................................................................. » 163<br />
Capitolo Sesto. — Le suddivisioni territoriali........................................................................... » 165<br />
Le regioni montane................................................................................................................. » 165<br />
Le regioni di collina e di p ia n u r a .................................................................................... » 173<br />
La divisione am m inistrativa................................................................................................ » 179<br />
Capitolo Settimo. — La popolazione e la sua distribuzione...................................................... » 183<br />
L ’aumento della popolazione................................................................................................ » 183<br />
Il movimento naturale............................................................................................................. » 190<br />
La densità di popolazione.................................................................................................... » 196<br />
L ’esodo dalla m ontagna........................................................................................................ » 208<br />
Emigrazione e immigrazione................................................................................................ » 212<br />
Condizioni sociali . . . . ' .................................................................................................... » 217<br />
Istituti culturali ..................................................................................................................... » 219<br />
Capitolo Ottavo. — L ’insediamento urbano e r u r a le .............................................................. » 225<br />
Modi e forme dell’insediam ento........................................................................................ » 225<br />
Insediamento accentrato e sp arso ........................................................................................ » 227<br />
I c e n t r i...................................................................................................................................... » 234<br />
Caratteristiche dei centri .................................................................................................... » 238<br />
Le dimore r u r a li............................................................................................................ » 247<br />
C on clu sio n e............................................................................................................................. » 263<br />
Capitolo N ono. — Tradizioni e dialetti regionali....................................................................... » 267<br />
Declino delle trad izion i......................................................................................................... » 267<br />
I dialetti lo m b a rd i................................................................................................................. » 271<br />
Caratteristiche dei dialetti lom bardi.................................................................................... » 273<br />
La letteratura d ialettale......................................................................................................... » 278<br />
Capitolo D ecimo. — L ’agricoltura, Vallevamento e i loro aspetti geografici......................... » 285<br />
Le attività eco n o m ich e........................................................................................................ » 285<br />
Le grandi opere d’irrig a z io n e ............................................................................................ » 289<br />
Lo sviluppo dell’ag rico ltu ra................................................................................................ » 305<br />
Decadenza della ru ralità......................................................................................................... » 312<br />
Progresso tecn ico ..................................................................................................................... » 315<br />
La proprietà fondiaria............................................................................................................. » 321<br />
Le colture e le zone a g rarie ................................................................................................ » 326<br />
II b o s c o ...................................................................................................................................... )) 335<br />
L ’allevam en to ......................................................................................................................... » 337<br />
La pesca .................................................................................................................................. » 343<br />
Capitolo U ndicesimo. — L ’attività industriale e commerciale.............................................. » 345<br />
Lo sviluppo in d u striale......................................................................................................... » 345<br />
L ’industria e stra ttiv a ............................................................................................................. » 353<br />
X<br />
ШШ ШІІгШШШіІ; ШІІІШШШШ
L ’industria idroelettrica e termoelettrica........................................................................Pag. 360<br />
Le industrie alim en tari.....................<br />
L ’industria tessile..................................<br />
L ’industria siderurgica e metallurgica<br />
L ’industria ch im ica..............................<br />
Industrie v a r i e ......................................<br />
L ’attività commerciale..........................<br />
Le comunicazioni..................................<br />
Il tu rism o ..............................................<br />
» 366<br />
» 371<br />
» 377<br />
» 383<br />
» 386<br />
» 389<br />
» 390<br />
» 399<br />
C apito lo D odicesim o. — Attraverso le terre lombarde.<br />
Il Milanese e il Lodigiano.................<br />
Il Pavese, la Lomellina e l’Oltrepò .<br />
Il Cremonese e il Cremasco . . . .<br />
Il Mantovano ......................................<br />
Il B re sc ia n o ..........................................<br />
Il B ergam asco ......................................<br />
Il Comasco e la Brianza.....................<br />
La Valtellina e le valli di Chiavenna<br />
Il V a re so tto ..........................................<br />
» 405<br />
» 405<br />
» 417<br />
» 421<br />
» 424<br />
» 428<br />
» 434<br />
» 440<br />
» 449<br />
» 45 S<br />
C apito lo T r ed icesim o. Milano e le maggiori città lom barde...................................... » 459<br />
Milano<br />
Varese .<br />
Como .<br />
Bergamo<br />
Brescia<br />
Pavia .<br />
Cremona<br />
Mantova<br />
459<br />
486<br />
489<br />
496<br />
503<br />
S09<br />
516<br />
522<br />
Conclusione........................................................................................................................................... » 529<br />
Nota di aggiornamento alla seconda edizione ............................................................................ » 533<br />
Nota bibliografica.............................................................................................................................. » 557<br />
Appendice bibliografica alla seconda edizione............................................................................... » 562<br />
Indice analitico alfabetico................................................................................................................. » 5^5<br />
T A B E L L E<br />
I. Temperature medie mensili e annue in ° C .....................................................................Pag. 541<br />
II. Precipitazioni medie mensili e annue in mm.................................................................... » 542<br />
IH. Dati relativi ai laghi lombardi........................................................................................... » 543<br />
IV. Ripartizione della superficie regionale e provinciale tra pianura, collina e montagna<br />
.................................................................................................................................. » 543<br />
XI
V. La popolazione in <strong>Lombardia</strong> dal 1750 al 1857 (esclusi l’Oltrepò pavese e la<br />
Lomellina) . . . . * .................................................................................................... Pag. 544<br />
VI. Densità calcolata sulla popolazione presen te................................................................. » 544<br />
VII. Popolazione (presente) della Regione e delle Province dal 1861 al 1951 . . . . » 545<br />
V ili. Popolazione residente dei centri, dei nuclei e delle case sparse in <strong>Lombardia</strong> (censimento<br />
1 9 5 1 ) ................................................................................................................... » 546<br />
IX. Popolazione residente dei centri, dei nuclei e delle case sparse in <strong>Lombardia</strong> (censimento<br />
19 6 1) .................................................................................................................... » 547<br />
X. L ’emigrazione lombarda dal 1876 al 1956 »<br />
XI. La popolazione residente attiva lombarda per settore di attività economica . . . » 549<br />
XII. Popolazione presente nel comune di Milano nei censimenti 1 8 6 1 - 1 9 5 1 ................... » 550<br />
XIII. Aumento di popolazione residente nei maggiori comuni lombardi dal 1901 al 1951 » 551<br />
XIV. Patrimonio zootecnico (censimento 1 9 6 1 ) ........................................................................ » 551<br />
XV. Ripartizione del territorio delle province e della regione secondo l’utilizzazione<br />
(e tta ri)............................................................................................................................... » 552<br />
XVI. Estensione e produzione delle principali colture erbacee e le g n o se ........................ » 553<br />
XVII. Numero delle imprese industriali secondo il numero degli addetti (censimento 1961 ) » 554<br />
XVIII. Addetti alle imprese industriali (distinte per numero di addetti) (censimento 1961) » 554<br />
XIX. Unità locali per ramo di attività economica (censimento 19 6 1 ) ................................ » 555<br />
XX. Addetti alle unità locali per ramo di attività economica (censimento 1961) . . . » 555<br />
C A R T IN E D IM O STRATIV E N E L TESTO<br />
Uexclave di Campione d’I t a lia .........................................................................................................Pag. 7<br />
La divisione politica del territorio lombardo verso il 1 3 0 0 ............................... » 34<br />
La divisione politica del territorio lombardo dopo la Pace di Lodi ( 1 4 5 4 ) .. » 38<br />
Divisione politica del territorio lombardo nel 1559 (Pace di Càteau-Cambrésis) . . . » 43<br />
La divisione politica del territorio lombardo nel 1 7 1 4 ........................................................... “ 46<br />
Le zone di montagna, collina, p ia n u r a ........................................................................................ » 50<br />
Schema geolitologico del territorio della <strong>Lombardia</strong>......................................................... » 56<br />
Il gruppo montuoso del B e rn in a .................................................................................................. » 64<br />
La zona dei fontanili nella pianura lo m b a rd a ........................................................................... » 134<br />
Carta delle precipitazioni................................................................................................................. » 147<br />
Divisione della <strong>Lombardia</strong> in regioni e sottoregioni geografiche, storiche e tradizionali » 168<br />
I dipartimenti lombardi del Regno ita lic o ................................................................................... » i 79<br />
La divisione in province dopo la R estaurazione....................................................................... » 180<br />
Rappresentazione schematica della densità media per kmq. in Lom bardia............................. » 197<br />
Distribuzione della popolazione sparsa (in % sulla residente) (censimento 1951) . . . » 226<br />
La distribuzione dei piccoli aggregati di case ( = nuclei) nel territorio bergamasco e, in<br />
parte, bresciano............................................................................................................................. » 230<br />
Distribuzione dei centri della L o m b a rd ia ................................................................................... » 248<br />
Caratteristica zona a « corti » sparse a est di Cremona tra Malagnino, Bonemersa e Pieve<br />
d’O lm i.............................................................................................................................................. » 252<br />
Forme prevalenti di dimore rurali in Lom bardia....................................................................... » 256<br />
Schema dei tipi di insediamento in <strong>Lombardia</strong> ....................................................................... » 265<br />
L ’alta percentuale della popolazione non agricola, sul totale di popolazione economicamente<br />
attiva (valori arrotondati all’unità) nell'alta pianura e nella collina della <strong>Lombardia</strong><br />
occidentale........................................................................................................................ » 286<br />
XII
I grandi canali tra Ticino e Adda e la rete principale di irrigazione.................................. Pag. 290<br />
Le irrigazioni in Lom b ard ia............................................................................................................. » 300<br />
Le coltivazioni prevalenti nelle diverse zone della L o m b ard ia.............................................. » 329<br />
La rete dei metanodotti..................................................................................................................... » 358<br />
I principali impianti idroelettrici negli alti bacini dell’Adda e dell’O glio............................. » 362<br />
Centri tessili della L o m b a rd ia ........................................................................................................ » 374<br />
La rete fondamentale delle strade della Lom bardia................................................................... » 396<br />
Schema degli impianti della città e del comune di M i la n o .................................................. » 474<br />
Distribuzione delle industrie in Milano nel 1 8 8 1 .................................. » 478<br />
Distribuzione delle industrie in Milano nel 1 9 1 0 .................................. » 478<br />
Distribuzione delle industrie in Milano nel 19 5 8 .................................. » 479<br />
Pianta di M ila n o ................................................................................................................................ » 482<br />
Pianta di Como a t t u a le ................................................................................................................... » 490<br />
Pianta di P a v ia .................................................................................................................................... » 514<br />
Sviluppo topografico di Pavia dall’antichità ad o g g i................................................................... » 515<br />
Pianta di C re m o n a............................................................................................................................ » 520<br />
T A V O L E A C O L O R I<br />
La Rocca Scaligera a Sirmione sul lago di G a r d a ....................................................................Pag. 32<br />
L ’aspro versante settentrionale dell’Adamello (m. 3554) con la sottostante Vedretta dei<br />
Frati, dai laghetti del Veneròcolo (m. 2 5 4 0 ) ....................................................................... » 64<br />
Madonna di Tirano, con il suo Santuario cinquecentesco, e Tirano (m. 438) in Valtellina » 240<br />
Il Naviglio Grande a C o r s ic o ......................................................................................................... » 288<br />
Fienagione in una marcita della Lomellina.................................................................................... > 320<br />
Impianto della « Montecatini » per la produzione di acido cianidrico a R h o ........................... » 384<br />
Il Sacro Monte (m. 880) nelle Prealpi di V arese....................................................................... » 45^<br />
Milano modernissima: il grattacielo Pirelli ................................................................................ » 480<br />
XIII
LOMBARDIA
Ъ.А.4 . .<br />
i<br />
B i<br />
n 1<br />
И<br />
LOMBARDIA<br />
8 S V<br />
---------------<br />
^ — r -<br />
1 : 1 2 5 0 0 0 0<br />
SîiÇi^<br />
»'l^jí^-J<br />
IW '<br />
p:<br />
Le Regioni d'Italia<br />
U N IO N E T IP O G R A F IC O -E D IT R IC E TO R IN ESE
Capitolo Primo<br />
IL NOME E IL TERRITORIO<br />
Origine e vicende del nome.<br />
Il territorio della regione lombarda, che per la sua prosperità costituisce un vanto<br />
dell’Italia intera e per le sue^ellezze naturali e per il suo fervore di attività è nota<br />
in tutto il mondo, deriva il suo toponimo dal nome di un antico popolo barbaro:<br />
i Langobardi о Longobardi. Erano questi di stirpe germanica, originariamente stanziati<br />
lungo il Danubio nell’area press’a poco corrispondente alla Pannonia, la quale,<br />
prima dell’esodo, era denominata appunto Langobardia. La leggenda vuole che al<br />
popolo il nome venisse dalla lunga barba che gli uomini solevano portare ; « nam<br />
— osserva Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum — iuxta illorum linguam<br />
‘ lang ’ longam, ‘ bari ’ barbara significai », e non manca di riferire il mito per cui la<br />
denominazione venne adottata in sostituzione dell’antica di Winnili.<br />
E noto come nella primavera dell’anno 568 d. C. l’orda longobarda, che la fama<br />
annunciava (come riferisce Velleio Patercolo) più feroce della germanica ferocia,<br />
calò, guidata da re Alboino, dalle Alpi Giulie e, saccheggiando e distruggendo,<br />
dilagò in gran parte della pianura veneta e padana, prendendovi stanza. Annoverava<br />
in tutto forse non molto più di centomila individui, comprese le donne e i bambini<br />
al seguito dei guerrieri, e costituiva certo una entità assai inferiore per numero alle<br />
genti insediate nella vasta pianura oggetto della conquista; ma queste erano divise<br />
di fede e di opinione, inermi e disusate alle armi. Caduta dopo tre anni Pavia,<br />
ultimo baluardo di resistenza, la città fu eletta capitale del nuovo regno, che si espanse<br />
in tempi successivi anche nella penisola.<br />
I — Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.
Gome già in periodo augusteo il territorio dell’attuale <strong>Lombardia</strong> era stato suddiviso<br />
tra la X e XI provincia, rispettivamente la Transpadana e la Venetia (con<br />
limite, tra l’una e l’altra, all’Oglio); ugualmente in periodo longobardo il territorio<br />
fu aggregato a due parti distinte in corrispondenza del corso dell’Adda: quella a<br />
oriente era compresa nell’Austria (termine con significato di « territorio orientale »),<br />
quella a occidente era compresa nella Neustria (con significato di « territorio occidentale<br />
»). Però su tali denominazioni con il trascorrere del tempo finì per prevalere<br />
l’appellativo di Langobardia in contrapposizione a Romania, come veniva chiamata<br />
dai Bizantini la parte dei territori lungo le coste adriatiche a loro fedeli.<br />
Il nome di Langobardia già si può leggere, e forse per la prima volta, in<br />
un codice datato da Parigi del 30 luglio 629 (ossia sessantun anni dopo la calata<br />
dei Longobardi) in cui Dagoberto, re dei Franchi, dichiara aperto il mercato di<br />
Parigi ai mercanti sive de Híspanla et de provincia sive de Langobardia. E da<br />
notare, però, che a quel tempo e ancor più nei secoli seguenti l’accezione del<br />
toponimo, per quanto non nettamente definito, superava di molto i limiti dell’attuale<br />
regione, estendendosi non solo a quasi tutta la conca padano-veneta, ma<br />
altresì, specie in periodo carolingio, all’intera Italia. Ciò appare documentato nei<br />
codici del secolo IX, nei quali i riferimenti all’Italia talvolta specificano: quae et<br />
Langobardia dicitur. Tale identificazione perdurò a lungo e benché, dopo Г888,<br />
con il termine di Langobardia si intendesse precisare la marca carolingia cui Milano<br />
era centro, ancor ai tempi dell’Alighieri il termine lombardo era usato come sinonimo<br />
di italiano. In seguito tal uso disparve e, con il trascorrere del tempo, il<br />
toponimo, abbreviato in <strong>Lombardia</strong>, rimase a un limitato territorio della pianura<br />
padana dove aveva preso stabile dimora il nucleo più consistente dell’orda longobarda.<br />
Tale territorio, tuttavia, non ebbe modo di identificarsi stabilmente con<br />
confini ben definiti, sicché non può far meraviglia di trovar menzionata nelle<br />
antiche carte, anche dopo il declino della potenza longobarda, una <strong>Lombardia</strong><br />
Veneta.<br />
In realtà la <strong>Lombardia</strong>, quale oggi s’intende, non costituì mai, nel volgere dei<br />
secoli, una unità politica о amministrativa, e solamente agli albori del Risorgimento<br />
acquisì una delimitazione territoriale sufficientemente chiara e stabile. Infatti lo<br />
stesso Ducato dei Visconti e degli Sforza, che costituì la maggiore potenza politica<br />
lombarda del Medioevo, in nessun tempo coincise esattamente con i limiti<br />
attuali e più volte fu soggetto a notevoli modificazioni marginali del suo territorio;<br />
esso tutt’al più agì, anche in ragione dell’importanza della città di Milano, che ne<br />
era la capitale, come stabile nucleo di attrazione. Alla Pace di Aquisgrana (1748)<br />
lo Stato di Milano comprendeva approssimativamente le attuali circoscrizioni provinciali<br />
di Milano, di Como, di Varese e parte di quella di Cremona (escluso il<br />
territorio di Crema), il circondario di Pavia e il territorio di Treviglio, con una<br />
superficie complessiva di circa 7900 chilometri quadrati. Nel volgere del secolo XVIII<br />
allo Stato vennero via via aggregandosi i territori del Ducato di Mantova, del Ducato<br />
di Sabbioneta e del Principato di Bozzolo. La campagna napoleonica in Italia (1796),
con la conseguente sottrazione alla Repubblica veneta del Bresciano, del Bergamasco<br />
e del Cremasco e poi la creazione della Repubblica Cisalpina con l’annessione della<br />
Valtellina e delle contee di Bormio e di Chiavenna, agì come avvio verso la formazione<br />
dell’unità regionale lombarda tra le Alpi e il Po, tra il Ticino e il Mincio. Il<br />
Congresso di Vienna e soprattutto le patenti imperiali del 7 aprile 1815, costituendo<br />
il Regno lombardo-veneto, a parte ogni altra considerazione, ne furono il riconoscimento<br />
politico. La <strong>Lombardia</strong> si estendeva, allora, per 21.564 chilometri quadrati.<br />
L ’assetto amministrativo conseguente all’unità italiana portò un aumento della<br />
superficie della <strong>Lombardia</strong>, poiché ad essa, dopo l’armistizio di Villafranca (1859),<br />
furono incorporate le terre della Lomellina e dell’Oltrepò pavese e, dopo la pace<br />
di Vienna (1866), furono di nuovo aggregate Mantova e le sue terre, perdute nel 1859.<br />
Alla data censuarla del 1871 la <strong>Lombardia</strong> misurava 23.527 chilometri quadrati.<br />
Nè, in seguito, le variazioni di superficie assunsero entità degna di menzione.<br />
Fot. Fotocelere<br />
Il confine italo-svizzero sul lago di Lugano tra Lavena e Pontetresa.<br />
A sinistra la sponda italiana, a destra la svizzera.<br />
Di sfondo il solco del torrente Tresa che scende al lago Maggiore.
I limiti regionali.<br />
I precedenti cenni sono sufficienti a indicare l’incerto e lento manifestarsi nel<br />
tempo di una individualità regionale lombarda e ciò anche a causa dell’assenza di<br />
una ben definita individualità fisica unitaria. Sotto questo aspetto, volendo attribuire<br />
come proprio della <strong>Lombardia</strong> il territorio costituito dal versante inferiore<br />
di sinistra del Po, si dovrebbero, come limiti fondamentali, indicare il crinale delle<br />
Retiche e delle Lepontine al bordo settentrionale, il medio corso del Po al bordo<br />
meridionale e i corsi del Ticino e del Sarca-Mincio ai bordi rispettivamente occidentale<br />
e orientale. Ne risulterebbero grosso modo quattro lati, uno per ciascuno<br />
dei punti cardinali, per cui, semplificando, è entrato nell’uso di paragonare la forma<br />
della <strong>Lombardia</strong> approssimativamente a quella di un quadrilatero. Ma, se si tien<br />
conto dei confini politici (lungo l’arco alpino) e provinciali (sugli altri lati), il terri-<br />
Chiasso (in primo piano) e Pontechiasso (al margine superiore dell’abitato),<br />
valico di frontiera più importante tra <strong>Lombardia</strong> e Svizzera.<br />
Di sfondo la città di Como, il Montorfano e Brúñate.<br />
Fot. Wyrsch
Fot. Swissair<br />
Veduta di Bellinzona.<br />
torio assegnato alla <strong>Lombardia</strong> presenta rientranze e appendici tali, da alterare profondamente<br />
la figura geometrica e rendere insignificante la similitudine. Tali confini<br />
misurano complessivamente 1393 km. e si sviluppano con un decorso quanto mai<br />
capriccioso, che solo in parte s’annoda ai limiti fisici sopra indicati.<br />
Il confine settentrionale della <strong>Lombardia</strong> coincide con un tratto del confine politico<br />
dello Stato italiano verso la Confederazione elvetica, che può considerarsi risultato<br />
di secolari vicende, cristallizzatosi nel 1797 con la formazione della Repubblica Cisalpina.<br />
Si snoda quasi totalmente in ambiente alpino e prealpino tra l’estremità settentrionale<br />
del lago Maggiore e il passo dello Stelvio, seguendo lo spartiacque principale<br />
solo per brevi tratti e disegnando deviazioni da esso in genere molto marcate e in<br />
prevalenza rivolte in versante padano. Nella sezione occidentale, ossia dal Verbano<br />
al Ceresio, il confine, snodandosi tra il monte e il piano, disegna il saliente meridionale<br />
del Canton Ticino (Svizzera) il cui apice tra Róderò e Ponte Chiasso lambisce<br />
il margine settentrionale della zona collinare. Il Ceresio, che si distende con<br />
uno sviluppo pressoché trasversale al saliente, viene lambito e tagliato alle sue<br />
estremità occidentale (Ponte Tresa-Porto Ceresio) e orientale (Santa Margherita-
гкШтШііШіШШмі<br />
I<br />
Veduta aerea di Campione d’Italia,<br />
exclave sulle sponde del lago di Lugano.<br />
Fot. Swissair<br />
Gandria), sicché il territorio propriamente lombardo comprende una porzione dello<br />
specchio anche di questo lago. E da notare inoltre che sulla riva orientale del medesimo<br />
si trova il minuscolo exclave di Campione. Nel complesso lo sviluppo di questo<br />
tratto di confine lombardo-ticinese è estremamente capriccioso ed è tale in quanto<br />
rappresenta il limite estremo delle acquisizioni svizzere avvenute nei secoli XV e XVI.<br />
Fu allora che l’aspirazione della Lega dei Cantoni d’Oltralpe a dominare l’accesso<br />
al Gottardo, già a stento soffocata dalle forze del Ducato di Milano, al declinare<br />
della potenza di questo, in seguito alla morte di Gian Galeazzo Visconti (1402), si<br />
concretò in una spedizione che per la vai Leventina mirava a Bellinzona. Ricacciati<br />
dalle milizie viscontee del Carmagnola, che guidò alla vittoria di Arbedo (1432),<br />
gli Svizzeri ripresero a discendere per le valli ticinesi pochi anni appresso: nel 1478<br />
per la vai Levantina raggiunsero Bellinzona; nel 1503, invano contrastati dalle forze<br />
di Ludovico il Moro, estesero la conquista dalla valle del Bienio alla Riviera, e<br />
nel 1512 occuparono Mendrisio, Lugano e la vai Maggia sin press’a poco ai limiti<br />
indicati dal confine attuale. Terra di conquista, l’alto Ticino languì sino a che, in<br />
periodo napoleonico, venne riconosciuto come cantone autonomo e annesso come<br />
tale alla Confederazione svizzera.
^ ’exclave di Campione d’Italia.<br />
Dai tipi dell’Istituto Geografico Militare (autorizzazione n. 902/ST/P del 17 dicembre 1959)-
V’ .SFi<br />
r_' - _ . '*•“ “ « ' f -■ ^ .<br />
i '-' _ y • _j4>^ís¿-j<br />
Montespluga, il lago omonimo (1908 m.)<br />
e, sullo sfondo, il passo dello Spluga (2115 m.), al confine italo-svizzero.<br />
Fot. Pasina<br />
Agli avvenimenti storici ora accennati si annodano le vicende riguardanti Campione,<br />
minuscolo exclave di 2,60 kmq. (dei quali, però, 1,70 sono di superficie<br />
lacustre); la fascia costiera, costituita dal versante inferiore del monte Sighignola,<br />
si estende come sviluppo per circa due chilometri e mezzo e nel tratto mediano<br />
accoglie, su lento pendio, il centro di Campione, cui si accede unicamente da una<br />
diramazione della grande arteria del Gottardo al ponte di Melide. L ’origine di questo<br />
piccolo exclave è piuttosto incerta. « Fino al 743 non si sa niente di certo. Ad ogni<br />
modo è tra il 756 e il 777 che matura quello stato di cose che ha poi dato origine a<br />
questa anomalia politico-territoriale, perpetuatasi fino ai giorni nostri. In tale periodo,<br />
infatti, avvennero donazioni di oliveti e di altri beni da parte di privati alla basilica<br />
locale di San Zenone e al monastero di Sant’Ambrogio di Milano. Per ben dieci<br />
secoli il monastero esercitò veri e propri diritti di sovranità temporale, oltre che<br />
spirituale, su Campione, ricevendo spesso espliciti riconoscimenti da parte della<br />
Svizzera. Molti però furono i privilegi concessi in cambio; il più importante risultò<br />
il diritto di protezione spettante ai vassalli. Nel 1516, ad es., proprio per questa<br />
8
Fot. Steiner<br />
Bondo, in valle Bregaglia, e la valle Bondasca, politicamente territorio svizzero, idrograficamente padano.<br />
Sullo sfondo, il gruppo di Sciora, il Cengalo e il Badile lungo i quali si snoda il confine.
Lo spartiacque tra il pizzo Tremoggia (a sinistra) e il pizzo Roseg (gruppo del Bernina) lungo il quale<br />
sua condizione particolare, Campione si salvò dall’occupazione svizzera che, per<br />
la debolezza degli Sforza, non risparmiò nessun angolo del Canton Ticino. Il feudo<br />
ambrosiano ebbe termine solo il 2 febbraio 1797, allorché, in base al Trattato di<br />
Campoformido, la <strong>Lombardia</strong> entrò a far parte della nuova Repubblica Cisalpina;<br />
in tale occasione infatti tutti i beni del monastero ambrosiano vennero confiscati<br />
e sottoposti al censo. Al Congresso di Vienna del 1815 la Svizzera cercò invano di<br />
annettersi Campione (oltre alla Valtellina, Bormio e Chiavenna)»; con la costituzione<br />
del Regno lombardo-veneto esso venne incluso nella provincia di Como e annesso<br />
al comune di San Fedele Intelvi prima e di Castiglione poi, finché con la liberazione<br />
della <strong>Lombardia</strong> entrò a far parte del Regno d’Italia (L. Pedreschi).<br />
Dal Ceresio, risalendo il poderoso contrafforte che s’erge a spartiacque tra il bacino<br />
dell’Adda e quello del Ticino, il confine s’interna decisamente nell’ambito delle<br />
Alpi, raggiungendo il passo dello Spinga (2115 m.) sullo spartiacque alpino tra il<br />
bacino padano e quello renano; ma da questo si allontana nuovamente poco ad<br />
IO
si snoda il confine politico italo-svizzero. Sotto la cresta si stende il ghiacciaio di Scerscen (versante padano).<br />
Fot. Fracchi<br />
oriente del passo per discendere in versante del Reno a circoscrivere la valle di Lei,<br />
già per lontane vicende storiche e per esigenze economiche legata al Chiavennasco<br />
e alla sua attività pastorale e rimasta poi annessa di conseguenza (ma non senza<br />
contrasti) alla <strong>Lombardia</strong>, unico lembo del bacino renano politicamente italiano. La<br />
valle, limitata verso l’Italia da una cresta elevata, è accessibile dal territorio italiano<br />
soltanto durante la stagione estiva (passi di Lei, 2660 m., e Angeloga, 2379 m.);<br />
d’inverno la si può raggiungere unicamente dal territorio svizzero (Innerferrera),<br />
ma in tale periodo risulta completamente disabitata.<br />
Il confine italo-svizzero, raggiunto un’altra volta lo spartiacque alpino tra il<br />
pizzo del Lago (3069 m.) e il pizzo Galleggione (3106 m.), un’altra volta lo abbandona<br />
per discendere al solco della vai Bregaglia (percorsa dal torrente Mera che<br />
proviene dal passo del Maloggia); la taglia trasversalmente a mezzo e s’eleva in<br />
versante opposto per raggiungere la cresta dell’aspro gruppo del pizzo Badile (3307 m.)<br />
e della Cima di Castello (3378 m.), per quindi riannodarsi allo spartiacque alpino<br />
II
al passo del Muretto (2560 m.) e seguirne lo sviluppo nel gruppo del Bernina passando<br />
successivamente per le più elevate e celebri vette delle Alpi Retiche, quali<br />
il pizzo Roseg (3936 m.), la punta Perrucchetti (4021 m.), che forma l’anticima del<br />
pizzo Bernina (4049 m.) e il pizzo Palù (3906 m.). Abbandonando di nuovo lo spartiacque<br />
il confine descrive poi due ampie deviazioni, una di seguito all’altra, la prima in<br />
versante padano, la seconda in versante danubiano ; dapprima cioè scende lungo il contrafforte<br />
sul quale si affaccia dominante il pizzo Scalino (3322 m.) per raggiungere<br />
il fondo della valle di Poschiavo, confluente dell’Adda, presso i ruderi del castello<br />
di Piattamala poco a monte del Santuario della Madonna di Tirano; quindi, risalendo<br />
il contrafforte opposto del Sassalbo (2865 m.), si riannoda allo spartiacque<br />
alpino che di nuovo abbandona per discendere in versante danubiano e ivi aggirare<br />
torno torno la valle di Livigno il cui torrente Spöl riversa le sue acque nell’Inn.<br />
Infine il confine, seguendo lo spartiacque tra il bacino dell’Adda e quello dell’Adige,<br />
La valle di Poschiavo (con il centro omonimo), confluente nella Valtellina,<br />
politicamente svizzera. Sullo sfondo il pizzo Scalino e la cresta lungo cui corre il confine.<br />
Fot. Steiner<br />
12<br />
T f J T T n .'ì,' Î ; Í f « Ш : r r n f T
Fot. Fracchi<br />
L ’ampia e verde valle di Livigno (i8i8 m.).<br />
piccolo lembo del bacino idrografico del Danubio<br />
incluso nel territorio politico italiano.<br />
raggiunge lo Stelvio. Di queste tre grandi deviazioni del confine politico dallo spartiacque<br />
principale, due assicurano il completo dominio svizzero dei valichi del Maloggia<br />
e del Bernina, testimonianza di antichissime vicende storiche e di secolari controversie.<br />
I più lontani precedenti storici della attuale divisione politica possono ritenersi<br />
anzitutto l’erezione di Coira a sede vescovile suffraganea di Milano, risalente<br />
al 453, poi la creazione dei feudi di vai Poschiavina e di vai Bregaglia avvenuta verso<br />
il 755 per concessione di Carlo Magno, infine la dipendenza dei due feudi dal vescovo<br />
di Coira decretata da Ottone I verso il 960. La scissione dei due feudi dalla Valtellina<br />
suscitarono controversie aspre e tenaci per le rivendicazioni dei diritti di pascolo<br />
e di bosco da parte di Tirano nei riguardi della valle di Poschiavo e da parte di Chiavenna<br />
e Piuro nei riguardi della vai Bregaglia; non le sopirono nè la dominazione<br />
dei Visconti e degli Sforza, nè l’occupazione grigionese di tutta la Valtellina, nè le<br />
vicende che intercorsero dalla Repubblica Cisalpina all’unità d’Italia. Solo nel 1863<br />
una convenzione tra il Regno d’Italia e la Confederazione elvetica portò ad una pacifica<br />
soluzione degli annosi problemi e all’adozione dei confini che, salvo rettifiche<br />
di dettaglio, sono gli stessi di oggi.<br />
13
Sugli altri tre lati i limiti regionali della <strong>Lombardia</strong> subiscono il richiamo dell’idrografia;<br />
ma il loro decorso non è tuttavia meno capriccioso.<br />
Sul lato occidentale il limite della <strong>Lombardia</strong> con il Piemonte si stacca dal confine<br />
politico dello Stato in coincidenza dell’apice settentrionale del Verbano di cui<br />
segue il solco snodantesi verso sud; discende quindi nel piano lungo il corso del<br />
Ticino; ma, pochi chilometri a valle del ponte di Boffalora, se ne allontana con<br />
brusco gomito verso sudovest per raggiungere la Sesia e quindi, serpeggiando lungo<br />
il corso di essa, il Po, includendo pertanto nella <strong>Lombardia</strong> la bella terra lomellina.<br />
Sul lato orientale il limite della <strong>Lombardia</strong> con l’Alto Adige, il Trentino e il<br />
Veneto si snoda dallo Stelvio lungo lo spartiacque tra i bacini dell’Adda e dell’Adige,<br />
seguendo la cresta del grandioso arco montuoso dominato dalle vette del Gran Zebrù<br />
(3859 m.) e del Cevedale (3778 m.); prosegue dal Corno dei Tre Signori (3359 na-)<br />
mantenendosi lungo lo spartiacque che distingue i bacini dell’Oglio e dell’Adige<br />
e, attraverso il passo del Tonale (1885 m.), raggiunge il gruppo dell’Adamello, da<br />
Il Ticino a Boffalora con il ponte di barche e il metanodotto.<br />
Dal Verbano sino a questo punto il fiume segna il limite tra <strong>Lombardia</strong> e Piemonte.<br />
Fot. Fracchi<br />
H<br />
14
i<br />
Fot. Dromostampa<br />
Il passo dello Stelvio (m. 2757), al limite tra la <strong>Lombardia</strong> e l’Alto Adige.<br />
Il valico è, per altezza, il secondo delle Alpi percorso da strada carrozzabile;<br />
io supera, di pochi metri, solo il passo dell’Iseran (Francia).<br />
cui discende mantenendosi in cresta lungo lo sprone meridionale per dirigersi verso<br />
le valli Giudicarie che attraversa in prossimità dell’apice settentrionale dellago d’Idro;<br />
da qui, piegando a gomito verso oriente, per groppe montuose, passa al lago di Garda<br />
di cui segue longitudinalmente il solco sino alla pianura; in questa serpeggia prima<br />
a cavallo del Mincio, si snoda poi tortuoso allontanandosi progressivamente dal fiume<br />
con direzione sudest; raggiunto il Po poco a valle di Ostiglia, ne segue il corso sino<br />
a Quatrelle.<br />
Sul lato meridionale il limite della <strong>Lombardia</strong> con l’Emilia segue per la maggior<br />
parte il corso del Po; se ne scosta ai margini occidentale e orientale disegnando due<br />
prominenze: una, quella dell’Oltrepò pavese, penetrante a mo’ di cuneo tra il territorio<br />
emiliano e piemontese e risalente per morbide groppe l’Appennino sino a raggiungere<br />
il monte Lèsima (1724 m.) alle sorgenti del torrente Stàffora; l’altra, quella<br />
dell’Oltrepò mantovano, espansa a recingere una fascia di fertile pianura tra Suzzara<br />
e Sèrmide e penetrante verso oriente tra il Veneto e l’Emilia.<br />
Entro questi limiti la superficie del territorio lombardo misura 23.803 kmq. (1957),<br />
valore che mette la nostra regione al quarto posto nella graduatoria di ampiezza delle<br />
regioni italiane, preceduta dalla Sicilia, dal Piemonte e dalla Sardegna. AltimetricaiS
Fot. Micheletti<br />
Veduta invernale del passo del Tonale (1885 rn.); esso, al limite tra la <strong>Lombardia</strong> e il Trentino,<br />
mette in comunicazione la Valcamonica con la vai di Sole.<br />
mente il territorio è compreso tra gli i i m. della località Quatrelle presso il margine<br />
del Po (Felónica, Mantova) e i 4021 m. della punta Perrucchetti, anticima del Bernina.<br />
La parte meridionale è occupata tutta dalla pianura che s’estende per 11.17 1 kmq.,<br />
pari al 46,9% dell’area totale. Di poco inferiore è l’area montuosa che si estende<br />
nella parte settentrionale su 9672 kmq., pari al 40,6% dell’area totale. La collina,<br />
interposta in fascia discontinua tra le due zone precedenti, occupa 2960 kmq., pari<br />
al 12,5% dell’area lombarda.<br />
La posizione.<br />
Riguardo alla posizione astronomica il territorio lombardo presenta in latitudine i<br />
seguenti estremi: a meridione il monte Lèsima, nell’Appennino dell’Oltrepò pavese,<br />
con latitudine 44° 41' nord; a settentrione il monte Boffalora, al margine della valle<br />
di Livigno lungo il confine italo-svizzero, con latitudine 46° 38' nord. L ’arco di<br />
meridiano intercorrente tra le due citate latitudini misura pertanto 1° 57' equivalente<br />
a una distanza di circa 220 km. in linea d’aria. È di particolare interesse rilevare<br />
16
che il 45° parallelo nord, il parallelo intermedio tra l’Equatore e il Polo Artico, si<br />
incurva sull’Oltrepò pavese e sull’Oltrepò mantovano e che la maggior parte della<br />
pianura lombarda si estende nella fascia tra il 45° e ü 46° parallelo nord, ossia,<br />
come è noto, in un’area della Terra particolarmente favorita dall’insolazione e dall’avvicendamento<br />
stagionale.<br />
Gli estremi della <strong>Lombardia</strong> in longitudine sono dati: a occidente dal vertice<br />
segnato da Cascina Lupo presso Palestro in Lomellina, a 3° 57' ovest di Monte Mario<br />
(corrispondente a 8° 30' est di Greenwich) ; a oriente dalla località Quatrelle sulla<br />
sponda destra del Po, a 1° 02' ovest di Monte Mario (corrispondente a 1 1 ° 25' est<br />
di Greenwich). L ’arco di parallelo intercorrente tra le due longitudini misura<br />
quindi 2° 55' corrispondente a una differenza oraria di poco meno di 12 minuti<br />
primi e a una distanza lineare approssimativamente di 230 km. in linea d’aria.<br />
In aggiunta ai valori estremi di latitudine e di longitudine, si può ricordare<br />
che il parallelo mediano (45° 39' nord) e il meridiano mediano (2° 30' ovest di<br />
Monte Mario) della regione si intersecano poco a sud dell’abitato di Sàrnico, che<br />
effettivamente (per la forma del territorio) può essere considerato il centro geometrico<br />
della <strong>Lombardia</strong>. Milano, che della <strong>Lombardia</strong> è la città capoluogo, risulta<br />
invece notevolmente eccentrica; basta ricordare, come esempio, che la città dista, in<br />
linea d’aria, circa 25 km. dal corso del Ticino e quasi cinque volte tanto, come<br />
minimo, dal corso del Mincio, fiumi entrambi che rappresentano, per alcuni tratti,<br />
i limiti di regione. Si può tuttavia aggiungere subito che Milano non assolve soltanto<br />
a una funzione regionale lombarda; le sue prerogative le conferiscono una<br />
preminenza su tutto il bacino padano e sotto tale visuale appaiono immediatamente<br />
i vantaggi della sua posizione rispetto alla pianura, rispetto alle valli e ai valichi delle<br />
Alpi centro-occidentali e degli Appennini settentrionali, rispetto infine agli sbocchi<br />
sul mare.<br />
La <strong>Lombardia</strong> rappresenta soltanto una porzione del territorio gravitante su<br />
Milano e anche da tale considerazione traluce la sua precipua caratteristica: quella<br />
cioè di parte di un’unità geografica di ben più ampia estensione; ossia la valle del Po.<br />
Più precisamente la <strong>Lombardia</strong> rappresenta una parte, la inferiore, del versante di<br />
sinistra di questa grande vallata. La sua individualità non è scaturita però da questo<br />
fatto, ma soprattutto da un succedersi di avvenimenti storici nei quali ha giocato<br />
un ruolo importante in ogni secolo la preminenza di Milano. Non regione propriamente<br />
fisica, dunque, ma regione storica formatasi e ampliatasi per coagulo intorno<br />
a Milano.<br />
Nei suoi attuali confini, la <strong>Lombardia</strong> non comunica direttamente con il mare:<br />
a settentrione la limitano le Alpi che s’ergono a immane barriera e a protezione dei<br />
rigori nordici; la fiancheggiano, a occidente, il Piemonte, che della grande vallata<br />
del Po occupa l’alto bacino, a oriente il Trentino-Alto Adige, che s’estende nell’alta<br />
valle dell’Adige, e il Veneto, che con il suo territorio s’espande sul basso corso<br />
del medesimo fiume; a mezzogiorno, infine, l’Emilia, che del bacino del Po occupa<br />
buona parte del versante di destra. Dall’Adriatico l’apice mantovano della <strong>Lombardia</strong><br />
• Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
17
dista solo una settantina di chilometri e il Po, che dall’apice si stacca per proseguire<br />
nella sua discesa verso il mare, sembra l’ombelico acqueo tra l’Adriatico e la nostra<br />
regione. Ma la non facile adattabilità del Po e dei suoi affluenti alla navigazione, per<br />
non dire d’altro, attenuano l’attrazione dell’Adriatico e dei suoi porti sulla <strong>Lombardia</strong>,<br />
che gravita invece in modo preponderante verso il Mar Ligure e i suoi porti<br />
e soprattutto verso Genova, nonostante l’interposto Appennino, per altro facilmente<br />
valicabile attraverso il passo dei Giovi (472 m.).<br />
18
Capitolo Secondo<br />
LE VICENDE STORICHE<br />
I primi abitatori.<br />
« Chi furono gli abitatori del nostro paese ? ». Con questa domanda Cesare Cantù<br />
esordiva nella Grande Illustrazione del Regno Lombardo-Veneto e nella risposta, rifacendosi<br />
a quanto generalmente si ammetteva, ripeteva la leggenda dei Celti antichi<br />
venuti dall’Asia, quattordici secoli a. C., calando dalle Alpi. Essi «piaciutisi della<br />
Valle di qua del Po, ne snidarono i Siculi, i Veneti e i Liguri, primi abitatori della<br />
pianura » e la signoreggiarono fondando la confederazione detta Is-Onihria, cioè<br />
l’Insubria, vale a dire il paese degli uomini prodi. Ma alcuni anni prima che il<br />
Cantù stendesse la seducente visione romantica dell’antica epopea insubra, legata<br />
nei riti e nella lingua a quella del paese transalpino che poi divenne la Francia, e<br />
della servitù in cui gli Insubri caddero ad opera degli Etruschi, venuti pur essi dal<br />
fecondo seno dell’Asia e calati nella pianura dalle Alpi Retiche, il rinvenimento di<br />
tracce di vita preistorica (che s’accrebbero notevolmente con l’intensificarsi delle<br />
ricerche) contribuivano a diradare in parte il velo di nebbie sui più lontani insediamenti<br />
umani nella nostra regione, che si possono ormai sicuramente far risalire al<br />
Neolitico e fors’anche al Paleolitico, se troveranno conferma i primi incerti reperti<br />
lombardi raccolti nel 1938 nella cavità del Buco del Piombo, sopra Erba (Como).<br />
La prima felice scoperta si ebbe nel i860, a Mercurago, presso Arona. Ma le<br />
indagini sistematiche in territorio lombardo si debbono ad Antonio Stoppani, che,<br />
nel 1863, faceva conoscere il tesoro delle sue scoperte palafitticole sul lago di Varese,<br />
dove la stazione di Isolino richiamò usi e maniere delle palafitte del territorio svizzero,<br />
dando fondamento alla teoria sulla provenienza dalla Rezia dei più antichi<br />
19
Il lago di Varese, dove, presso le sponde,<br />
sono state trovate tracce numerose di un insediamento palafitticolo.<br />
Anche il vicino lago di Biandronno (che si intrawede sullo sfondo)<br />
non manca di identiche tracce.<br />
Fot. Sef<br />
abitatori della pianura padana. Poi nuove ricerche portarono a diversi orientamenti,<br />
che ci presentano la civiltà delle palafitte come uno sviluppo di quella che fu la vita<br />
dell’uomo che abitò nelle caverne, nei « fondi di capanne », come attesterebbero i<br />
ritrovamenti all’isola dei Cipressi sul lago di Pusiano, a Trescore, a Seniga, a<br />
Ostiano, ecc. Comunque è certo che i palafitticoli si espansero dal Varesotto al Bresciano,<br />
sul lago Maggiore, sui laghetti di Varese, di Monate e di Comabbio, sui<br />
laghi briantei di Pusiano e di Annone, sul lago d’Iseo e sul lago di Garda. E mentre<br />
quasi nulla si sa dell’uomo delle caverne, l’ampia documentazione (ricca di materiale<br />
siliceo e osseo) raccolta nelle varie stazioni di palafitte offre la possibilità di<br />
ricostruire la vita dell’uomo palafitticolo, che viveva di caccia, di pesca e forse anche<br />
dei raccolti di una primitiva agricoltura. Forma di civiltà, questa, che rispecchia<br />
anche i reperti delle stazioni terramaricolo del Mantovano e del Cremonese, ma qui,<br />
forse, già più progredite.<br />
20
Nuova luce sull’insediamento preistorico in <strong>Lombardia</strong> portarono le ricerche<br />
sull’età neolitica, che, dal Milanese, al Bresciano e al Mantovano, confermano<br />
l’ascesa nel cammino della civiltà dell’uomo delle palafitte. In questo periodo si<br />
affinava la lavorazione degli utensili di selce, si forgiavano armi di rame e si praticava<br />
sicuramente l’inumazione (Sepolcreto di Remedello Sotto).<br />
L ’età del bronzo segna una più grande conquista: i villaggi all’aperto, come<br />
documentano scoperte fatte, ad esempio, nel Mantovano e nel Cremonese. La falce<br />
di bronzo e la lancia sono il simbolo dei nuovi agricoltori e dei nuovi guerrieri.<br />
Le necropoli dei terramaricoli attestano la pratica dell’incinerazione, come si rileva<br />
a Monte Lonato e a Bietole Virgilio.<br />
Poi (ed è da poco varcato il primo millennio a. C.) un nuovo progresso segna<br />
« la trionfante età del ferro, affidata a uomini ormai scaltriti negli scambi commerciali<br />
e culturali, vicini e lontani: Golasecca, Somma Lombardo, Vergiate, Rebbio<br />
Incisioni rupestri a Capo di Ponte in Valcamonica.<br />
Le figure (uomini e animali) sono scolpite su vaste superfici di arenarie rossastre e grigiastre limate<br />
e lisciate dal ghiacciaio pleistocenico e rappresentano la testimonianza del maggiore insediamento<br />
camunno della preistoria.<br />
Fot. Donà<br />
21
ч \ î^v -<br />
Fot. Sef<br />
Brescia. Il Tempio Capitolino о Capitolium, eretto nel 73-74 d- C. sotto l’imperatore Vespasiano.<br />
La sua mole limitava uno dei lati minori del Foro dell’antica città romana.<br />
Da una cella del tempio fu tratta alla luce la famosa statua bronzea detta della Vittoria di Brescia.<br />
e la vicina Camorta ed altri ed altri nomi di località, sempre più prossime a Milano,<br />
ci trasmettono l’ombra sempre più chiara di codesti antichi ricordi » (A. Calderini).<br />
La civiltà di Golasecca palesa qualche influenza estense e, meglio, etrusca. E quale,<br />
poi, sia stata la dominazione dell’Etruria per via commerciale о politica è possibile<br />
conoscere attraverso la notevole documentazione epigrafica. Essa, dalle Alpi al Po<br />
e all’Oltrepò, si divide geograficamente in aree: l’una dei nord-Etruschi (tra Bolzano,<br />
Sondrio e Lugano), ossia degli antichissimi Etruschi rimasti per via, lungo la discesa<br />
nella penisola, l’altra degli Etruschi Cisappenninici, più noti alla storia. L ’indagine<br />
linguistica conferma tale distinzione.<br />
22
Dai Liguri e dagli Etruschi, i secoli sono corsi fino ai Gelto-Galli. Come questi<br />
abbiano conquistato la Valle padana lo dice la leggenda più che la storia. L ’invasione<br />
si fa datare dal 400 a. C., due millenni e mezzo, all’ingrosso, dall’apparizione<br />
dei Liguri, circa mille anni dopo quella degli Insubri e ottocento dalla dominazione<br />
etrusca. Di quanto volle far credere la storiografia romantica sull’originalità celtogallica,<br />
della capacità organizzativa sociale e politica, della religione, ecc., oggi non<br />
molto resiste all’indagine critica. I ritrovamenti archeologici si riferiscono, sotto il<br />
rispetto artistico, al periodo romano, onde trovano più fondamento gli attributi di<br />
celto-romano e di gallo-romano; e, come in arte, anche nella monetazione è stato<br />
ammesso che i Galli furono tributari dei Greci e dei Romani.<br />
Dei Galli Gisalpini uno dei più potenti gruppi fu quello dei Cenomani, abitanti<br />
tra le Alpi e il Po, dalla sponda occidentale del Garda fino all’Oglio о all’Adda, che<br />
ebbero come capitale Brescia. Essi dominarono su altre tribù, come i Camunni di<br />
Valcamònica ed estesero la loro influenza sulle valli finitime che risalgono verso<br />
il Trentino, sì che Brescia fu salutata da Catullo madre della sua natale Verona.<br />
Dalla conquista romana alle dominazioni straniere.<br />
Il primo incontro dei Galli con i Romani avvenne, dopo la sconfitta degli Insubri<br />
nel 221 a. C., ad opera di Marco Claudio Marcello; e se i moti posteriori turbarono<br />
i buoni rapporti stabilitisi inizialmente e se la battaglia del Ticino e la vittoria di<br />
Annibaie poterono dar modo di palesare una latente ostilità, la supremazia di Roma<br />
si affermò definitivamente sui Cenomani nel secolo che intercorre tra il 1 1 8 (sconfitta<br />
degli Stoni) e il 16 a. C., allorché, sotto Augusto, i superstiti dell’ultima ribellione,<br />
vinti da Publio Silio, furono venduti all’asta e gli altri aggregati a quel ch’era ormai<br />
il Municipio di Brescia.<br />
L ’organizzazione romana delle Gallia Gisalpina e la condotta dei Galli verso<br />
Roma sono fatti noti che rientrano in un quadro più generale. Il territorio, che ai<br />
giorni nostri va sotto il nome di <strong>Lombardia</strong>, risultava del tutto indistinto; con<br />
l’assetto augusteo delle Province, esso era suddiviso per la maggior parte tra la<br />
X Provincia, ossia la Venetia, e la XI Provincia, ossia la Transpadana, il cui limite<br />
divisorio, tra le Alpi e il Po, si snodava lungo il bacino dell’Oglio e, nella parte<br />
mediana ne seguiva il corso; l’Oltrepò mantovano apparteneva alla V ili Provincia,<br />
l’Aemilia, e l’Oltrepò pavese era diviso tra questa e la Liguria, che costituiva la<br />
IX Provincia. Inserita da Augusto nell’Impero come parte integrante dell’Italia,<br />
la vasta pianura aveva visto accrescersi la sua prosperità, sicché — poteva affermare<br />
Strabone — « per la frequenza degli abitanti, per l’ampiezza e l’opulenza delle città,<br />
i Romani di quelle contrade sovrastavano a tutti gli Italiani ». Quelli che erano stati<br />
minuscoli insediamenti di remota origine ligure, etrusca e gallica erano divenuti<br />
23
fiorenti municipi, come Novum Comum, Bergomum, Brixia, Mediolanum, Ticinum,<br />
Cremona e Mantua. Con la Tetrarchia, Milano raggiunse l’acme dello splendore,<br />
sì da essere chiamata da Ausonio « la seconda Roma ». Qui fu proclamato quell’editto<br />
del 313, in nome di Costantino e del collega d’oriente Licinio, che significò la grande<br />
vittoria del Cristianesimo sul paganesimo. Quell’influsso « fatale » che venne attribuito<br />
a Milano data forse da questo grandioso avvenimento.<br />
Il Cristianesimo si diffuse ben presto nella pianura padana e le antiche basiliche<br />
dedicate ai martiri ricordano la secolare persecuzione e il trionfo definitivo nel secolo<br />
che fu di Sant’Ambrogio (333-397), personalità politica e religiosa che nella storia<br />
lombarda risuonerà quanto alcun’altra mai, anche per il suo romano patriottismo di<br />
fronte ai barbari. E tra gli ospiti illustri del tempo, a cui Milano offrì dimora, sopra<br />
tutti avanza Sant’Agostino, che nella vicina campagna, ove trovò quiete il suo<br />
animo, scrisse Le Confessioni.<br />
Fot. Sef<br />
Milano. Le Colonne di San L o <br />
renzo Maggiore. Esse sono la<br />
testimonianza più suggestiva di<br />
Milano romana ; provengono da<br />
un edificio (tempio о terme) del<br />
II о III secolo e vennero qui<br />
trasferite quando fu eretta, nel<br />
IV secolo, la basilica cristiana.
Fot. Stefani<br />
Pavia. Piazza Leonardo da Vinci con tre torri medioevali,<br />
superstiti delle moltissime dominanti sull’antica città, che pertanto era chiamata civitas centum turrium.
Poi venne l’ora, nel V secolo, delle invasioni barbariche; e tra le tante orde,<br />
gli Eruli, i Goti, i Longobardi, che calarono nella pianura padana, vi si soffermarono<br />
definitivamente gli ultimi, per lasciarvi, dopo la fusione con i vinti Romani,<br />
il retaggio del nome. Quanto abbia sofferto delle invasioni la pianura tra le Alpi e<br />
il Po è noto nelle linee essenziali: dalla devastazione subita da Milano ad opera<br />
degli Unni di Attila, alle battaglie combattute in campo aperto tra i barbari stessi<br />
e tra questi e i Bizantini, dalla battaglia dell’Isonzo (28 agosto 489) che, vinto<br />
Odoacre, aprì la via verso la parte occidentale della pianura a Teodorico, alla battaglia<br />
deir Adda ( ii agosto 490) che decise il duello mortale tra i due barbari, è<br />
tutto un susseguirsi di avvenimenti che coinvolgono i centri maggiori e minori del<br />
vasto territorio, facendone preda di guerra e di confisca. La guerra greco-gotica<br />
aggravò i danni e la distruzione di Milano, fatta da Uraria, completò il campo delle<br />
rovine. Procopio narra lo scempio dell’ira barbarica sopra trecentomila persone, ossia<br />
quante ne avrebbe avute nel 539 Milano, che durante la guerriglia e la guerra combattuta,<br />
aveva generosamente aperto le porte ai profughi delle campagne. Ben diverso<br />
destino toccò a Pavia, eletta da Teodorico, dopo Verona e Ravenna, a terza capitale<br />
del suo Regno, rinnovata e arricchita di un Palatium, delle terme e dell’anfiteatro:<br />
fu allora che Ticinum cominciò a chiamarsi Papia. Tra le sue mura i Goti opposero<br />
estrema resistenza ai Bizantini e questi, a loro volta, per tre lunghi anni, ai Longobardi,<br />
che poi elessero la città a sede dei re e della corte regia. Per qualche tempo<br />
questa preminenza fu contesa da Monza, dove, presso il Palatium, Teodolinda fece<br />
innalzare la basilica di San Giovanni Battista, al cui fonte battesimale volle che il<br />
figlio Adaloaldo divenisse cristiano e cattolico e, come tale, fratello in Cristo del<br />
popolo oppresso e quindi suo naturale difensore di fronte agli oppressori longobardi,<br />
di cui era il re. A Pavia si adunavano i grandi del Regno e fu in una di queste<br />
assemblee che, nel 643, re Rotar! emanò il famoso editto, in cui, nella codificazione<br />
delle consuetudini longobarde, affiorano gli influssi della romanità: la lingua e<br />
il diritto. Ma nel lungo susseguirsi di lotte, la floridezza economica della regione,<br />
che già aveva raggiunto alti livelli, era venuta via via declinando: i commerci s’erano<br />
arenati, la vita cittadina s’era illanguidita, l’attività s’era immiserita. Sul capo di<br />
Desiderio gravò la sconfitta e la fatale espiazione di Ermengarda, come vuole il<br />
dramma romantico, se non la storia che non ha risposto generosamente alle appassionate<br />
ricerche dei longobardisti.<br />
A i Longobardi successero i Branchi (774). Con questi, la tradizione regia di<br />
Pavia non soffrì soluzione di continuità, anche quando alla ripudiata intitulatio di<br />
Regnum Langobardorum si sostituì quella fatidica di Regnum Italiae. Il sistema feudale<br />
iniziato dai Longobardi si consolidò con il dominio dei Branchi: ai duchi e ai conti<br />
era demandato il governo delle città, e su questi esercitava l’autorità imperiale un<br />
principe, elevato alla dignità di re d’Italia, alla cui scelta partecipavano elettori italiani,<br />
tra i quali, primo, l’arcivescovo di Milano, la cui potenza s’accrebbe in<br />
questo periodo in modo cospicuo, tanto da poterla spuntare anche con Carlo Magno<br />
a proposito del rito. Ciò valga per misurare la potenza spirituale della Chiesa ambro-<br />
26
Fot. Stefani<br />
La Basilica di San Pietro ad Agliate Brianza. È tra le più antiche della <strong>Lombardia</strong><br />
e la tradizione ne attribuisce la fondazione ad Ausperto, arcivescovo di Milano (880 circa).<br />
siana, la quale, ripetendo il nome del santo vescovo attraverso i secoli, dal tardo<br />
impero alle invasioni germaniche e ai regimi successivi, difese con vigore il suo<br />
dominio spirituale e curiale, sì che si può affermare che la storia dell’arcidiocesi<br />
ambrosiana s’identifica con la storia della regione su cui essa si estese, ossia su buona<br />
parte della <strong>Lombardia</strong> e, oltre i confini, sul Canton Ticino, che rimase dipendente<br />
ecclesiasticamente dall’arcivescovo di Milano fino al 1888. Carlo Magno fu costretto<br />
a riconoscere il rito ambrosiano e non potè, pertanto, dar esecuzione, in buona<br />
parte della sua nuova conquista italica, al capitolare del 789, col quale si imponeva<br />
in tutti i territori soggetti il cantus romanus. Fu tra la fine della dominazione longobarda<br />
e l’inizio della dominazione carolingia, e più precisamente dalla prima alla<br />
seconda metà del secolo V ili, che il metropolita ambrosiano s’intitolò arcivescovo.<br />
Il primo fu Tommaso: il sanctissimus vir domnus Thomas archiepiscopus sanctae<br />
27
Mediolanensis Ecclesiae, che governò la cattedra santambrosiana dal 755 al 783. Il<br />
suo successore, l’arcivescovo Pietro, il 22 ottobre dell’anno 789, circondato da tutta<br />
la sua curia, come il solenne avvenimento comportava, fondava il monastero di<br />
Sant’Ambrogio presso la chiesa dove riposava, tra i santi martiri Protaso e Gervaso,<br />
il santo padre e fondatore, confessore di Cristo.<br />
Pavia, che durante la dominazione longobarda s’era affrancata dalla Chiesa ambrosiana,<br />
teneva pur essa alta nominanza e fu durante la dominazione carolingia che,<br />
fermi restando pur ivi la corte e il tribunale regio, ebbe vita nella città, per effetto<br />
del Capitolare di Corteolona (maggio 825), quella scuola in cui si ricercano le origini<br />
della famosa Università. Il primo insegnante fu Dungal, di origine nordica e monaco,<br />
il quale donò la sua biblioteca al Monastero di Bobbio (fondato al principio del<br />
secolo VII dall’irlandese San Colombano), sede di uno scriptorium illustre, che lasciò<br />
splendidi codici conservati per la maggior parte nella Biblioteca Ambrosiana, nella<br />
Vaticana e nella Universitaria di Torino.<br />
Durante la dominazione carolingia, anche Como si riaffacciò alla storia. Al tempo<br />
delle invasioni aveva subito anch’essa le angherie dei soldati di Attila: forse aveva<br />
avuto modo di riaversi, ma le fortificazioni di Narsete non le erano giovate contro<br />
i Longobardi, che la legarono al territorio di Milano. Sotto i Franchi, Como fu<br />
innalzata a comitatus; a ciò le giovò la posizione notevolissima dal punto di vista<br />
militare e ben presto la città crebbe in potenza.<br />
E ancora nel secolo IX, tra quelle che oggi sono le maggiori città lombarde,<br />
un’altra emerse dall’oscurità: Mantova. Il primo accenno al suo nome è legato al<br />
vescovo Laiulfo vivente neH’827; poi su di essa cala di nuovo il silenzio, fino a<br />
quando Bonifacio di Canosa non la scelse come sua sede. La ripresa cittadina<br />
avvenne nel secolo X e sboccherà nell’XI e nel XII in quella fioritura di vita e di<br />
civile progresso, donde sorge il Comune e una nuova storia nella vita del popolo<br />
italiano.<br />
Nell’ordine delle successioni dinastiche che s’ebbero dopo la deposizione di Carlo<br />
il Grosso (887), a cui, ultimo dei Carolingi, la sorte beffarda aveva serbato il nome<br />
del primo sacro romano imperatore, si annoverano casate italiane e casate d’oltralpe,<br />
quelle di Provenza, di Borgogna e, infine, di Sassonia che legherà la Corona d’Italia<br />
a quella di Germania per secoli. Nella lotta, intessuta di violenze, d’astuzie e d’inganni,<br />
per il possesso della Corona, la storia della <strong>Lombardia</strong> nel declinante millennio<br />
non si dissociò da quella del Regno d’Italia. Per la loro posizione geografica le città<br />
lombarde, specialmente Milano e Pavia, ebbero tuttavia un ruolo non secondario;<br />
ma fu soprattutto l’immensa autorità dell’arcivescovo di Milano (ritenuto per gran<br />
tempo il depositario legittimo del diritto di incoronazione dei re d’Italia) che fece<br />
di questa città il fulcro di molti avvenimenti storici.<br />
La Casa di Sassonia regnò sull’Italia sino al 1024 e ad essa succedette la Casa di<br />
Franconia, la quale imperò in Germania e in Italia esattamente un secolo.<br />
28
Il sorgere dei Comuni.<br />
Il secolo di supremazia della Casa di Franconia fu contrassegnato da avvenimenti<br />
solenni. Fu infatti l’età della prima formazione degli Stati nazionali in Europa, del<br />
rinnovamento sociale ed economico, delle Repubbliche marinare, della lotta per le<br />
investiture, delle Crociate, del Comune. Nei duelli dinastici, nelle lotte tra l’Impero<br />
e il Papato e negli avvenimenti connessi, i grandi vassalli e gli alti ecclesiastici fanno<br />
valere il loro apporto alla contesa, il popolo acquista coscienza del suo stato: i centri<br />
lombardi, da Milano a Como a Pavia, gareggiano in quel risorgimento sociale, anelanti<br />
a più ampie libertà.<br />
Cominciò Pavia: nel 1024, alla morte di Enrico II, distrusse il Palatium. Milano<br />
accolse Corrado II che, autorevolmente sostenuto dall’arcivescovo Ariberto, fu incoronato<br />
re in Sant’Ambrogio.<br />
Ariberto da Antimiano appare una tra le figure politiche di più alta risonanza<br />
del secolo XI. Disceso da stirpe longobarda, fattosi sacerdote, rifiutò la sua legge<br />
e visse, in conformità del canone, secondo la legge romana. Nel governo dell’arcidiocesi<br />
(esercitata con severa autorità) e nella lotta contro l’imperatore (da amico<br />
divenutogli nemico a causa della questione dei valvassori) non volle mai piegarsi,<br />
anche quando i valvassori, ribellatisi, si unirono in una poderosa alleanza, la « Motta »,<br />
e sconfissero i suoi fedeli vassalli e «capitane!» о «cattani», a Campomalo (1036).<br />
Corrado II, invocato dai valvassori, scese in Italia e, preoccupato del crescente potere<br />
della feudalità ecclesiastica, elargì la Constitutio de feudis e marciò su Milano. I Milanesi<br />
si strinsero allora attorno al loro arcivescovo e combatterono sotto la strana<br />
insegna militare e religiosa ad un tempo costituita da un carro con sopra la croce<br />
e il gonfalone, il Carroccio, che diventerà poi il simbolo della libertà comunale;<br />
combatterono con tanto accanimento che Corrado fu costretto a levar le tende.<br />
Enrico III, succeduto a Corrado, trovò una forma d’accordo con Ariberto. Però,<br />
pochi anni appresso (1041), nuovi contrasti tra il popolo, ormai conscio della sua<br />
forza, e i valvassori, con i quali questa volta si era schierato l’arcivescovo, costrinsero<br />
questo e quelli a lasciar la città. Il timore di più gravi danni per un intervento<br />
dell’imperatore indusse le parti avverse a un accordo, ma ormai l’autorità dell’arcivescovo<br />
e i privilegi dei valvassori erano tramontati. Il Comune nasceva così integro<br />
e indipendente.<br />
Se, dopo aver accennato ai fatti politico-religiosi, si vuol ricercare nella cronologia<br />
una data о un avvenimento che sia indizio dell’evolversi della vita civica, ecco,<br />
con l’anno 1066, tralucere dai documenti cenni su arti e mestieri operanti nella città<br />
di Milano, sicché facilmente si può arguire l’operosità diffusa e la ricchezza circolante:<br />
si parla di contrade degli spadari e degli armorari, degli speronar!, dei borsai,<br />
dei cappellai, degli orefici, dei mercanti e di altri mestieri ancora e della pescheria<br />
29
Fot. Stefani<br />
Brescia. La Torre del Popolo, del secolo XI, e il Palazzo del Broletto, del secolo XII,<br />
con la Loggia delle Grida, monumenti tra i più suggestivi dell’età comunale lombarda.<br />
ѵгт>::
Fot. Brunner<br />
Como. La torre di Porta Vittoria, del 1192, e le mura di età comunale che, con planimetria rettangolare,<br />
recingono la città vecchia. Il loro perimetro segue dappresso lo sviluppo delle difese romane ;<br />
in prossimità della Torre, sotto un edificio scolastico, vi sono infatti avanzi della Porta Praetoria,<br />
del II о III secolo dopo Cristo.<br />
vecchia e di simili cose : una società alacre e vivace in cui non mancavano già i primi<br />
accenni a lotte di classe.<br />
Intanto anche altre città lombarde erano sorte a Comune; ma dobbiamo pur<br />
credere che ciò non piacesse a Milano, la quale con ogni mezzo, anche con la guerra<br />
e la distruzione, perseguì il suo programma di espansione e di accentramento, per<br />
sempre e vieppiù imporre il suo prestigio di metropoli. Prima cadde Como: fu nell’agosto<br />
del 1127, dopo una guerra decennale alla quale presero parte, contro il<br />
fiorente Comune del Lario, città di qua e di là del Po: Asti e Cremona, Piacenza<br />
e Parma, Modena e Bologna. Poi fu la volta di Pavia e di Novara per il possesso<br />
e la difesa di Crema. Ma contro i Pavesi era riservata anche un’altra sconfitta: quella<br />
ch’essi subirono a Marcinago il 23 luglio 1132, dove gli scampati divennero prigionieri<br />
dei Milanesi. Il trionfo di Milano era schiacciante. Anche l’imperatore Lotario<br />
si schierò dalla parte di Milano nella Dieta di Mantova, il che giustificò la guerra<br />
contro i Cremonesi nell’anno 1137.<br />
Nella città vittoriosa fermentava intanto nuovo fervore di attività e anche un<br />
rinnovato fervore religioso per il quale lavorava, sebbene sopita, la patarìa: ecco<br />
31
la fondazione del monastero di Chiara valle; ecco in città l’erezione del monastero<br />
di Brera ad opera degli Umiliati, noti per l’importanza ch’ebbero poi nei fasti economici<br />
della vita civica.<br />
Tutto sembrava ben promettere all’avvenire di Milano, allorché in Germania,<br />
nel 1152, venne eletto Federico Barbarossa. Due anni dopo avvenne la prima calata<br />
di carattere esplorativo del nuovo sovrano in Italia; si ebbero la Dieta di Roncaglia,<br />
energica rivendicazione dei diritti imperiali, e, contro Milano, le rimostranze dei<br />
Pavesi, dei Lodigiani, dei Comaschi e dei Cremonesi; quindi fatti più gravi: la<br />
distruzione di Tortona, di Chieri e di Asti. Milano, che non aveva nascosto la sua<br />
ostilità all’imperatore, si mise in allarme. Ma la città .era troppo forte e le forze<br />
imperiali troppo modeste e Federico, dopo essere stato incoronato prima a Pavia<br />
poi a Roma, ritornò in Germania (1155). Riapparve tre anni dopo in Italia e rinnovò<br />
la Dieta di Roncaglia, dove prevalse il programma rigoroso dell’Impero contro<br />
le libertà comunali. Crema e Milano si ribellarono. Il 1159 vide la distruzione di<br />
Crema e le sconfitte dei Milanesi ad opera dei Lodigiani e dei Pavesi. Ma non<br />
bastò: la guerra contro Milano proseguì aspra; Federico voleva stroncare la sua<br />
potenza nascente, nè valsero gli aiuti dei Bresciani e dei Piacentini ai Milanesi,<br />
Fot. Sef<br />
Legnano. Il monumento eretto<br />
a ricordo dell’epica battaglia<br />
del 29 maggio 1176, con la<br />
quale gli eserciti della Lega<br />
Lombarda sbaragliarono le<br />
forze del Barbarossa.
Fot. Stefani<br />
La Rocca Scaligera a Sirmione sul lago di Garda. Venne<br />
edificata nel see. XIII (forse da Mastino della Scala)<br />
e la tradizione vuole che vi abbia soggiornato Dante.<br />
^ Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>
ormai in tragiche condizioni economiche. La città, soffrendo ogni più dura miseria,<br />
resistè per l’intiero n ó i e per tutto il rigido inverno fino al marzo dell’anno seguente;<br />
alla fine fu costretta a capitolare. Il Barbarossa ordinò la distruzione, e lo sterminio<br />
avvenne tra il 26 marzo e il 1° aprile.<br />
Ma ecco che il nuovo arcivescovo Caldino, consacrato nel 1166 da Papa Alessandro<br />
III, giunse da Roma a ricondurre alla patria i dispersi cittadini e a sostenerli<br />
nella dura fatica di ricostruire la città. Il convegno di Pontida, il cui nome più che<br />
nella storia risuona nella poesia, è dell’anno seguente: la Lega lombarda riunì Bergamaschi,<br />
Bresciani, Cremonesi, Milanesi e Mantovani. Ad un tentativo di rivincita<br />
del Barbarossa, ritornato da Roma in Pavia, diedero risposta, con i fondatori della<br />
prima Lega, i nuovi alleati: Venezia, Verona, Padova e Vicenza e altre città. La lotta<br />
continuò fino alla sconfitta imperiale e alla pace di Costanza (1183), a sette anni<br />
e un mese di distanza dall’epica vittoria sui campi di Legnano (29 maggio 1176),<br />
così luminosa negli annali della storia d’Italia.<br />
La Signoria dei Visconti e degli Sforza.<br />
Ormai il corso della nuova storia nella valle padana portava l’impronta di Milano :<br />
dal Comune, vittorioso sull’Impero, alla Signoria gli avvenimenti si incalzano dalla<br />
seconda metà del XII alla prima metà del XIII secolo.<br />
Dopo la morte di Federico Barbarossa (1190), cui successe il figlio Enrico VI,<br />
le lotte tra i Comuni si riaccesero. Ma le Leghe di Pavia, Cremona, Lodi, Como,<br />
Bergamo non ebbero potere di indebolire Milano, anche se il Comune era travagliato<br />
da discordie intestine, dalle quali ebbe origine la « Credenza di Sant’Ambrogio ». Era,<br />
questa, un governo del popolo, che, come ha scritto il Ciulini, rappresentava « uno<br />
strepitoso avvenimento » ; sorse contro le vessazioni dei nobili, ma poi, per le lotte<br />
interne, perse il mordente della sua origine e del suo programma. Nè fu, del resto, un<br />
caso unico, anche in quel periodo. Se s’indaga nella storia di un altro Comune lombardo,<br />
ad esempio Bergamo, si può osservare come dopo la fase iniziale del Comune<br />
(quella che è stata definita eroica, perchè la città conquistò l’indipendenza sul campo<br />
di battaglia e ascese a tanta dignità e ricchezza mercè l’operosità dei cittadini), il<br />
periodo successivo fu contrassegnato dalle lotte faziose e dalle discordie delle classi.<br />
La seconda Lega lombarda e il bellum civile del 1226 fecero proseguire le lotte<br />
intestine. Finalmente nel 1230 la parte popolare riuscì anche a Bergamo a partecipare<br />
al Coverno : sorse così la « Società del Popolo ».<br />
Ma ormai, qui e altrove, le libertà comunali volgevano al tramonto. L ’evoluzione<br />
costituzionale del Comune passando, о per libera scelta о per intervento imperiale<br />
Lome avvenne nel 1158 a Piacenza, a Cremona e in altre città, per volere del Barbarossa),<br />
dall’istituto del console a quello del podestà e, ancora, a quello del capi-<br />
• Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
33
La divisione politica del territorio lombardo<br />
verso il 1300.<br />
Utet<br />
tano del popolo, ci porta al secolo XIII,<br />
allorché dai contrasti tra i cittadini e<br />
dalle lotte di classe sorse la Signoria.<br />
Questa, a Milano, dai Torriani (1240-<br />
1259) si trasferì ai Visconti (1277), i<br />
quali, alla fine del secolo seguente,<br />
ascenderanno al principato.<br />
I Torriani, cioè quelli della casata<br />
Della Torre, venivano dalla Valsàssina :<br />
il più famoso. Pagano, aveva acquisito<br />
benemerenza raccogliendo i dispersi<br />
Milanesi, sconfitti a Cortenuova e rincorsi<br />
nella fuga dai Bergamaschi fedeli<br />
a Federico IL La Credenza di<br />
Sant’Ambrogio lo elesse quindi a suo<br />
capo (1240), e la vittoria di Cassano<br />
d’Adda (1259) su Ezzelino da Romano<br />
significò la vittoria dei guelfi nella Credenza<br />
e in Milano. In breve, i Della<br />
Torre divennero potenti a Bergamo,<br />
a Como, a Lodi, a Novara; ma contro<br />
di essi s’avventarono le spire della<br />
biscia viscontea e il duello fu feroce<br />
e decisivo. La fortuna dei Visconti si profilò con l’arcivescovo Ottone, che, vincitore<br />
a Desio nel 1277, ebbe in sue mani Napo Della Torre. Il quartiere dei Torriani<br />
in Milano fu raso al suolo e la via delle Case Rotte con il suo nome perpetua<br />
nella metropoli il ricordo del fatto.<br />
L ’origine dei Visconti è avvolta in una leggenda di conio umanistico : essa narra<br />
che la famiglia provenisse dalla rocca di Angera, che s’erge solenne sul lago Maggiore.<br />
Ora, nell’etimologia encomiastica, Angera proviene da Anglus, il mitico nipote<br />
di Enea, che, abbandonato il Lazio dopo l’arrivo da Troia, avrebbe valicato Г A p<br />
pennino, attraversato la pianura e si sarebbe fermato sulla rocca; perciò la gente<br />
dei Visconti da lui discenderebbe. E la biscia che il « melanese accampa » avrebbe<br />
anch’essa origini favolose e guerriere, perchè risalirebbe a uno degli antenati che,<br />
fattosi crociato, si sarebbe distinto in battaglie e duelli, riportando lo scudo del più<br />
forte infedele ucciso sul campo. E non meravigli se altre versioni in argomento si<br />
possono raccogliere tra i genealogisti dei Visconti, poiché furono molti e con scarsi<br />
scrupoli documentari.<br />
I Visconti erano ghibellini e il loro sopravvento sui guelfi in Milano aprì le porte<br />
al dominio della valle padana: Matteo I, portato sulla scena politica dal prozio Ottone,<br />
divenne nella famiglia e nel governo veramente quel « grande » come è ricordato negli<br />
annali storici.<br />
34
Nel 1315 la Signoria viscontea dominava da Milano a Pavia e dall’uno all’altro<br />
capo di <strong>Lombardia</strong>, da Bergamo a Como, a Cremona, a Novara e si spingeva ad<br />
Alessandria, a Vercelli; nel 1320 puntava su Genova; e, nella lotta, gli ostacoli erano<br />
infranti, fossero essi rappresentati da Roberto d’Angiò о da Filippo di Valois о da<br />
un legato pontificio come Bertrando del Poggetto. A Matteo seguì il figlio Galeazzo,<br />
che continuò la politica antiguelfa; ma non gli giovò il suo ghibellismo con Ludovico<br />
il Bavaro, dal quale fu rinchiuso nel castello di Monza (1327), morendo l’anno<br />
seguente a Pescia. Dei suoi fratelli. Marco, che pur seppe battersi sul campo di<br />
battaglia nel 1313 alla conquista di Tortona, nel 1320 a Moncalieri, nel 1322 a<br />
Bassignana sul Po, implicato nella congiura del cugino Lodrisio, finì tragicamente<br />
(1329); Giovanni, divenuto arcivescovo, seppe creare alla signoria della sua famiglia<br />
buone relazioni con i signori fuori di <strong>Lombardia</strong>; Luchino si distinse nella politica<br />
interna del dominio con provvedimenti fiscali e con giustizia civile. Nel 1354, morto<br />
l’arcivescovo Giovanni, i nipoti, per volontà del defunto, si suddivisero il dominio<br />
visconteo: Matteo ebbe, al di qua del Po, Lodi e Monza e, al di là. Piacenza,<br />
Bergamo. La poderosa mole della Rocca, iniziata nel 1331, nel luogo ove si suppone che vi fosse<br />
il Castrum e il Campidoglio romano. Essa fu teatro di furiosi assalti, resistendo validamente.<br />
Le mura venete ne accrebbero la forza difensiva. Nel 1849 i cittadini insorti vi assediarono gli<br />
Austriaci, che bombardarono l’abitato.<br />
Fot. Stefani<br />
35
Fot. Stefani<br />
Brescia. Santo Stefano in Arce e la Torre Mirabella sul Colle Cidneo, dove secondo la tradizione ebbe sede il<br />
primo insediamento dal cui nome Brich derivò Brixia. In età romana vi sorse l’Arce. Per opere successive,<br />
del Comune, dei Visconti e della Serenissima si formò il complesso fortificato, il Castello, che domina la città.
Fot. Stefani<br />
Pavia. Il Castello Visconteo fatto erigere tra il 1360 e il 1365 da Galeazzo II e completato dal figlio<br />
Gian Galeazzo. Il grandioso complesso a pianta quadrata è considerato una tra le più belle opere<br />
civili del Trecento lombardo.<br />
Parma e Bologna; Galeazzo II ebbe invece Como, Novara, Vercelli e altre città e,<br />
quantunque avesse ottenuto il primato nel Consiglio generale di Milano, dovette<br />
tuttavia dividere il dominio della città col fratello Bernabò, al quale toccarono i<br />
quartieri da Porta Orientale a Porta Romana. Del loro dominio rimase un ricordo<br />
efferato: Matteo, torbido e vizioso, fu avvelenato l’anno successivo; Galeazzo rimase<br />
celebre per le sue raffinate torture (Quaresime di Galeazzo); Bernabò per le sue<br />
bizzarrie d’inaudita ferocia. Ma presto la figura di Gian Galeazzo, figlio di Galeazzo,<br />
s’impone nella storia degli avvenimenti del tempo. Il giovanetto, che l’imperatore<br />
Carlo IV armava cavaliere, che il Petrarca elogiava, che il re di Francia Giovanni II<br />
accoglieva come figlio, dandogli in isposa la figlia Isabella, doveva far tremare al<br />
cenno del suo comando amici e nemici. Ogni altra sua impresa cede a quella che<br />
il 30 marzo 1397 lo portò sul soglio per investitura di Venceslao imperatore, che gli<br />
37
concesse il titolo di duca di Milano. Già oltre i confini del ducato la biscia viscontea<br />
avvinghiava nelle sue spire Comuni e Signorie e già anche Firenze vacillava, allorché<br />
si sparse la notizia della morte del duca nel Castello di Melegnano il 3 settembre<br />
1402. La morte richiamò alla realtà anche coloro che, poeti о no, avevano esaltato<br />
il dominatore, invocandogli sul capo il diadema reale.<br />
Gian Galeazzo lasciava due figli, Giovanni Maria e Filippo Maria, natigli dal<br />
secondo matrimonio con la cugina Caterina, figlia di Bernabò. I due eredi erano<br />
minorenni per cui il governo del Ducato fu affidato ad una reggenza di Caterina e<br />
di altri fedeli in nome di Giovanni Maria. Il quale non mancò, crescendo, di farsi<br />
conoscere come indegno successore del padre, sì che finì trucidato il 16 maggio 1412.<br />
Gli successe il fratello, Filippo Maria, mentre il Ducato andava in sfacelo. Ma il<br />
giovane principe seppe riunire in unità lo Stato di Milano e abilmente destreggiarsi<br />
nel governo del dominio e rintuzzare le offensive di Venezia, di Firenze e del Papato;<br />
e se amò Г astrologia, come gli uomini del suo tempo, non fu quello spirito bizzarro<br />
come le vecchie biografie ci han tramandato. Certo la sua vita familiare fu torbida:<br />
fatta assassinare, nel castello di Binasco, la prima moglie (che gli era servita per<br />
ricostituire il dominio) e poscia ripudiata la seconda. Maria di Savoia, egli ebbe<br />
dalla concubina Agnese del Maino una<br />
La divisione politica del territorio lombardo<br />
dopo la Pace di Lodi (1454).<br />
I, Guastalla (Torelli); 2, Novellala (Gonzaga, ramo cadetto);<br />
3, Correggio (Correggeschi) ; 4, Carpi (Pii).<br />
Utet<br />
38<br />
figlia. Bianca Maria, che predilesse,<br />
legittimò e sposò a Francesco Sforza,<br />
allora condottiero, e poi, in ragion di<br />
tal matrimonio, erede del Ducato di<br />
Milano.<br />
Filippo Maria morì il 13 agosto<br />
1447. I Milanesi insorsero allora a libertà:<br />
irruppero nel Palazzo ducale,<br />
diedero fiamme all’Archivio della cancelleria<br />
e proclamarono l’Aurea Repubblica<br />
Ambrosiana. Questa, tra governo<br />
provvisorio e dei Capitani e Difensori,<br />
tra guerre interne ed esterne, stremata<br />
di forze, sopravvisse fino alla fine del<br />
febbraio 1450. La mattina del 26,<br />
Francesco Sforza, alla testa delle sue<br />
truppe, entrava trionfalmente in M i<br />
lano e veniva acclamato duca, dando<br />
origine alla dinastia visconteo-sforzesca,<br />
chiusasi nel 1535 con Francesco IL<br />
Ma prima di seguire i successivi<br />
sviluppi della storia di Milano (che<br />
pur domina su quella delle altre città<br />
lombarde), occorre qui far cenno alle
città lombarde che durante il dominio<br />
visconteo furono perdute per il Ducato<br />
e di qualche altra che ebbe una storia<br />
indipendente ed illustre. Le città che<br />
lo Stato di Milano perdette durante il<br />
duello combattuto contro Venezia, che<br />
tendeva ad ingrandirsi nel retroterra,<br />
furono: Brescia, che aprì le porte alla<br />
Repubblica di San Marco (1426) e alla<br />
quale restò legata fino al 1509, riunendosi<br />
poi alla stessa dopo il breve periodo<br />
della dominazione francese (1509-<br />
1516) fino al 1797; Bergamo, conquistata<br />
da Venezia nel luglio del 1428,<br />
e Crema, che si diede al governo veneziano<br />
dopo la morte del duca Filippo<br />
Maria: dedizione che fu riconosciuta<br />
nei patti del 1454 da Francesco Sforza.<br />
Mantova è la seconda città lombarda,<br />
che assurse alla dignità di capitale<br />
d’uno Stato, di notevole importanza<br />
nella storia, anche per la sua<br />
posizione tra Venezia e Milano. La<br />
famiglia dei Gonzaga, le cui vicende<br />
sono legate alla storia di Mantova, si<br />
affermò nel Trecento; ma già nel secolo<br />
precedente aveva fatto parlare di<br />
sè per aver dato appoggio ai Bonacolsi<br />
contro i Casalodi. Contro la signoria<br />
dei primi insorse poi Luigi Gonzaga<br />
che, il 16 agosto 1328, venne proclamato<br />
dal popolo Capitano generale. Creato<br />
Fot. Stefani<br />
Milano. L ’imponente mole del Castello Sforzesco.<br />
La sua costruzione fu voluta da Francesco Sforza<br />
e iniziata il 1° luglio 1450 sulle rovine di un<br />
Castrum Portae Jovis distrutto durante la Repubblica<br />
Ambrosiana.<br />
poscia Vicario imperiale da Ludovico il Bavaro, per i suoi tre susseguenti matrimoni<br />
s’imparentò con i Ramperti di Brescia, con i Malatesta di Rimini e con<br />
i Malaspina. Seguì, nel governo di Mantova, il figlio Guido (1360-1369), col<br />
titolo di Capitano generale; a questo il figlio Luigi II (1369-82), al quale, a sua<br />
volta, succedette Francesco I (1382-1407), la cui signoria si consolidò, estendendo<br />
i suoi possessi da Legnano a Castelgoffredo, a Viadana, a Gazzuolo e ad<br />
altre terre. Nel 1403 ottenne dall’imperatore Venceslao il titolo di marchese e in<br />
tal modo apriva la via al principato. Il successore Gian Francesco tenne alto il<br />
nome dei Gonzaga manovrando abilmente negli avvenimenti politici e militari, che<br />
impegnavano il Ducato di Milano, in fase di ricostituzione, e la Repubblica di<br />
39
San Marco, che cercava di ingrandire il retroterra veneto. Il dominio gonzagesco<br />
perdette nel frangente Asola, Lonato e Peschiera, ma, per altro, aprì a Mantova<br />
quell’orizzonte di capitale e di mecenatismo di cui andrà più famosa. Luigi III,<br />
detto il Turco, non fu da meno: seppe destreggiarsi con sagacia con gli altri potentati<br />
e governare con saggezza il suo dominio fino al 1478. Il matrimonio con Barbara<br />
di Brandeburgo gli procurò l’amicizia della Corte imperiale ; la personale capacità<br />
gli accattivò la fiducia di Francesco Sforza, il quale pensò persino di allacciare con<br />
i Gonzaga rapporti più stretti e familiari (che tuttavia non poterono aver luogo).<br />
Intanto a Milano, Francesco Sforza governava saviamente quello Stato che le<br />
potenze firmatarie della Lega italica, dopo la pace di Lodi, gli avevano riconosciuto<br />
(1454). Il «Gran Sforzesco», com’è chiamato, dominò la situazione politica e ridiede<br />
La Certosa di Pavia, testimonianza tra le più illustri del fervore rinascimentale alla corte dei Visconti<br />
e degli Sforza. La costruzione fu iniziata nel 1396 per volere di Gian Galeazzo Visconti e proseguita<br />
nel corso dei due secoli seguenti.<br />
Fot. Sef<br />
40
Fot. Stefani<br />
Mantova. Il Castello San Giorgio, costruzione del secolo XIV, eretta per volere di Francesco I Gonzaga.<br />
Il Castello non è che una piccola parte di queirimmenso complesso di edifici, che costituisce il<br />
Palazzo Ducale о Reggia dei Gonzaga.<br />
allo Stato i confini dei tempi più felici del dominio visconteo, dalle Alpi al Mar T irreno,<br />
e nel 1464, con l’acquisto di Genova, fin sulle terre di Corsica. Ebbe accanto<br />
a sè, nella ripresa politico-amministrativa del dominio, uomini capaci e fedeli quali<br />
quelli della famiglia Simonetta. Così s’accrebbe il prestigio dello Stato di Milano<br />
e non solo tra gli altri Stati dell’Italia, ma anche tra i potentati d’Europa: si racconta<br />
che Luigi XI, quando parlava del duca di Milano, si togliesse il cappello. La<br />
corte sforzesca aprì le porte all’umanesimo: col Eilelfo, il Lascaris e altri uomini<br />
illustri, l’educazione dei principi ducali fu nelle mani di validi maestri. Tra i tanti,<br />
valga un esempio: Ippolita, che divenne la sposa di Alfonso, erede al trono aragonese<br />
di Napoli, sapeva di latino e di greco (a lei il Lascaris dedicò la sua grammatica) e,<br />
inoltre, danzava in modo da destare ammirazione.<br />
Il figlio primogenito di Lrancesco Sforza e suo successore, Galeazzo Maria, dopo<br />
la morte del padre (1466), governò, in un primo momento, con la madre Bianca<br />
Maria; poi, unico signore, rinnovò le scelleratezze dei Visconti. Tuttavia, nutrito<br />
41
La Rocca di Soncino (cittadina presso la sponda destra dell’Oglio),<br />
fatta edificare da Galeazzo Maria Sforza nel 1473.<br />
Fot. Stefani<br />
di studi umanistici continuò la munificenza paterna, arricchì di codici la biblioteca<br />
ducale nel castello di Pavia, accolse in Milano i primi stampatori. Ancor giovane,<br />
cadde in una tragedia di sangue, ucciso nella notte di Santo Stefano del 1476. L ’episodio<br />
è diversamente interpretato; alla tesi del delitto privato si oppone quella che<br />
vede nei congiurati, nutriti di studi umanistici, l’ira di Bruto: la vendetta del Montano,<br />
del Lampugnani e dell’Olgiati contro il tiranno che aveva abusato del potere,<br />
distruggendo la libertà.<br />
L ’erede Gian Galeazzo, primogenito di Galeazzo Maria, era giovanissimo e governò<br />
quindi sotto la reggenza della madre, Bona di Savoia. L ’anima del governo era però<br />
Cicco Simonetta, l’uomo che Francesco Sforza aveva avuto al suo fianco nella rico-<br />
42
stituzione dello Stato, 1 uomo dal polso fermo, che per qualche tempo seppe tenere<br />
a freno anche le voglie dei fratelli del duca ucciso, volti ad impossessarsi del potere;<br />
preso però a tradimento da uno di questi, Ludovico il Moro, fu decapitato nel<br />
castello di Pavia (1480). Si narra ch’egli, dopo la cattura, dicesse coraggiosamente<br />
al Moro :
iChiávenha'. '. ' ! ' 1' !-ól i, '<br />
Territori passati<br />
a i Savoia sino<br />
a l Ш 8<br />
La divisione politica del<br />
territorio lombardo nel<br />
1714.<br />
Utet<br />
Cremona. Eppure il medesimo periodo ha lasciato opere grandiose: chiese e palazzi<br />
privati, ad opera di uomini che nella storia dell’arte portano nomi di alta risonanza.<br />
Quando il 24 settembre 1706, Eugenio di Savoia entrò in Milano alla testa delle<br />
truppe austro-piemontesi, al servizio dell’imperatore Giuseppe I d’Asburgo, la situazione<br />
economica del Ducato non si presentava certamente fiorente; e le condizioni,<br />
sotto l’urto delle truppe occupanti, peggiorarono dall’una all’altra guerra di successione.<br />
Gravi furono per l’economia della regione anche le perdite territoriali<br />
dell’Oltrepò, della Lomellina e del Novarese (1734). In compenso, nel 1745 Mantova<br />
venne aggregata al residuo territorio dell’antico Ducato, dando origine così alla <strong>Lombardia</strong><br />
austriaca.<br />
Chiusasi, nel 1748, la guerra di successione austriaca col riconoscimento dei diritti<br />
di Casa d’Asburgo sulla <strong>Lombardia</strong>, Maria Teresa e quindi il figlio e successore<br />
Giuseppe II diedero l’avvio a quelle riforme illuminate che favorirono il progresso<br />
civile ed economico e anche culturale. Lo Stato assoluto consentì e favorì l’avanzare<br />
di una nuova classe sociale titolata, già forte in mezzi economici, la cosiddetta borghesia,<br />
alla quale s’aprirono nuove possibilità nel campo amministrativo, prodromi<br />
di una futura espansione politica. La città di Milano si trasformò; l’edilizia privata<br />
si rinnovò. Già nel secolo precedente erano sorti palazzi signorili di notevole architettura;<br />
ora le case comuni perdevano del tutto la rude scorza medioevale: sparivano<br />
logge e « baltresche » ; i muri venivano intonacati e imbiancati ; le strade selciate e<br />
cordonate di granito; l’arbitrio privato disciplinato dall’interesse generale. Lu in<br />
46
questa atmosfera che Г Università di Pavia raggiunse quella fama di antesignana nel<br />
risorgimento degli studi « novatori » e « luminari » (A. Visconti).<br />
Sopraggiunge il 1796 e, sotto rincalzare delle truppe francesi guidate da Napoleone<br />
Bonaparte, Milano si svuotò delle autorità austriache. Il 9 maggio si formò<br />
la Giunta interinale di governo. Il 15 dello stesso mese, dopo la vittoriosa battaglia<br />
di Lodi, Napoleone entrò in Milano. Il risveglio nazionale ebbe allora il suo momento<br />
propizio. Il 21 giugno del 1797 la Valtellina affermò la sua indipendenza. Il 9 luglio<br />
venne proclamata la Repubblica Cisalpina che comprendeva la <strong>Lombardia</strong>, parte<br />
dell’Emilia e un lembo di Toscana. Parve tutto crollare con l’occupazione austrorussa,<br />
ma fu una breve pausa: il pericolo dileguò sui campi di Marengo (1800). La<br />
«seconda» Cisalpina rinacque per cedere presto il posto alla Repubblica italiana proclamata<br />
nei Comizi di Lione (gennaio 1802). Infine, il 26 maggio 1805, Napoleone<br />
s’incoronò re d’Italia nel Duomo di Milano. Così la metropoli lombarda, divenuta<br />
sede di un regno, raggiunse il sogno delle generazioni dei Visconti e degli Sforza<br />
che, nella storia della tradizione regale, risale al lontano Medio Evo, allorché, in<br />
Sant’Ambrogio, i monarchi cingevano quella stessa Corona ferrea che Napoleone si<br />
era posta sul capo.<br />
Milano, capitale del Regno d’Italia, divenne il centro delle aspettative nazionali:<br />
a Milano giungevano poeti e letterati, scienziati e pensatori d’ogni parte d’Italia,<br />
arricchendola di passione patriottica e di esperienze letterarie. Dall’Università di<br />
Veduta su Milano da Porta Ticinese in un disegno dell’Ottocento. In primo piano il propileo del<br />
Gagnola innalzato a ricordo della vittoria napoleonica di Marengo. A i lati i bastioni delle mura<br />
spagnole. Sulla fuga dei tetti, il campanile di Sant’Eustorgio e la cupola di San Lorenzo Maggiore.<br />
47
Pavia, il Foscolo richiamava gli Italiani al culto della storia e l’esortazione scaturiva<br />
dalla contemplazione d’una eredità luminosa, che il Muratori aveva illustrato nei<br />
Rerum Italicarum Scriptores e in altri solenni volumi, stampati in Milano dalla Società<br />
Palatina, nella prima metà del Settecento.<br />
Quando la stella di Napoleone tramontò, si verificò anche lo sfacelo delle sue<br />
imprese. Il tentativo di un regno italico nazionale fallì miseramente e gli avvenimenti<br />
di portata internazionale coinvolsero nuovamente l’Italia, dandole un nuovo volto<br />
politico. La <strong>Lombardia</strong> ritornò sotto l’Austria, inglobata nel Regno lombardo-veneto<br />
sanzionato costituzionalmente con l’atto emanato il 7 aprile 1815 dall’imperatore<br />
Francesco I. Il nuovo Regno fu diviso in due parti separate dal Mincio, una lombarda<br />
sotto il Governo milanese, l’altra veneta sotto il Governo veneziano. La <strong>Lombardia</strong><br />
comprendeva i territori dell’antico Ducato di Milano (escluso l’Oltrepò e la<br />
Lomellina), del Bergamasco, del Bresciano, del Mantovano, delle contee di Chiavenna,<br />
di Bormio e la Valtellina. Il 3 gennaio 1818 l’arciduca Ranieri fu creato<br />
primo viceré.<br />
Come nel Regno lombardo-veneto si attuasse il governo austriaco e quali siano<br />
stati l’ardore di opposizione, il sacrificio e il martirio dei Lombardo-Veneti sta in<br />
una delle pagine più fulgide della nostra epopea risorgimentale, un’epopea che appartiene<br />
a tutti gli Italiani. È una folla di nomi che si affacciano alla memoria ; ogni<br />
terra di <strong>Lombardia</strong> vanta un eroe del pensiero e dell’azione: da coloro che nelle<br />
carceri dello Spielberg languirono о ascesero sui patiboli di Belfiore e con l’olocausto<br />
della vita fecero trionfare l’ideale, vissuto nelle barricate del 1848, a coloro che si<br />
immolarono sui campi di battaglia delle guerre d’indipendenza: alpigiani e uomini<br />
della pianura, d’illustre casato о di umile origine, provenienti e dalle città e dai villaggi<br />
più oscuri.<br />
I fatti gloriosi del 1859 coronano questa epopea con l’unità d’Italia.<br />
E come nell’Italia nuova i Lombardi abbiano risposto all’appello della Patria,<br />
lo documentano il fervore di vita e le conquiste civili, di cui si orna la nostra storia<br />
contemporanea, nell’agricoltura, nell’industria, nel commercio, nella scuola: nello<br />
sviluppo della istruzione sta la leva d’ogni vitale energia; nella capacità organizzativa,<br />
nell’esecuzione ferace e diuturna del dovere, la fonte di ogni sicuro progresso.<br />
48
Capitolo T erzo<br />
IL RILIEVO: MONTAGNE E PIANURE<br />
Cenni geomorfologici.<br />
Il territorio della <strong>Lombardia</strong>, entro i limiti della sua pur modesta estensione,<br />
manifesta una singolare mutevolezza di paesaggi: da quelli imponenti dell’aspra<br />
chiostra di alte cime, maestosamente drappeggiate di nevi e di ghiacci, a quelli<br />
riposanti della pingue distesa di pianura, solcata dalle pigre acque di mille rivi<br />
d’argento, è tutto un frequente cangiare di forme e di prospettive. È fuor di ogni<br />
dubbio che all’origine di tale caratteristica varietà di paesaggio si debba porre fondamentalmente<br />
il motivo orogenetico o, più specificatamente, una serie di motivi<br />
interdipendenti tra loro e tutti ricollegabili all’orogenesi. Per semplicità si possono<br />
compendiare in due: l’uno d’ordine geologico, l’altro d’ordine litologico.<br />
Geologicamente la <strong>Lombardia</strong> ha in comune con il Piemonte e le Venezie (le<br />
regioni che Г affiancano rispettivamente a est e a ovest) la grandiosità e la molteplicità<br />
dei fenomeni che sono stati la causa delle manifestazioni morfologiche attualmente<br />
più appariscenti del territorio, ossia, in poche e semplici espressioni, il complesso<br />
corrugamento da cui è derivato il vasto sistema orografico delle Alpi e il<br />
successivo colmamento della conca che ha dato origine alla vasta pianura padanoveneta.<br />
Però, litologicamente la parte montana della nostra regione rappresenta quasi<br />
una zona d’innesto della diversa gamma delle formazioni che più spiccatamente<br />
caratterizzano le due regioni contermini, quelle dei cristallini che prevalgono nel<br />
Piemonte e quelle dei calcari che prevalgono nelle Venezie; sicché nel suo àmbito<br />
la <strong>Lombardia</strong> può vantare, benché attenuate, sia la selvaggia severità dei paesaggi<br />
montani del primo che l’aggraziata singolarità dei paesaggi più suggestivi delle<br />
seconde. Sotto tale aspetto si può ben asserire che la <strong>Lombardia</strong> rappresenta un’area<br />
4 — Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
49
di collegamento о, se si preferisce, di trapasso tra il Piemonte e le Venezie. Occorre<br />
tuttavia avvertire che la regione non manca anche di sue peculiari caratteristiche,<br />
che le conferiscono un’impronta inconfondibile; tipico esempio è quello degli ampi<br />
bacini lacustri che dal margine della pianura s’insinuano, a guisa di fiordi (ma di<br />
questi assai più ridenti), tra le giogaie dei monti.<br />
Da quanto premesso risulta con evidenza che la prima fondamentale distinzione<br />
in ordine fisico della <strong>Lombardia</strong> va fatta tra la montagna, che si distende in fascia<br />
da ovest a est nella parte settentrionale della regione, e la pianura che si distende,<br />
ugualmente in fascia, nella parte meridionale; l’una soggetta, sino dal suo formarsi,<br />
a fenomeni di degradazione, tuttora intensi, l’altra a fenomeni di sedimentazione,<br />
ormai appena percettibili.<br />
50
Tra la zona di montagna e la zona di pianura non v ’è una netta separazione e<br />
un brusco passaggio; ma tra l’una e l’altra s’interpone, a transizione, una fascia di<br />
collina, più о meno espansa, ma nel complesso non molto estesa. Infatti questa occupa<br />
quasi il 12,5% del totale del territorio della <strong>Lombardia</strong> contro circa il 46,9% della<br />
pianura e il 40,6% della montagna.<br />
La zona di montagna della <strong>Lombardia</strong> si estende tra lo spartiacque alpino e il<br />
limite con la collina. Per quanto l’uno e l’altro abbiano un andamento tortuoso, è<br />
facile a primo colpo d’occhio rilevare che la zona montuosa in versante lombardo<br />
si estende in ampiezza progressivamente da occidente a oriente, soprattutto a causa<br />
del limite montagna-collina che, tra il Verbano e il Benaco, manifesta una direzione<br />
generale da nordovest a sudest. Pertanto, mentre ad occidente l’ampiezza della fascia<br />
montuosa è di circa 75 km. in linea d’aria (ad es., tra Lecco e lo Spinga), ad oriente<br />
è di almeno 115 km. (ad es., tra Brescia e lo Stelvio).<br />
In relazione agli affioramenti litoligici, a cui fa riscontro, come s’è fatto cenno,<br />
una particolare morfologia, la montagna lombarda si suddivide in due fasce press’a<br />
Fot. Fracchi<br />
Il versante lombardo del<br />
monte Cevedale (metri<br />
3778) con la vedretta di<br />
Cedec e, a destra, il<br />
monte Pasquale (m. 3559)<br />
visti dal Passo dello Zebrù<br />
(m. 3010). Sul fondo della<br />
conca il Rifugio Pizzini<br />
(m. 2706).<br />
SI
poco parallele Tuna all’altra e disposte nella direzione assiale del sistema delle Alpi;<br />
la fascia settentrionale, propriamente alpina, costituita in prevalenza da formazioni<br />
cristalline paleozoiche, e la fascia meridionale prealpina, costituita in prevalenza da<br />
formazioni calcaree mesozoiche; la prima è altimetricamente più elevata, di forme<br />
più aspre, provvista di ghiacciai; la seconda è altimetricamente meno elevata, di<br />
forme frequentemente morbide e del tutto priva di ghiacciai. La linea di distinzione<br />
tra le due zone segue approssimativamente la spezzata che da Luino, sul<br />
lago Maggiore, attraverso la vai Tresa, raggiunge Lugano, sul lago omonimo, e<br />
quindi, attraverso la vai Menaggio, l’abitato omonimo sul lago di Como. Da Bellano,<br />
sulla sponda opposta del medesimo lago, lungo la Valsàssina e la Vaitorta<br />
raggiunge Piazza Brembana nella valle del Brembo; da qui, per la Vaisecca e la<br />
Valcanale, Gromo, nella valle del Serio e successivamente Viiminore nella vai di<br />
Scalve e lungo questa il passo di Campelli e Capo di Ponte nella Valcamònica.<br />
Le morbide forme modellate nei teneri scisti filladici<br />
al Giogo Santa Maria (2502 m.), alla quarta Cantoniera dello Stelvio.<br />
Sovrapposti i calcari mesozoici del Piz Umbrail (3031 m.).<br />
Fot. Prof. Corti<br />
52
Fot. Fagnani<br />
Panorama alpino dal lago d’Arcoglio verso il pizzo Scalino (a sinistra).<br />
Le formazioni sono in prevalenza costituite da scisti e da gneiss<br />
in strati pressoché verticali che si coricano orizzontalmente verso lo Scalino.<br />
Tra questa località e il lago di Garda il limite disegna un ampio saliente rivolto<br />
a sud, tagliando per il passo di Croce Domini verso Bagolino e seguendo da ultimo<br />
la vai di Ledro, ormai in territorio trentino.<br />
Non è, quello indicato, un limite tra Alpi e Prealpi sviluppato lungo accidenti<br />
morfologici molto appariscenti, come possono essere ampi solchi vallivi quali, ad<br />
esempio, la Valtellina, adottata in passato quale linea divisoria; ma esso rappresenta<br />
il risultato di accurate ricerche e validi studi e ha il merito di indicare una esatta<br />
delimitazione dal punto di vista litologico, morfologico e altimetrico.<br />
Le rocce cristalline che formano la fascia propriamente alpina non costituiscono<br />
un ammasso omogeneo, bensì assai differenziato, se non sempre per composizione<br />
mineralogica о chimica, certo per struttura e per compattezza. Di riflesso la morfologia<br />
risulta nient’affatto monotona ma, al contrario, è molto varia.<br />
I micascisti, che si distinguono per l’abbondanza e l’evidenza delle lucenti scagliette<br />
di mica e per la forte scistosità, sono molto erodibili e franosi e quindi i<br />
monti e le valli modellati in tale roccia, specialmente se non molto elevati, hanno<br />
morbide forme, quali, ad esempio, si possono osservare nell’alto Verbano, nell’alto<br />
Lario, nella Valtellina e, in lembi minori, nell’alta Valcamònica. Anche alcune delle<br />
S3
La Seriori (3195 m.) vista dal<br />
Badile. La punta è scolpita nel<br />
ghiandone, granito a grossi cristalli<br />
di feldspato.<br />
Fot. Prof. Corti<br />
cime più elevate, se formate da micascisti, non presentano eccessive asprezze e tipico<br />
esempio ne è il Cevedale (3764 m.). Inoltre i terreni formati dai micascisti sono<br />
discretamente fertili e formano i pascoli e i prati più produttivi.<br />
Per solito sono assai erodibili e per lo più franose anche le filladi (di composizione<br />
eguale ai micascisti, ma di grana più minuta), i calcescisti, le quarzofilladi, ecc.,<br />
mentre i micascisti gneissici e le quarziti rappresentano un graduale passaggio a<br />
rocce affini più compatte. Una morfologia piuttosto blanda manifestano, nella regione<br />
lombarda, anche i porfidi, che sono tuttavia rocce estremamente compatte, ma ciò<br />
si deve al fatto che gli affioramenti lombardi più notevoli, quelli tra Verbano e<br />
Ceresio, per essere altimetricamente poco elevati e nelle zone di transito delle colate<br />
glaciali, furono da queste modellati in forme tondeggianti.<br />
Il gruppo degli gneiss, che costituiscono l’ossatura fondamentale delle Alpi, in<br />
relazione alla maggiore о minore scistosità dei diversi tipi presenta forme discretamente<br />
varie, ma in genere notevolmente aspre (benché non nella misura dei complessi<br />
formati da rocce granitiche) e di frequente contrassegnate da grandiose e<br />
54
ovinose frane. In tal modo si manifestano, oltre che nel Canton Ticino, nelle valli<br />
San Giacomo e Bregaglia, nella Valtellina, nelle valli ad essa confluenti (vai Grosina)<br />
e, infine, nell’alta Valcamònica. Esempio tipico di cima di gneiss è il corno Stella<br />
(2620 m.) nelle Orobie. La scistosità di queste rocce permette la loro utilizzazione<br />
per la copertura dei tetti delle case e delle baite; però le lastre ottenute dagli gneiss<br />
lombardi non valgono le famose bèole della vai d’Ossola.<br />
I graniti raggiungono il massimo di asperità che si possa rilevare nella morfologia<br />
lombarda: le valli affondano anguste e orride, le cime si elevano tormentate<br />
e sconvolte e la tendenza di queste rocce a fratturarsi in grossi blocchi, detti piödesse,<br />
accresce il tragico aspetto di tali forme. La valle del Màsino e le montagne circostanti<br />
ne sono il più caratteristico esempio: il granito ivi affiorante, distinto con il<br />
nome locale di ghiandone per i suoi bianchi e grossi cristalli di feldspato, forma<br />
attorno alla fossa valliva una corona di vette non tra le più elevate, ma certo tra<br />
le più attraenti della <strong>Lombardia</strong>, quali la cima di Castello (3378 m.), il pizzo Badile<br />
(3007 m.) e il pizzo Cengalo (3267 m.). Le sieniti e le dioriti per asperità di forme<br />
Fot. Prof. Corti<br />
La Cresta Güzza (3870 m.)<br />
scolpita nella diorite, la medesima<br />
roccia che forma la maggior<br />
parte dell’aspro gruppo<br />
del Bernina.<br />
55
si affiancano ai graffiti e il Bernina (4050 m.) ne dà testimonianza. La stessa cosa<br />
vale per la scura tonalité dell’Adamello (3554 m.) che presenta una selva di vette<br />
audacemente scolpite e profondamente tormentate, la cui base di frequente è cinta<br />
di « mari di pietre ».<br />
Infine il serpentino о « pietra verde », che affiora particolarmente nel gruppo<br />
del Disgrazia (3678 m.) e nella vai Malenco, è roccia compatta ma soggetta ad una<br />
notevole frantumazione in grosse scaglie e in lastre, chiamate localmente lavègg,<br />
usate per la copertura dei tetti. Nelle zone meno elevate il serpentino dà luogo a<br />
Schema geolitologico del territorio della <strong>Lombardia</strong>.<br />
I, alluvioni recenti (D ilu v iu m recente); 2, alluvioni antiche (D ilu v iu m antico); 3, morene e anfiteatri morenici del<br />
Pleistocene; 4, argille e sabbie del Pliocene; 5, marne, arenarie e argille del Miocene; 6, calcari marnosi dell’Oligocene;<br />
7, calcari grigiastri dell’Eocene; 8, calcari e scisti argillosi del Cretacico; 9, calcari del Lias; io, calcari e<br />
dolomie del Trias superiore; ii, calcari e dolomie del Trias inferiore; 12, arenarie, conglomerati, argille e tufi del Permiano;<br />
13, scisti cristallini e gneiss; 14, serpentino (Disgrazia); 15, graniti, dioriti e porfidi (Badile, Adamello, Varesotto, ecc.).<br />
56
Fot. Nangeroni<br />
Il monte Disgrazia (3678 m.)><br />
la più alta cima scolpita nel serpentino, visto dal passo del Ventina.<br />
forme nel complesso blande, ma, nelle più elevate, frequentemente rotte da sfasciumi,<br />
determina cime a forme ardite, che tuttavia non eguagliano le asprezze del<br />
granito. Per il suo bel colore è molto usato in <strong>Lombardia</strong> come pietra ornamentale;<br />
anche la pietra oliare, che è serpentino a grana finissima, viene molto apprezzata<br />
localmente come pietra suscettibile di artistico cesello.<br />
I gruppi montuosi alpini.<br />
Tutta la zona alpina della <strong>Lombardia</strong> rientra per intero nelle Alpi centrali e si<br />
suddivide fra tre sezioni :<br />
a) le Alpi Lepontine, che abbracciano tutta l’area alpina lombarda a occidente<br />
del passo dello Spinga (2117 m.) e del solco che da esso discende al Lario;<br />
b) le Alpi Retiche, che si estendono a oriente del medesimo passo e del<br />
medesimo solco, limitate a sud dalle incisioni in successione della bassa Valtellina,<br />
dell’Aprica, della valle di Còrteno e della Valcamònica:<br />
57
Veduta aerea sul gruppo Gottardo.<br />
Fot. Swissair<br />
c) le Alpi Orobiche о Oròbie, che si allungano in regolare catena tra il Lario<br />
e rOglio a sud del solco bassa Valtellina-Aprica-valle di Còrteno e parallelamente<br />
allo stesso.<br />
La sezione appartenente alle Alpi Lepontine, per la maggior parte in territorio<br />
politicamente svizzero, non è altimetricamente elevata come i gruppi montuosi che<br />
le emergono vicini (Finsteraarhorn, 4275 m., ecc.); le cime più alte si allineano lungo<br />
10 spartiacque principale e, tra il passo di Novena (2440 m.) e quello dello Spluga,<br />
oscillano appena sopra i 3000 m. ; vi succedono, da occidente ad oriente, il pizzo Gallina<br />
(3067 m.), il pizzo Rotondo (3196 m.) e il pizzo Lucendro (2967 m.) che formano<br />
11 cosiddetto massiccio del San Gottardo, importante nodo idrografico dal quale,<br />
oltre il Ticino, hanno origine, in opposto versante, il Rodano e il Reno. Il San Gottardo<br />
è ben noto anche per il valico omonimo (2112 m.) percorso da una facile strada<br />
e attraversato da un traforo ferroviario, fondamentale per le comunicazioni tra la<br />
<strong>Lombardia</strong> e la Svizzera centrale.<br />
Dopo il passo, sul crinale delle Lepontine si succedono il pizzo Centrale (3003 m.)<br />
e il piz Blas (3023 m.), che domina sulla profonda incisione del passo di Lucomagno<br />
(1916 m.), già importante via militare e commerciale nell’antichità e attualmente<br />
di interesse prevalentemente turistico. Successivamente lo spartiacque con andamento<br />
tortuoso si eleva nel monte Scopi (3200 m.), piz Medel (3203 m.), piz Vial (3172 m.).<br />
S8
piz Terri (3153 m.), piz Scharboden (3126 m.) e nel pittoresco gruppo dell’Adula<br />
о Rheinwaldhorn, che raggiunge i 3406 metri. Dopo il passo di San Bernardino<br />
(2063 m.), come quello di Lucomagno importante via di comunicazione nell’antichità<br />
(e attualmente attraversato da una autostrada in galleria) il crinale si allaccia<br />
al pizzo Tambó (3279 m.) che domina sullo Spluga (2115 m.). La serie delle<br />
più alte vette s’adornano di numerosi ghiacciai per lo più di modeste dimensioni e<br />
frequentemente, come nell’Adula, di circo.<br />
Il versante meridionale, idrograficamente tributario del lago Maggiore, appartenente<br />
quindi per intero al bacino del Ticino, è costituito in prevalenza da gneiss<br />
e micascisti, la cui massa si presenta incisa da un ventaglio di ampi e profondi<br />
solchi vallivi convergenti verso l’apice settentrionale del lago Maggiore: la ramificata<br />
vai Maggia, la breve vai Verzasca e la vallata del Ticino. Questa, dalle sorgenti<br />
allo sbocco nel Verbano, si distingue nei tre tronchi della vai Bedretto (dal passo<br />
di Novena ad Airolo), della vai Leventina (da Airolo a Biasca) e, tra le confluenze<br />
Fot. Steiner<br />
Il passo del Maloggia (a sinistra, 1817 m.),<br />
versante della Mera, con la valle Muretto e il passo omonimo.<br />
59
della val Bienio, che discende dal Lucomagno, e della vai Mesolcina, che proviene<br />
dal San Bernardino, della Riviera, dal fondo largo e pianeggiante. Tali valli, alcune<br />
delle quali chiaramente modellate dalle colate glaciali del Quaternario, sono separate<br />
l’una dall’altra da lunghe dorsali montuose che raramente (e comunque di poco)<br />
superano i 3000 m., ma non pertanto manifestano frequenti asprezze che rendono<br />
assai movimentata la morfologia.<br />
Di tutta questa sezione alpina, strettamente legata dal punto di vista fisico alla<br />
<strong>Lombardia</strong>, solo due lembi di modesta estensione rientrano nel territorio amministrativo<br />
delle province lombarde: l’alto Luinese, in provincia di Varese, e il versante<br />
orientale del lungo contrafforte che dal pizzo Tambó si snoda tra il bacino del<br />
Ticino e quello dell’Adda sino alla vai Menaggio. Il primo s’eleva dalle sponde del<br />
lago Maggiore in una cerchia di cime sui 1600 m. che fanno corona alla vai Veddasca.<br />
Il secondo sorge tra le sponde dei laghi di Como e di Lugano e in breve<br />
s’aderge oltre i 2000 m. in una fuga di cime separate da alti valichi; quelle, progressivamente<br />
sempre più elevate (monte Garzirola, 21 i i m., pizzo di Gino, 2245 m.,<br />
monte Cardinello, 2520 m., pizzo Roggione, 2575 m.), raggiungono il massimo nel<br />
pizzo Quadro (3013 m.); questi, mai più bassi dei 2200 m. (passo di Sant’Iorio,<br />
2240 m., passo della Forcola, 2226 m., passo di Baldiscio, 2353 m.), sono ben noti<br />
al contrabbando.<br />
Il passo dello Spinga (2115 m.) con la profonda valle San Giacomo che da esso<br />
discende sino al piano di Chiavenna, il piano di Chiavenna stesso, e, in prosecuzione,<br />
il lago di Mezzola e il Lario con la sua criptodepressione, formano una assai marcata<br />
e pressoché rettilinea incisione trasversale di tutto il complesso montuoso della<br />
<strong>Lombardia</strong>. Tale incisione non solo serve a dividere le Alpi Lepontine dalle<br />
Alpi Retiche, ma anche a distinguere due zone per altro aspetto differenziate: quella<br />
occidentale, precedentemente descritta, improntata da una maggiore uniformità<br />
litologica e morfologica e quella a oriente caratterizzata da un affiorare tumultuoso<br />
di rocce eterogenee e da un altrettanto rapido variare della morfologia.<br />
La sezione appartenente alle Alpi Retiche può essere distinta in due parti: quella<br />
tra lo Spluga e lo Stelvio, che, attraverso l’eccelso Bernina, si sviluppa lungo la catena<br />
di spartiacque alpino, e quella che dallo Stelvio si dirama a dorsale in direzione meridionale<br />
attraverso i maestosi gruppi del Cevedale e dell’Adamello ; l’una seguita dappresso<br />
(ossia con le deviazioni già rilevate) dal confine politico italo-svizzero, l’altra<br />
dal limite regionale lombardo-altoatesino-trentino; sicché di entrambe le parti si<br />
può considerare come aggregabile propriamente all’individualità fisica della <strong>Lombardia</strong><br />
solamente uno dei due rispettivi versanti: quello idrograficamente appartenente<br />
ai bacini abduano e camunno.<br />
La grande cerchia montuosa lungo lo spartiacque alpino presenta una successione<br />
di cime oscillanti tra i 3000 e i 4000 m., non raramente di forma aspra e<br />
tormentata, talvolta isolate, tal altra riunite in pittoresco aggruppamento, per lo più<br />
ammantate di candidi drappeggi di nevai e di ghiacciai. Seguendo il crinale si possono<br />
distinguere diverse parti. La parte che, per brevità, può essere indicata con<br />
60
il nome della cima che la sovrasta, il pizzo d’Èmet (3217 m.), si dispone a catena,<br />
a forma di una grande L, parallelamente ai due solchi confluenti della vai San Giacomo<br />
e della vai Bregaglia, che la limitano tra il passo dello Spinga (2115 m.) e il<br />
passo del Maloggia (1817 m.). Nell’angolo interno rivolto a nordest ha origine una<br />
delle valli del ventaglio sorgentizio del Reno e precisamente quella indicata con il<br />
nome di Reno di Lei, già menzionata perchè area al di là dello spartiacque alpino<br />
inclusa in territorio politicamente italiano. La catena dell’Emet si distende continua<br />
con valichi elevati (tra i quali il passo Angeloga, 2397 m., principale via mulattiera<br />
per la valle del Reno di Lei) e cime elevate, quali, oltre raffilato Èmet, il<br />
monte Suretta (3031 m.), che incombe sul valico dello Spluga, il pizzo Stella<br />
(3163 m.), la cui ardita piramide domina la confluenza della vai San Giacomo e<br />
della vai Bregaglia, il pizzo Galleggione (3106 m.) e il pizzo Duana (3130 m.), che<br />
sovrasta il passo del Maloggia. Negli gneiss, che intercalati a graniti e a rari calcari<br />
formano questa sezione montuosa, s’aprono, simili a dilaniate ferite, grandiose frane,<br />
che, con l’orrido aspetto delle loro petraie, allungano verso i fondivalle le asperità<br />
dell’alto crinale. Di alcune storiche si ricorda il tragico avvenimento: come quella<br />
del 1618 in vai Bregaglia che distrusse l’abitato di Piuro, rivale di Chiavenna,<br />
facendo più di mille vittime, e quella del 1834 in vai San Giacomo che si abbattè<br />
su Isola Liro (Isolato), distruggendo anche un tratto della strada dello Spluga.<br />
Caratteristico è il fatto che nelle cavità tra i sassi di un’imponente frana preistorica,<br />
precipitata dal pizzo di Prata, a Chiavenna (che in parte sorge sui detriti stessi), sono<br />
Fot. Nani<br />
Grandiosa visione<br />
sul Disgrazia (3678<br />
metri) e sulle cime<br />
circostanti visti dal<br />
ghiacciaio di Scerscen<br />
superiore (Bernina).<br />
61
stati derivati dei vani, i cosiddetti erotti, che per la fresca temperatura estiva (12°)<br />
servono come depositi del vino.<br />
Il passo delMaloggia о Maloia (1815 m.) è il più basso dei valichi dello spartiacque<br />
alpino che fa da limite settentrionale alla <strong>Lombardia</strong>; esso forma un’ampia soglia<br />
rocciosa (su cui si possono notare alcune marmitte dei giganti) alla testata della<br />
vai Bregaglia e immette nella ridente valle dell’Inn о Engadina. E un passo già noto<br />
nell’antichità e attualmente d’intenso traffico turistico, transitabile anche d’inverno.<br />
Lo spartiacque alpino, a sud del passo, risale verso le erode del piz la Margua<br />
(3162 m.) e del monte Muretto (3104 m.) e raggiunge, attraverso il gruppo del Bernina,<br />
il passo omonimo. Ma a questo maggiore gruppo si allaccia, per mezzo del<br />
passo del Muretto (2560 m.), il gruppo attiguo del Badile-Disgrazia e insieme formano<br />
un poderoso bastione ben circoscritto su ogni lato da ampi e profondi solchi<br />
vallivi: in versante abduano, dal tronco longitudinale della Valtellina, dalla confluente<br />
valle di Poschiavo che lo limita a oriente e dalla vai Bregaglia che con il<br />
Piano di Chiavenna lo aggira ad occidente; in versante danubiano dall’Inn e dal<br />
suo affluente Bernina che discende dal passo omonimo.<br />
Il gruppo Badile-Disgrazia forma un’aspra chiostra di cime disposte approssimativamente<br />
a semicerchio attorno al solco profondo della vai Màsino, che, angusta<br />
e pittoresca, discende da questi monti a confluire nella Valtellina. Tra il pizzo Bigóncio<br />
Il Badile (3308 m.) e il Cengalo (3267 m.), dal passo di Camerozzo (2745 m.);<br />
entrambe le cime sono scolpite nel ghiandone.<br />
Fot. Nangeroni<br />
62
Fot. Fracchi<br />
Il versante lombardo del gruppo del Bernina: da sinistra, il Ròseg (3939 m.),<br />
la Porta Ròseg (3524 m.), il Scerscen (3964 m.) e la Spalla del Bernina (4049 m.).<br />
(3033 m.) e i Corni Bruciati (3114 m.), che formano le estremità occidentale e orientale<br />
della cerchia, v’è una lunga serie di cime tutte sensibilmente al di sopra dei<br />
3000 m. ; un gruppo tra esse, scolpite nel serizzo, dalle forme slanciate e levigate,<br />
quali il pizzo Badile (3307 m.), il pizzo Cengalo (3267 m.), l’ago di Sciora (3205 m.),<br />
la cima di Castello (3378 m.), la punta Bàsica (3305 m.), i pizzi Torrone (3333 m.),<br />
è palestra di arditissimo alpinismo; un altro gruppo di cime, scolpite nel serpentino,<br />
ha forme più opulente: vi predomina il monte Disgrazia (3678 m.) regalmente circondato<br />
dal pizzo Ventina (3261 m.), dalla punta Kennedy (3295 m.), dal pizzo Cassandra<br />
(3226 m.) e dalla Corna Rossa (3180 m.).<br />
Altimetricamente ancor più elevato e indubbiamente ancor più spettacolare è<br />
l’insieme di cime prevalentemente granitiche che fanno corona al Bernina alla testata<br />
della vai Malenco, valle ampia e ridente, confluente alla Valtellina. Il pizzo Bernina,<br />
che, con i suoi 4049 m., sulle altre sovrasta, è la vetta più alta della <strong>Lombardia</strong> e<br />
la più orientale tra quelle superiori ai 4000 metri. Si ritiene che il suo nome possa<br />
derivare dall’alpe omonima e questa deve forse il suo toponimo a verri, radice<br />
romancia che signiflcherebbe ontano. L ’eccelsa vetta è affiancata a occidente dal<br />
63
J'.<br />
^^Irpass<br />
^<br />
, 30S3<br />
ç^hWf'n - г і ^ ^-i
■;ÿ: .<br />
m . V"* f?■Я'? >^'<br />
. Sís'í<br />
' ^'-' --vfîïïî-î?' ■;<br />
%ь:<br />
Fot. Saglio
e negli gneiss, pur vario di forme non eguaglia certamente la maestosità del Bernina.<br />
In generale prevale una maggiore morbidità di forme, sulle quali tuttavia si elevano<br />
aspre cime quali quelle di Campo (3302 m.), il pizzo Zembrasca (3090 m.), il<br />
monte di Foscagno (3058 m.), il monte Cornacela (3143 m.) e il piz Umbrail<br />
(3031 m.) lungo lo spartiacque e, isolate, la cima Viola (3374 m.), il pizzo Dosdè<br />
(3280 m.) e la cima de’ Piazzi (3439 m.) la più alta della zona. I valichi sono<br />
numerosi: il meno elevato è quello di Fraele (1952 m.), ma il più notevole è quello<br />
di Foscagno (2291 m.), percorso dalla strada che mette in comunicazione la Valtellina<br />
con la vallata di Livigno, lembo di territorio italiano in bacino idrograficamente<br />
danubiano.<br />
Con lo Stelvio già si è al margine della linea di spartiacque alpino e precisamente<br />
al punto di distacco della lunga dorsale del Cevedale e deU’Adamello. Il passo<br />
(2757 m.) è il più alto d’Italia tra quelli valicati da strade carrozzabili ed è inferiore<br />
appena di pochi metri all’Iseran, che tiene il primato per la regione alpina.<br />
L ’arco montuoso che, tra i passi dello Stelvio e di Gavia (2621 m.), recinge la<br />
testata della Valfurva, confiuente della Valtellina, è uno dei più attraenti della <strong>Lombardia</strong><br />
per la bellezza delle sue cime, la vastità dei ghiacciai e la varietà delle forme.<br />
Il passo del Bernina (versante abduano) con il lago Bianco, il pizzo Palù (3906 m.),<br />
il ghiacciaio omonimo e, sullo sfondo, la vetta del Bernina.<br />
Fot. Photoglob Wehrli A.G.
Il versante settentrionale<br />
del Corno<br />
Dosdè (3233 m.)<br />
e, sullo sfondo, del<br />
gruppo di Cima<br />
Viola (3374 m.) dal<br />
passo di Vallacela<br />
(valle di Livigno).<br />
Fot. Fracchi<br />
A conferire un’inconfondibile impronta giova soprattutto la presenza di lembi di<br />
rocce dolomitiche e calcaree giacenti suU’ammasso di rocce cristalline, residuo di<br />
queirimmensa coltre di terreni mesozoici che in lontani tempi geologici ricopriva<br />
tutta l’area alpina e che rimase attenagliata nell’immane corrugamento. Frammenti<br />
di tale natura emergono anche altrove nell’ambito dei cristallini (come il dolomitico<br />
Sassalbo, 2865 m., che domina la valle di Poschiavo), ma qui essi si espandono in<br />
superficie e si elevano in altezza formando una serie di vette che, con la loro evidente<br />
stratificazione a varia inclinazione, con la frequente desolata nudità della<br />
roccia, con la pallida colorazione delle pareti, con il frastaglio minuto in burroni<br />
e burroncelli, con l’abbondanza di colate di detriti, recano una nota inconsueta nel<br />
dominio del cristallino. Lungo l’arco si succedono in crescendo altimetrico il seghettato<br />
monte Cristallo (3431 m.), le cime di Campo (3480 m.), la cima Trafoi<br />
(3563 m.), la punta Thurwieser (3652 m.), lo Zebrù (3740 m.), da cui si diparte la<br />
dorsale che ascende all’Ortles (3899 m.) totalmente in territorio alto-atesino, e la<br />
vertiginosa cuspide del Gran Zebrù (3859 m.).<br />
A completamento della chiostra maestosa fa seguito, con evidente contrasto morfologico,<br />
una serie di colossi scolpiti in scisti cristallini, quali la morbida piramide<br />
del monte Cevedale (3778 m.), la calotta del Palón della Mare (3704 ü tozzo<br />
66
monte Vioz (3644 m.), l’agile punta San Matteo (3684 m.) e l’elegante pizzo Tresero<br />
(3602 m.), dalle cui cime discende il grande ghiacciaio del Forno (il più importante<br />
dei ghiacciai di questo settore, qui chiamati vedrette come nelle Alpi orientali)<br />
la cui lingua discende sino a 2200 m., orlata sui lati e sulla fronte di una<br />
serie di morene che mostrano assai bene i diversi momenti della fase involutiva<br />
iniziata nel 1864. Dal corno dei Tre Signori (3359 m.), che, all’estremità meridionale<br />
dell’arco montuoso, incombe sul passo di Gavia (2621 m.) collegante la Valfurva<br />
con l’alta Valcamònica, un contrafforte digrada lentamente verso l’ampia insellatura<br />
del Tonale (1885 m.), facile valico tra la Valcamònica e la vai di Sole. A sud del<br />
Tonale s’adergono Г Adamello e, del tutto in territorio trentino, la Presanella.<br />
La massa di diorite quarzifera (detta tonalité) dell’Adamello si eleva a forma<br />
di acrocoro coronato da una chiostra di stupende vette disposte a semicerchio attorno<br />
all’alta vai di Genova, ossia con la convessità rivolta alla Valcamònica verso la quale<br />
irradiano massicce ed elevate dorsali, che racchiudono pittoresche vallate, aspramente<br />
modellate, ricche di conche e rallegrate di ameni laghetti. Il limite regionale passa<br />
per punta Lago Scuro (3160 m.), punta Pisgana (3101 m.), monte Mandrone<br />
(3283 m.) e, tagliando trasversalmente il bacino ablatore della vedretta del Mandrone,<br />
raggiunge monte Fumo (3418 m.); sicché l’ampio arco che comprende l’Ada-<br />
Fot. Fracchi<br />
II versante calcareo della valle dello Zebrù visto dal monte Porcellino.<br />
Da sinistra si susseguono le seguenti cime: Trafoi (3563 m.), Thurwieser (3652 m.),<br />
Zebrù (3740 m.) e Gran Zebrù (3859 m.).<br />
67
La vetta del Gran Zebrù (3859 m.)-<br />
A destra il versante atesino, a sinistra il versante abduano.<br />
Fot. Stefani<br />
mello (3554 m.) e le cime minori del corno Bianco (3434 m.) e del corno Miller<br />
(3373 risulta totalmente in territorio lombardo.<br />
Visto dal lato occidentale il massiccio dell’Adamello si presenta con straordinaria<br />
imponenza per l’ardito cesello delle cime minori che lo contornano, prima tra<br />
tutte l’aspra vetta del corno Baitone (3331 m.); tuttavia chi raggiunge le maggiori<br />
elevazioni stupisce nel vedere attorno all’allineamento di cime stendersi ampi pianori,<br />
in parte coperti da estesi ghiacciai, che costituiscono un aspetto insolito e<br />
quant’altri mai interessante della morfologia lombarda. I ghiacciai sono numerosi;<br />
rientra in parte nel territorio lombardo anche la vedretta del Mandrone (che scola le<br />
sue acque nel Sarca), la più vasta del gruppo, misurando oltre 13 kmq. di superficie.<br />
Il lungo contrafforte che dall’Adamello si dirige verso sud digrada lentamente formando<br />
belle cime, quali quella di Buciaga (3015 m.), del monte Campelio (2809 m.),<br />
del monte Re di Castello (2891 m.), e, al passo di Croce Domini, s’innesta nelle<br />
Prealpi bresciane.<br />
La terza sezione delle Alpi lombarde è costituita, come s’è accennato, dalle<br />
Orobie. Esse s’interpongono tra la fascia di predominio dei cristallini e la fascia di<br />
68
netta prevalenza dei calcari e a rappresentarne il passaggio vengono quivi a contatto<br />
formazioni di diversa età e natura: sul versante valtellinese prevalgono micascisti<br />
e gneiss, sul versante bergamasco arenarie, puddinghe, argilloscisti paleozoici<br />
e gli uni e gli altri si contendono il crinale determinando una notevole varietà di<br />
forme e di aspetti.<br />
La catena si distende continua e rettilinea dalle sponde del Lario sino alla<br />
Valcamònica con uno sviluppo in linea d’aria di oltre 75 km. ; verso nord i<br />
contrafforti discendono precipiti, verso sud, invece, si allungano nelle Prealpi in<br />
poderose dorsali che discendono sino al margine della pianura. Lungo il crinale i<br />
passi sono numerosi ma tutti elevati; uno solamente ha un’altimetria inferiore ai<br />
2000 m., il valico di Ga’ San Marco (1992 m.), tra la vai Mora (affluente del Brembo)<br />
e la valle del Bitto (affluente dell’Adda), la cui mulattiera fu nei secoli passati assai<br />
frequentata da Bergamaschi e Valtellinesi. La parte più elevata della catena coincide<br />
con la parte mediana, press’a poco alla testata della vai Seriana. Il pizzo di Coca<br />
Fot. Prof. Corti<br />
Il versante settentrionale della vetta deU’Adamello (3554 m.) dal Rifugio Garibaldi<br />
(ora sommerso dalle acque di un bacino a scopo idroelettrico).<br />
69
Il gruppo del Baitone<br />
(3331 m.) visto<br />
dalla valle dell’Avio.<br />
Fot. Prof. Corti<br />
raggiunge la massima altimetria con 3052 m. ; poco inferiori gli sono la punta di Scais<br />
(3039 m.) e il pizzo di Redorta (3037 m.) che s’ergono vicini. Ma lungo il crinale<br />
vi sono numerose altre cime prossime ai 3000 m. e tra esse assai note il pizzo del Diavolo<br />
(2926 m.), il monte Torena (2911 m.) e il monte Gleno (2883 m.) a est, il<br />
pizzo del Diavolo di Tenda (2914 m.), il corno Stella (2620 m.) e il monte Legnone<br />
(2609 m.) a ovest del gruppo principale. Per lo più le vette, dalla larga gengiva<br />
ammantata di verdi boschi e di pascoli, si ergono aspre e brune, cinte da frane talvolta<br />
rossastre, ornate di minuscoli ghiacciai. Da esse lo sguardo spazia, al di là del<br />
solco della Valtellina, sulla cerchia dei monti cristallini delle Retiche e, dal lato<br />
opposto, sulla digradante fuga delle dorsali calcaree delle Prealpi e l’evidenza del<br />
contrasto risalta anche all’occhio meno esercitato. Si tratta indubbiamente di una<br />
delle zone montane più pittoresche e più attraenti della <strong>Lombardia</strong> e tuttavia<br />
forse una tra le meno note, a causa della non agevole accessibilità poiché mancano<br />
ancora strade di valico.<br />
70
Fot. Prof. Corti<br />
Alpi Orobie:<br />
veduta invernale del gruppo centrale dal Coca al Rodes (versante valtellinese).<br />
Le grandi vallate.<br />
%<br />
Conchiuso così il sommario panorama della grandiosa fascia montuosa delle<br />
Alpi lombarde e della attraente serie delle sue svettanti cime è pur necessario a<br />
questo punto un richiamo alle depressioni, ossia alle non meno belle vallate che,<br />
tra i gruppi montuosi, s’insinuano e si ramificano, distinguendoli l’uno dall’altro.<br />
Anzitutto è facile rilevare, sia pure da un rapido sguardo ad una carta sommaria,<br />
come la disposizione dei solchi vallivi presenti una curiosa singolarità. Non solo<br />
infatti vi sono tronchi di valle trasversali ossia solchi che seguendo, come par logico,<br />
la maggior pendenza d’insieme del sistema alpino, scendono direttamente dal crinale<br />
più elevato di spartiacque verso la pianura; ma vi sono tronchi di valle longitudinali,<br />
ossia solchi che seguono parallelamente la direzione delle catene montuose compli-<br />
71
cando assai il disegno della rete valliva; e ciò non solo nell’àmbito propriamente lombardo,<br />
ma anche ai margini di esso.<br />
Il solco longitudinale di maggiore evidenza è quello costituito dalla bassa Valtellina,<br />
che si allunga ampia e rettilinea da Tresenda al Lario. Però, sul suo<br />
allineamento è facile rilevare un sèguito. A oriente esso prosegue nell’aperto solco<br />
del passo dell’Aprica (1174 m.), nella valle di Còrteno, nell’alta Valcamònica, nel<br />
passo del Tonale (1885 m.), e, in territorio trentino, nella vai di Sole; a occidente,<br />
se pur con meno evidenza, nella valle del Liro, nel passo di Sant’Iorio (2240 m.) e,<br />
in territorio ticinese, nella vai Marobbia, nella bassa valle del Ticino, nell’apice settentrionale<br />
del Verbano e, infine, nelle Centovalli fino alla vai Vigezzo, in territorio<br />
piemontese. Si tratta di un allineamento di solchi e di insellature che si considerano<br />
riflesso di una grande frattura, о serie di fratture, complessivamente chiamate con la<br />
denominazione di linea insubrica о linea del Tonale, che ha spezzato l’immane complesso<br />
roccioso dalla superficie sino alle radici, facilitando l’opera di erosione dell’acqua<br />
nella formazione delle valli e dei valichi. In modo analogo, ma ovviamente con fenomeni<br />
di proporzioni più modeste, si può spiegare la formazione di altri solchi longitudinali.<br />
Le vette del Coca (3052 m.), dello Seals (3039 m.)<br />
e del Redorta (3037 m.) scolpite negli scisti argillosi permiani.<br />
Fot, Nangeroni<br />
7 2
Fot. Bromofoto<br />
Il passo deir Aprica (1174 m.) tra la Valcamònica e la Valtellina,<br />
invaso da alberghi e condomini.<br />
I tronchi di valle così originatisi, innestandosi a quelli trasversali, hanno assai<br />
complicato lo sviluppo delle vallate delle Alpi lombarde. Non è da credere,<br />
però, che la rete idrografica sin dai primordi dell’emersione alpina ricalcasse il<br />
disegno attuale. Essa, anzi, ha subito una profonda evoluzione, che in tempi successivi<br />
ne ha mutato l’aspetto; e non mancano tentativi di ricostruzione, basati<br />
sui tronchi di valle sospesi, sui terrazzi che a varia altezza rompono la pendenza dei<br />
versanti montuosi (e che dovrebbero rappresentare, almeno alcuni, i lembi residui<br />
degli antichi fondivalle) e sulle alluvioni abbandonate allo sbocco nella pianura. Il<br />
più caratteristico esempio, per la nostra regione, è costituito dall’Aprica (1174 m.),<br />
che all’osservatore si presenta come un tronco di valle lungo un paio di chilometri,<br />
sospeso sia sul lato che per la valletta di Còrteno sbocca nella Valcamònica, sia, e<br />
ancor più, sul lato che s’affaccia alla Valtellina. Ciò induce a ritenere che tale tronco<br />
rappresenti il solco prepliocenico di una valle che discendeva dal Tonale per confluire<br />
nell’Adda convogliando in questa le acque dell’Adamello. A comprova vi sono le<br />
alluvioni del Comasco e del Varesotto (verso cui sfociava l’Adda di allora) nelle<br />
quali si trovano elementi di tonalité senza alcun dubbio provenienti dall’Adamello.<br />
In un secondo tempo l’Oglio, arretrando alla propria testata per progressiva erosione,<br />
catturò le acque del Tonale-Adamello, lasciando l’Aprica come un tronco morto in<br />
lenta demolizione da parte del Fiumicello che percorre oggi la valle di Còrteno.<br />
73
Fot. Sef<br />
La Valtellina in prossimità di Sondrio : come per tutto il tratto tra Tirano e il Lario, presenta un<br />
fondo ampio e pianeggiante (formato da colmamento alluvionale), nel quale di frequente si innestano<br />
ampie conoidi alluvionali.<br />
È dunque attraverso una lenta evoluzione che si è giunti all’attuale rete idrografica.<br />
Occorre però aggiungere anche che tutte le grandi valli che provengono<br />
dalla zona alpina recano ancor oggi evidente l’impronta del glacialismo quaternario,<br />
ossia rivelano nelle loro forme il modellamento delle grandi colate di ghiaccio che,<br />
provenienti dal cuore delle Alpi, si sono insinuate nei solchi preesistenti, raggiungendo<br />
con le loro fronti il margine della pianura. I fondivalle larghi e piatti (ragione<br />
di un più fitto insediamento umano e di una più agevole penetrazione delle vie di<br />
comunicazione) ne sono la manifestazione più tipica; ma infinite volte si rivelano<br />
74
i segni del passaggio delle immani colate; non ultime le tipiche rocce montonate<br />
о striate dalla potente lima e i massi erratici abbandonati lontano dai luoghi di<br />
origine. Però non tutte le valli o, almeno, non in tutto il loro sviluppo le valli presentano<br />
la tipica sezione trasversale, che si suol dire a U, delle valli glacializzate.<br />
A volte si tratta di frane, a volte di ampi coni di deiezione che, posteriormente al<br />
glacialismo, hanno mutato le forme originarie. A volte si tratta anche di incisioni<br />
operate sul fondovalle, sempre posteriormente al glacialismo, dalla rapida corsa dei<br />
torrenti. Questi, distruggendo l’antico fondo, hanno prodotto una sezione trasversale<br />
ad angolo acuto о come si suol dire a V. Ciò si riscontra in valli particolarmente<br />
ripide, come, ad esempio, la vai Màsino, о nei gradini con i quali le valli secondarie<br />
confluiscono talvolta nelle valli maggiori, come, ad esempio, la vai Malenco.<br />
Le attuali grandi vallate alpine della <strong>Lombardia</strong> sono la Valtellina con la valle<br />
della Mera e la Valcamonica, cui si può aggiungere, per il particolare interesse che<br />
riveste, la valle del Ticino anche se in territorio politicamente svizzero.<br />
La valle del Ticino si distende ad ampio arco con la convessità rivolta a oriente<br />
nell’ambito delle Alpi Lepontine. Il solco ha origine al passo di Novena (2440 m.)<br />
e sbocca all’apice settentrionale del lago Maggiore (195 m.), con una lunghezza<br />
di 90 km. circa e una pendenza media di fondovalle del 25%o. Nel suo sviluppo si<br />
Fot. Swissar<br />
Valle del Ticino. Brenno.<br />
75
Fot. Fagnani<br />
Veduta panoramica sul Pian di Spagna,<br />
con lo sbocco dell’Adda e della Mera nel Lario.<br />
distingue con diversi nomi: vai Bedretto, vai Levantina e Riviera. La vai Bedretto<br />
si incide alle falde meridionali del San Gottardo tra il passo di Novena e Airolo<br />
(1178 m.); è un tratto assai ridente con pochi centri dalle belle dimore in legno,<br />
dove allo smeraldo dei prati di fondovalle fa contrasto il cupo verde delle abetaie<br />
risalenti i versanti. Ad Airolo (dove s’interna la galleria del San Gottardo) inizia<br />
la vai Leventina che termina a Biasca (305 m.): è un tratto di fondovalle a pendenza<br />
ancor rilevante, con pittoresche prospettive offerte dal profilo ora aspro ora blando<br />
dei versanti coperti a chiazze dal bosco ceduo, percorso dall’ardita linea ferroviaria<br />
e dalla strada del Gottardo e fitto di abitati. A Biasca confluisce sulla sinistra la<br />
vai Bienio (che nel tratto superiore prende il nome di vai Santa Maria) proveniente<br />
dal passo di Lucomagno, e ha inizio la Riviera. In questa il fondovalle si fa largo<br />
e piatto e con più evidenza si manifesta il modellamento glaciale; ad Arbedo confluisce<br />
sulla sinistra, con sbocco ugualmente ampio e piatto, la vai Mesolcina, che<br />
discende dal San Bernardino. L ’ultimo tratto di valle, da Bellinzona al Verbano,<br />
è costituito dal piano di colmamento alluvionale operato dal Ticino; il fiume vi è<br />
canalizzato e il territorio accuratamente bonificato.<br />
La Valtellina è la maggiore delle vallate lombarde e una delle maggiori della<br />
regione alpina. Essa si sviluppa trasversalmente sino a Tresenda, località sottostante<br />
al passo dell’Aprica, e longitudinalmente da Tresenda al Lario, con una lunghezza.<br />
76
Breno in Valcamònica.<br />
Sullo sfondo la pittoresca cuspide del Badile (2435 m.)-<br />
Fot. Sef<br />
tra la testata (passo di Alpisella, 2285 m.) e lo sbocco nel lago di Como (199 m.),<br />
di 115 km. a pendenza media di fondovalle del i8%o. L ’alto bacino, all’origine della<br />
valle, è costituito da quattro solchi disposti a ventaglio e confluenti nell’aperta conca<br />
di Bormio (1225 m.). Sono ricchi di acque — e quindi di bacini idroelettrici — e<br />
notevoli come vie di comunicazione : la vai Viola, che con il passo omonimo (2450 m.),<br />
s’aflaccia sulla valle di Poschiavo e con il passo di Foscagno (2291 m.) comunica<br />
con la valle di Livigno; la valle di Fraele, ramo sorgentizio dell’Adda, la valle del<br />
Braulio, che con il Giogo Santa Maria (2504 m.) s’afFaccia alla vai Monastero e con il<br />
passo dello Stelvio (2757 m.) comunica con la valle dell’Adige; infine la pittoresca<br />
Valfurva che con il passo di Gavia (2621 m.) comunica con la Valcamònica. Dalla<br />
77
conca di Bormio il solco vallivo va progressivamente incassandosi e spopolandosi;<br />
superata la stretta di Le Prese si fa nuovamente aperto e fitto di abitati; a mezza via<br />
tra Sondalo (939 m.) e Tirano (450 m.) riceve da destra la bella e ramificata vai Grosina,<br />
sospesa, alla confluenza, di un centinaio di metri sul fondovalle principale.<br />
A valle di Tirano, sino allo sbocco nel Lario, il fondovalle si stende amplissimo,<br />
alluvionato, con tenue pendenza (circa il 4°loo) e vi trovano sede numerosissimi centri.<br />
Le valli confluenti più importanti (valle di Poschiavo, vai Malenco, vai Màsino) si<br />
innestano sulla destra; ma, anche se di minor sviluppo, più numerose sono le confluenti<br />
di sinistra, disposte, rispetto al solco principale, a guisa dei denti di un<br />
pettine. Son queste inoltre che sul fondovalle valtellinese segnano il loro sbocco con<br />
coni di deiezione tuttora vivi, che costituiscono, in periodo di piena dei torrenti,<br />
un non trascurabile pericolo. L ’Adda a sua volta, sfociando nel Lario, ha costruito<br />
in tempi storici un vastissimo delta, noto con il nome di Piano di Spagna, cui si<br />
deve la separazione del lago di Mezzola dal Lario. In questo luogo si verifica la confluenza<br />
della valle di Chiavenna, costituita dall’incontro della vai San Giacomo,<br />
detta anche valle Spinga perchè proveniente dal passo omonimo, e della vai Bregaglia<br />
che discende dal Maloggia. Il fondovalle tra Chiavenna e Mezzola è ampio<br />
e piatto e deve la sua origine al colmamento alluvionale dell’apice lacustre del Lario<br />
determinato dai torrenti delle numerose vallecole laterali e soprattutto dalla Mera,<br />
colmamento avvenuto in epoca storica, tanto che la denominazione di Samòlaco è<br />
l’evidente derivazione del Summo Lacu dell’Itinerario di Antonino.<br />
La Valcamònica, dal passo del Tonale (1885 m.) allo sbocco nel lago d’Iseo<br />
(186 m.), s’incide per circa metà del suo percorso nelle formazioni alpine e per metà<br />
in quelle prealpine. Complessivamente ha una lunghezza di circa 70 km. con una<br />
pendenza media del fondovalle del 22°/oo- L ’alta valle è assai varia d’aspetto e nel<br />
complesso molto pittoresca, soprattutto per le prospettive che s’aprono sull’Adamello<br />
attraverso il solco delle vallette provenienti dal gruppo, quale, in particolare,<br />
la vai d’Avio, allietata da boschi, cascate e laghi. A Edolo (715 m.) confluisce la<br />
valle di Gòrteno, che discénde dall’Aprica e da qui il solco, da longitudinale quale<br />
era, diviene trasversale e, ad eccezione del tratto tra Breno e Cividate chiuso in stretta<br />
forra, si fa progressivamente sempre più ampio ed aperto.<br />
La zona prealpina.<br />
A sud della fascia alpina e giustapposta da essa si stende la zona delle Prealpi,<br />
di diverso aspetto ma non meno attraente delle Alpi. «Vorrei — scrisse Torquato<br />
Taramelli, appassionato studioso della geologia della nostra regione — vorrei possedere<br />
la penna del Manzoni о dello Stoppani, per poter adeguatamente esprimere<br />
tutta la poesia di questo paesaggio prealpino lombardo, così vario da luogo a luogo,<br />
78
così selvaggio e domestico ad un tempo; dove si alternano con squisita delicatezza<br />
le movenze più svariate dei pendii e si succedono le vette e si sovrappongono i piani<br />
di vista e si alternano le ombre e si addensano i boschi e si estendono i pascoli in<br />
quella giusta misura che appaga l’occhio e non lo stanca e che ricrea lo spirito senza<br />
opprimerlo. Per poco che noi vogliamo esaminare le caratteristiche geologiche delle<br />
Prealpi, potremo renderci facilmente ragione di questa varietà di paesaggio e del<br />
carattere peculiare che questo acquista in ciascuna valle о parte di valle; basta che<br />
noi fissiamo nella mente qualche corrispondenza esatta tra la natura del paesaggio<br />
e la qualifica della roccia che lo determina. Così, se si tratta di calcari magnesiaci<br />
о dolomitici, i monti che ne sono formati presentano le vette a guglia con versanti<br />
nudi, con frequenti burroni, con stratificazione assai grandiosa, di colorito cinereo<br />
о giallo chiaro, con frane abbondanti ma coperte in gran parte dalla vegetazione.<br />
Se invece sono montagne di calcari puri о leggermente marnosi, abbiamo quell’altro<br />
aspetto delle montagne a contorni meno aspri, però abbastanza mossi, a larghi<br />
festoni, a lunghi crinali, a valli profonde ma in ogni senso accessibili ed abbastanza<br />
boscose. Se invece si tratta di terreni scistosi о marnosi о arenacei (che però sono<br />
meno frequenti), ecco subito i contorni dei rilievi farsi più morbidi e le valli acquistare<br />
un frastaglio minutissimo e la vegetazione addensarsi ed estendersi i pascoli<br />
più fertili e spesseggiare gli abitati e divenire insomma il paesaggio più familiare<br />
e più ameno, con un aspetto altresì di migliore benessere degli abitanti ».<br />
In realtà la serie delle formazioni prealpine, che abbraccia l’intero Mesozoico,<br />
presenta una giacitura strutturalmente così complicata e una successione di rocce<br />
a tanto diversa erodibilità da imprimere per ciò stesso al paesaggio una notevole<br />
varietà di aspetti anche nell’àmbito di piccoli spazi. Le formazioni più tenere, come<br />
quelle marnose e argillose, danno luogo con frequenza a comode insellature — quali,<br />
ad esempio, la Forcella di Bura (884 m.) tra la vai Brembilla e la vai Taleggio о il<br />
giogo della Presolana (1286 m.) tra la vai Borlezza e la vai di Scalve — mentre<br />
per contro le formazioni compatte s’innalzano in alte groppe di diverso profilo in<br />
ragione della disposizione degli strati. Delle cime, quelle che conferiscono maggior<br />
vivacità al paesaggio sono le dolomitiche, quali, ad esempio, le Grigne, il Resegone,<br />
l’Arera, l’Alben e la Presolana. Anche i versanti montuosi rivelano per lo più la<br />
roccia che li forma, e tipico esempio ne è la dolomia retica che, in fascia continua<br />
di poche decine di metri di potenza, emerge talvolta sul pendio a forma di gradino<br />
aspro e spoglio di vegetazione, come sul versante del monte Crocione che sovrasta<br />
Menaggio sul lago di Como.<br />
Se poi consideriamo i solchi vallivi nel loro sviluppo, la corrispondenza coi terreni<br />
attraversati — ci avverte il Taramelli — è ancora più manifesta. Strette,<br />
impervie, talora orride lungo l’alveo, le valli presentano l’aspetto di chiuse dove<br />
affiorano calcari e dolomie. Tali, ad esempio, il tratto inferiore della vai Taleggio,<br />
la vai Serina, il corso inferiore della vai Brembana e specialmente la bellissima<br />
valle del Dezzo, a monte di Albareto, la quale poscia, a poco a poco, si allarga<br />
per confluire nell’ampia vallata dove serpeggia il fiume Oglio, come un nastro<br />
79
d’argento. Invece dove le nostre valli attraversano terreni molto erodibili, ecco che<br />
il paesaggio si spiana, le valli si allargano, compaiono i villaggi e si espandono i<br />
fertili coltivi e i prati. Tali, ad esempio, le conche tanto amene di Moggio e Barzio in<br />
Valsàssina, della valle Imagna, della vai Brembilla, dell’alta vai Taleggio, di San Giovanni<br />
Bianco, di San Pellegrino e di Zogno, del tratto medio della vai Seriana da<br />
Colzate ad Albino, dell’alta vai Cavallina e, in vai Sabbia, dei dintorni di Preseglie<br />
e di Vestone.<br />
Ma ciò che conferisce spiccata individualità ed anche preziosità al paesaggio<br />
prealpino della <strong>Lombardia</strong> sono le conche dei laghi: il Verbano о lago Maggiore,<br />
il Ceresio о lago di Lugano, il Lario о lago di Como, il Sebino о lago d’Iseo, l’Eridio<br />
о lago d’Idro, il Benaco о lago di Garda. Sono di ampiezza varia e di varia configurazione,<br />
ma nel complesso il loro specchio si stende allungato da nord a sud,<br />
per la maggior parte profondamente incastonato (soprattutto nella parte settentrionale)<br />
tra le montagne e con l’apice meridionale (o gli apici, se vi sono più ramificazioni)<br />
affacciato sulla pianura. Gli azzurri specchi celano depressioni profonde<br />
anche di 200-300 m. sotto il livello del mare, dalla forma di caratteristico navicello,<br />
distinto a sua volta in diverse conche, a varia profondità, separate tra loro da soglie<br />
che talvolta emergono parzialmente a formare isolotti, come quello caratteristico<br />
del Montisela nel lago d’Iseo. Sull’origine di questi bacini si sono affacciate varie<br />
ipotesi: ma per certo essi sono l’impronta più singolare del glacialismo quaternario,<br />
il quale in molti modi rivela la sua importanza nel modellamento del paesaggio<br />
montano e collinare della nostra regione. Senza dubbio i solchi, nei quali oggi<br />
affonda la depressione, non sono opera esclusiva della colata glaciale; essi preesistevano<br />
come antiche valli a loro volta incise da antichi fiumi in corrispondenza, almeno<br />
in parte, di linee di minor resistenza (fratture, dislocazioni, rocce più erodibili, ecc.);<br />
ma è altresì certo che la profonda criptodepressione attuale è opera delle lingue glaciali<br />
che hanno scavato il fondo delle antiche valli nelle quali si sono incanalate. Nè<br />
ciò può destare meraviglia: si sa per certo che le potenti lingue raggiungevano,<br />
nella zona degli attuali laghi, lo spessore di oltre 1500 m. (attestabile dai depositi<br />
di morene abbandonati sui versanti montuosi) ed erano impregnate da un’enorme<br />
congerie di materiale roccioso, che operava sul fondo e ai lati a guisa dei denti di<br />
una lima. In tal modo si produsse quell’insieme di meraviglie che sono i laghi prealpini<br />
di <strong>Lombardia</strong>.<br />
Modesta in estensione al suo affiorare presso le sponde del Verbano, la fascia<br />
delle Prealpi si distende progressivamente in ampiezza e si erge in altezza verso<br />
oriente. Essa è costituita in prevalenza da poderosi contrafforti che, in prosecuzione<br />
di quelli alpini e diretti grosso modo da nord-nordest a sud-sudovest digradano<br />
verso la pianura. Solchi più о meno ampi e profondi li intercalano nella stessa direzione<br />
e offrono possibilità di una molteplice ripartizione in gruppi. Però, a tale scopo<br />
servono soprattutto i laghi prealpini, i cui bacini, prosecuzione delle valli alpine,<br />
allungandosi trasversalmente alla fascia calcarea, permettono una chiara distinzione<br />
in quattro sezioni e precisamente, da occidente a oriente, le Prealpi varesine (tra<br />
80
Rocce levigate e striate<br />
dalla colata glaciale pleistocenica,<br />
impregnata<br />
di morena, in lento e<br />
prolungato movimento<br />
verso valle (vai Reguzzo).<br />
Fot. Nangeroni<br />
i laghi Maggiore e di Lugano), le Prealpi comasche (tra il lago di Lugano e il ramo<br />
sudorientale del lago di Como), le Prealpi lecchesi-bergamasche (tra il ramo sudorientale<br />
del Lario e il lago d’Iseo) e infine le Prealpi bresciane (tra il lago d’Iseo e<br />
il lago di Garda).<br />
Le Prealpi varesine, nel breve spazio che intercorre tra i cristallini del Luinese<br />
e il limite con la collina, oltre a manifestarsi geologicamente assai complesse, presentano<br />
una grande varietà litologica, poiché le formazioni sedimentarie vi affiorano<br />
a frammenti tra i porfidi e i tufi (Permiano). Da ciò deriva una morfologia discretamente<br />
cesellata e per di più frazionata in una serie di blocchi da una complicata rete<br />
di valli a diversa altimetria e sezione, sospese о meno, che s’incrociano anche tra<br />
loro e che evidentemente rappresentano relitti di idrografie di età diversa e di difficile<br />
ricostruzione. Nel complesso si possono distinguere i seguenti gruppi: a occidente<br />
quello della Valtravaglia circoscritto dai solchi della Morgorabbia e del Boesio,<br />
che per la varietà delle formazioni e la disposizione degli strati presenta una morfologia<br />
vivace specialmente nel monte Nudo (1235 m.); a oriente quello compreso<br />
tra i rami meridionali divergenti del lago di Lugano che raggiunge con forme blande<br />
i 1015 m. del monte Pravello; infine al centro quello compreso tra le valli della<br />
Tresa sul lato settentrionale, della Morgorabbia e del Boesio sul lato occidentale,<br />
della Bàvera sul lato orientale, che si presenta come un vasto zoccolo inciso da valli<br />
e vallette quali la Valganna, la vai Marchirolo, la valle di Brinzio, tra cui s’elevano<br />
distinte groppe montuose che nel Campo dei Fiori raggiungono l’altimetria massima<br />
di 1226 metri.<br />
La varietà degli affioramenti litologici che distingue la sezione varesina scompare<br />
nelle Prealpi comasche, nelle quali diviene assolutamente predominante Tarn-<br />
6 — L e Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
81
masso di calcari cinerei (Lias) che determinano una fuga di cime dal morbido profilo.<br />
Vi si distinguono due parti: quella tra il lago di Lugano e il ramo sudoccidentale<br />
del lago di Como, incisa per traverso dall’amena valle Intelvi e dominata dal<br />
monte Generoso (1701 m.) dalle inconsuete asperità, meta di escursioni facilitate<br />
dalla tramvia che da Capolago risale il versante svizzero sino alla sommità; e quella<br />
compresa tra i due rami meridionali del Lario, dominata dal San Primo (1685 m.).<br />
Però, sul lato orientale di questo triangolo montuoso, e precisamente a oriente del<br />
solco della Vallassina che vi s’incide nel senso dell’altezza, affiorano dolomie che<br />
arricchiscono il paesaggio di asperità che ad esse sono precipue, come nei ben noti<br />
Corni di Canzo (1373 m.), meta di numerose comitive domenicali.<br />
Il paesaggio dolomitico domina nei dintorni di Lecco, dove, ben circoscritto tra<br />
il lago e la Valsàssina, s’erge, tormentato e pittoresco, il gruppo delle Grigne (2410 m.)<br />
Prealpi varesine: il laghetto di Ghirla.<br />
Fot. Stefani<br />
82
Fot. Fracchi<br />
I Corni di Ganzo (1373 m.) nelle Prealpi comasche.<br />
che, con il vicino Resegone (1875 m.), formano un quadro tra i più famosi di<br />
tutte le Prealpi, celebrato nella letteratura e persino soffuso di leggenda. Le imponenti<br />
scogliere s’elevano alternando squarci orridamente diruti e morbidi terrazzi a<br />
pascolo; si spogliano, verso le cime, di ogni vegetazione e, nude, innalzano un<br />
ricamo minutamente cesellato di torri, di guglie, di aghi e di pinnacoli, palestra di<br />
audace alpinismo. L ’insieme s’offre anche come mirabile palestra di studio: la<br />
evidenza geologica e strutturale, l’abbondanza di fossili, il risalto morfologico, le<br />
caratteristiche del carsismo, le impronte e i depositi del glacialismo quaternario,<br />
insomma la varietà dei fenomeni riuniti in breve spazio sono stati richiamo di grandi<br />
maestri del passato, primo tra tutti Antonio Stoppani, e richiamo, oggi, di appassionati<br />
delle scienze della natura.<br />
Le Prealpi bergamasche sono costituite da lunghe e ramificate dorsali intercalate<br />
da due valli principali: la vai Brembana e la vai Seriana. Queste hanno i loro bacini<br />
sorgentizi adiacenti l’uno all’altro sul versante meridionale delle Alpi Orobie: quello<br />
brembano tra il pizzo dei Tre Signori e il pizzo del Diavolo di Tenda, quello soriano<br />
tra quest’ultimo e il monte Gleno. I solchi delle due valli, diretti senza notevoli tortuosità<br />
verso la pianura e tra loro grosso modo paralleli, distinguono le Prealpi ber-<br />
83
La dolomitica Grigna meridionale (2184 m.)<br />
con il sottostante pianoro dei Resinelli.<br />
Fot. Fracchi<br />
gamasche in tre parti, che possono essere indicate, secondo la loro posizione, in<br />
occidentale, centrale e orientale. Ciascuna di tali parti risulta costituita da vari gruppi<br />
montuosi distinti tra loro dai solchi delle valli minori confluenti nelle maggiori.<br />
La parte occidentale, costituita dalla dorsale che si stacca dal pizzo dei Tre Signori,<br />
è una zona di ricchi prati e di estesi pascoli soprattutto nella sezione mediana dove<br />
prevalgono i calcari marnosi. Tra la Vaitorta e la Valsàssina s’aderge un gruppo di<br />
belle cime sopra i 2000 m., quali la Corna Grande (2089 m.), il Zuccone di Campelli<br />
(2161 m.), la cima di Piazzo (2057 m.); poi la dorsale digrada irradiando a<br />
ventaglio una serie di contrafforti intercalati da belle valli: la vai Taleggio aperta<br />
e solatia nella parte alta, incisa in angusta forra nella parte inferiore; la vai Brembilla<br />
che con la sua testata a bassa insellatura aperta sulla vai Taleggio (Forcella di<br />
Bura, 884 m.) schiude verso di questa un’agevole via di accesso; la valle ¡magna che<br />
s’origina, come la vai Taleggio, alle falde orientali del Resegone privo, da questo<br />
lato, del suo suggestivo profilo seghettato.<br />
84
La parte centrale delle Prealpi bergamasche, compresa tra il Brembo e il Serio,<br />
è ugualmente costituita da una lunga dorsale che dalle Orobie digrada sino alle colline<br />
su cui sorge Bergamo; è aspra e spoglia nella sezione settentrionale; ricca di<br />
prati e di boschi nella meridionale per l’affiorare di acque sorgive. Vailette confluenti<br />
verso i due solchi maggiori ne incidono i versanti e tra esse particolarmente<br />
notevoli la vai Parina e la vai Serina, dirette al Brembo, e la vai del Riso, la vai Vèrtova<br />
e la valle di Trevasco, dirette al Serio. Esse permettono di distinguere nella<br />
dorsale diversi gruppi: quello del diruto e tormentato pizzo dell’Arerà (1512m .), quello<br />
del monte Alben (2019 m.) e infine quello del Canto Alto (1146 m.) che domina la<br />
piana bergamasca.<br />
La parte orientale delle Prealpi bergamasche, compresa tra le valli Seriana e<br />
Camònica, si distingue dalle precedenti per un maggiore frazionamento e per una<br />
maggiore varietà di forme. Si possono individuare cinque gruppi montuosi distinti<br />
da valli ben disegnate e a volte, come la valle del Dezzo, profondamente incise;<br />
anzitutto quello dominato dall’aspra cima dolomitica della Presolana (2521 m.) limitato,<br />
oltre che dall’alta vai Seriana, dall’alta vai Borlezza e dalla media valle del<br />
Fot. Magri<br />
Il gruppo dolomitico della Presolana (2521 m.)<br />
nelle Prealpi bergamasche.<br />
8S
Dezzo, tra loro agevolmente collegate dall’ameno giogo della Presolana (1286 m.);<br />
poi il gruppo tra la Valcamònica e la valle del Dezzo (nota per la paurosa forra<br />
che caratterizza il suo tronco inferiore), dominato dal pizzo Camino (2492 m.);<br />
ancora il quadrilatero montuoso dominato dal monte Pora (1879 m.) recinto dalle<br />
valli Camònica, di Scalve e Borlezza; infine i due gruppi meridionali tra loro distinti<br />
dalla vai Cavallina che accoglie nel suo grembo il minuscolo e incantevole lago<br />
d’Endine: quello a occidente arcuato in catena digradante dal pizzo Formico (1637 m.)<br />
in morbide ondulazioni sino a confondersi con la collina, quello orientale del monte<br />
Torrezzo (1378 m.) affacciato sul lago d’Iseo.<br />
La sezione bresciana delle Prealpi presenta un aspetto nel complesso disteso e<br />
riposante. Dalla zona interna, non priva di qualche aspro dettaglio, al margine delle<br />
colline, man mano che l’altimetria lentamente decresce, si appiattiscono i profili e<br />
si ammorbidiscono le forme. Due grandi valli dirette verso il piano s’incidono nel<br />
complesso montuoso: la vai Trompia, che sbocca presso Brescia, e la vai Sabbia,<br />
che dal lago d’Idro alla pianura disegna un’ampia S, la cui curvatura inferiore si<br />
accosta a circa quattro chilometri dalla sponda occidentale del lago di Garda. Ne<br />
risultano tre dorsali montuose: quella occidentale tra la bassa Valcamònica con il<br />
lago d’Iseo e la vai Trompia, quella mediana tra la vai Trompia e la vai Sabbia,<br />
quella infine tra la vai Sabbia e il lago di Garda. La prima si sviluppa in continuità<br />
dal passo di Croce Domini (1893 m.) fino alla collina sebina con una fuga di cime<br />
oscillanti sui 2000 m. tra monte Colombine (2215 m.) e monte Guglielmo (1949 m.);<br />
Fot. Magnolini<br />
86<br />
Il pizzo Camino (2492 m.) tra<br />
la vai di Scalve e la Valcamòmca.
Piramidi di terra, derivate<br />
dalla erosione<br />
dei depositi morenici,<br />
nell’alta valle di Zone<br />
(Prealpi bresciane).<br />
Fot. Nangeroni<br />
la seconda, culminante nella caratteristica Corna Biacca (2006 m.) scolpita nel calcare<br />
bianco, ha numerose e basse insellature che facilitano le comunicazioni tra le<br />
valli adiacenti; la terza, s’immerge nel lago di Garda scoscesa e pittoresca, ma presenta<br />
cime di morbide forme e di modeste altimetrie (monte Caplone, 1977 m.)<br />
verso cui risalgono aspre e ramificate valli, quali, ad es., la valle Toscolano-Vestine<br />
e le valli di Tremòsine, che si aprono in alto in ampie conche.<br />
Particolarmente esteso ed intenso nelle Prealpi bresciane è il fenomeno carsico<br />
di superficie, che tuttavia appare, sempre notevolmente interessante, anche in altre<br />
parti della <strong>Lombardia</strong>. Singolarmente tormentato è l’altopiano di Serie (chiamato<br />
localmente Cariàdeghe), tra il Chiese e il Mella, dove le doline hanno una densità<br />
pari a quella delle zone più tipiche del Carso.<br />
La zona della collina.<br />
Alle falde delle Prealpi si stende, pur senza una netta continuità, una zona di<br />
morbide e ridenti colline. Essa si espande particolarmente allo sbocco dei grandi<br />
solchi di provenienza alpina e si riduce invece allo sbocco delle valli propriamente<br />
prealpine. È quindi assai ampia tra il Ticino e l’Adda, attorno all’apice meridionale<br />
87
Fot. Sanelli<br />
Grandiose concrezioni nel Buco della Volpe,<br />
profonda cavità delle Prealpi comasche.<br />
del lago d’Iseo e al margine meridionale<br />
del lago di Garda; si riduce e si fa saltuaria<br />
allo sbocco della vai Brembana, della<br />
vai Seriana e della vai Trompia.<br />
Ciò è facilmente spiegabile con l’origine<br />
morenica della maggior parte dell’area collinare;<br />
è quindi ovvio che questa si espanda<br />
là dove le fronti dei grandi ghiacciai quaternari,<br />
giungendo alla pianura, si aprivano<br />
in grandi ventagli che abbandonavano il<br />
materiale morenico in grandi cumuli, tra<br />
cui tutt’al più qua e là emergono i dossi<br />
di preesistenti colline rocciose; è del pari<br />
ovvio che la stessa area collinare si riduca<br />
là dove non si ebbero manifestazioni glaciali<br />
e dove quindi vi sono esclusivamente<br />
colline di roccia in posto, talvolta isolate e<br />
con netto distacco dalle falde alpine, come<br />
le colline di San Vigilio e di Albano presso<br />
Bergamo, del Montórfano di Rovato, di<br />
Castenèdolo presso Brescia. Questi colli<br />
sono, come gli altri, coperti da coltivi e<br />
da fustaie; nel Bergamasco e nel Bresciano<br />
si designano spesso con il nome di ronchi,<br />
che par voglia indicare pendii disboscati<br />
sin dal periodo medioevale e trasformati in<br />
vigneti. Ma non tutte le colline rocciose<br />
sono della stessa natura e di materiale inutilizzabile:<br />
alcune sono costituite da lembi affioranti di calcari marnosi, come ad<br />
esempio quelle di Merone, utilizzati per cementi; altre di calcari, come quelle di<br />
Ternate e del Montórfano comasco, adatti per calce о per pietrisco; altre di arenarie,<br />
usate, come a Malnate, anche come pietra da costruzione; altre di conglomerati,<br />
tra cui noti quelli deltizi di Sirone, utilizzati per pietre da molere; altre<br />
infine di argille, dove marine e ricche di fossili, come a Folla d’Induno, dove<br />
lacustri, come nel Montórfano comasco, utilizzate per mattoni.<br />
Le colline moreniche presentano, spesso assai chiaramente, una disposizione che<br />
rispecchia assai fedelmente l’ampiezza e la forma dei grandi ventagli delle antiche<br />
fronti glaciali nelle loro successive fasi; infatti si presentano in serie arcuate con<br />
la concavità rivolta verso la montagna e ordinatamente concentriche allo sbocco<br />
delle grandi vallate sì da richiamare l’immagine dell’anfiteatro. Notevole è il distendersi<br />
ininterrotto dei complessi morenici della <strong>Lombardia</strong> occidentale dove si affiancano,<br />
a guisa di ampi festoni, l’anfiteatro ticinese del Verbano e gli anfiteatri abduani<br />
88
dei rami del Ceresio, del lago di Como, della Vallassina e del lago di Lecco, il cui<br />
arco meridionale si protende sin presso il parallelo di Merate. Separatamente si<br />
distendono l’anfiteatro del Sebino, che si apre, meno ampio dei precedenti ma più<br />
chiaramente delineato, tra Adro e Provaglio a formare la Franciacorta e l’anfiteatro<br />
del Garda che amplissimo giunge sino a Fonato, a Solferino, a Volta e, in territorio<br />
veneto, a Custoza e a Pastrengo.<br />
Non tutte le colline moreniche sono relitti di una medesima glaciazione. Gom’è<br />
noto, il glacialismo quaternario ebbe quattro manifestazioni e, di esse, almeno tre<br />
sono rappresentate in ogni anfiteatro morenico; la quarta, più antica (Gùnz), è<br />
nascosta sotto la poderosa coltre di alluvioni grossolane e cementate, dette localmente<br />
ceppo, che appare lungo l’incisione dei solchi fluviali sino all’Oglio e che fa<br />
quasi da piattaforma portante delle morene delle successive glaciazioni. La meno<br />
recente di queste (Mindel) è rappresentata dall’arco più esterno di ciascun anfiteatro<br />
e si distingue per la profonda alterazione del materiale, decalcificato, ben poco<br />
ferace e di un bel color rosso, detto ferretto; ne rimangono numerosi lembi a morbidissime<br />
ondulazioni, isolati dall’erosione torrentizia posteriore; sono spesso a brughiera<br />
e vengono chiamati groane (generalizzando il nome della vera Groana, di<br />
identica origine e natura, situata tra Seveso e Saronno) о baragge. Delle due più<br />
recenti glaciazioni (Riss e Würm) sono le colline della parte interna di ciascun<br />
anfiteatro; si tratta di depositi di materiale che in genere conservano un notevole<br />
Fot. Fracchi<br />
La tormentata superficie carsica nelle dolomie della Grigna settentrionale.<br />
89
L ’espansione massima dei ghiacciai della <strong>Lombardia</strong> nel Pleistocene.<br />
Da G. Nangeroni<br />
stato di conservazione, talvolta disposti in belle e rilevanti cerehie, ricchi di massi<br />
erratici, localmente detti trovanti. In questa zona, incastonati nelle cerehie moreniche,<br />
si trovano i laghetti di Biandronno, di Varese, di Monate e di Comabbio nell’anfiteatro<br />
ticinese, di Montòrfano, di Alserio, di Pusiano, di Annone nell’anfiteatro<br />
abduano, che introducono una nota di pacata bellezza nel paesaggio collinare.<br />
La pianura.<br />
Al margine meridionale dei colli ha inizio la bella e fertile pianura, dovuta al<br />
colmamento alluvionale del vasto golfo di mare pliocenico, i cui depositi più profondi<br />
si trovano in corrispondenza di una linea che va da Magenta a Mantova a<br />
circa 300 m. sotto il livello attuale della pianura. Questa è quindi strutturalmente<br />
costituita da materiali trascinati giù dalle Alpi ad opera di antichi fiumi, i quali,<br />
perdendo via via il loro impeto, abbandonavano dapprima gli elementi più grossolani,<br />
poi quelli medi e infine quelli più minuti. Anche in relazione a questo fatto.<br />
90
Fot. Brunner<br />
L ’apice meridionale del lago di Como con la città di Como, raccolta al piede delle estreme propaggini<br />
calcaree delle Prealpi (a sinistra) e protetta dai colli conglomeratici del Baradello (a destra).<br />
Sullo sfondo si delineano le basse colline moreniche (formate dai depositi della fronte del ghiacciaio<br />
oligocenico) spesso allungate in ampi festoni (messi in risalto da una più densa vegetazione).<br />
la pianura, pur conservando Tuniformitá morfologica, non è affatto monotona, come<br />
si suole ritenere, ma sensibilmente diversa da zona a zona. Anzitutto essa, dal margine<br />
della collina al corso del Po, discende come un piano inclinato a pendenza media<br />
di circa il 3°/oo, poco più nell’alta pianura, poco meno nella bassa.<br />
Alta e bassa pianura sono espressioni che ricorrono normalmente anche in luogo<br />
e indicano due diverse zone: quella settentrionale altimetricamente più elevata (all’incirca<br />
al di sopra dell’isoipsa dei n o m.) e costituita in prevalenza da alluvioni<br />
grossolane, quindi permeabili, e quella meridionale, altimetricamente meno elevata<br />
(all’incirca al di sotto dell’isoipsa dei n o m.) e costituita da alluvioni minute,<br />
quindi impermeabili. Ne consegue che, per la maggiore о minore permeabilità dei<br />
terreni, le due parti sono differenziate tra loro da una diversa abbondanza di acque,<br />
per cui la più elevata si indica anche come pianura asciutta e la meno elevata come<br />
pianura irrigua.<br />
L ’alta pianura non è perfettamente piatta ma spesso terrazzata. Infatti, dal margine<br />
meridionale della zona collinare si allungano verso sud i residui di quello che<br />
fu un antico ripiano costituito dai depositi alluvionali di materiale ciottoloso {Diluvium<br />
antico). Tale ripiano, dopo la sua formazione, venne frazionato dai corsi d’acqua<br />
che, discendendo dalla montagna al Po, rinvigoriti nella loro azione erosiva da un<br />
91
Veduta aerea sulla « bassa » lombarda ai margini dell’Adda<br />
in prossimità di Cassano.<br />
Fot. Fotocielo<br />
generale sollevamento della zona, incassarono profondamente il loro letto nelle loro<br />
stesse alluvioni, determinando un complesso terrazzamento laterale. Ora i lembi<br />
residui dell’antico ripiano appaiono a guisa di lingue, più о meno appuntite, che<br />
dalla zona collinare si allungano verso sud con i margini laterali segnati, a volte<br />
con evidenza, da scarpate di una decina di metri e anche più. Il materiale di rivestimento<br />
dei pianalti è per lo più costituito dal ferretto, derivato dall’alterazione<br />
delle alluvioni di cui sono formati (o, in parte, anche dal morenico di antica deposizione<br />
mindeliana), sicché, di conseguenza, vi è un quasi impercettile trapasso tra<br />
la collina e la pianura; tanto più che su queste aree, qua e là si estende, in prosecuzione<br />
dalla collina ferrettizata, il dominio della brughiera.<br />
92
Altimetricamente sottostante a tali ripiani alti e inserita tra essi, ecco, infine,<br />
la più tipica e vera alta pianura anch’essa, in parte, terrazzata in vasti gradini verso<br />
i solchi fluviali, incassati, nella parte occidentale della pianura, di diverse decine<br />
di metri, a volte anche a guisa di canons.<br />
Insensibilmente l’alta pianura sfuma nella bassa; ma a distinguerle s’interpone<br />
il limite settentrionale delle resorgive. Dalla diversa distribuzione del materiale alluvionale<br />
nella pianura lombarda, cui s’è accennato (simile del resto a quello nella<br />
pianura piemontese e veneta), deriva infatti un diverso comportamento idrico delle<br />
acque meteoriche e fluviali. Nell’alta pianura, ad alluvioni grossolane e permeabili,<br />
esse vengono parzialmente assorbite dal terreno e formano una falda freatica che<br />
scorre sulle sottostanti argille impermeabili. Dove le acque di tale falda, scorrendo<br />
per naturale pendenza verso il solco padano, incontrano la soglia dei terreni impermeabili<br />
della bassa pianura, per effetto del rigurgito provocato dalla diminuzione<br />
di porosità, sgorgano spontaneamente in superficie con una serie di polle sorgentizie,<br />
che, nella parlata locale, vengono chiamate fontanili, e concorrono, con le acque<br />
derivate dai fiumi, aU’irrigazione e in particolare all’irrigazione iemale dei prati<br />
marcitori.<br />
La bassa, quindi, oltre che dall’altimetria, risulta caratterizzata dall’abbondanza<br />
di acque che, opportunamente sistemate in canali e rogge, scolano lentamente verso<br />
il Po e accentrano in ogni parte il grado di fertilità del terreno. A ciò naturalmente<br />
giova l’uniformità della distesa, nella quale, unica e isolata, emerge soltanto la collina<br />
di San Colombano al Lambro (144 m.) costituita da un modesto ma interessante<br />
affioramento di formazioni di marne, arenarie e argille mioceniche.<br />
Fot. Sef<br />
La collina di San Colombano al Lambro.<br />
93
Le dorsali appenniniche dell’Oltrepò pavese<br />
con la valle della Stàffora da Monte Pénice.<br />
Fot. Fracchi<br />
L ’Oltrepò pavese.<br />
Un lembo distinto, dal punto di vista fisico, costituisce l’Oltrepò pavese, triangolo<br />
di territorio lombardo che dal corso del Po risale verso l’Appennino. In esso<br />
la pianura alluvionale si distende in stretta fascia limitata tra il corso del Po e la<br />
spezzata che corre tra Rivazzano, Casteggio, Stradella e Bonesco; poi succedono<br />
ondulazioni collinari modellate assai morbidamente nelle arenarie, dove argillose,<br />
dove gessose, del Miocene, e nelle arenarie dell’Oligocene, tutte notevolmente erodibili.<br />
Dalle colline si rilevano le groppe montuose a blandi profili scavate in parte<br />
nei calcari marnosi eocenici, che formano pure il monte Lèsima (1724 m.), alternati<br />
con scisti argillosi e, in misura minore, con serpentini di intenso colore verde о<br />
addirittura nerastri, che formano i groppi. Tutto il complesso montuoso e collinare<br />
è intagliato da torrenti, tra i quali particolarmente notevole è la Stàffora.<br />
94
C apitolo Q u arto<br />
LE ACQUE<br />
Caratteristiche generali.<br />
La <strong>Lombardia</strong> è una regione tra le più dotate e forse la più ricca di acque superficiali<br />
dell’Italia. Ciò dipende da molteplici cause ed essenzialmente, com’è ovvio,<br />
dalle precipitazioni atmosferiche, dalla loro quantità e distribuzione nel tempo. Ma<br />
poiché sotto tale aspetto la <strong>Lombardia</strong> non gode di condizioni notevolmente diverse<br />
da quelle delle regioni adiacenti, Piemonte e Venezie, bisogna aggiungere che a contribuire<br />
alla ricchezza idrica della <strong>Lombardia</strong> intervengono la struttura, la litologia,<br />
la morfologia e l’altimetria, le quali possono influire in diversi modi, ma, per quel<br />
che riguarda la <strong>Lombardia</strong>, influiscono soprattutto nel ritardare (in quel gran ciclo<br />
dell’acqua che viene dal mare e al mare ritorna) l’afflusso delle acque al mare. Si<br />
potrebbero citare, come esempio caratteristico, le nevi e soprattutto i ghiacciai nell’ambito<br />
alpino; ma non sono questi gli aspetti più tipici della <strong>Lombardia</strong>, superata<br />
dal Piemonte, quanto i grandi e numerosi bacini lacustri, serbatoi che costituiscono<br />
una notevole riserva idrica, e i fontanili, le tiepide sorgenti di pianura che danno<br />
un contributo prezioso all’irrigazione della bassa pianura.<br />
La <strong>Lombardia</strong>, sotto l’aspetto idrico, appare quindi una regione privilegiata:<br />
essa annovera sulle Alpi oltre duecento ghiacciai (senza contare la parte svizzera),<br />
che, per quanto di modeste dimensioni, complessivamente costituiscono una notevole<br />
riserva che si arricchisce nell’inverno per emungere nell’estate; essa ha laghetti alpini,<br />
in genere minuscoli, ma il cui bacino ha spesso favorito la costruzione di sbarramenti<br />
per ingigantire la loro capacità idrica; essa ha laghi di ampio e profondo bacino,<br />
scaglionati nella fascia prealpina con funzioni di provvidi serbatoi naturali, nei quali<br />
le acque fluviali, torbide e fredde, decantano e intiepidiscono; essa ha ricchezza di<br />
95
Le fronti dei ghiacciai<br />
di Fellaria (orientale<br />
e occidentale),<br />
nel gruppo del Bernina,<br />
quali ancora si<br />
presentavano nel<br />
1928.<br />
Fot. Nangeron<br />
Fot. Riva<br />
Le fronti dei medesimi<br />
ghiacciai di Fellaria<br />
nel 1953-
sorgenti perenni in montagna e di resorgive nel piano; essa, infine, ha fiumi che<br />
scorrono attraverso tutta la regione e, pur essendo tutti tributari del Po, sono tra<br />
i maggiori dell’Italia per portata e i meno capricciosi per regime. Naturalmente non<br />
ogni lembo del territorio è ugualmente favorito, ma senza dubbio la <strong>Lombardia</strong> deve<br />
in parte anche alla disponibilità complessiva di acqua la sua attuale prosperità.<br />
I ghiacciai.<br />
Il limite medio delle nevi persistenti sul versante lombardo oscilla intorno<br />
ai 2800 m. sul mare, con variazioni da zona a zona: 3000 circa nel gruppo del<br />
Gevedale, 2950 nella media Valtellina, 2850 neH’Adamello, 2700 nelle Orobie. La<br />
superficie al di sopra del limite altimetrico medio, escludendo il territorio svizzero,<br />
Fot, Fracchi<br />
Fronte del ghiacciaio del Forno (settembre 1951).<br />
Il tratteggio a sinistra indica il livello del ghiacciaio nello scorso secolo.<br />
7 — Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
97
è modesta, approssimativamente Г 1,5% del territorio lombardo, ma in essa si formano<br />
gli accumuli di neve che danno luogo ai ghiacciai (nella <strong>Lombardia</strong> orientale,<br />
all’uso delle Alpi orientali, chiamati anche vedrette), quei candidi drappeggi dell’alta<br />
montagna, debordanti anche al di sotto del limite delle nevi persistenti, che<br />
conferiscono al paesaggio un aspetto talmente pittoresco che spesso all’estasiato visitatore<br />
fa obliare di quanta utilità essi siano nel quadro dell’economia moderna. Come<br />
è noto, l’area glacializzata sul versante meridionale delle Alpi è minore che sul versante<br />
opposto e attualmente, purtroppo, si è in un periodo di rilevante regresso<br />
generale, ossia la massa di neve invernale che alimenta i ghiacciai non è tale da<br />
compensare la fusione estiva dei ghiacciai stessi, per cui diminuiscono di volume<br />
e di superficie; e ciò è riscontrabile anche in <strong>Lombardia</strong>. Infatti solo trent’anni fa<br />
(decennio 1920-30) l’area glacializzata propriamente lombarda (ossia esclusa la parte<br />
ticinese) era calcolata in circa 150 kmq. e distribuita tra 239 ghiacciai; per contro<br />
una recente indagine di un eminente glaciólogo, il Nangeroni, ha accertato che di<br />
essi, nel 1953, ben 66 tra i minori, pari al 28%, erano da cancellarsi dal novero,<br />
alcuni ridotti ormai ad esili placche, altri addirittura scomparsi del tutto. In con-<br />
La vedretta di Scerscen inferiore nel gruppo del Bernina (settembre 1938).<br />
Di sfondo il Piz Tramoggia (3441 m.).<br />
Fot. Fracchi<br />
98
seguenza del contrarsi della superficie dei ghiacciai (calcolato alla fronte di un<br />
valore medio generale di 9 m. all’anno), si è anche rilevato che colate precedentemente<br />
unitarie si erano sdoppiate per emersione di setti rocciosi di divisione,<br />
sicché si dovevano conteggiare 18 nuovi piccoli ghiacciai. Di conseguenza il numero<br />
dei ghiacciai attuali risulta di 19 1, con una riduzione della superficie molto varia<br />
dall’uno all’altro, ma probabilmente del 20% di media rispetto al 1920-30; ossia<br />
l’area glacializzata attuale si aggira attorno ai 120 chilometri quadrati.<br />
L ’area glacializzata è esclusiva della zona alpina e si espande in particolare nei<br />
gruppi del Cevedale e del Bernina; meno notevole, ma non trascurabile è quella<br />
dell’Adamello. Nel complesso si hanno 39 ghiacciai nel gruppo del Cevedale, 33 nel<br />
gruppo del Bernina-Disgrazia (versante di vai Malenco e di vai Codera) e 25 nel<br />
gruppo del Badile-Disgrazia (versante di vai Màsino e di vai Codera), 27 nel gruppo<br />
dell’Adamello e, infine, 13 nella zona dello Spinga, 20 nei gruppi Dosdè e Piazzi,<br />
13 nel Livignasco e 21 nelle Orobie, nelle quali si è avuto il più alto numero di<br />
ghiacciai scomparsi (20) nel volgere di un solo trentennio.<br />
In genere i ghiacciai lombardi sono piccoli, ma non ne mancano alcuni estesi;<br />
appartiene anzi alla <strong>Lombardia</strong> il massimo ghiacciaio delle Alpi italiane, il ghiacciaio<br />
del Forno, nel gruppo del Cevedale, che misura circa 12,7 kmq. e si allunga per<br />
5,5 km. discendendo con la sua fronte a 2200 m. sul mare. Notevoli sono anche il<br />
ghiacciaio del Mandrone, nel gruppo dell’Adamello (kmq. 12), i due ghiacciai<br />
di Scerscen (kmq. 7 e 5), che sino al 1940 congiungevano le loro fronti, e i due<br />
di Fellaria (kmq. 8 e 6), pure separatisi di recente, nel gruppo del Bernina.<br />
I laghi.<br />
Attribuiti per lo più all’opera di modellamento di un fenomeno glaciale di ben<br />
più vaste proporzioni di quello attuale, ossia all’espansione glaciale avvenuta agli<br />
albori del Quaternario, sono i grandi laghi prealpini che costituiscono una delle<br />
caratteristiche idrologiche più peculiari della <strong>Lombardia</strong>. I maggiori si allungano<br />
per una sessantina di chilometri e anche più, a guisa di tortuosi budelli, tra la zona<br />
alpina e la zona collinare attraversando tutta la fascia delle Prealpi ; sono il lago Maggiore,<br />
che fa da limite tra la <strong>Lombardia</strong> e il Piemonte e il cui apice settentrionale<br />
appartiene al Canton Ticino (Svizzera), il lago di Como e il lago di Garda che fa<br />
da limite tra la <strong>Lombardia</strong> e il Veneto e il cui apice settentrionale rientra nel Trentino;<br />
i minori sono il lago di Lugano, il cui tortuoso sviluppo s’annoda al confine<br />
politico con la Svizzera, il lago d’Iseo e il lago d’Idro. Va annoverato tra i laghi<br />
prealpini anche il piccolo lago d’Endine, intravallivo.<br />
Il lago Maggiore о Verbano si allunga al margine occidentale della <strong>Lombardia</strong><br />
con direzione complessiva da nordest a sudovest, snodandosi dalle poderose dorsali<br />
99
La punta d’Ispra sulla sponda lombarda del lago Maggiore.<br />
Fot. Sef<br />
meridionali delle Lepontine sino alle colline dell’anfiteatro ticinese. Tra le due bocche<br />
del Ticino come immissario a nord e come emissario a sud intercorrono poco più<br />
di 50 km. in linea d’aria e 66 considerando le tortuosità, tuttavia modeste, del suo<br />
sviluppo. La larghezza oscilla da 3 a 4 chilometri e mezzo (Cànnero Riviera-Germignaga)<br />
e presenta una sola tozza ramificazione, il golfo Borromeo, sulla costa piemontese,<br />
dando luogo alle prospettive più pittoresche nelle quali s’inquadrano le<br />
isole Borromee. Il suo specchio, a un livello medio di 194 m. sul mare, si estende<br />
per 212 kmq. di superficie (sino a 219 nelle massime piene) e risulta quindi, per<br />
ampiezza, il secondo dei laghi italiani, preceduto solo dal lago di Garda. La sua<br />
conca a navicello, nella quale sbocca a guisa di valle sospesa la conca secondaria<br />
del golfo Borromeo, raggiunge la massima profondità di 372 m. ; 178 m., quindi,<br />
sotto il livello del mare. La sponda lombarda del lago è altimetricamente meno<br />
elevata di quella piemontese; questa, di forme più aspre, è scolpita per lo più in<br />
masse cristalline (micascisti, gneiss e graniti), quella invece, tra Luino e Angera, in<br />
formazioni calcaree mesozoiche, il che fa presumere che il lago si allunghi lungo<br />
l’asse di una grandiosa frattura. Nella parte meridionale del lago, poi, sulla sponda<br />
lombarda la montagna cede il posto alla collina offrendo più spaziosi e riposanti<br />
orizzonti.<br />
Il bacino imbrifero del lago è molto esteso: va dal monte Rosa all’Adula. Oltre<br />
al Ticino e ai tributari della sponda piemontese (il Verzasca, il Maggia, che forma<br />
l’amplissimo delta su cui sorge Locamo, e il Toce), scaricano le loro acque nel Verbano<br />
100<br />
«U 9tu<br />
Û<br />
s<br />
-A
anche il lago di Lugano, per mezzo del fiume Tresa, e i laghi varesini di Varese, di<br />
Monate, di Comabbio, di Ganna e di Ghirla. I mesi di maggior afflusso di acque sono<br />
l’aprile e il maggio, l’ottobre e il novembre; allora il livello del lago Maggiore aumenta,<br />
come media, di un metro e mezzo sulla magra invernale, eccezionalmente di diversi<br />
metri. Nell’ottobre 1868 si ebbe la piena maggiore degli ultimi cento anni e si registrarono<br />
ben 7 m. sopra il livello di magra.<br />
Il lago di Lugano о Geresio è il più tortuoso dei laghi lombardi. Si snoda tutto<br />
nell’àmbito delle Prealpi per una lunghezza complessiva di 35 chilometri. La sua<br />
conca può essere distinta in due parti dalle morene di Melide, che ne rompono la<br />
continuità e, quasi affiorando, hanno permesso, in prossimità deìVexclave di Campione,<br />
la costruzione di un ponte tra le opposte sponde, sul quale transitano la<br />
ferrovia e la strada del Gottardo. La parte tra Porlezza e Melide, per metà italiana<br />
e per metà svizzera, si sviluppa da nord-nordest a sud-sudovest tra sponde piuttosto<br />
ripide e distanti tra loro poco più poco meno di un migliaio di metri, ad<br />
esclusione del tratto, senza dubbio il più pittoresco del lago, in cui s’apre Tinse-<br />
Fot. Ed. Beringer e Pampaluchi<br />
Il lago di Lugano da monte Brè verso sud, con il ponte di Melide<br />
e i rami di Capolago (a sinistra) e di Porto Ceresio (a destra).<br />
lOI
Il lago di Lugano a Porto Ceresio.<br />
Fot. Stefani<br />
natura di Lugano, ampia 3 km. e a morfologia blanda ma frazionata. La parte<br />
oltre Melide volge a uncino, irradiando successivamente lungo il margine meridionale<br />
le piccole ramificazioni di Capolago (in territorio svizzero). Porto Ceresio<br />
(in territorio italiano) e Ponte Tresa (località di frontiera tra Italia e Svizzera) da<br />
cui diparte l’emissario Tresa che, in prossimità di Luino, sbocca nel lago Maggiore.<br />
Lo specchio del Ceresio, a livello medio di 271 m. sul mare, misura esattamente<br />
48,90 kmq. di superficie, dei quali 18,04 appartengono all’Italia e 30,86 alla Svizzera.<br />
Anche delle sponde (km. 93) la parte maggiore fa parte della Svizzera (km. 58.60),<br />
la minore dell’Italia (km. 34,40). A differenza degli altri laghi il Ceresio non ha<br />
immissari provenienti da zone notevolmente innevate e glacializzate delle Alpi; il<br />
suo bacino è molto limitato e costituito da modesti torrenti; ciononostante le piene,<br />
normalmente primaverili e autunnali, con massimi in quest’ultima stagione, sono<br />
notevoli e talvolta anche improvvise perchè la regione imbrifera è caratterizzata da<br />
piogge abbondanti e spesso violente.<br />
102
Fot. Fotocielo<br />
La parte centrale del lago di Como. In primo piano l’isola Comacina (con la chiesetta di San Giovanni); essa, nel<br />
1917, venne lasciata in eredità ad Alberto I, re dei Belgi, che ne fece dono al Governo italiano, il quale la<br />
destinò all’Accademia di Belle Arti di Milano per farne residenza di artisti. Nella parte mediana dell’illustrazione,<br />
gli abitati d’isola, di Campo e di Lenno, questi ultimi al piede del dosso dell’Avedo о di Balbianello, che forma<br />
un pittoresco promontorio sulla cui estremità s’intravede Villa Arconati, in cui fu ospite Silvio Pellico alla vigilia<br />
del suo arresto. Sullo sfondo la punta di Bellagio, che con la sua prominenza segna l’inizio dei due rami meridionali<br />
del Lario.
L ’alto Lario da San Vito (Cremia) verso Piona,<br />
di cui è visibile il promontorio.<br />
Fot. Stefani<br />
Il lago di Como о Lario si stende dalle Alpi Retiche sino al margine della collina<br />
attraversando, con la parte meridionale, tutta la fascia delle Prealpi, dove presenta'<br />
una grandiosa biforcazione, quant’altre mai interessante sotto diversi aspetti<br />
e soprattutto rispetto alla sua incerta genesi. Nel complesso il suo specchio in planimetria<br />
presenta un disegno che suol essere paragonato, per la forma, a una Y rovesciata.<br />
La bozza di Bellagio, protesa come una minuscola penisola nel centro lago,<br />
segna il distacco dei due rami che, divergendo, si distanziano progressivamente l’uno<br />
dall’altro, sicché i due apici, sulle cui sponde sorgono Como e Lecco, distano tra<br />
loro 24 km. in linea d’aria. Localmente per indicare le diverse parti si usano diverse<br />
denominazioni: il ramo settentrionale si designa come ramo о lago di Còlico, oppure<br />
anche come « alto lago » ; il ramo presso la cui estremità si trova Lecco come ramo о<br />
104
lago di Lecco; il ramo al cui apice si trova Como come ramo о lago di Como p. d .;<br />
infine, la parte mediana di divergenza dei diversi rami come « centro lago ». Di<br />
tutte le parti, più spettacolare è quella del « centro lago » nella quale si specchiano<br />
le famose località turistiche di Bellagio, Cadenabbia, Tremezzo, Menaggio, Varenna<br />
e altre minori. Il lago di Còlico, benché si incunei nella zona alpina, è dei tre rami<br />
il più aperto e ridente poiché i versanti che lo recingono (scolpiti nei micascisti)<br />
sono di forme per lo più assai morbide; al suo apice settentrionale sfociano Г Adda,<br />
alle cui alluvioni si deve la formazione del vasto Pian di Spagna, e la Mera, la quale<br />
prima di confluire nel Lario decanta le sue acque nel piccolo lago di Mezzola,<br />
l’incantevole specchio che rappresenta un residuo dell’antico apice settentrionale<br />
del Lario, reciso dal corpo maggiore per il formarsi del Pian di Spagna. Il lago di<br />
Como propriamente detto si snoda a budello tra alti e ripidi versanti che si riflettono<br />
nelle acque conferendo ad esse cupi riflessi da fiordo. Il lago di Lecco é delle<br />
Fot. Stefani<br />
Il ramo comasco del Lario.<br />
Sullo sfondo, lo sbocco della valle Intelvi.<br />
N \ -Ч 1 \ Î’<br />
\. l- \ ' \ l t ^<br />
■ ì: Ï .> f -<br />
Í i г I ib i. i<br />
* > l '<br />
■ f - ir ìd -<br />
' ш т м<br />
l-SJ<br />
105
Il lago di Olginate.<br />
Sullo sfondo, la cresta seghettata del Resegone.<br />
Fot. Stefani<br />
diverse parti la più severa per l’affiorare lungo le sponde delle formazioni dolomitiche<br />
che denunciano sin dalla base, con gli scoscesi versanti rotti da nudi strapiombi<br />
e da gole profonde, le asprezze delle incombenti Grigne. A ll’apice meridionale il<br />
lago si restringe per ritornar fiume, a ciò costretto dalle conoidi del Gerenzone, del<br />
Caldone e del Bione (su cui sorge Lecco) ; ma immediatamente a valle, uno di seguito<br />
all’altro e tra loro ugualmente separati da conoidi, si espandono gli specchi dei laghi<br />
di Garlate e di Olginate, i quali, avanti che i grandi ventagli alluvionali ne determinassero<br />
le separazione, costituivano certo parte integrante del lago di Lecco.<br />
Lo specchio attuale dall’apice settentrionale (Gera) a Como, ossia sull’asse di<br />
maggior sviluppo, misura in linea d’aria 46 km. che diventano una cinquantina<br />
seguendo la linea mediana del bacino. La larghezza massima è di 4300 m. nel<br />
centro lago, la minima è di 650 m. tra Carenno e Torriggia nel ramo comasco. La<br />
superficie, al livello medio di 199 m. sul mare, è di 146 kmq., sicché il Lario si<br />
pone per ampiezza al terzo posto tra i laghi italiani, dopo il Benaco e il Verbano.<br />
La conca a navicello del vasto e complesso bacino è distinta sul fondo da modeste<br />
soglie, alcune, come quella di Dervio, di Mandello e di Abbadia, certamente alluvionali,<br />
altre forse moreniche о rocciose. La parte più profonda è quella del ramo<br />
di Como dove, di fronte ad Argegno, si raggiungono i 410 m., dei quali 2 1 1 sotto<br />
il livello marino.<br />
Il bacino imbrifero del Lario è meno esteso di quello del Verbano, ma comunque<br />
assai ricco di acque; oltre all’Adda e alla Mera, che sono di gran lunga i maggiori,<br />
106
sfociano nel lago una trentina di corsi minori (tra cui il Liro, l’Albano, il Sanagra<br />
e il Telo d’Intel vi sulla sponda occidentale, il Varrone e il Pioverna su quella<br />
orientale); il loro contributo di acque nelle stagioni di maggiori precipitazioni,<br />
la primavera e l’autunno, diventa notevole. Allora il livello del lago cresce di<br />
alcuni metri, talvolta assai rapidamente, e non di rado le acque invadono la parte<br />
più bassa della città di Como. A tal proposito sul portale del fianco sinistro del<br />
Duomo, tra i motivi ornamentali scolpiti nel marmo, vi è una rana (e il Portale è<br />
detto appunto della Rana) che, secondo la tradizione, indica l’altezza dove sarebbe<br />
giunto il livello della massima piena.<br />
Il lago d’Iseo о Sebino si stende da nordest a sudovest a guisa di una tozza S,<br />
nell’ambito della zona prealpina; solo l’estremità meridionale s’incunea tra le colline<br />
dell’anfiteatro morenico. L ’Oglio vi sfocia all’apice settentrionale ed esce da<br />
quello meridionale; tra i due estremi intercorrono 21 km. in linea d’aria e 25<br />
seguendo la linea mediana. In larghezza lo specchio oscilla in media sui 2 chilometri<br />
e mezzo con un massimo di 4 e mezzo nella parte mediana. Per estensione<br />
è il quarto dei laghi prealpini (e il sesto dei laghi italiani), misurando, al livello<br />
medio di 186 m. sul mare, 65,3 kmq. di superficie. La sua conca a navicello nella<br />
parte mediana si sdoppia e tra le due parti emerge il pittoresco dosso di Montìsola;<br />
la conca occidentale, più profonda, scende a 251 m., dei quali 65 sotto il livello<br />
Fot. Magnolini<br />
Il lago d’Iseo con il Montìsola.<br />
107
Il lago di Garda,<br />
con risoletta omonima, in prossimità del golfo di Salò.<br />
Fot. Fotocielo<br />
marino. A nord e a sud della Montìsola, il cui nome indica la sua caratteristica di<br />
isola montuosa, la più vasta e la più alta dei laghi italiani (4,3 kmq. di superficie;<br />
600 m. di altezza), emergono le due isolette di Loreto e di San Paolo. È la zona<br />
più bella del Sebino e da essa si domina gran parte dello specchio lacustre e delle<br />
cortine montuose che lo recingono, quella occidentale о bergamasca ripida e rotta<br />
da pittoreschi strapiombi e quella orientale bresciana per lo più a morbiti profili.<br />
Il bacino imbrifero del lago, costituito essenzialmente dall’Oglio, non è molto esteso<br />
e comunque non è tale da determinare preoccupanti oscillazioni del livello; le piene,<br />
primaverili e autunnali, sono normalmente moderate.<br />
Il lago di Garda о Benaco è il più vasto dei laghi italiani. La sua superficie, al<br />
livello medio di 65 m. sul mare, misura 370 kmq. (158 più del lago Maggiore<br />
e 224 più del lago di Como); essa si distende da nordest a sudovest in forma allungata<br />
(km. 51 >6) espandendosi a sud a guisa di clava e qui raggiungendo l’ampiezza<br />
massima di 17 chilometri. Di fronte a Castelletto la vasta conca raggiunge la profondità<br />
di 346 m. che costituisce la maggiore criptodepressione d’Italia (281 metri<br />
sotto il livello marino). Il bacino imbrifero del lago è relativamente modesto; il<br />
maggior immissario è il Sarca che raccoglie le acque dell’arco montuoso compreso<br />
108
tra i gruppi deirAdamello-Presanella e del Brenta. Le piene primaverili e autunnali<br />
sono quindi di modesta rilevanza e oscillano attorno al metro.<br />
La sponda lombarda del Garda si estende tra Reamòl (a nord di Limone) e<br />
Santa Maria di Lugana (a oriente della penisoletta di Sirmione). La parte settentrionale,<br />
ossia a nord di Gardone, è accompagnata da versanti per lo più ripidi che<br />
diventano spesso addirittura strapiombanti. La parte meridionale, orlata di morbide<br />
colline, disegna tre golfi in successione: quello penetrante di Salò, quello ampio di<br />
Desenzano, protetto dalla splendida penisoletta di Sirmione, e quello intermedio<br />
ai due, al cui ingresso emergono l’isoletta di Garda e diversi scogli pittoreschi.<br />
Il piccolo lago d’Idro о Eridio, ricordato tra i laghi minori delle Prealpi, si stende<br />
nel solco della vallata del Chiese. Il suo specchio, al livello medio di 368 m. sul mare,<br />
si estende per 10,9 kmq.; si allunga lungo il solco vallivo da nordest a sudovest<br />
Fot. Stefani<br />
Il Iago d’Idro (vai Sabbia).<br />
109
Il lago d’Èndine (val Cavallina).<br />
Fot. Stefani<br />
per circa io km. con un massimo di larghezza di quasi г chilometri. Relativamente<br />
alla sua ampiezza è discretamente profondo, giungendo, davanti alla Rocca d’Anfo,<br />
a 122 metri. Racchiuso tra erte montagne, il piccolo lago presenta pittoresche prospettive,<br />
che, in alcuni punti, abbracciano a sfondo le Giudicarle.<br />
Nella vai Cavallina, a 337 m. sul mare, v’è un altro piccolo lago prealpino, il<br />
lago d’Èndine о di Spinone, di 2,1 kmq. di superficie. La sua conca si allunga per<br />
circa 6 km. nel solco vallivo e raggiunge una profondità di una decina di metri;<br />
per le modeste dimensioni durante l’inverno si copre talvolta di uno strato di<br />
ghiaccio.<br />
n o
Oltre ai laghi prealpini vi è nella <strong>Lombardia</strong> occidentale un altro gruppo di laghi,<br />
sempre di origine glaciale, ma più propriamente determinati dai depositi morenici<br />
abbandonati dalle fronti delle grandi colate glaciali dell’inizio del Quaternario. Essi<br />
sono in genere di modesta estensione e di scarsa profondità; quattro, ossia i laghi<br />
di Varese, di Comabbio (detto anche di Varano), di Monate e di Biandronno, giacciono<br />
incastonati tra le cerehie dell’anfiteatro ticinese e altri quattro, ossia i laghi<br />
di Annone, di Pusiano (il « vago Èupili » del Parini), d’Alserio e di Montòrfano racchiusi<br />
tra le colline dell’anfiteatro abduano. La loro presenza conferisce alla regione<br />
collinare del Varesotto e della Brianza una nota di suggestiva grazia tanto più<br />
attraente per la vicinanza dei gruppi montuosi delle Prealpi e delle Alpi che formano<br />
un’incomparabile cornice.<br />
Il lago di Varese è il maggiore per ampiezza tra i laghi pedemontani (kmq. 15);<br />
il suo specchio giace a 238 m. sul mare, in una vasta conca verso cui digradano<br />
dolcemente, da nord, le pendici prealpine del Campo dei Fiori e, da sud, i poggi<br />
Fot. Fracchi<br />
Il lago di Pusiano nell’anfiteatro morenico abduano.<br />
Ili
Il lago Bianco (2609 m.) al Gavia, con l’imponente sfondo del San Matteo.<br />
Fot. Stefani
morenici sparsi di villaggi e di ville. Nel lago riversano le loro acque numerosi<br />
ruscelli, che discendono dalle alture circostanti, e, attraverso il canale Brabbia, il<br />
lago di Gomabbio; a sua volta il lago di Varese invia le sue acque, attraverso il<br />
torrente Bardello, nel lago Maggiore. Presso la sponda occidentale emerge dall’acqua<br />
la minuscola isola di Isolino, famosa per la stazione palafitticola (scoperta<br />
verso la metà del secolo scorso) che ha dato interessanti reperti tra l’Eneolitico e<br />
l’età del bronzo. A ovest del lago di Varese, e separato da questo da un sottile<br />
lembo di terra, vi è il piccolo lago di Biandronno (kmq. 0,470) ridotto ormai a<br />
palude; a maggior distanza verso sudovest vi sono i due laghi di Monate (kmq. 2,8),<br />
dove pure furono rinvenute palafitte dell’età del bronzo, e di Gomabbio (kmq. 3,8),<br />
le cui acque limpidissime sono utilmente sfruttate per la piscicoltura.<br />
I laghi briantei sono allineati tutti, uno affiancato all’altro, al margine pedemontano<br />
del triangolo prealpino compreso tra i due rami meridionali del Lario. Il maggiore<br />
tra essi per estensione è il lago di Annone, detto anche di Oggiono o, più<br />
esattamente, di Ogionno (kmq. 5,7). Il suo specchio, a 226 m. sul mare, protetto<br />
a nord dal monte Rai e a ovest dalla dorsale del monte Barro, è recinto a sud da<br />
un bordo di calcari e di arenarie coperte da morene; la penisoletta di Isella lo<br />
divide quasi completamente in due bacini dei quali l’occidentale è detto propriamente<br />
di Annone e l’orientale di Ogionno. E alimentato da modestissimi ruscelli<br />
e da polle profonde; le sue acque si scaricano, attraverso il Rio Torto che percorre<br />
la Valmadrera, nel lago di Lecco.<br />
Separato da un ripiano torboso dal lago di Annone, e a ovest di questo, vi è<br />
l’amenissimo lago di Pusiano о Eupili, di ampiezza poco inferiore al precedente<br />
(kmq. 5,3). La sua conca raggiunge la maggiore profondità dei laghi briantei (24 m).<br />
e riceve buon contributo di acque dal Lambro (in questo tratto detto Lambrone),<br />
che è pure emissario. A occidente del lago di Pusiano, e da questo separato in epoca<br />
piuttosto recente (forse nel secolo XV) dalle alluvioni del Lambrone, vi è il piccolo<br />
e solitario lago di Alserio (kmq. 1,7). Infine, a mezza strada tra questo e l’abitato<br />
di Gomo, vi è il minuscolo lago di Montòrfano (kmq. 0,4), ai piedi del colle omonimo<br />
che, come dice il nome, sorge isolato.<br />
A necessario completamento della rassegna dei maggiori laghi lombardi sono<br />
da ricordare da ultimo anche i laghetti di montagna che, rari nelle Prealpi, sono<br />
invece frequenti nelle Alpi e conferiscono al paesaggio, per solito aspro, una nota<br />
di grazia. Se ne incontrano lungo gli itinerari montani in gran numero (certamente,<br />
per la sola <strong>Lombardia</strong> non inferiore al migliaio) e nella maggior parte tra i 1800 e<br />
i 2400 metri. Ve ne sono alcuni di richiamo per la loro bellezza, come il lago Palù<br />
(1921 m.) e il lago Pirola (2283 m.) nel gruppo del Bernina, i laghi Gemelli<br />
(1737 e 1841 m.) e il lago Rotondo (1972 m.) sul versante brembano delle Orobie,<br />
il lago d’Arno (1816 m.) e il lago Baitene (2281 m.) nel gruppo dell’Adamello, il<br />
lago Nero (2386 m.) e il lago Bianco (2609 m.) al passo di Gavia, con il sovrastante<br />
lago Verde (2841 m.), ecc., ma nessuno eguaglia il fascino dei laghi delle Alpi dolomitiche.<br />
Molti dei laghetti della montagna lombarda sono stati utilizzati come<br />
8 — L e R e g io n i d ’ Ita lia - L o m b a rd ia .<br />
113
serbatoi per l’industria idroelettrica e i loro bacini modificati con la costruzione di<br />
sbarramenti per aumentarne la capienza; hanno quindi perso in bellezza per acquistare<br />
in utilità.<br />
I fiumi.<br />
Il Po, che in due brevi tratti, nel Pavese e nel Mantovano, attraversa il territorio<br />
lombardo e per un tratto maggiore lo lambisce lungo il confine meridionale,<br />
accoglie le acque scolanti da tutta la regione per avviarle, attraverso il suo corso,<br />
al mare Adriatico. Alla sua sponda sinistra giungono — in successione da occidente<br />
ad oriente — l’Agogna, il Ticino, l’Olona, il Lambro, l’Adda (in cui confluiscono<br />
il Brembo e il Serio), l’Oglio (in cui confluiscono la Mella e il Chiese), il Mincio e<br />
altri corsi minori; alla sua sponda destra giungono la Stàffora e altri torrenti più<br />
modesti.<br />
Ad alimentare questi corsi fluviali contribuiscono, com’è naturale, le precipitazioni<br />
che sul suolo lombardo cadono discretamente copiose, ma in misura diversa<br />
a seconda delle stagioni e dei luoghi: nella zona propriamente alpina più abbondanti<br />
d’estate che nelle altre stagioni, nella zona delle Prealpi, della collina e della pianura,<br />
invece, più abbondanti di primavera e d’autunno che nell’estate e nell’inverno.<br />
II regime di tutti i fiumi lombardi, о anche le diverse parti di uno stesso fiume,<br />
mostrano di risentire direttamente di tale situazione pluviometrica, ossia il volume<br />
delle loro acque cresce sensibilmente nei periodi di piogge più copiose. Ma sul<br />
regime dei fiumi influisce sensibilmente anche il fatto che una parte delle precipitazioni<br />
invernali, stagione di per sè non abbondante di piogge in nessuna parte della<br />
<strong>Lombardia</strong>, cade sotto forma di neve, che discioglie nella primavera e, alle maggiori<br />
altitudini, nell’estate, insieme ai ghiacciai. Sicché la stagione invernale segna il periodo<br />
di maggior povertà di acque fluviali.<br />
Le accennate condizioni sono da tenere ben presenti per una rapida intuizione<br />
delle caratteristiche di regime dei fiumi lombardi, non trascurando altresì che per<br />
il tratto inferiore di alcuni di essi agiscono da regolatori i bacini lacustri; pertanto<br />
è opportuno conoscere l’area dalla quale ha origine e dove si alimenta ciascun fiume.<br />
Alcuni, il Ticino, l’Adda e l’Oglio, nascono nel cuore delle Alpi e si riversano in<br />
uno dei grandi laghi prealpini prima di giungere alla pianura. Ad essi può essere<br />
aggregato il Mincio, che discende dal lago di Garda, il cui principale immissario,<br />
il Sarca, espande il suo ventaglio sorgentizio tra 1’Adamello e il Brenta. Altri fiumi<br />
lombardi, quali Г Agogna, l’Olona, il Lambro, il Brembo, il Serio, il Chiese, il Cherio<br />
e la Mella, nascono nelle Prealpi о tutt’al più al margine delle Alpi. Ad essi può<br />
essere aggregata la Stàffora, il maggiore dei corsi d’acqua dell’Oltrepò pavese, che<br />
discende dal cuore dell’Appennino. Vi sono infine altri minori fiumi di <strong>Lombardia</strong>,<br />
114
Fot. Sef<br />
L ’Agogna attraverso la campagna della Lomellina.<br />
come il Terdoppio, l’Arno, la Lura, il Sèveso, la Mòlgora, che nascono tra le colline.<br />
Orbene, il Ticino, l’Adda e l’Oglio, nel loro percorso propriamente alpino, hanno<br />
un periodo di piena da maggio a luglio a causa dello scioglimento delle nevi montane;<br />
poi la loro portata decresce lentamente pur mantenendosi ricchi di acque a<br />
causa delle piogge estive sulle Alpi e del contributo dei ghiacciai; con il progredire<br />
dell’autunno s’impoveriscono e passano l’inverno in magra (regime alpino). È tuttavia<br />
da sottolineare il fatto che l’intensa utilizzazione delle acque di tali fiumi a<br />
scopo idroelettrico ha alterato talvolta profondamente le caratteristiche idrologiche<br />
naturali. I fiumi che hanno origine nelle Prealpi e così pure la Stàffora, di origine<br />
appenninica, manifestano due periodi di piena in primavera e in autunno; il primo<br />
iiS
è per solito superiore al secondo a causa della coincidenza delle precipitazioni con<br />
lo scioglimento delle nevi. Nell’estate e nell’inverno sopravvengono magre, la seconda<br />
delle quali è più marcata (regime prealpino). Anche i fiumi provenienti dalle colline<br />
presentano gli stessi periodi di piena e di magra, ma, poiché ad essi manca il<br />
contributo delle acque di scioglimento delle nevi, la piena primaverile è per lo più<br />
minore di quella autunnale (regime subalpino). Vi è da aggiungere che i maggiori<br />
fiumi lombardi nel loro percorso in pianura, per l’azione regolatrice dei laghi, non<br />
conservano le caratteristiche di regime del loro percorso montano, ma partecipano<br />
del regime pluviale della zona che attraversano e del regime fluviale degli affluenti<br />
prealpini; perciò essi denunciano i massimi di portata a primavera inoltrata (maggio-giugno)<br />
e in autunno.<br />
In conclusione, l’unica caratteristica comune al regime di tutti i fiumi lombardi<br />
è la magra invernale; per i fiumi alpini a questa fa riscontro una piena estiva; per<br />
Il Ticino a Sesto Calende (a destra la sponda piemontese).<br />
Fot. Fotocielo<br />
Il6
Fot. Sef<br />
Il Ticino al Ponte coperto di Pavia.<br />
i fiumi prealpini, per i fiumi che hanno origine dalle colline e anche per i grandi<br />
fiumi nel loro percorso di pianura si alternano due piene in primavera e in<br />
autunno.<br />
Dei fiumi lombardi l’Adda vanta il primato per ampiezza del bacino idrografico,<br />
precedendo in graduatoria il Ticino e l’Oglio. L ’Adda supera anche gli altri fiumi<br />
per lunghezza di corso, precedendo l’Oglio e il Ticino. Quest’ultimo tiene invece il<br />
primato di portata media. Ma su questi vari aspetti di ciascuno è necessaria qualche<br />
maggiore precisazione.<br />
L ’Agogna nasce dal Mottarone che si eleva in territorio piemontese tra il lago<br />
d’Orta e il lago Maggiore. Il suo bacino misura 1560 kmq. e solo una piccola<br />
porzione di esso fa parte della <strong>Lombardia</strong>. In questa infatti si snoda solo il tronco<br />
inferiore del suo corso tra Confienza e il Po nel quale si getta alla Cascina Giarola,<br />
presso Mezzana Bigli. In questo tratto il fiume è arricchito da acque di fontanili.<br />
Le sue piene primaverili e autunnali sono rovinose e durante la loro fase massima<br />
si sono misurate portate di oltre 300 metri cubi al secondo.<br />
Il Terdoppio nasce presso Agrate Conturbia nella collina novarese. Lungo il<br />
suo corso riceve acque da numerosi colatori e ne dona a numerose altre rogge. Entra<br />
in territorio lomellino presso le Cascine Barbarava di Gravellona e giunge al Po,<br />
potentemente arginato, a est di Mezzana Rabattone. Il suo regime manifesta un<br />
117
carattere torrentizio: ha magre estive prolungate e piene considerevoli primaverili<br />
e autunnali durante le quali si registrano portate di un centinaio di metri cubi<br />
al secondo.<br />
Il Ticino ha un’ampiezza di bacino di complessivi 7228 kmq. dei quali ben 6466<br />
in zona montuosa. Il fiume discende dal passo di Novena (2440 m.) e sbocca nel Po<br />
presso il ponte della Becca (56 m. sul mare) dopo un percorso di 248 km. dei quali<br />
circa 90 come immissario del lago Maggiore (in territorio quindi politicamente<br />
svizzero). Nel percorso montano (costituito dalle valli Bedretto, Leventina e della<br />
Riviera) riceve le acque del Bienio, che discende lungo la valle omonima, e del Moesa,<br />
che percorre la vai Mesolcina, quindi, arginato, attraversa la pianura di Magadino,<br />
formata dalle sue stesse alluvioni, per sfociare nel lago Maggiore. Presso la località<br />
detta la Cicognola, all’apice meridionale dello stesso, il Ticino esce maestoso facendo<br />
registrare alla vicina stazione idrometrica di Golasecca (Sesto Calende) una portata<br />
media di 312 metri cubi al secondo. Il regime manifesta una piena maggiore, con<br />
portata media massima di 2135 metri cubi al secondo (ma eccezionalmente anche<br />
del doppio), durante il mese di giugno, e una piena minore in novembre; la magra<br />
registra i valori minimi nel mese di febbraio con media di 35 metri cubi al secondo.<br />
Per attenuare nel limite del possibile tanta variabilità di portata, e soprattutto aumentare<br />
il flusso di acque nei periodi di magra allo scopo di una migliore utilizzazione<br />
a uso idroelettrico, poco a monte di Golasecca fu portato a termine nel 1942 lo<br />
sbarramento di Miorina, il quale fa da regolatore dell’invaso del Verbano e quindi<br />
da regolatore anche del Ticino.<br />
Da qui il fiume prende a scendere attraverso la pianura con una pendenza media<br />
dell’ i,5°/oo, lievemente superiore nel tratto che attraversa l’alta pianura e di poco<br />
inferiore nel tratto della bassa. Le acque lungo il filone e in superficie scorrono con<br />
velocità variabile da i a 3,5 m/sec. e la profondità del letto, sempre lungo il filone<br />
e a livello medio, va da mezzo metro sino asm. nei tratti più profondi. In tutto il<br />
suo percorso il fiume disegna ampi meandri e il suo letto, là dove divaga in diversi<br />
rami, si allarga anche più di un chilometro. Nell’alta pianura, ossia sin press’a poco<br />
a Tornavento, il solco s’incassa di una cinquantina di metri rispetto al livello della<br />
campagna ed è accompagnato lateralmente da ampi terrazzi scavati in alluvioni<br />
antiche о recenti e tra loro distinti da scarpate ben disegnate. Le bocche di presa<br />
dei canali derivati per la navigazione о per l’irrigazione del Milanese si trovano<br />
nella parte superiore del fiume e, per superarne le scarpate, ne accompagnano per<br />
lungo tratto il corso: presso Ca’ Maddalena (Somma Lombarda) vi è la presa del<br />
canale Villoresi, l’ultimo ad essere costruito dei grandi canali lombardi; presso<br />
Tornavento (Lonate Pozzolo) vi è la presa del Naviglio Grande, che è invece cronologicamente<br />
il primo. Ma se dal Medioevo sino al secolo scorso la utilizzazione<br />
delle acque del Ticino è stata in funzione unicamente dell’irrigazione e della navigazione,<br />
nel nostro secolo ha avuto sviluppo lo sfruttamento a scopo idroelettrico.<br />
Con la costruzione della diga di Pamperduto si dà l’avvio alle grandi centrali di<br />
Vizzola, di Tornavento, di Turbigo (superiore e inferiore) e, recentemente, di Porto<br />
118
Fot. Fracchi<br />
Il Lambro a Canònica in Brianza.<br />
della Torre (Somma Lombardo) il cui sbarramento serve ad alimentare anche il<br />
canale Elena (1954).<br />
L ’Olona è un fiume assai modesto dal punto di vista fisico, ma di notevole interesse<br />
per le vicende collegate allo sviluppo del suo corso e di grande importanza nel<br />
quadro dell’economia lombarda. Le sue sorgenti si trovano nel parco di Villa Gagnola<br />
a La Rasa (548 m.) in Valganna (Prealpi varesine). Attraversa con direzione da nordnordovest<br />
a sud-sudest la zona collinare e lungh’essa il suo solco s’incide profondamente<br />
tra morene e alluvioni terrazzate; raggiunta la pianura e la zona dei fontanili<br />
il fiume scorre a livello del piano e, piegando a sudest, si dirige verso Milano, dove<br />
si scarica nella darsena di Porta Ticinese. Complessivamente il fiume misura in lunghezza<br />
71 km., con una pendenza media del 6%o. Il suo regime è tipicamente subalpino;<br />
la portata media, a Vedano, è di circa 3 metri cubi e mezzo al secondo; ma<br />
durante le piene, per lo più improvvise e di breve durata, può raggiungere i 60 metri<br />
cubi al secondo, causando dannosi straripamenti nel tratto di pianura e, nonostante<br />
i lavori di sistemazione, anche alla periferia di Milano; durante l’inverno la portata<br />
119
Il profondo solco del medio corso dell’Adda a monte di Pademo<br />
con la centrale elettrica e le chiuse.<br />
Fot. Fracchi<br />
si riduce a poco più di un metro cubo al secondo. A causa delle notevoli utenze,<br />
tra il 25 marzo e il 12 settembre, vengono immessi nel suo letto, se necessario,<br />
da 500 a 1000 1/sec. traendoli dal canale Villoresi che incrocia l’Olona tra Parabiago<br />
e Nerviano.<br />
Se quello descritto è il corso attuale dell’Olona, occorre però rilevare che così<br />
è, a causa della deviazione apportata al fiume tra Lucernate (Rho) e Milano. L ’opera<br />
di deviazione fu eseguita in epoca molto remota non bene individuata (forse tra<br />
il II e il III secolo d. C.) per rifornire di acque i canali della città di Milano e per<br />
irrigare le sue campagne. Difficile è ricostruire il precedente percorso del fiume,<br />
le cui tracce sono del tutto cancellate, ma è credibile che, sull’allineamento del percorso<br />
a monte di Lucernate, il fiume discendesse nella pianura lungo la direttrice<br />
segnata dalle odierne località di Cascina Olona, Còrsico oppure anche Trezzano;<br />
tanto la roggia Carona, come la roggia Vecchia о la roggia Colombana potrebbero<br />
rappresentare l’alveo originario dell’Olona. Certo è che in prossimità di Binasco<br />
si trova un corso d’acqua, ridotto per scopo irrigatorio alla funzione di colatore,<br />
che conserva il nome di Olona e che quasi certamente è la prosecuzione dell’antico<br />
corso; esso, intermedio tra Ticino e Lambro e parallelo ad essi, discende sino al Po<br />
nel quale sbocca presso San Zenone.<br />
120
Quello dell’Olona non è del resto un caso unico. Infatti nella rete di canali che<br />
si annoda in Milano sono state convogliate probabilmente, ma con opera molto più<br />
semplice, le acque del Sèveso, piccolo fiume che s’origina nell’anfiteatro morenico<br />
abduano in prossimità di Como e attraversa la zona collinare e l’alta pianura in un<br />
solco terrazzato. V ’è chi ritiene che il Sèveso, in antichi tempi, attraversasse Milano<br />
lungo l’alveo che ora si chiama Vettabbia, raggiungendo poi il Lambro a Melegnano;<br />
ma ciò è difficile da accertare.<br />
Anche la Mòlgora, piccolo torrente che nasce nell’anfiteatro abduano e che attualmente<br />
si riversa nella Muzza, confluiva un tempo nell’Adda attraverso il solco che<br />
s’incide nella pianura a nord di Comazzo.<br />
Il Lambro è un fiume direttamente confluente nel Po, di discreto sviluppo<br />
(km. 124) ma di modesta portata; ha origine alla fonte intermittente del Menaresta,<br />
al centro del triangolo compreso tra le diramazioni meridionali del Lario; discende<br />
per la Valassina, da cui esce attraverso la stretta di Casiino d’Erba dove la portata<br />
media è poco meno di 2 metri cubi al secondo; sbocca con il nome di Lambrone<br />
nel laghetto morenico di Pusiano; ne esce aprendosi la via tra i depositi morenici<br />
e, incassato tra i terrazzi alluvionali, si dirige verso sud in direzione di Monza. Nella<br />
zona dei fontanili, scomparsi i terrazzi laterali, il fiume scorre a livello della pianura,<br />
sfiorando Milano sul lato orientale; quindi al richiamo della pendenza si dirige, con<br />
corso tortuoso, verso sudest. A Melegnano, dove s’inserisce nuovamente tra scarpate<br />
terrazzate, il Lambro riceve le acque dell’Addetta scaricatore della Muzza, e<br />
della Vettabbia, proveniente da Milano; a Sant’Angelo Lodigiano accoglie le acque<br />
del Lambro meridionale. Aggirato sul lato orientale il colle di San Colombano, il<br />
fiume si getta nel Po presso Corte Sant’Andrea.<br />
L ’Adda è tra i più importanti affluenti di sinistra del Po e certamente il più<br />
importante tra quelli che espandono il loro bacino totalmente in territorio lombardo.<br />
Il fiume nasce a 2237 m. sotto il passo di vai Alpisella (2285 m.); dalla sua origine<br />
alla confluenza nel Po si snoda per 313 km., dei quali circa 115 come immissario<br />
del Lario. L ’ampiezza del bacino abduano è di 7989 kmq. (5286 dei quali in zona<br />
di montagna), superiore, quindi a ^ e lla di ogni altro fiume lombardo, Ticino<br />
compreso. Dai minuscoli laghetti dai quali prende l’avvio, l’Adda scende povera<br />
d’acque lungo la valle di Fraele (da alcuni anni sbarrata da dighe che formano i<br />
laghi di Fraele e Cancano) e raggiunge la conca di Bormio dove riceve il contributo,<br />
scarso oggi per l’utilizzazione delle acque da parte degli impianti idroelettrici,<br />
del Braulio (valle del Bràulio), del Viola (vai Viola) e del Frodolfo (Valfurva). Si<br />
incanala poi nel solco della Valtellina e discende rapida e spumeggiante sino a<br />
Tirano, poi si placa e si snoda, non senza qualche meandro, sul fondo piatto della<br />
valle. Riceve sulla destra il contributo del torrente Roasco (vai Grosina), del Màllero<br />
(vai Malenco) e del Màsino (vai Màsino), che discendono dal versante retico.<br />
Non minore è il contributo dei numerosi torrenti (Belviso, Caronella, Malgina,<br />
Armisa, Venina, Livrio, Tártano, Bitto) che discendono dalla Orobie, ma esso è<br />
soprattutto primaverile e autunnale allorché detti torrenti hanno piene talvolta anche<br />
121
L ’Adda a Lodi.<br />
Fot. Bromofoto<br />
violente e rovinose. L ’Adda però non ingrossa progressivamente con il suo procedere<br />
verso il Lario, come si sarebbe indotti a credere, ma si immiserisce notevolmente<br />
là dove gli impianti idroelettrici, che sono numerosi, ne sottraggono e<br />
imbrigliano le acque; si arricchisce d’improvviso dove le centrali liberano l’acqua<br />
utilizzata. Nella sezione inferiore l’Adda procede tuttavia discretamente ricca di<br />
acque, tra argini rettilinei, attraverso il bonificato Pian di Spagna, un tempo sede<br />
di acquitrini e infestato dalla malaria, e sbocca infine nel Lario poco a settentrione<br />
di Còlico. Qui essa denuncia una portata media di circa 70 metri cubi al secondo<br />
con massimi in giugno di circa 750 metri cubi al secondo e minimi in febbraio di<br />
circa 20 metri cubi al secondo. Ma il Lario, come s’è accennato, si arricchisce anche<br />
delle acque di altri notevoli bacini alpini e prealpini. La Mera è l’immissario più<br />
notevole, dopo Г Adda; proviene dal Passo Maloia e riceve, in prossimità dell’abitato<br />
di Chiavenna, le acque del Liro che discende dal passo dello Spinga.<br />
L ’Adda esce dal Lario all’apice meridionale del ramo di Lecco; da qui al Po,<br />
il fiume discende con pendenza media dell’ i,i°/oo e una velocità media in superficie<br />
da 0,3 a 4,7 m. al secondo. Il suo letto ha larghezza varia da un minimo di 80 a<br />
un massimo di 800 metri. Al ponte che sovrasta l’inizio dell’emissario la portata<br />
media è calcolata in 160 metri cubi al secondo. Durante i periodi di piena, che normalmente,<br />
come per il Ticino, cadono in giugno, il massimo di portata può superare<br />
i 900 metri cubi al secondo, mentre nei periodi di magra, che coincidono con<br />
il gennaio, il volume di acqua si contrae sino a 30 metri cubi al secondo.<br />
122
Il Brembo a San Pellegrino Terme.<br />
Fot. Stefani
Dopo il ponte di Lecco Г Adda forma i laghetti di Cariate (kmq. 4,64) e di Olginate<br />
(kmq. 0,77), separati dal Lario (del quale un tempo costituivano l’apice più<br />
meridionale) dalle alluvioni via via accumulate dai precipiti torrenti che discendono<br />
dalle circostanti alture: dal Gerenzone, dal Caldone e dal Bione, che hanno formato<br />
il delta su cui si espande la città di Lecco, dal Galavesa e dall’Àspide, che hanno<br />
formato i delta opposti di Vercurago-Calòlzio e di Olginate. Dopo i laghetti, il<br />
fiume divaga pigro per breve tratto, poi va rapidamente incassandosi nel ceppo,<br />
che forma sponde ripide e alte anche una cinquantina di metri. Sul fondo di tale<br />
specie di canon spumeggia l’acqua rotta da scogli; a Paderno, dove la rapida è più<br />
impetuosa, un canale, risalente al secolo XVIII, della lunghezza di circa due chilometri<br />
e diviso in 6 conche che permettono ai natanti di superare un dislivello di 29 m.,<br />
si snoda a lato del fiume. Altre opere per alimentare le centrali elettriche di Paderno<br />
e di Robbiate furono costruite a partire dal 1898, data d’inizio dell’industria idroelettrica<br />
lombarda. A Trezzo vi è la chiusa per la presa della Martesana e a Cassano<br />
la presa della Muzza.<br />
Poco a monte di Vaprio e di Canònica, l’Adda riceve sulla destra le acque del<br />
primo dei due maggiori affluenti oròbici, il Brembo, che, dalle sorgenti alla confluenza,<br />
misura 72 km. di sviluppo. Il suo ampio bacino si estende ad abbracciare<br />
il versante meridionale delle Orobie occidentali tra il pizzo del Diavolo di Tenda<br />
e il pizzo dei Tre Signori, dalle cui pendici meridionali discendono i molti rami<br />
dell’ampio ventaglio sorgentizio, convergenti in un unico solco che prende il nome<br />
del fiume a Lenna, in vista di San Martino dei Calvi. Scendendo lungo la valle in<br />
direzione della pianura il Brembo si arricchisce delle acque dei torrenti Enna<br />
(vai Taleggio), Brembilla (vai Brembilla) e Imagna (vall’Imagna) sulla destra. Parina<br />
(vai Parina) e Serina (vai Serina) sulla sinistra. Sbocca nella pianura tra Almè e<br />
Alenno e, incassato tra alte ripe scavate nel ceppo, si dirige senza tortuosità<br />
all’Adda.<br />
A valle di Cassano, l’Adda si sbizzarrisce in un letto molto ampio nel quale le<br />
acque corrono veloci e capricciose dividendosi in numerosi rami per interposti isolotti<br />
ghiaiosi talvolta ammantellati di boscaglia. A valle di Lodi le acque rallentano<br />
la loro corsa e si raccolgono in un letto ben disegnato ma tortuosissimo per una<br />
serie di ampi meandri che si succedono ininterrottamente l’uno all’altro. Dalla<br />
Gran Carta Corografica Statistica del Regno lombardo-veneto di A. Maridati<br />
del 1859 risulta che alcune delle anse, oggi abbandonate, un secolo fa erano ancora<br />
vive, mentre altre sin da allora erano morte.<br />
A Bocca di Serio nell’Adda confluisce il Serio, di 124 km. di sviluppo. Il suo<br />
alto bacino raccoglie le acque del versante meridionale delle Orobie orientali tra<br />
il pizzo del Diavolo di Tenda e il monte Gleno. Dalle pendici del pizzo Torena,<br />
donde ha origine, il Serio discende per la vai Bondione in direzione longitudinale<br />
alla catena orobica; quindi piega verso la pianura lungo la valle che dal fiume prende<br />
nome di Seriana; sbocca nell’alta pianura nei pressi di Alzano e ne discende con<br />
frequenti ramificazioni, incassato in un solco che attenua la sua profondità nella<br />
124
^ i f.V / у Л " ,<br />
Fot. Stefani<br />
Il fiume Serio.<br />
bassa e che tale si mantiene sino alla confluenza con l’Adda. Questa, sempre con<br />
ampi meandri, corre verso il Po nel quale sbocca a un livello medio di 39 metri<br />
sul mare.<br />
L ’Oglio, come l’Adda, estende il suo bacino di 6641 kmq. (dei quali 3426 in<br />
zona di montagna) totalmente in territorio lombardo con uno sviluppo tra sorgente<br />
e confluenza nel Po di 281 chilometri. Il flume ha le sue sorgenti a 2610 m. sulle<br />
pendici meridionali del corno dei Tre Signori (3359 m.) che si erge al punto di<br />
contatto di tre importanti bacini idrograflci e precisamente quelli dell’Oglio, del-<br />
125
l’Adda e del Noce (Adige); ma il ventaglio di alimentazione dell’Oglio si espande<br />
in una vasta zona ricca di acque che, a sud dell’ampio valico del Tonale, abbraccia<br />
anche un lembo dell’Adamello, le cui acque sono in gran parte captate da grandiosi<br />
impianti idroelettrici. A Ponte di Legno, che si trova alla confluenza delle alte ramiflcazioni<br />
del flume, le acque dell’Oglio si avviano per il fondo della pittoresca e<br />
ampia valle che prende il nome di Camònica; in essa riceve il contributo di acque<br />
di numerosi affluenti tra i quali, particolarmente notevoli, sulla destra il Fiumicello<br />
(valle di Còrteno), scendente dal passo dell’Aprica, e il Dezzo, proveniente dalla<br />
valle di Scalve attraverso un’orrida e profonda gola; sulla sinistra Г Avio, il Pagherà<br />
e il Remulo, che scendono dal massiccio dell’Adamello, e quindi il Puglia (vai Saviore)<br />
e il Grigna. A Breno (340 m.) le acque del fiume si placano e discendono lente, per<br />
la minor pendenza del fondovalle, sino al lago d’Iseo, nel quale si riversano. Il fiume<br />
riprende il suo corso presso Sàrnico, traversa l’anfiteatro morenico via via incassan-<br />
L ’Oglio poco a valle di Sàrnico.<br />
Fot. Sef<br />
126
Fot. Calzolari<br />
Il Mincio presso Rivalla.<br />
dosi, raggiunge l’alta pianura tra larghe sponde terrazzate e, come il Ticino e l’Adda,<br />
dona acque e numerose derivazioni per irrigazione e per sfruttamento industriale,<br />
soprattutto idroelettrico. Presso l’abitato di Paiosco riceve sulla destra le acque del<br />
Cherio, emissario del laghetto d’Èndine in vai Cavallina; s’inoltra per lungo tratto<br />
in direzione sud, poi devia verso sudest serpeggiando con meandri sempre più ampi.<br />
Poco a monte del ponte di Ostiano riceve le acque del Mella (96 km.), proveniente<br />
dalla vai Trompia, e tra Canneto e Acquanegra riceve le acque del Chiese (160 km.),<br />
fiume che si origina sul versante tridentino dell’Adamello ed entra nel territorio<br />
lombardo alla confluenza nel lago d’Idro, all’imbocco della vai Sabbia. Lungo questa<br />
il Chiese discende con andamento tortuoso a doppio gomito, avvicinandosi alla<br />
sponda occidentale del Garda; allo sbocco nella pianura cede parte delle sue acque<br />
al Naviglio bresciano; quindi corre senza deviazioni sino alla confluenza nell’Oglio,<br />
che a sua volta, dopo una ventina di chilometri, entra nel Po, le cui acque in questo<br />
punto hanno un livello medio di 16,5 m. sul mare.<br />
Il Mincio inizia il suo corso, quale emissario del lago di Garda, in un lembo di<br />
territorio veneto; ma pochi chilometri a valle raggiunge il limite amministrativo<br />
tra Mantova e Verona e ad esso s’annoda sino a Pozzuolo; poi diviene fiume man-<br />
127
Il Lago Superiore formato dal Mincio a Mantova.<br />
Fot. Sef<br />
tovano per eccellenza. Il fiume attraversa nella parte mediana l’ampio anfiteatro<br />
benacense chiuso tra alte ripe moreniche, e le sue acque non mancano d’impeto;<br />
ma poi nella pianura corre a livello della campagna (anzi nel tratto inferiore sospeso),<br />
la corrente si placa e a valle di Coito già le acque sono tanto pigre da impaludare.<br />
A Mantova il Mincio forma tre piccoli laghi, superiore, di mezzo e inferiore, che<br />
circondano la città su tre lati, quindi con lento corso va a confondere le sue acque<br />
con quelle del Po che in questo punto ha un livello medio di 12,5 m. sul mare. Nel<br />
complesso il bacino Sarca-Mincio si estende per 2859 kmq., dei quali solo 815 nella<br />
collina e nella pianura; la lunghezza totale è di 194 km. dei quali 75 del solo Mincio<br />
tra il Garda e il Po. In questo tratto la pendenza media risulta di o,7°/oo; è maggiore<br />
nella zona collinare, quasi insensibile in quella di pianura. La portata media<br />
è di 60 metri cubi al secondo. Le piene autunnali sono superiori a quelle primaverili<br />
e si raggiungono i 150 metri cubi al secondo; in febbraio la magra registra una portata<br />
di circa 30 metri cubi al secondo.<br />
Il Mincio ha costituito in ogni secolo un problema notevole per la sistemazione<br />
delle sue acque. Si ritiene per certo che in antichi tempi il Mincio, dopo Mantova,<br />
avesse un percorso diverso dell’attuale e che, unito al Tàrtaro, corresse verso levante<br />
sfociando direttamente nel mare in prossimità di Adria; quando poi volgesse il suo<br />
corso verso il Po e in esso riversasse le sue acque, non si sa con esattezza: v’è chi<br />
ritiene che un alveo artificiale verso Governolo sia stato aperto da Quinto Curio<br />
Ostilio per ordine del Senato romano e chi, forse più giustamente, attribuisce il<br />
nuovo corso alle conseguenze delle terribili piogge che nel 589 fecero straripare
molti fiumi; l’Adige, in tale circostanza, traboccò dal suo letto alla Cucca (Veronella)<br />
e le sue acque dilagando e tutto invadendo avrebbero cancellato il solco del Mincio,<br />
del Tàrtaro e delle Fosse Filistine. Nè forse alla falla si volle porre rapido riparo,<br />
poiché, imperversando in quel tempo la lotta dei Longobardi contro Ravenna, l’allagamento<br />
danneggiava le terre dell’Esarcato e favoriva gli avversari in quanto costituiva<br />
un’ampia fascia di naturale difesa. Le piene dell’Adige probabilmente continuarono<br />
per lungo tempo a ristagnare e a rendere acquitrinose e malsane terre<br />
che in precedenza erano fertili e salubri. Il Mincio, costretto a nuova via, si riversò<br />
allora spontaneamente nel Po presso Governolo, ma, a causa della modesta pendenza,<br />
avveniva che le sue acque defluissero con difficoltà e, peggio, che le piene del maggior<br />
fiume, risalendo lungo il corso dell’affluente, impaludassero le terre circostanti. I Mantovani<br />
dinanzi alla loro città videro quindi formarsi in periodi di piena uno spazioso<br />
lago, « onde — immagina uno scrittore secentesco, il Bertazzolo — tutti si auguravano<br />
di vederlo sempre in quello stato per vaghezza e fortezza della città ». E fu<br />
appunto per farne una fortezza che nel 1198 Alberto Pitentino, architetto delle<br />
Comunità, ideò il progetto che doveva dare stabilità ai laghi. Con gli sbarramenti<br />
di Mulina e di Belfiore si diè vita al lago superiore a quota di 17,49 m. sul mare;<br />
con l’argine di Governolo si formarono i laghi di mezzo e inferiore a quota 13,26 metri<br />
sul mare; con il sor adore di Pradella e l’argine di Cerese si formò il lago di Paiolo,<br />
sicché la città di Mantova fu tutta cinta dalle acque. La sistemazione non potè tuttavia<br />
essere definitiva a causa del graduale innalzamento delle arginature del Po che,<br />
costringendo le piene del fiume a più alto livello, determinarono il progressivo interrimento<br />
dei laghi di mezzo e inferiore, per il deposito di materiale portato dal rigurgito<br />
delle acque. Cessata poi la finalità difensiva della città, si prospettò la utilità<br />
di eliminare gli specchi d’acqua e di essi uno, il lago di Paiolo, fu prosciugato infatti<br />
nel 1780.<br />
Non si può concludere questo rapido quadro della rete fluviale della <strong>Lombardia</strong><br />
senza aggiungere ai precedenti cenni occasionali qualche precisazione relativamente<br />
al Po che in due tratti, per complessivi n o km., traversa il territorio della <strong>Lombardia</strong><br />
e per 210 km. ne segna il limite. Il Po, serpeggiando lungo il 45° parallelo, lambisce<br />
il territorio lombardo dalla confluenza della Sesia a quella dell’Agogna; ivi il confine<br />
a tratti si annoda e a tratti si scosta dal fiume seguendo le anse abbandonate<br />
dell’antico letto. Tra il ponte di Gerola e il ponte di Pieve, il Po diviene totalmente<br />
lombardo, sbizzarrendosi in numerosi ed ampi meandri, ricevendo sulla sinistra<br />
il Ticino e dal versante appenninico, sul quale si estende l’Oltrepò pavese, numerosi<br />
torrenti tra i quali la Stàffora (km. 38), che attraversa la campagna vogherese<br />
e lambisce Voghera, il Coppa, lo Scuropasso e il Versa. Dopo il ponte di Pieve,<br />
il Po torna a segnare il limite della <strong>Lombardia</strong> (salvo minuscole deviazioni) sino<br />
all’isola fluviale di San Simeone. Quindi entra di nuovo in territorio lombardo traversando<br />
il Mantovano sin presso il ponte di Ostiglia. Poi di nuovo il Po segna il<br />
confine della <strong>Lombardia</strong> sino a Quatrelle, all’estremità orientale della regione lombarda.<br />
9 — R e g io n i d 'I t a lia - L o m b a rd ia .<br />
129
Il grande fiume, già dàlia confluenza del Ticino, è accompagnato da argini,<br />
poiché durante le piene il suo livello sale sino a minacciare la pianura circostante;<br />
il pericolo maggiore delle piene si fa sentire sulla sponda cremonese e mantovana.<br />
A conclusione di tutto quanto esposto, è opportuno aggiungere alle iniziali<br />
alcune osservazioni di carattere generale. Come già s’è accennato la conca padanoveneta<br />
si presenta nei suoi tratti essenziali come un’immensa valle di cui la <strong>Lombardia</strong><br />
occupa il tratto medio del versante alla sinistra orografica. Questa posizione<br />
del territorio si riflette anche sullo sviluppo della sua rete idrografica; difatti la direzione<br />
dei corsi fluviali della <strong>Lombardia</strong> rispecchia il richiamo della duplice pendenza<br />
della grande valle padana; la pendenza assai marcata e generale (e quindi<br />
influente sull’intero corso dei fiumi) tra lo spartiacque alpino e il letto del Po, e<br />
la pendenza meno marcata (e influente solo sul corso inferiore) verso lo sbocco<br />
adriatico. In relazione a ciò, nel corso dei fiumi lombardi si possono distinguere<br />
due parti; quella che si incide nell’ambito della montagna e quella che si snoda<br />
nell’area di pianura; nella prima i corsi fluviali discendono verso il piano con un<br />
percorso vario condizionato almeno in parte dalle situazioni geologiche, strutturali<br />
e litologiche che hanno presieduto alla evoluzione dei solchi; nella seconda, non<br />
più impediti di secondare del tutto il richiamo della pendenza, discendono deviando<br />
lievemente e progressivamente dalla parte della foce del Po. Per tal ragione i maggiori<br />
fiumi presentano un parallelismo di percorso che, per quanto non rigido e totale,<br />
è pur sempre notevolissimo. Esso si manifesta nelle Prealpi e specialmente nella<br />
pianura; in quelle la direzione generale, non esclusi i laghi, è da nord-nordest<br />
II Po con il ponte di barche presso Borgoforte.<br />
Fot. Sef<br />
130
Fot. Sef<br />
La valle della Stàffora a Varzi.<br />
a sud-sudovest, in questa da nordovest a sudest formando quindi nell’assieme un<br />
ampio angolo ottuso con il vertice rivolto a ovest. Tale parallelismo presenta un<br />
particolare interesse nella fascia prealpina, per via delle possibilità di penetrazione;<br />
nella pianura, oltre che per la ripartizione del territorio che i fiumi, almeno i maggiori,<br />
determinano (Ticino, Adda, Oglio e Mincio segnano in parte il limite di<br />
provincia), anche in relazione alla tecnica di utilizzazione delle acque a scopo irriguo.<br />
Ma sotto tale aspetto giova ricordare un’altra caratteristica morfologica comune<br />
ai fiumi della <strong>Lombardia</strong> occidentale e ad alcuni dei loro affluenti. Dopo lo sbocco<br />
dai solchi vallivi о dai bacini lacustri prealpini, essi affondano il loro corso nelle<br />
alluvioni antiche о recenti, formando incisioni più о meno aperte e profonde<br />
parecchie decine di metri; tipico è il caso dell’Adda che corre per parecchi chilometri<br />
in una gigantesca trincea profonda un centinaio di metri, che fu paragonata<br />
a un canon. A mano a mano che il corso fluviale s’awicina alla bassa, il dislivello<br />
tra la superficie delle acque e il piano di campagna diminuisce. Tale dislivello è<br />
normalmente modellato in terrazzi multipli, più о meno ampi, più о meno evidenti,<br />
che nei fiumi maggiori, Ticino, Adda e Oglio, pur attenuandosi, si accompagnano<br />
per tutto il percorso, anche attraverso la bassa, sino al Po. L ’Olona e il Lambro,<br />
invece, dopo il tratto superiore profondamente incassato e nettamente terrazzato,<br />
raggiunto il limite alto dei fontanili, scorrono a livello del piano di campagna; solamente<br />
verso lo sbocco nel Po il loro corso riappare accompagnato da terrazzi. Non<br />
manca una giustificata spiegazione di tale morfologia: l’incassatura lungo il corso<br />
superiore fu interpretata come una ripresa della capacità erosiva delle acque dei<br />
131
Il grande fiume, già dàlia confluenza del Ticino, è accompagnato da argini,<br />
poiché durante le piene il suo livello sale sino a minacciare la pianura circostante;<br />
il pericolo maggiore delle piene si fa sentire sulla sponda cremonese e mantovana.<br />
A conclusione di tutto quanto esposto, è opportuno aggiungere alle iniziali<br />
alcune osservazioni di carattere generale. Come già s’è accennato la conca padanoveneta<br />
si presenta nei suoi tratti essenziali come un’immensa valle di cui la <strong>Lombardia</strong><br />
occupa il tratto medio del versante alla sinistra orografica. Questa posizione<br />
del territorio si riflette anche sullo sviluppo della sua rete idrografica; difatti la direzione<br />
dei corsi fluviali della <strong>Lombardia</strong> rispecchia il richiamo della duplice pendenza<br />
della grande valle padana: la pendenza assai marcata e generale (e quindi<br />
influente sull’intero corso dei fiumi) tra lo spartiacque alpino e il letto del Po, e<br />
la pendenza meno marcata (e influente solo sul corso inferiore) verso lo sbocco<br />
adriatico. In relazione a ciò, nel corso dei fiumi lombardi si possono distinguere<br />
due parti: quella che si incide nell’ambito della montagna e quella che si snoda<br />
nell’area di pianura; nella prima i corsi fluviali discendono verso il piano con un<br />
percorso vario condizionato almeno in parte dalle situazioni geologiche, strutturali<br />
e litologiche che hanno presieduto alla evoluzione dei solchi; nella seconda, non<br />
più impediti di secondare del tutto il richiamo della pendenza, discendono deviando<br />
lievemente e progressivamente dalla parte della foce del Po. Per tal ragione i maggiori<br />
fiumi presentano un parallelismo di percorso che, per quanto non rigido e totale,<br />
è pur sempre notevolissimo. Esso si manifesta nelle Prealpi e specialmente nella<br />
pianura; in quelle la direzione generale, non esclusi i laghi, è da nord-nordest<br />
Il Po con il ponte di barche presso Borgoforte.<br />
Fot. Sef<br />
Ш<br />
Ш<br />
I .<br />
:<br />
1 ■<br />
130
Fot. Sef<br />
La valle della Stàffora a Varzi.<br />
a sud-sudovest, in questa da nordovest a sudest formando quindi nell’assieme un<br />
ampio angolo ottuso con il vertice rivolto a ovest. Tale parallelismo presenta un<br />
particolare interesse nella fascia prealpina, per via delle possibilità di penetrazione;<br />
nella pianura, oltre che per la ripartizione del territorio che i fiumi, almeno i maggiori,<br />
determinano (Ticino, Adda, Oglio e Mincio segnano in parte il limite di<br />
provincia), anche in relazione alla tecnica di utilizzazione delle acque a scopo irriguo.<br />
Ma sotto tale aspetto giova ricordare un’altra caratteristica morfologica comune<br />
ai fiumi della <strong>Lombardia</strong> occidentale e ad alcuni dei loro affluenti. Dopo lo sbocco<br />
dai solchi vallivi о dai bacini lacustri prealpini, essi affondano il loro corso nelle<br />
alluvioni antiche о recenti, formando incisioni più о meno aperte e profonde<br />
parecchie decine di metri; tipico è il caso dell’Adda che corre per parecchi chilometri<br />
in una gigantesca trincea profonda un centinaio di metri, che fu paragonata<br />
a un canon. A mano a mano che il corso fluviale s’awicina alla bassa, il dislivello<br />
tra la superficie delle acque e il piano di campagna diminuisce. Tale dislivello è<br />
normalmente modellato in terrazzi multipli, più о meno ampi, più о meno evidenti,<br />
che nei fiumi maggiori, Ticino, Adda e Oglio, pur attenuandosi, si accompagnano<br />
per tutto il percorso, anche attraverso la bassa, sino al Po. L ’Olona e il Lambro,<br />
invece, dopo il tratto superiore profondamente incassato e nettamente terrazzato,<br />
raggiunto il limite alto dei fontanili, scorrono a livello del piano di campagna; solamente<br />
verso lo sbocco nel Po il loro corso riappare accompagnato da terrazzi. Non<br />
manca una giustificata spiegazione di tale morfologia: l’incassatura lungo il corso<br />
superiore fu interpretata come una ripresa della capacità erosiva delle acque dei<br />
131
Occhio di fontanile (pianura milanese).<br />
Fot. Bianchì<br />
fiumi a causa di un sollevamento generale della regione (avvenuto dopo la glaciazione<br />
Mindel); il terrazzamento, sempre nella stessa zona, come una successione di lunghi<br />
periodi di piene e di magre. I terrazzi verso la confluenza, invece, sono interpretati<br />
come adattamento del solco dell’affluente al livello del grande collettore. Mentre<br />
nei fiumi maggiori i terrazzi a valle si sono fusi con quelli a monte, nei fiumi minori<br />
il raccordo non è avvenuto, per cui il loro corso presenta una zona mediana non<br />
terrazzata.<br />
E comprensibile come nell’alta pianura, dove le esigenze di irrigazione sono<br />
notevoli, l’apporto di acque dai profondi solchi fluviali non sia stata impresa agevole:<br />
sono occorse infatti prese di canali assai a monte e un lungo percorso degli<br />
stessi lungo i terrazzi. Può servire come esempio la presa del Villoresi nel Ticino<br />
e lo sviluppo del canale parallelamente al fiume sin oltre Tornavento, a più di dieci<br />
chilometri dalla presa.<br />
Un’altra caratteristica importante, la quale ha riflessi non trascurabili sulla utilizzazione<br />
delle acque, risiede nel fatto che i quattro maggiori fiumi: Ticino, Adda,<br />
Oglio e Mincio sboccano nella pianura come emissari di grandi laghi e questi hanno<br />
una importante funzione regolatrice. Anzitutto con la loro estensione attenuano<br />
negli emissari gli effetti delle forti variazioni di portata cui sono soggetti i corsi<br />
d’acqua montani, alpini e prealpini; soprattutto smorzano la violenza delle piene.<br />
132
Inoltre, per la lunga permanenza nei bacini lacustri, le acque alpine perdono quella<br />
frigidità e quella torbidità tipica dei fiumi che si alimentano alle nevi e soprattutto<br />
ai ghiacciai. Gli emissari perciò convogliano verso il piano acque tiepide e limpide<br />
che tornano tanto utili a scopi irrigui e industriali.<br />
I fontanili.<br />
Il quadro delle acque superficiali non si esaurisce in <strong>Lombardia</strong> con l’esame<br />
della rete idrografica costituita dai fiumi e dai laghi; questa costituisce solo una<br />
parte dell’intricato reticolato che nella bassa i corsi d’acqua disegnano ad opera non<br />
solo dei fiumi ma anche dei canali derivati e dei fontanili. Secoli e secoli di tenace<br />
lavoro hanno domato la capricciosa irruenza о la limacciosa pigrizia delle acque,<br />
creando una fitta rete di canali di irrigazione e di scolo che, quasi sistema arterioso<br />
e venoso, raccolgono e distribuiscono le acque nella misura necessaria all’agricoltura.<br />
Ma di questa opera umana vien fatta illustrazione poche pagine appresso. Qui conviene<br />
attenersi al fatto idrologico d’ordine naturale costituito dai fontanili, le preziose<br />
sorgenti perenni e limpide che tanta floridezza hanno recato all’agricoltura lombarda.<br />
I fontanili, all’origine dei quali s’è accennato precedentemente, si manifestano<br />
in una fascia che dal Ticino al Mincio si distende nella parte mediana della pianura.<br />
Il limite settentrionale di essa è costituito da una spezzata che passa in prossimità<br />
di Magenta e Rho, s’incurva a sud di Milano, si snoda per Sesto San Giovanni,<br />
Melzo, Treviglio, s’insinua in corrispondenza del corso del Serio sino a nord di<br />
Martinengo, poi per Chiari, Bagnolo Mella e Castiglione delle Stiviere raggiunge<br />
il Mincio presso Volta. L ’ampiezza della fascia in cui si manifestano i fontanili è<br />
assai variabile; nel complesso è maggiore nella <strong>Lombardia</strong> occidentale meno nella<br />
orientale: tra la Sesia e il Ticino si può calcolare di una trentina di chilometri; tra<br />
il Ticino e l’Adda è, come massimo, di una ventina di chilometri; oltre Г Adda va<br />
via via riducendosi sino a un paio di chilometri о poco più al limite orientale. Il<br />
numero dei fontanili è difficile a precisarsi; un conteggio eseguito per la provincia<br />
di Milano ne assomma oltre 600 ed è certamente errato per difetto; sicché è presumibile<br />
che in tutta la pianura lombarda ve ne siano come minimo un paio di<br />
migliaia. Da notare che l’afflusso medio di acque per i 600 fontanili è computabile<br />
complessivamente in non meno di un centinaio di metri cubi al secondo, e quindi<br />
si può calcolare che il volume d’acqua donato da tutti i fontanili lombardi sia<br />
almeno pari alla portata media di un fiume come Г Adda! Queste considerazioni,<br />
sia pur tenendo conto della loro larga approssimazione, possono dar l’idea dell’importanza<br />
che i fontanili rivestono nel quadro idrografico della bassa.<br />
La variazione del flusso d’acqua con il variare delle stagioni non è molto forte;<br />
aumenta di riflesso all’aumentare delle piogge e alle piene dei fiumi e diminuisce<br />
133
in relazione al diminuire delle piogge о alle magre dei fiumi; ossia i fontanili hanno<br />
maggior volume di acque nella primavera inoltrata e nel tardo autunno. Allora<br />
l’occhio, com’è chiamata la polla sorgentizia, sgorga vigoroso ed è nettamente visibile<br />
sullo specchio d’acqua, per il pullulare rapido a simiglianza di acqua bollente.<br />
Riguardo poi alla temperatura dell’acqua, ripetuti esperimenti effettuati durante<br />
l’inverno hanno confermato che, con una temperatura dell’atmosfera in vicinanza<br />
del suolo di o°, e una temperatura del suolo in superficie di +o°,5, le acque dei<br />
fontanili hanno temperature oscillanti tra i + i o ° e i + 12 ° . Per contro, misurazioni<br />
compiute durante l’estate hanno dimostrato che con una temperatura dell’aria<br />
di + 24°, le acque conservano alla sorgente una temperatura di poco superiore a<br />
quella invernale e, pur potendo lungo le rogge assorbire calore, non raggiungono<br />
temperature di oltre + 16 -18 °. Sicché l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo è<br />
considerato prezioso soprattutto durante l’inverno e infatti sono proprio i fontanili<br />
che hanno favorito raffermarsi della marcita. Si comprende quindi come sin dall’antichità<br />
gli agricoltori abbiano favorito l’afflusso delle acque inserendo nel terreno<br />
tini senza fondo о tubi di ferro (ora anche di cemento), allargando la testa del<br />
fontanile con scavi, ampliando le aste di sfogo, ecc.<br />
Se le sorgenti di pianura costituiscono nel loro assieme un fenomeno di notevole<br />
importanza anche per i riflessi nel campo economico, è però da non dimenticare<br />
il gruppo assai numeroso e vario delle sorgenti della zona di montagna. Tra esse<br />
le intermittenti o, più propriamente, intercalari hanno attirato l’attenzione sin dal-<br />
134
Roggia di irrigazione<br />
nella bassa pianura.<br />
Fot. Stefani<br />
1 antichità ; la più illustre è quella detta Pliniana, perchè ne fecero cenno Plinio<br />
il Vecchio nella sua Storia Naturale (II, io6) e Plinio il Giovane nelle sue Epistole<br />
(IV, 30); essa suscitò la curiosità anche di Leonardo da Vinci. La fonte si trova<br />
nel parco della solitaria villa omonima sulla sponda orientale del secondo bacino<br />
del lago di Como; scende con un salto di circa 80 m. formando una bella cascata<br />
ora ricca ora povera di acque, la cui variabilità viene spiegata in connessione a irregolarità<br />
del corso sotterraneo, forse in parte con sviluppo a guisa di sifone, per cui<br />
le acque sgorgano più abbondanti quando il loro livello, colmato il sifone, supera<br />
il gomito superiore; esaurita la riserva il flusso s’attenua in attesa che il sifone<br />
nuovamente sia colmo.<br />
Ad irregolarità del corso sotterraneo è dovuta anche la variabilità del flusso della<br />
piccola sorgente del fiume Lambro che sgorga al Pian Rancio a 942 m. ; localmente<br />
è chiamata Menaresta, termine dialettale che vorrebbe significare l’aumento (mena)<br />
135
e la diminuzione (resta) di acque. La sorgente sgorga infatti ininterrottamente, ma<br />
con variazioni sensibili di quantità, non però a periodicità regolare. Aumento e diminuzione<br />
possono alternarsi nel volgere di uno stesso giorno о a distanza di più<br />
giorni. La media del flusso è di 30 metri cubi al giorno, con minimi di 9 e massimi<br />
di 90.<br />
Più spettacolare è il fenomeno del Fiumelatte cui fa cenno Leonardo da Vinci<br />
in una nota del Codice atlantico. La sorgente si trova sulla sponda orientale del lago di<br />
Como e più esattamente nel centro lago, a pochi chilometri a sud di Varenna. Il getto<br />
d’acqua compare d’improvviso a primavera da una piccola grotta a un centinaio di<br />
metri sopra il livello del lago; il flusso è notevole e scende ripido e impetuoso in<br />
bianca spuma, tanto da sembrare latte, come dice il nome. In autunno, al sopravvenire<br />
del gelo, la fonte s’inaridisce e per tutto l’inverno rimane asciutta. L ’esplorazione<br />
della cavità (1933) ha assodato che il Fiumelatte rappresenta lo sfloratore<br />
di un corso sotterraneo ad acque perenni, che s’arricchisce d’acque al sopravvenire<br />
dello sgelo e sfoga per mezzo della sorgente, pure perenne, detta Uga, dalla quale<br />
traggono alimento le cascatelle del parco di Villa Capuana.<br />
E ovvio che questi interessanti fenomeni rientrano nel quadro parzialmente noto,<br />
ma certamente grandioso, della circolazione profonda delle acque legata al fenomeno<br />
carsico, e quindi proprio della zona prealpina. Per quanto in <strong>Lombardia</strong> non si<br />
abbiano fenomeni così imponenti come nella Venezia Giulia, tuttavia non mancano<br />
esempi interessanti oltre che di sorgenti carsiche anche di laghi e di fiumi sotterranei.<br />
Come esempio più tipico si può ricordare l’abisso Rameròn nel monte Campo dei<br />
Fiori, con un laghetto e un corso d’acqua.<br />
136
Capitolo Q uinto<br />
IL CLIMA E LA VITA VEGETALE ED ANIMALE<br />
La <strong>Lombardia</strong>, sotto l’aspetto climatico, non presenta una propria individualità,<br />
ma partecipa delle condizioni generali per le quali si distingue l’area del bacino<br />
padano. Questo, allungato sul 45° parallelo nord, sotto il cui arco si snoda il Po,<br />
nei suoi tratti morfologici essenziali, si presenta costituito da un vasto bassopiano<br />
contornato da un’alta cerchia montuosa. Pianura e montagna costituiscono una<br />
distinzione fondamentale anche riguardo alla situazione climatica.<br />
L ’area di pianura manifesta dei caratteri climatici le cui generalità possono<br />
essere così riassunte in breve : le stagioni sono nettamente differenziate con<br />
estati calde e inverni rigidi, ma senza eccessi; però la notevole umidità accentua,<br />
specialmente sull’area irrigua della bassa, le caratteristiche stagionali, rendendo afosa<br />
l’estate e nebbioso l’inverno; le precipitazioni cadono in quantità moderata, più<br />
frequenti in primavera e in autunno, ma senza una forte differenziazione con le<br />
altre stagioni; i temporali estivi sono frequenti e spesso grandiniferi, le nevicate<br />
invernali meno frequenti ma immancabili. Nel complesso la pianura del Po, raccolta<br />
nel grembo dell’ampio arco montuoso formato dalle Alpi e dagli Appennini,<br />
da quelle parzialmente protetta dai rigori nordici e da questi preclusa ai tepori<br />
mediterranei, gode di quello che si suol definire come tipo moderato del clima<br />
continentale.<br />
Pur nel quadro della rilevata uniformità, è possibile tuttavia qualche lieve differenziazione,<br />
causata da fattori locali, con le regioni contermini: per l’aspetto termico,<br />
ad esempio, la pianura piemontese, rinserrata nella cerchia incombente dei più<br />
alti monti, ha in ogni periodo temperature medie inferiori, sia pur di poco, a<br />
quelle della pianura lombarda; ancor più accentuata è la diversità con la pianura<br />
137
veneta tutta aperta al respiro del mare e quindi con medie più alte di quelle lombarde.<br />
Altre lievi differenze sono connesse alla diversa quantità delle precipitazioni<br />
e al loro andamento: così la pianura lombarda gode nel complesso di un po’ più<br />
di piogge del Piemonte e dell’Emilia; inoltre, mentre nella pianura piemontese о<br />
almeno in parte di essa il massimo coincide con la primavera, nella pianura lombarda<br />
coincide con l’autunno; mentre qui il minimo coincide con l’inverno, nella pianura<br />
emiliana coincide con l’estate. Tali differenze, per quanto modesta sia la loro entità,<br />
possono tuttavia tornar utili per spiegare le variazioni di situazione nell’àmbito della<br />
stessa pianura lombarda, di cui si fa cenno appresso.<br />
Con caratteri suoi propri, nettamente diversi da quelli della pianura, è il clima<br />
della zona montuosa del sistema delle Alpi che, attraverso un graduale passaggio<br />
che interessa la fascia prealpina, manifesta verso il margine settentrionale della regione<br />
i tipici caratteri alpini, i cui fattori essenziali sono l’altimetria e l’esposizione, che<br />
si modificano notevolmente da luogo a luogo. Nel complesso si notano temperature<br />
medie più basse in rapporto con la maggiore altimetria, radiazione solare più intensa,<br />
frequente serenità durante l’inverno e frequente nebulosità durante l’estate. Le piogge<br />
generalmente sono più copiose che non nella pianura, ma variamente distribuite,<br />
più abbondanti sugli alti gruppi montuosi, meno nelle vallate; il massimo coincide<br />
con l’estate, il minimo con l’inverno.<br />
Ad ogni modo se i suddetti caratteri generali valgono in via di approssimazione<br />
anche per la <strong>Lombardia</strong>, il territorio di questa manifesta differenziazioni non trascurabili<br />
da luogo a luogo ed anche peculiarità di situazioni, quale quella dei laghi,<br />
che meglio risaltano se si procede ad esaminare separatamente i diversi elementi<br />
climatici.<br />
La temperatura.<br />
Nella pianura lombarda la temperatura media oscilla tra i + 13° e i +14°, valori<br />
che, per quanto acquistino significato soprattutto al confronto con quelli di altre<br />
regioni, sono comunque indicativi per confermare le ottime condizioni termiche<br />
in cui trovasi la nostra regione. Naturalmente anche per la media annua si notano<br />
differenze da luogo a luogo, ma non sono molto significative: lo scarto in più о in<br />
meno dalla media, in località anche lontane tra loro, è tutt’al più di un grado.<br />
Più interessante appare l’esame delle medie del mese più caldo e del più freddo;<br />
esso mette anzitutto in evidenza che, in generale, nel mese di luglio il termometro<br />
oscilla su una media di + 24°, nel mese di gennaio oscilla su una media di<br />
con una escursione termica media annua di 23°. Ovviamente le medie stagionali,<br />
estate e inverno, vedono attenuarsi tali valori, poiché i mesi che precedono e che<br />
seguono immediatamente il luglio e il gennaio registrano temperature rispettiva-<br />
138
Neve a Milano.<br />
Fot. Stefani
mente meno elevate e meno basse; così la media estiva è all’incirca sui + 2 2 ° e la<br />
media invernale sui + 3 °.<br />
Le medie suddette presentano tuttavia qualche lieve diversità da luogo a luogo;<br />
nel complesso si può dire che la fascia meridionale ha inverni più rigidi ed estati<br />
più calde, per contro la zona settentrionale ha estati non altrettanto calde e inverni<br />
non ugualmente rigidi. Infatti nella fascia che si allunga ai margini del Po tra il<br />
Cremonese e il Mantovano, corrispondente alla parte più depressa della bassa, la<br />
media di luglio si mantiene prossima ai + 2 5 ° (Cremona 24°,S; Mantova 24^,8);<br />
per contro, nella fascia che si stende ai margini delle colline la media dello stesso<br />
mese si aggira sui + 2 3 ° (Brescia 23L8; Bergamo 23°,o)> e nell’àmbito delle colline<br />
è anche minore (Varese i9°,9). Milano, che si trova approssimativamente in posizione<br />
intermedia tra le due zone suddette, ha nel mese di luglio una temperatura<br />
media di +24°,3-<br />
La bassa о meglio la zona del maggior caldo estivo è altresì la zona che nell’inverno<br />
ha il maggior freddo con medie di gennaio che sfiorano lo 0° (Pavia o°,2;<br />
Cremona o°,y; Mantova o°,8). Migliore è la situazione della zona settentrionale che.<br />
Lo specchio del lago Segrino (Prealpi comasche) gelato durante l’inverno.<br />
140
La temperatura media mensile<br />
a Milano calcolata nel periodo<br />
1838-1955 (Da L. Santomauro).<br />
Utet<br />
oltre a più fresche estati, gode di temperature invernali meno rigide, sui + 2 ° come<br />
media di gennaio (Brescia i°,8; Bergamo 2°,2; Varese io,8). Milano registra una<br />
media di gennaio di i°,2.<br />
Un comportamento analogo, ma assai più attenuato, presentano le temperature<br />
minime e massime giornaliere, ossia le medie dei valori estremi giornalieri. Tutta<br />
la pianura lombarda (oltre che, com’è ovvio, la montagna) ha minimi giornalieri<br />
normalmente al di sotto dello 0° durante tutto gennaio e per buona parte delle<br />
due quindicine che precedono e seguono il gennaio. A Milano la media mensile<br />
dei minimi del gennaio oscilla attorno ai — 3°; per la bassa è nel complesso di<br />
poco inferiore e nella collina, dove non raramente la superficie dei laghetti si copre<br />
di uno spesso strato di ghiaccio, è di poco superiore; in compenso la collina gode<br />
di una trasparenza maggiore dell’atmosfera e quindi, durante le ore di sole, di una<br />
breve parentesi di tepore, negata invece alla bassa dalla persistente coltre di nebbia,<br />
ciò che ostacola in essa lo scioglimento delle precipitazioni nevose. Lo constata in<br />
pratica chi, viaggiando, attraversa d’inverno la campagna lombarda: nella bassa permangono<br />
a distanza di tempo sul terreno (che non sia a marcita) spruzzate di neve<br />
che altrove si sciolgono entro pochi giorni dalla caduta.<br />
Le temperature massime giornaliere nella pianura cominciano a superare i + 2 4 °<br />
verso la fine di giugno e al di sopra di tale limite si mantengono sino a dopo la<br />
metà di agosto. La media delle massime giornaliere del mese di luglio oscilla<br />
attorno a + 3 0 ° per Milano ed è di poco superiore nella bassa e di poco inferiore<br />
nella collina. In compenso nella collina le notti sono fresche, mentre nella bassa permangono<br />
calde e afose.<br />
Se, procedendo, si prendono in considerazione i minimi e i massimi assoluti, il<br />
divario tra gli estremi è ancora maggiore. A Milano il minimo assoluto registrato<br />
141
nell’ultimo ventennio ha sfiorato i — 15° (1929 e 1933), nra, risalendo negli anni<br />
sino al 1838, si trovano minimi anche di — 17°, che sono meno eccezionali nella<br />
pianura della bassa e invece del tutto ignoti nella zona della collina, dove i minimi<br />
sono contenuti nei — 12°. Pure a Milano il massimo assoluto, negli anni dal 1838<br />
all’attuale, ha superato più volte i + 3 8 °; l’ultima volta nel 1947 con з8°,2. Anche<br />
nella zona della collina si sono registrati massimi di poco inferiori, mentre a Mantova<br />
si segnala un massimo di + 3 9 °,!.<br />
I laghi prealpini dal punto di vista termico costituiscono delle oasi di notevole<br />
mitezza e ciò in relazione alla presenza della massa stessa delle acque, le quali, per<br />
la capacità dei bacini e per la lentezza del ricambio, servono da regolatrici termiche<br />
attenuando i calori estivi e temperando i rigori invernali. La media della temperatura<br />
di gennaio sui grandi laghi, nei punti più favorevoli, è la più alta registrata<br />
in <strong>Lombardia</strong> oscillando tra i -Ьз° e i + 4 ° (Bellagio з°,8; Salò 4°,o), e ciò permette<br />
all’ulivo (e con qualche accorgimento anche agli agrumi) di prosperare lungo<br />
Coltivazione di limoni e cedri sul Garda (Limone sul Garda).<br />
Fot, Fracchi<br />
142
le sponde meglio esposte. Di luglio la media risulta pure attenuata rispetto a quella<br />
di pianura, ma poco differenziata da quella della collina, oscillando sui + 2 3 ° (Bellagio<br />
23°, i ; Salò 2q°,o), segno che l’influsso delle acque dei bacini lacustri è più<br />
sensibile d’inverno che d’estate. Tuttavia a rendere più gradevole l’estate sui laghi<br />
contribuiscono le brezze, a cui si accenna in sèguito.<br />
Nella zona di montagna le medie termiche annue e stagionali decrescono, com’è<br />
ovvio, in rapporto all’aumentare dell’altimetria, ma in misura differente a seconda<br />
delle particolari condizioni locali di esposizione, di morfologia, di ventilazione, ecc.<br />
Per quanto sia dunque difflcile generalizzare, è tuttavia possibile qualche osservazione<br />
d’insieme. Anzitutto si può notare, come indicazione generica, che la fascia<br />
montuosa delle Prealpi può essere considerata, anche sotto l’aspetto termico, di transizione<br />
tra la Padania e le Alpi ; è facile, ad esempio, che ivi le condizioni del bassopiano<br />
о dell’alta montagna, a seconda della direzione del vento, facciano sentire,<br />
per quanto in modo attenuato, la loro influenza; così avviene che nell’estate ondate<br />
di caldo risalgano dal piano verso le Prealpi о che ondate di freddo discendano verso<br />
di esse dai gruppi alpini.<br />
Naturalmente tutto ciò si risente soprattutto alle minori altimetrie, ossia soprattutto<br />
lungo i fondivalle, che, come la vai Brembana, la vai Seriana, ecc., s’incidono<br />
quasi rettilinei dallo sbocco verso settentrione. Verso l’alto questi influssi, più che<br />
per la temperatura, si possono manifestare con annuvolamenti, seguiti spesso da<br />
precipitazioni locali. Ma, a parte ciò, l’altimetria rivela chiaramente il suo predominio<br />
nell’andamento termico, e i relativi valori medi mensili e stagionali decrescono<br />
progressivamente in ragione dell’altezza. Come esempio, uno tra i molti, di<br />
località prealpine a media altimetria, si può indicare Collio a 840 m. in vai Trompia:<br />
ivi la media annua è di quella di gennaio di 0° e quella di luglio di - f i 8°.<br />
Nell’àmbito della regione alpina, appunto a causa dell’altimetria, i tronchi inferiori<br />
delle grandi vallate, i cui fondivalle si trovano a poche centinaia di metri sul<br />
mare, come ad esempio, il tratto longitudinale della Valtellina tra i 200 e i 400 m.,<br />
hanno inverni rigidi, ma estati piuttosto calde. Sondrio, ad esempio, ha di gennaio una<br />
media di + o °,2 e di luglio di + 2 2 °. Con l’altitudine le condizioni vanno rapidamente<br />
mutando e ai mille metri già si gode del tipico clima alpino: raggi solari<br />
brucianti per la secchezza dell’aria, ma nello stesso tempo temperature relativamente<br />
basse, rapida dispersione del calore al tramonto e temperature notturne assai<br />
rigide; il tutto relativamente alla stagione. Bormio, a 1225 m. in alta Valtellina,<br />
ha una media annua di + 8 ° ; in gennaio la media è di — 1°,4, mentre in luglio<br />
è di + 17 ° . Notevolissima l’escursione termica diurna: a Bormio d’estate si possono<br />
avere + 2 3 ° durante le ore più calde e + 2 ° durante le ore più fredde; d’inverno<br />
0° о anche qualche grado sopra lo zero (ma -f 16-18° al sole!) durante le ore<br />
più soleggiate, e — 20° durante la notte.<br />
La durata del gelo è pur essa in relazione all’altimetria. L ’osservazione di molti<br />
anni induce a ritenere che nell’àmbito alpino, a circa 1000 m. di altezza, il gelo si<br />
veriflchi tra la metà di ottobre e la metà di aprile per almeno 150 giorni di media.<br />
143
Consueto aspetto di Milano durante l’inverno.<br />
Qui, velata dalla nebbia, l’antica Basilica di Sant Eustorgio.<br />
Fot. Stefani
Con l’aunaentare deH’altimetna tale numero aumenta, con il diminuire della stessa<br />
decresce. A Sondrio, ad esempio, si contano 85 giorni, che è pur sempre una notevole<br />
media. Ma anche per la durata del gelo hanno un ruolo importante l’esposizione,<br />
la morfologia, la ventilazione. Per tale ragione maggiore è l’uniformità nell’àmbito<br />
della pianura: Milano, che è in posizione mediana, ha una media di 61 giorni di<br />
gelo, saltuari, nel periodo tra l’inizio di dicembre e la fine di febbraio. Nella bassa<br />
la media sale di circa 7 giorni, nella collina diminuisce invece di un egual numero.<br />
La frequenza delle brinate è notevole specialmente tra la fine di dicembre e l’inizio<br />
di febbraio e in tal periodo la vegetazione appare per lo più con il suggestivo<br />
rivestimento di minuscoli aghi di ghiaccio. Privilegiate anche sotto questo aspetto<br />
sono le zone dei laghi dove i giorni di gelo sono meno di una trentina (Salò 27) e<br />
le brinate, almeno lungo le sponde più favorite, sconosciute.<br />
Contrariamente alla zona alpina, dove l’umidità dell’aria è normalmente molto<br />
scarsa, la zona di pianura è notevolmente umida e ciò, oltre ad accrescere nell’uomo<br />
la sensibilità alle variazioni termiche, è causa delle nebbie che durante il periodo<br />
invernale stagnano lungamente spesse e opache, con grave danno per le comunicazioni.<br />
La nebbia è amica delle giornate serene e forma una coltre di un centinaio<br />
di metri, al di sopra della quale brillano il sole о le stelle. La zona più colpita è<br />
Fot. Taglibbue<br />
La nebbia, amica della « bassa », raramente raggiunge il piede delle Prealpi.<br />
Ecco l’inconsueto spettacolo visto dalle alture di Brúñate (Como).<br />
IO — Le Regioni d ’Italia ~ <strong>Lombardia</strong>.<br />
145
Um idità relativa<br />
Tem peratura<br />
/<br />
/<br />
/<br />
^<br />
26 ° C<br />
24<br />
22<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14 Z<br />
■-12<br />
10 ^<br />
5 I<br />
Andamento dell’umidità relativa e della<br />
temperatura media a Milano (Da L. Santomauro).<br />
G F M A M G L A S O N D G Utet<br />
quella della bassa, più ricca di acque superficiali, e in particular modo il Mantovano.<br />
Qui i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio assommano come media<br />
70 giorni di nebbia. A Milano, dove a render più densa la nebbia si associano il<br />
fumo dei camini e le polveri delle industrie formando il cosiddetto smog, nei<br />
quattro mesi suddetti si contano in media 38 giorni nebbiosi, ma il loro numero<br />
è estremamente variabile da un anno all’altro. Nell’alta pianura il numero dei<br />
giorni di nebbia diminuisce e sulla collina essa diventa una rarità. Talora il trapasso<br />
tra la zona coperta da nebbie e la contigua a nord priva di nebbie è netto.<br />
Attraversando la <strong>Lombardia</strong> nella direzione dei meridiani avviene, ad esempio, di<br />
lasciare una località della collina avvolta nel vivo sole e, al margine con l’alta pianura,<br />
di penetrare d’improvviso nella nebbia fitta in solo poche decine di metri di<br />
percorso. Anche nelle altre stagioni e nei giorni sereni, sulla pianura irrigua grava<br />
una coltre d’aria a notevole umidità; ma in luogo delle nebbie si forma una leggera<br />
foschia che vieta la visione, così bella, delle cerehie montuose delle Alpi e degli<br />
Appennini.<br />
Le precipitazioni.<br />
Le precipitazioni sulla regione lombarda, pur variando di quantità da luogo a<br />
luogo, sono nel complesso discretamente copiose. Dalla carta delle isoiete risulta<br />
che esse aumentano di quantità assai regolarmente dal Po alle Prealpi, mentre nelle<br />
Alpi presentano una distribuzione molto più varia. I minimi si registrano nell’area<br />
più depressa tra Mantova e Cremona con circa 600 mm. annui (Mantova 685 mm.).<br />
Da qui verso la collina (e anche verso l’Oltrepò pavese) la quantità annuale di piogge<br />
146
aumenta progressivamente e regolarmente. La isoieta dei 1200 mm. corre al limite<br />
tra la collina e le Prealpi. Milano, che si trova in posizione intermedia, ha una quantità<br />
media annua di 1000 mm. circa.<br />
Nelle Prealpi le piogge sono ancor più copiose che nella pianura e nel complesso<br />
aumentano progressivamente verso la zona più interna: così dai 1300 mm. di Como<br />
si passa ai 1500 mm. di Loveno (Bellagio), ai 2000 mm. di Dongo. Nè si tratta di<br />
Utet<br />
Carta delle precipitazioni.<br />
147
Preannuncio di temporale estivo sul Bernina (Piz d’Argient, 3943 m.).<br />
Fot. Prof. Corti<br />
una situazione particolare della zona, chè infatti nel cuore delle Prealpi del Varesotto,<br />
del Comasco e del Bergamasco si registra lo stesso aumento con medie anche<br />
superiori ai 2000 mm. (Foppolo 2073 mm.).<br />
Nelle Alpi le precipitazioni variano di quantità in modo sensibile da una località<br />
all’altra. Nel complesso si rileva una attenuazione, rispetto alle Prealpi, specialmente<br />
lungo i solchi vallivi e in particolare i tronchi di valli longitudinali, come ad esempio,<br />
la bassa Valtellina e l’alta Valcamònica, dove si hanno valori medi anche oscillanti<br />
sugli 800 mm. (Tirano 800 mm. ; Temù 800 mm.). Sugli alti gruppi montuosi,<br />
coronati di frequente, soprattutto in estate, di grandiosi annuvolamenti, le precipitazioni<br />
sono invece nuovamente copiose; nei gruppi del Bernina, del Disgrazia,<br />
deirOrtles la quantità media può raggiungere anche i 2000 millimetri. Infatti, osservazioni<br />
pluriennali segnalano, ad esempio, 1950 mm. al San Gottardo, 2500 mm. allo<br />
Spinga, ecc., ma i dati hanno valore relativo per il giuoco dei venti che in montagna<br />
modifica le quantità di precipitazioni tra luoghi anche vicinissimi.<br />
148
Dal quadro, pur così rapidamente delineato, della piovosità nella nostra regione,<br />
risulta che la sua distribuzione quantitativa ha un nesso evidente con l’orografia.<br />
L ’alta pianura e la collina godono di maggior copia di precipitazioni che non la bassa<br />
e ciò compensa in parte della rispettiva composizione dei suoli : mentre infatti, come<br />
già s’è accennato, la collina e l’alta pianura costituiscono un’area di imbibizione<br />
per la prevalenza di terreni permeabili, la bassa, per la prevalenza di terreni impermeabili,<br />
costituisce un’area di drenaggio. Le Prealpi vantano le più vaste aree di<br />
maggior piovosità. Esse, con il loro sia pur graduale ma netto emergere dalla zona<br />
della collina, provocano un brusco innalzamento dei venti umidi meridionali e<br />
quindi l’avvio di quella catena di fenomeni meteorologici che dà luogo alla pioggia.<br />
Nell’àmbito delle Alpi, infine, le sensibili variazioni locali si spiegano con il fatto<br />
che i venti sia settentrionali che meridionali giungono alla fascia più interna già<br />
impoveriti di umidità a causa delle precedenti precipitazioni marginali prealpine;<br />
perciò le precipitazioni si conservano copiose soltanto dove l’altimetria, accentuandosi,<br />
determina ulteriormente la condensazione.<br />
Le copiose piogge primaverili e il contemporaneo scioglimento delle nevi<br />
aumentano il livello dei laghi talvolta in misura così eccezionale da determinare allagamenti,<br />
come questo della piazza Cavour a Como.<br />
Fot. Publifoto<br />
4 9
Riguardo alla distribuzione mensile della piovosità, dall’esame delle tabelle statistiche<br />
(nonostante la diversità di livello dei valori locali che esse presentano) si<br />
rileva immediatamente una prima caratteristica generale a tutta la regione lombarda<br />
e cioè che la stagione meno copiosa di piogge è l’inverno. Rispetto all’epoca dei<br />
massimi di piovosità si possono poi individuare due regimi principali: uno con un<br />
solo massimo durante l’estate, ed uno con due massimi in primavera ed in autunno:<br />
il primo è propriamente un regime continentale, l’altro può essere indicato come<br />
un regime sublitoraneo. Il regime continentale si estende nell’area occupata dal versante<br />
alpino; il regime sublitoraneo si espande su tutta la pianura: il passaggio<br />
dall’uno all’altro è ovviamente graduale e una indagine particolarmente dettagliata<br />
permetterebbe di distinguere un tipo di transizione.<br />
Nell’area di pianura e di parte delle Prealpi, a regime sublitoraneo, l’andamento<br />
mensile delle piogge presenta i due massimi in coincidenza, senza eccezioni, con<br />
il maggio e con l’ottobre, con una lieve prevalenza di quantità di piogge nel primo<br />
dei due suddetti mesi per la maggior parte delle località pedemontane e di pianura.<br />
Il minimo invernale, che è pure il principale, coincide con il mese di gennaio,<br />
mentre il minimo estivo ha luogo per lo più in agosto e si accentua specialmente<br />
nella bassa dove in alcuni luoghi eguaglia, per quantità, il minimo invernale.<br />
Nell’area a regime continentale, e cioè nell’àmbito delle Alpi, il massimo di piovosità<br />
coincide con l’agosto, però con quantità che superano di poco quello del<br />
luglio. In alcune località marginali dell’area alpina, poi, per l’influsso dell’area a<br />
regime sublitoraneo si veriflca un massimo secondario in ottobre e, in alcuni casi,<br />
come ad esempio a Sondrio, questo massimo si accentua tanto da soverchiare<br />
quello estivo.<br />
È ovvio che nella zona di montagna le precipitazioni nevose siano, durante la<br />
cattiva stagione, del tutto normali; ma naturalmente in ciò ha un peso preponderante<br />
l’altimetria. Sui rilievi alpini, a un livello di 1500 m., le precipitazioni cadono<br />
di norma sotto forma di neve dal mese di novembre sin verso la metà di aprile,<br />
e il mantello nevoso permane per sei о sette mesi; ma già ai 2000 m. si ha un<br />
anticipo ad ottobre e un posticipo a giugno, sicché le strade dei passi, che sono in<br />
genere poco al di sopra di tale altimetria, rimangono chiuse per otto mesi dell’anno,<br />
a meno che, come avviene per il passo di Foscagno, non si ricorra agli spazzaneve.<br />
Verso i 1000 m., invece, la neve può far la sua comparsa in novembre, ma, sia<br />
per la meno rigida temperatura, sia per le piogge che vi si intercalano, per solito<br />
non resiste sul terreno. L ’innevamento vero e proprio comincia con il dicembre e<br />
si protrae sino all’inizio d’aprile. E ovvio però che tale situazione vari notevolmente<br />
da anno a anno e da luogo a luogo in relazione alla quantità delle precipitazioni<br />
e all’esposizione. In situazione press’a poco analoga si trovano le Prealpi per<br />
la parte altimetricamente al di sopra dei 1500 m. ; verso i 1000 m. e soprattutto<br />
al di sotto, pur avendo anche qui un ruolo preponderante la quantità annua delle<br />
precipitazioni nevose e l’esposizione, si può dire che, in generale, per l’alternarsi,<br />
anche in pieno inverno, delle precipitazioni nevose e piovose, il mantello di neve<br />
150
Disgelo primaverile di un laghetto alpino nell’alta Valcamònica.<br />
Fot. Stefani
Giorni<br />
12<br />
Media mensile dei giorni di precipitazioni liquide,<br />
di precipitazioni nevose, di manifestazioni temporalesche<br />
e di grandinate a Milano. Medie<br />
dell’Osservatorio di Brera, calcolate da L. Santomauro<br />
tra il 1763 e il 1955.<br />
I, numero dei giorni di precipitazione; 2, numero dei<br />
giorni di neve; 3, numero dei giorni di temporale;<br />
4, numero dei giorni di grandine.<br />
G F M A M G L A S O N D<br />
non resiste a lungo. Ad ogni modo in marzo esso normalmente scompare. Sulla<br />
pianura le nevicate possono verificarsi da dicembre a febbraio, eccezionalmente<br />
prima о dopo; sono nel complesso poco frequenti, ma è difficile che un inverno<br />
trascorra senza neve. I dati di un cinquantennio per Milano dimostrano che la<br />
neve è mancata un solo anno e che negli altri anni, per i quali s’ebbe una media<br />
di otto giorni di neve, la quantità media annua fu di 38 cm. con un massimo, in<br />
verità eccezionale, di oltre un metro nel 1947. Ad ogni modo la neve non resta<br />
lungamente sul terreno, salvo che nel gennaio.<br />
I temporali sono frequenti in tutta la <strong>Lombardia</strong> e specialmente nella zona pedemontana<br />
dove si registrano, come media, più di trenta giorni all’anno, media tra<br />
le più elevate d’Italia. Le manifestazioni temporalesche sono limitate al periodo<br />
compreso tra l’aprile e l’ottobre, con un massimo di frequenza nel mese di agosto.<br />
La grandine, purtroppo non raramente, accompagna le manifestazioni specialmente<br />
nella zona al margine delle Prealpi con prevalenza nei mesi di giugno, luglio<br />
e agosto. Talvolta i chicchi di grandine sono anche di notevolissimo peso: a Como<br />
si ricordano le grandinate del 1950 e del 1951 con chicchi di 700 e più grammi,<br />
che recarono gravi danni anche a edifici civili e industriali. Per porre riparo a<br />
tale flagello, soprattutto a difesa dell’agricoltura, vengono ora sperimentati i razzi<br />
antigrandine su larghi spazi della pianura e della collina, con risultati ancora molto<br />
incerti.<br />
Nel complesso i giorni di precipitazione durante l’anno variano sensibilmente<br />
da zona a zona. La media per Milano, calcolata su un periodo di oltre un secolo,<br />
è di 107 giorni e cioè poco meno di un terzo dell’anno, e, in genere, la parte mediana<br />
della pianura lombarda ha una media oscillante attorno a 100 giorni all’anno. Questi<br />
sono distribuiti quasi ugualmente tra le diverse stagioni, ma con sensibili differenze<br />
152
da mese a mese: maggio denuncia un massimo e febbraio un minimo. Il numero<br />
complessivo dei giorni di pioggia da questa fascia mediana di pianura decresce tanto<br />
verso la bassa (85 giorni) come e soprattutto verso la montagna (75 giorni). In<br />
quest’ultima zona, in compenso, cresce sensibilmente l’intensità delle precipitazioni,<br />
che nella pianura, durante le stagioni di transizione e specialmente l’autunno, sono<br />
invece minute, insistenti e fastidiose.<br />
Fot. Publifoto<br />
Grandinata a Milano.<br />
153
I venti.<br />
Riguardo ai venti la <strong>Lombardia</strong> è nel complesso una zona assai tranquilla.<br />
Sulla pianura spirano venti irregolari, normalmente moderati, di provenienza<br />
variabile tra luogo e luogo. Nella fascia della « bassa », soffiano in prevalenza da ovest<br />
d’inverno e da est d’estate. Durante l’inverno anche a Milano prevalgono venti occidentali,<br />
ma nelle altre stagioni si fanno più frequenti i venti da sudest; tali venti<br />
del secondo quadrante accentuano la loro frequenza sull’alta pianura. Nel complesso,<br />
come s’è accennato, si tratta di venti moderati : a Milano la velocità media è di 6 chilometri<br />
orari e la media massima di 20 chilometri. I mesi più ventosi per tutta la<br />
<strong>Lombardia</strong> sono il marzo e l’aprile; i meno ventosi l’agosto e il novembre.<br />
In generale i venti occidentali sono capricciosi, fastidiosi e spesso anche impetuosi;<br />
i venti settentrionali sono apportatori di sereno, i venti meridionali di pioggia.<br />
A proposito di questi ultimi si può notare come dal loro urto contro la montagna si<br />
Incendio primaverile del bosco ceduo sulle pendici del monte Nuvolone,<br />
nelle Prealpi comasche.<br />
Fot. Moser<br />
T54
Lo specchio del lago di Como increspato dalla breva.<br />
Fot. Stefani
determinino facilmente formazioni nuvolose che avvolgono anzitutto le cime; il contadino<br />
e il montanaro indicano pertanto tale segno come premonitore di prossime<br />
piogge; sicché non mancano detti dialettali, suggeriti dall’antica saggezza, che avvertono<br />
del fatto.<br />
Talvolta durante l’inverno, e particolarmente all’inizio di esso, spira sulla nostra<br />
regione il föhn che proviene da oltralpe. E tiepido e secco, perciò dannoso all’agricoltura,<br />
perchè prosciuga il terreno; è anche pericoloso, perchè può suscitare incendi<br />
nei boschi. Di solito dura due о tre giorni, dopo i quali sopravvengono annuvolamenti<br />
più о meno intensi.<br />
Nelle vallate sensibili sono le brezze. Le brezze di valle risalgono verso i monti<br />
dal tardo mattino sin verso il tramonto; le brezze di monte discendono dai monti<br />
da sera sino a mattino inoltrato. Sui laghi, ove, soprattutto nel passato, avevano un<br />
ruolo di notevole importanza nella navigazione, prendono denominazioni particolari:<br />
così la brezza di monte è detta tramontana sul lago Maggiore, tivàn (o tivano) sul<br />
Fot. Cartiera Vita Mayer<br />
156<br />
La brughiera a Tradate con<br />
predominio del pino silvestre.
lago di Como e sul lago di Lugano, sòver (o sòvere) sul lago d’Iseo e sul lago di<br />
Garda; la brezza di valle a sua volta è detta inverna (o verna) sul lago Maggiore,<br />
breva sul lago di Como e sul lago di Lugano, ora sul lago d’Iseo e sul lago di Garda.<br />
In conclusione, nell’àmbito delle due regioni climatiche in cui si suddivide, a<br />
causa soprattutto dell’altimetria, il territorio lombardo, si rilevano delle differenze<br />
termiche e pluviometriche, che, per quanto si tratti di sfumature, permettono di<br />
individuare delle subregioni, determinate in parte dalla gradualità stessa del fattore<br />
altimetrico.<br />
Così una sensibile differenza si rileva tra la pianura vera e propria e la collina.<br />
La pianura si distingue per gli inverni aspri, nebbiosi e poveri di piogge, le primavere<br />
e gli autunni capricciosi e moderatamente piovosi, le estati afose, temporalesche<br />
e velate. La collina, invece, si distingue per gli inverni rigidi, sì, ma asciutti<br />
e rallegrati da cieli limpidi e da ore diurne di piacevole tepore; da estati calde e<br />
anche più temporalesche, ma rese gradevoli dalla frescura serótina e notturna; da<br />
primavere e autunni pure capricciosi, ma più copiosi di piogge.<br />
NeU’àmbito della montagna poi v’è una gradualità di passaggio in relazione<br />
all’altimetria, che permetterebbe di fare distinzione tra la fascia basale о dei fondivalle,<br />
la fascia montana о dei versanti e la fascia culminale о delle più alte montagne.<br />
Ma per altro verso si può almeno fare una distinzione tra la zona prealpina e quella<br />
alpina, chè infatti nella prima si manifestano influenze sensibili delle due aree adiacenti,<br />
la pianura e l’alta montagna, ed essa rappresenta tra queste quasi un’area di<br />
transizione; infatti, se dal lato termico manifesta chiara preponderanza soprattutto<br />
il carattere montano, dal lato pluviometrico predomina il regime di piogge che è<br />
proprio della pianura. Nelle Prealpi poi formano casi a sè le aree lacustri che rappresentano,<br />
sotto l’aspetto termico, quasi delle aree mediterranee, come chiaramente<br />
denuncia la stessa associazione vegetale.<br />
La vegetazione.<br />
Il rivestimento vegetale del suolo lombardo, nonostante la limitata estensione<br />
della regione, appare mutevolissimo in relazione appunto alla variabilità delle caratteristiche<br />
climatiche che, sia pure per sfumature, differenziano un’area dall’altra,<br />
tanto più che ad accentuare tale mutevolezza ha contribuito l’opera secolare dell’uomo.<br />
L ’uomo, sradicando alcune specie per favorirne altre, ha risparmiato soltanto<br />
i lembi meno adatti alla trasformazione. Sotto questo aspetto si può ricorrere ancora<br />
alla distinzione in due zone; la zona di pianura, dove l’aratro ha quasi totalmente<br />
cancellato le vestigia del mantello floristico spontaneo, e la zona di montagna, dove<br />
persistono per più aree i residui del mantello vegetale originario che con diversa<br />
associazione può prosperare alle diverse altezze,<br />
IS7
La pianura lombarda, così come quella padana, quando i primi uomini si affacciarono<br />
ad essa, era per la maggior parte coperta dalla foresta, costituita prevalentemente<br />
da querce, tigli, faggi, castagni e olmi. Essa si espandeva fitta e intricata,<br />
dominio di cervi, di caprioli e di cinghiali; diradava ai margini degli specchi d’acqua,<br />
fiumi, laghi e acquitrini (ai cui bordi, nel Neolitico, si stanziarono i palafitticoli).<br />
Tale rimase per millenni, e anche nell’epoca romana fu sostanzialmente rispettata.<br />
Ancora nel V secolo d. C., Sidonio Apollinare ricorda il fitto rivestimento di querce<br />
e di aceri delle sponde della cerulea Adda e del pigro Mincio. Non fu certo la decadenza<br />
a sfoltire la pianura lombarda del suo fitto mantello, riserva di caccia dei<br />
feudatari gelosamente difesa; anzi è probabile che in quel lungo periodo anche le<br />
superfici che, già acquitrinose, erano state bonificate, per l’abbandono venissero<br />
in parte invase dalla boscaglia. Gli storici ci attestano che all’epoca di Teodolinda<br />
sui colli briantei eran vi silva et squallor, che nel 1090 nei boschi di Sèrmide nel<br />
Mantovano abbondavano i cervi, che ancora nel 1300 i Bergamaschi invocavano<br />
la liberazione dalle torme di lupi che si annidavano nel folto. Ma già agli albori<br />
del millennio di cui s’approssima il tramonto, andava estendendosi il risanamento<br />
delle terre acquitrinose, si dava inizio al convogliamento delle acque e risorgeva<br />
l’agricoltura; si fa risalire, ad esempio, al secolo XII la sistemazione delle prime marcite,<br />
che nei secoli seguenti occuparono una larga fascia nell’area dei fontanili. Il<br />
bosco fu pertanto sacrificato, lentamente ma inesorabilmente, e prima che altrove<br />
nella bassa, tanto che, se i Gonzaga vollero aver « luoghi di cacce e di piaceri campestri<br />
» dovettero, nel 1615, costituire il Bosco Fontana alle porte di Mantova. Nella<br />
pianura asciutta invece il bosco ebbe più lunga vita e ancor verso la metà dello<br />
scorso secolo si conservavano tra Bollate e Garegnano gli ultimi lembi dei boschi<br />
della Merlata, che dalle porte di Milano si stendevano verso settentrione. Attualmente<br />
i boschi nella pianura, se si escludono i rari parchi, son limitati ai pianalti<br />
ferrettizzati, alle alte ripe e alle golene lungo il corso dei fiumi, e, in qualche parte,<br />
alle colline; ma nessuno tra essi conserva intatta la composizione primitiva, neppure<br />
la brughiera dove, come in altri luoghi, si è diffusa, prevalendovi, la robinia<br />
(Robinia pseudacacia) introdotta in <strong>Lombardia</strong> nel secolo XVIII. Comunque le<br />
brughiere rimangono le zone a boscaglia di maggiore estensione e di aspetto<br />
più selvaggio.<br />
Per quanto l’opera di bonifica ne abbia ridotta l’estensione, esse invadono<br />
ancora i pianalti e le ondulazioni ferrettizzate del Varesotto, del Comasco e, per<br />
qualche tratto, del Bresciano, più ostiche all’aratro e meno accessibili all’irrigazione.<br />
Tra le specie vegetali più tipiche, oltre la invadente robinia, prevalgono il pino silvestre<br />
(Pinus silvestris), già presente allo stato spontaneo ma propagato forse durante<br />
il regno di Maria Teresa, la farnia (Quercus pedunculata), il castagno (C astanea sativa),<br />
più raramente la betulla (B etu la pendula), e altre specie meno frequenti, che la scure<br />
periodicamente sfoltisce; esse dominano su un sottobosco costituito in prevalenza<br />
dal brugo (C alluna vulgaris), che in autunno, con la fioritura, accresce la melanconia<br />
dei luoghi con la sua veste rosa-viola, e dalla ginestra dei carbonai (Sarotham nus<br />
158
scoparius) che invece, di primavera, con i suoi fiori giallo-oro porta una nota vivace,<br />
dalla felce aquilina {Pteridium aquilinum), dalla molinia (M olinia caerulea), ecc.<br />
Del tutto diversa è la cosiddetta « brughiera di Montechiari », chiamata più<br />
propriamente « campagna » bresciana, che ha qualche analogia con i sabbioni della<br />
Lomellina; si tratta in realtà di modeste estensioni di alluvioni ghiaiose lievemente<br />
ferrettizzate con un mantello di stentata e rada vegetazione erbacea costituita dal<br />
corineforo {Corynephorus canescens), dal panico glauco (Setaria glauca), dallo sdorano<br />
(Scleranthus annuus) e da altre specie xerofile, tra cui si fa strada la robinia.<br />
Nel paesaggio della bassa lombarda le specie arboree attualmente più comuni<br />
e più diffuse sono l’ontano (A lnus glutinosa), il salice (S a lix aurita) e il pioppo;<br />
soprattutto quest’ultimo nelle sue varietà (Populus alba e Populus nigra), oltre che<br />
in filari lungo le rogge, lo si vede di frequente in ordinati boschetti lungo i fiumi,<br />
perchè si dimostra particolarmente adatto ai suoli argillosi-sabbiosi che accompagnano<br />
i loro solchi. Si tratta naturalmente di piantagioni, utili ai fini industriali, che<br />
vengono rinnovate ogni quattro о cinque anni. Verso l’alta pianura insensibilmente<br />
il pioppo, l’ontano e il salice cedono il posto alla quercia (Quercus cerris e pedunculata)<br />
e all’olmo (Ulm us campestris) che nella collina s’associano al faggio, al castagno e<br />
Fot. Ispcttoiato Prov. Agricoltura<br />
Pioppeta nella « bassa ».<br />
159
alla roverella {Quercus pubescens), in trasgressione con il mantello vegetale delle prime<br />
pendici prealpine. Ma queste specie non caratterizzano il paesaggio come fa il pioppo<br />
nella bassa.<br />
Nell’àmbito prealpino le coste dei maggiori laghi costituiscono meravigliose oasi<br />
floristiche, che in botanica vengono distinte sotto il nome di Insubria; qui vengono<br />
armoniosamente a contatto le specie vegetali che ornano le sponde del Mediterraneo<br />
con quelle che avvolgono i fianchi delle Alpi. Il tepore che nell’inverno emana dalla<br />
massa d’acqua facendo delle sponde lacustri, о di parte di esse, quasi altrettante serre,<br />
permette al limone, all’arancio, al melograno di fruttificare, all’olivo, all’eucalipto,<br />
all’agave di prosperare, alla camelia, all’oleandro, all’acacia di fiorire. Ma a meglio<br />
definire l’aspetto floristico, più che la vegetazione d’importazione vale quella spontanea.<br />
Oliveti sul lago di Garda (Sirmione).<br />
Fot. Stefani<br />
160
Fot. Stefani<br />
Castagneto in Valtellina (Ardenno).<br />
Sulle sponde del lago di Garda, dove il clima è più caldo e più asciutto che sugli<br />
altri laghi, l’aspetto mediterraneo si rivela chiaramente nelle macchie cupe di lecci<br />
(Quercus ilex), nei profumati cespugli di rosmarino {Rosmarinus officinalis), nei colorati<br />
cespi di oleandro (Nerium oleander), nella ruta (Ruta graveolens), nella valeriana<br />
{Rhamnus alaternus), ecc.<br />
Sulle sponde del lago di Como e del lago Maggiore, che sono meno miti e più<br />
irrorate dalle piogge, l’associazione di specie termofile s’impoverisce, ma non mancano<br />
l’erica legnosa {Erica arborea), il tasso {Taxus taccata), l’agrifoglio {Ilex aquifolium)<br />
e altre specie più umili quali la nigella, i muscari {Mascari comosum e racemosum),<br />
il garofano delle certose {Dianthus carthusianorum), ecc. Per il carattere<br />
climatico dei bordi dei laghi sono stati costituiti parchi e giardini con piante esotiche<br />
che contribuiscono a rendere più ameno il paesaggio. Notevoli sono particolarmente<br />
quello di Villa Carlotta a Cadenabbia, famoso per le fioriture di azalee<br />
e di rododendri, di Villa Serbelloni a Bellagio, di Villa Taverna a Torno, di Villa<br />
d’Este a Cernobbio, sul lago di Como, di Villa Ciani sul lago di Lugano, ecc.<br />
Lungo il margine pedemontano e lacustre ha inizio il rivestimento floristico delle<br />
Prealpi che risale su per i pendi! sino a sposarsi con la tipica flora delle Alpi. Scom<br />
II — Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
l6 l
parso quasi del tutto dalla pianura, qui il bosco rimane ancora, ma assai depauperato.<br />
Purtroppo nel rivestimento arboreo la scure ha spesso portato devastazione, non<br />
solo per necessità, alle minori altitudini, di far posto ai coltivi, ma spesso, alle maggiori<br />
altitudini, anche per insano desiderio di guadagno. La decimazione culminò<br />
nello scorso secolo, che viene ricordato come il periodo di « fatale esterminio dei<br />
boschi resinosi ». Ad ogni modo nell’àmbito della montagna permangono ancora<br />
notevoli aree di vegetazione arborea. La successione altimetrica è quella nota per<br />
tutto l’arco alpino, però con limiti altitudinali degli orizzonti dei diversi piani, intermedi,<br />
in generale, tra quelli più elevati delle Alpi occidentali e quelli meno elevati<br />
delle Alpi orientali.<br />
Il piano submontano è caratterizzato dalle querce, quali la roverella (Quercus<br />
pubescens), la rovere (Quercus petraea), il cerro (Quercus c'erris), e dal castagno<br />
(Castanea sativa), associati al nocciolo (Corylus avellana), al carpino (O strya carpinifolia),<br />
al maggiociondolo (Laburnum alpinum), alla robinia, ecc., con un ricco<br />
sottobosco in cui, assai ricercato, fiorisce il ciclamino (Cyclam en europeum). Questo<br />
bosco assai vario di specie, alternato ai coltivi e ai prati, risale le pendici sin verso<br />
i 900 metri. Poi s’entra in un ambiente a carattere schiettamente montano (piano<br />
montano) caratterizzato dal faggio (Fagus silvática) che, per quanto non manchi<br />
anche a livelli inferiori, trova a queste altitudini il suo ambiente più adatto.<br />
Abetine, prati e pascoli a Borno in Valcamònica.<br />
Fot. Magnolini<br />
162
È però, com’è noto, un albero di notevoli esigenze, per cui è più frequente sui pendii<br />
delle Prealpi nè troppo caldi nè troppo freddi, specialmente meridionali e a suolo<br />
fresco e profondo. E meno frequente nell’àmbito alpino e, ad esempio in Valtellina,<br />
s’arresta verso Tirano, a causa probabilmente del föhn, che rende l’aria troppo secca<br />
per le esigenze della pianta. Nella stessa Valtellina l’altitudine superiore del faggio<br />
oscilla sui 1400 m., ma ormai associato all’abete bianco {Abies alba), conifera dal<br />
bel tronco diritto, dalle fronde cadenti, ornate di aghi pettinati. A l di sopra del<br />
limite del faggio, le conifere predominano incontrastate: ecco all’abete bianco associarsi<br />
il pino silvestre {Pinus silvestris), frequente nell’alta e media Valtellina, il<br />
peccio о abete rosso {Picea excelsa), il larice {L a rix decidua), il pino cembro {Pinus<br />
cembro,) i cui ultimi esemplari isolati si possono trovare nelle Retiche sino a<br />
2400 metri. Ma verso i 2200 m. il bosco di conifere cede ormai il dominio al<br />
piano culminale, con forme cespugliose di pino montano {Pinus montana), arbusti<br />
di ontano verde {A lnus viridis), rododendri {Rhododendron ferrugineum e hirsutum),<br />
ginepro nano {Juniperus nana), e successivamente ai pascoli.<br />
Naturalmente la successione altimetrica è tutt’altro che rigida, e in particolare<br />
nella <strong>Lombardia</strong> e nel Canton Ticino le specie di un piano si frammischiano a quelle<br />
di un altro. Questa interferenza è dovuta alle particolarità del clima, precedentemente<br />
indicate. In ogni caso è più facile trovare evasioni di specie dal proprio piano<br />
verso il basso che verso l’alto. Così, ad esempio, si incontra il faggio a soli 400 m. in<br />
vai Sabbia, l’abete bianco allo stesso livello presso Ludiana nel Canton Ticino e<br />
persino il rododendro a soli 300 m. a Orselina presso Locamo.<br />
La fauna.<br />
La <strong>Lombardia</strong>, già ricca nei suoi boschi di gran numero di esemplari faunistici,<br />
con il depauperamento del mantello vegetale, ha visto ridursi a quasi nulla le specie<br />
esistenti e molte del tutto scomparire.<br />
La fauna alpina è costituita da pochi esemplari di camosci, mentre manca del<br />
tutto lo stambecco. Anche l’orso è assente: l’ultimo esemplare fu catturato nel<br />
bosco di Suadilla in quel di Bormio all’inizio del secolo. Rarissima è la volpe e rari<br />
sono la lepre bianca e l’ermellino. Altri mammiferi ancora discretamente frequenti<br />
sono lo scoiattolo e la marmotta. Anche i volatili non si contano numerosi: la pernice<br />
e il fagiano sono le specie più soggette alla caccia; raro ormai è il francolino<br />
nei monti del Bresciano e l’urogallo nella Valtellina.<br />
Sulle Prealpi la fauna locale è ancor più povera: nelle macchie più solitarie si<br />
nasconde la lepre, soggetta, poiché è l’esemplare faunistico più appetito, a spietata<br />
caccia. Rarissima è ormai la volpe e rara la faina. Temuta e per fortuna non molto<br />
frequente è la vipera comune; per contro discretamente numerose sono altre specie<br />
163
di rettili innocui. Tra gli uccelli le specie più notevoli sono il merlo e la gazza, ma<br />
durante il passo la famiglia dei volatili si arricchisce notevolmente di tordi, storni,<br />
fringuelli, allodole, pispole, ecc., e ciò consente di mantener in vita i roccoli, caratteristici<br />
quartieri di caccia delle Prealpi.<br />
Anche la pianura ha una fauna poverissima. Ivi lepri, fagiani e storni, ecc., si<br />
trovano ormai solo nelle riserve di caccia; anzi, i fagiani sono allevati e lasciati in<br />
libertà appunto perchè anche le riserve non si spopolino. Anche qui però vi è il<br />
passo invernale di volatili, di anatre, di folaghe e di beccaccini lungo le sponde dei<br />
laghi intermorenici, dei fiumi e nelle marcite. Anzi le folaghe, assieme ad alcune<br />
specie di gabbiani, svernano sui laghi di Mantova.<br />
Di maggior significato è la fauna ittica dei fiumi e dei laghi. Nei torrenti e nei<br />
laghi di montagna vi sono esclusivamente la trota e il temolo, mentre nei fiumi di<br />
pianura abbondano i lucci, i cavédani, le tinche, gli spinarelli e le carpe, quest’ultime<br />
frequenti anche nelle acque delle rogge e nelle risaie. Ad essi, nel Po e nel corso<br />
inferiore dei suoi affluenti, si aggiunge lo storione, tuttavia non molto frequente.<br />
Nei laghi le specie ittiche sono maggiori: manca lo storione, ma sono frequenti<br />
il luccio, il cavédano, la tinca, lo spinarello, il barbo, l’anguilla, l’arborella, ecc. ;<br />
assai comune è l’agone, varietà di sardella che si è adattata bene nelle acque dolci,<br />
il persico e la trota di lago che può raggiungere un peso notevole. Vi sono poi specie<br />
importate dall’Europa centrale e dall’America settentrionale; tali il coregone о lavarello<br />
frequente nel lago di Como, il salmerino immesso nel lago Maggiore e nel<br />
lago di Lugano, la marena immessa nel lago di Monate, il persico-sole diffuso all’inizio<br />
del secolo in tutte le acque, ma piuttosto con danno perchè non commestibile e di<br />
rapida riproduzione.<br />
164
Capitolo Sesto<br />
LE SUDDIVISIONI TERRITORIALI<br />
Le regioni montane.<br />
L ’ambiente naturale che, come già s’è rilevato, presenta una notevole varietà<br />
di forme e di aspetti, offre la possibilità di distinguere nell’àmbito del territorio<br />
lombardo diverse aree con propria individualità. Ciò risulta indubbiamente più evidente<br />
là dove la morfologia è più mossa e più accentuata e dove quindi l’idrografia<br />
delinea bacini nettamente separati tra loro da alti rilievi. Oltre quindi la distinzione<br />
più volte accennata tra montagna, collina e pianura, si distinguono in particolare<br />
nella zona alpina e prealpina della <strong>Lombardia</strong> alcune regioni fisiche ben<br />
circoscritte, costituite dalle grandi vallate, le quali, per la loro stessa caratteristica<br />
naturale, hanno avuto in qualche caso trascorsi storici particolari e, forse anche per<br />
questo, manifestano un’individualità riguardo all’ambiente antropico. Tale è il caso<br />
soprattutto delle alte valli del Ticino e dell’Adda che, per essere nella parte più<br />
interna del sistema alpino, interposte tra due aree che furono teatro di vicende storiche<br />
diverse, sono state attratte ora nell’orbita politica dell’una e ora dell’altra ed<br />
hanno infine visto maturare nei loro riguardi un diverso destino: di autonomia cantonale<br />
nell’àmbito della Confederazione elvetica per le valli ticinesi, di aggregazione<br />
airitalia per la quasi totalità dell’alto bacino abduano.<br />
Per la Valtellina, quindi, diversi motivi concorrono a caratterizzarne l’individualità,<br />
ma, qual più qual meno, tutti subordinati a quelli fisici. Il grande solco<br />
percorso dall’Adda dalla testata al Lario, sotto l’aspetto geografico, forma con le<br />
valli confluenti una unità fisica nettamente delimitata dalla imponente cornice dei<br />
gruppi montuosi delle Reti che e delle Orobie, le cui creste svettano tra i 3000 e<br />
4000 metri. In esse s’avvallano diversi valichi transitabili nella buona stagione, e<br />
165
La valle della Mera dal laghetto di Mezzola.<br />
Fot. Stefani<br />
nella loro importanza si può trovar spesso ragione delle antiche contese per il possesso<br />
del territorio о di parte di esso. Per tali passi fluirono durante molti secoli il<br />
commercio e, con il commercio, le genti, per cui non parrebbe fuori di luogo cercare<br />
le tracce residue delle migrazioni da meridione e da settentrione nelle parlate<br />
e nei costumi locali.<br />
Sebbene associate spesso alla Valtellina, le valli diChiavenna non formano geograficamente<br />
un tutto unico con la vallata dell’Adda. Esse, infatti, costituiscono un’unità<br />
fisica a sè che ha in comune con il solco dell’Adda solo lo sbocco nel Lario, là dove<br />
un lembo del Pian di Spagna fa da sponda al corso della Mera. Per il resto l’ampia<br />
vallata detta, per il suo fondo pianeggiante. Piano di Chiavenna con le valli coni66
Veduta sul Lario da Lierna (ramo di Lecco).<br />
Fot. Stefani
Divisione della <strong>Lombardia</strong> in regioni e sottoregioni geografiche,<br />
storiche e tradizionali.<br />
fluenti, la vai Bregaglia e la vai San Giacomo, forma un’individualità che per molti<br />
aspetti, da quelli morfologici a quelli antropici, vuol essere considerata distinta da<br />
quella propriamente valtellinese. Riguardo alla storia le vicende della Valtellina e<br />
delle valli di Chiavenna si svolsero pressoché identiche. Per dirla in breve, la contea<br />
di Chiavenna e la Valtellina con la contea di Bormio furono contese nel Medioevo<br />
dal Vescovo di Como e da quello di Coira; entrambe divennero possesso dei<br />
Visconti nel 1335 e successivamente degli Sforza; nel 1512 passarono in possesso<br />
dei Grigioni e tali rimasero (salvo la parentesi seguita al Sacro Macello nel 1620)<br />
sino al 1797. Da quell’anno, incluse nella Repubblica Cisalpina, seguirono poi le<br />
168
sorti della restante parte della <strong>Lombardia</strong>. Ma da tal seguito di vicende tanto la<br />
Valtellina come le valli di Chiavenna non uscirono indenni, ossia non poterono conservare<br />
la loro integrità fisica e il confine politico attuale ne è la risultante. In<br />
conclusione, alla parte ora considerata della <strong>Lombardia</strong>, che s’identifica con la<br />
attuale circoscrizione provinciale di Sondrio, non par dubbio di poter riconoscere<br />
un’unità regionale in cui si possono distinguere come individualità distinte la Valtellina<br />
e le valli di Chiavenna.<br />
Non ugualmente semplice è l’individuazione di regioni nella zona alpina-prealpina<br />
tra la regione ora individuata e la pianura. Tuttavia, appoggiandosi anche alla tradizione,<br />
si possono distinguere: il bacino lariano, le valli bergamasche, la Valcamònica<br />
e le valli bresciane.<br />
Con il nome di bacino lariano si vuole indicare lo specchio del lago di Como<br />
e l’area montuosa circostante. In un quadro strettamente fisico evidentemente si<br />
dovrebbe limitare la sua superficie alla regione idrografica, ossia a quella parte del<br />
territorio che versa le sue acque nel lago; a tale esigenza risponde il limite orientale<br />
che corre tra il monte Legnone, il pizzo dei Tre Signori, il Zuccone di Campelli<br />
e il Resegone. Sul lato occidentale resterebbero invece escluse la valle Cavargna e<br />
la valle del Telo di Osteno, confluenti nel Ceresio e quella parte orientale del<br />
Ceresio stesso che il confine assegna all’Italia e a cui dà facile accesso la vai Menaggio.<br />
Ma necessità e tradizione consentono di aggregare questa parte minore alla maggiore<br />
in un tutto unico in cui domina come elemento principale il lago di Como,<br />
che costituisce la continuazione dei solchi delle valli dell’Adda e della Mera e, biforcandosi<br />
verso la pianura sulla quale si affaccia con i suoi apici meridionali di Como<br />
e di Lecco, rappresenta la più agevole via di penetrazione dalla pianura lombarda<br />
alle Alpi Retiche, alle sue valli e ai suoi valichi.<br />
Sotto questo aspetto al bacino del Lario si accosta la regione camuña, costituita<br />
dalla Valcamònica e dal lago d’Iseo. Essi, in prosecuzione l’uno dell’altra, s’interpongono<br />
tra le valli propriamente bergamasche e le valli propriamente bresciane,<br />
sicché il loro territorio fu causa di rivendicazioni delle due città. Nel 1863 la<br />
Valcamònica, nella sua quasi integrità idrografica, fu assegnata a Brescia (non senza<br />
proteste dei Bergamaschi) e il lago suddiviso longitudinalmente a mezzo. La<br />
Valcamònica, percorsa dall’Oglio, risulta ben circoscritta alla testata dalle dorsali<br />
che si dipartono dal corno dei Tre Signori e sui lati dall’Adamello e dalle Orobie<br />
e dai loro contrafforti meridionali. Unica complicazione è la profonda forra del confluente<br />
Dezzo, la quale, rendendo difficile l’accesso all’alta valle, è stata la causa<br />
per cui questa (facilmente accessibile dalla vai Seriana attraverso la Presolana) venne<br />
assegnata alla provincia di Bergamo, di cui tuttora fa parte. L ’alta Valcamònica<br />
vanta tre valichi: il Tonale, l’Aprica e il Gavia, dei quali i primi due sono particolarmente<br />
importanti per le comunicazioni con la vai di Sole e la Valtellina. Essi,<br />
favorendo la valle quale zona di transito (esempio ne sono i passaggi del Barbarossa<br />
nel 1158 e nel 1166), ne agevolarono nel corso dei secoli la sua partecipazione alla<br />
vita e alla storia lombarda. La Valcamònica termina, anche di nome, all’apice set-<br />
169
L ’alta Valcamònica<br />
(sullo sfondo a sinistra il passo del Tonale).<br />
Fot. Magnolini<br />
tentrionale del lago dTseo. Lo specchio lacustre si stende spazioso sul prolungamento<br />
del fondovalle, accompagnato da chiostre montuose su entrambi i lati, sino<br />
a Sàrnico e a Iseo, tra i quali si affaccia per largo tratto sulla conca padana. Nell’unità<br />
idrografica costituita dal bacino montano deU’Oglio è nel complesso necessario distinguere<br />
l’area della Valcamònica da quella del lago d’Iseo come distinte individualità.<br />
La regione costituita dalle valli bergamasche comprende la vai Brembana, la<br />
vai Seriana e la vai Cavallina, disposte una a fianco dell’altra tra il bacino lariano<br />
e la regione camuña e nel complesso convergenti verso Bergamo. Esse si differenziano<br />
dalla Valcamònica per una minore penetrazione verso la zona alpina; la<br />
vai Cavallina s’incide addirittura nella fascia marginale delle Prealpi. La più occidentale<br />
delle tre valli è la valle del Brembo о Brembana, che, per quanto notevolmente<br />
ramificata per numerose valli confluenti, risulta ben delimitata dalle Alpi Orobie<br />
che ne formano la testata e dai contrafforti che dalle Orobie si dipartono allungandosi<br />
verso sud: quello del Zuccone di Campelli-Resegone che fa da limite occidentale<br />
con il bacino lariano e quello Arera-Alben che fa da spartiacque tra il Brembo e<br />
il Serio. La continuità della cresta montuosa che l’attornia concede scarsi valichi e<br />
solo il passo di Gà San Marco divenne di intenso transito quando i confini della<br />
170
Repubblica veneta s’affacciarono sulla Valtellina tra il pizzo dei Tre Signori e il<br />
corno omonimo. La valle del Serio о Soriana, che affianca ad oriente il solco del<br />
Brembo, è la più importante delle valli bergamasche. Ha la sua testata nella parte<br />
più elevata delle Orobie e, nel suo percorso verso la pianura, è affiancata da alte dorsali<br />
che si dipartono dalla cresta oròbica. I valichi sono alti e non agevoli; solo nella<br />
media valle in prossimità di Clusone s’apre il solco che costituisce una duplice porta,<br />
aperta verso sudest, ossia verso la vai Borlezza e, per questa, verso il lago d’Iseo,<br />
e verso nordest, ossia attraverso il passo della Presolana, verso l’alta valle del Dezzo<br />
(o vai di Scalve), la cui forra paurosa, come già s’è accennato, ostacola nel tratto<br />
inferiore la transitabilità verso lo sbocco naturale in Valcamònica. Nel complesso<br />
le tre valli formano individualità distinte, ma per il fatto di gravitare, in relazione<br />
alla loro disposizione, verso Bergamo, vengono per tradizione associate.<br />
Fot. Stefani<br />
Alla testata della valle del Brembo.<br />
Sullo sfondo il pizzo dei Tre Signori.<br />
171
La sponda lombarda<br />
del lago di Garda dal<br />
santuario di Montecastello<br />
(m. 700) verso<br />
sud.<br />
Fot. Micheletti<br />
La stessa considerazione potrebbe valere per le valli propriamente bresciane,<br />
ossia la vai Trompia e la vai Sabbia, nei confronti di Brescia. La vai Trompia sbocca<br />
addirittura nel piano dove sorge la città. Essa giace racchiusa e ben delimitata dall’estrema<br />
biforcazione del contrafforte che dall’Adamello digrada verso sud e quindi<br />
modesta è la sua penetrazione nell’àmbito prealpino. Più ad oriente s’incide la tortuosa<br />
valle del Chiese; essa rientra in territorio lombardo solo con il tronco inferiore<br />
ossia quello che si sviluppa a valle del lago d’Idro e che costituisce la continuazione<br />
delle valli Giudicarie. Tuttavia, pur essendo parte di una unità idrografica, il tronco<br />
lombardo non manca di una propria individualità e si distingue anche per una propria<br />
denominazione, quella di vai Sabbia.<br />
Mancano nella divisione sin qui tracciata due aree, quella della montagna sulla<br />
sponda lombarda del lago di Garda e quella della montagna del Varesotto. La<br />
prima è evidente che non possa costituire di per sè un’unità integra d’ordine fisico,<br />
essendo parte della regione benacense. Cercando di conciliare le diverse esigenze<br />
con la tradizione, miglior soluzione sembra quella di aggregare in unità la zona<br />
montana e la zona collinare di tutta la sponda bresciana tra Limone e Desenzano,<br />
dividendo in essa, in corrispondenza di Salò, le due parti a diversa altimetria, come<br />
individualità distinte.<br />
Molto simile si presenta il quadro del territorio varesino. Anche qui la zona<br />
montana rappresenta una porzione di una regione che il confine scinde in due parti.<br />
Non resta quindi che indicare l’area, seeondo la tradizione, con la denominazione<br />
unitaria di Varesotto, distinguendo in essa la parte di montagna e la parte di<br />
collina.<br />
172
Le regioni di collina e di pianura.<br />
Se la natura, nell’ambiente alpino e prealpino, con la varietà di altimetria e di<br />
forme e la netta separazione di bacini idrografici, offre sostegno per una sicura individuazione<br />
di regioni minori nell’àmbito delle maggiori e di una loro suddivisione,<br />
nell’area della collina, e ancor più della pianura lombarda, essa concede scarsi appigli<br />
per una distinzione di tal fatta; l’unico elemento che si dimostri di qualche efficacia<br />
è il corso dei fiumi, ma i frequenti mutamenti territoriali determinati dal rapido<br />
evolversi delle vicende storiche non hanno consentito la formazione di unità regionali<br />
stabili. Si può dire che l’unico caso chiaro e netto della pianura lombarda è<br />
quello della Lomellina i cui limiti su tre lati sono ben delineati dal corso del Po,<br />
della Sesia e del Ticino.<br />
Il nome della Lomellina viene dall’antica mansio di Lomello, posta in posizione<br />
lievemente elevata sulla pianura, in un’ansa dell’Agogna. Lomello fu eretta, probabilmente<br />
da Carlo Magno, in comitato, il cui territorio si estendeva press’a poco<br />
entro i limiti quali oggi si assegnano alla Lomellina, con in più un’appendice oltre<br />
il Po e l’esclusione del Siccomario, che con le terre di San Martino e di Travacò<br />
formava il « verziere di Pavia ». Estesasi lentamente in epoca comunale la giurisdizione<br />
pavese, la Lomellina, nel secolo XIII, « uscì dalla nebula di generiche denominazioni,<br />
per assumere un valore di terra ben definita nei suoi limiti storico-geografici »<br />
(P. Landini). La sua unità venne spezzata nel 1532 da Francesco Sforza con la<br />
formazione del Contado di Vigevano, e la scissione venne accentuata nel Trattato<br />
del 1 703 con il quale veniva riconosciuta a Vittorio Amedeo di Savoia provinciam quae<br />
dicitur Lumellina, escludendo in tal espressione il territorio di Vigevano e del Siccomario<br />
(poi trasferiti ai Savoia nel 1743). La campagna napoleonica doveva tuttavia<br />
portare presto una radicale trasformazione} e nel 1800 tutta la Lomellina venne<br />
inglobata nella Repubblica Cisalpina. Ma si trattava di una breve parentesi che tuttavia<br />
doveva permettere, con il ritorno della Lomellina sotto i Savoia, la formazione<br />
della provincia di Lomellina (1818) che ricostituiva l’unità regionale. Nella sua integrità<br />
essa passerà poi, con l’unità d’Italia, a far parte della <strong>Lombardia</strong>.<br />
Nella pianura e nella collina lombarda non vi sono altre regioni ugualmente ben<br />
definite geograficamente e storicamente. Non possono essere infatti considerate unità<br />
geografiche neppure l’Oltrepò pavese e l’Oltrepò mantovano, la cui aggregazione<br />
alla <strong>Lombardia</strong> ha radici puramente storiche (che rimontano ai Comuni e alle<br />
Signorie), ma i cui limiti non trovano appiglio ad alcun elemento geografico. La<br />
loro storia rientra per lo più nella storia delle città e della supremazia da esse esercitata.<br />
Ed è per tal fatto che attualmente, se si vuol procedere ad una divisione in<br />
aree della pianura e della collina, non si può altrimenti procedere che attraverso<br />
173
ad una nomenclatura cittadina, consacrata dalla tradizione, per la quale le aree vengono<br />
indicate come Milanese, Mantovano, ecc., i cui limiti rimangono alquanto<br />
incerti. Procedendo in tal modo si possono distinguere il Varesotto, il Comasco,<br />
il Bergamasco e il Bresciano, il cui territorio si estende nella collina e nella parte<br />
settentrionale della pianura; il Pavese, il Lodigiano, il Cremasco, il Cremonese e<br />
il Mantovano, che si estendono nella bassa pianura, e infine il Milanese che si pone<br />
tra il Varesotto e il Comasco a nord, il Pavese e il Lodigiano a sud.<br />
Con il nome di Varesotto si indica il vasto territorio in parte montuoso e in<br />
parte collinare che si stende a oriente del lago Maggiore. Nei confronti del terri-<br />
Campagna di Lomellina.<br />
Fot. Sef<br />
174
Aspetto primaverile della pianura lombarda.<br />
Fot. Dulevant
torio comasco può servire come limite il confine provinciale, mentre, indipendentemente<br />
da questo, il limite meridionale sembra doversi arrestare al limite dell’anfiteatro<br />
morenico, chè ai piedi di questo già si entra nell’orbita di Milano, e ciò vai<br />
forse a spiegare l’antagonismo di Gallarate e di Busto Arsizio nei confronti del<br />
capoluogo della provincia di cui fanno parte.<br />
Anche il Comasco (sotto il cui nome s’intende spesso comprendere anche quella<br />
parte montana indicata più propriamente come bacino lariano) può avere un giusto<br />
limite meridionale in corrispondenza del margine del suo anfiteatro morenico.<br />
A oriente esso confina con la Brianza, di incerta estensione, ma che pare giusto<br />
limitare, come s’ accenna poco avanti, tra la valle del Lambro e il corso dell’Adda.<br />
Il Bergamasco o, com’è uso dire localmente, la Bergamasca (in cui va inclusa<br />
anche la parte montana precedentemente indicata con la denominazione di valli bergamasche)<br />
nella pianura si estende tra il corso dell’Adda e quello dell’Oglio e tra<br />
essi sino al limite della attuale circoscrizione provinciale.<br />
Il Bresciano include (oltre la parte montana dianzi indicata con il nome di<br />
valli bresciane) un’ampia porzione di pianura approssimativamente limitata dalrOglio<br />
e dal Chiese. L ’anfiteatro morenico del Garda, che pur fa parte del territorio<br />
di Brescia, come già s’è accennato, è preferibile includerlo nella regione<br />
individuata come sponda bresciana del Garda.<br />
Il Milanese è nettamente limitato ai lati occidentale e orientale dal Ticino e<br />
dall’Adda. Gli anfiteatri morenici ne indicano il limite settentrionale, una spezzata<br />
a sud di Binasco e di Melegnano il limite meridionale. Dal Milanese pare opportuno<br />
Campagna mantovana (Piètole).<br />
Fot. Calzolari<br />
176
Ville dl finanza: Villa Taverna a Canònica Lambro.<br />
Fot. Stefani<br />
12 — L e Regioni d ’Italia - Lonthardia.
distinguere, per ragioni di storia e di tradizione, il Lodigiano, che anche sotto<br />
l’aspetto geografico si distingue per limiti ben disegnati dall’Adda, dal Po e dal<br />
Lambro.<br />
Il Pavese, nella sua maggior estensione, comprende le terre dell’antico principato<br />
e quindi anche l’Oltrepò e la Lomellina; ma con più proprietà per territorio<br />
del Pavese propriamente detto deve intendersi quello compreso tra Ticino, Po e<br />
Lambro sino ai confini con il Milanese.<br />
A oriente dell’Adda, ben delimitato da questa, dal Po e, in parte, dall’Oglio si<br />
stende il Cremonese. Esso occupa la maggior parte della pianura; ma par giusto,<br />
per motivi storici e tradizionali, distinguerne da esso il Gremasco che occupa la<br />
porzione settentrionale a nord di Soresina e sino ai limiti con il Bergamasco.<br />
Infine vi è il Mantovano che occupa la parte a oriente del Chiese e dell’Oglio<br />
e che corrisponde approssimativamente all’antico ducato dei Gonzaga. Il suo territorio<br />
è attraversato dal Po e dal Mincio sicché si suole distinguere l’Oltrepò e<br />
l’Oltremincio mantovano dal Mantovano propriamente detto.<br />
Dopo aver accennato in precedenza alle regioni individuabili nell’àmbito della<br />
<strong>Lombardia</strong> in base a criteri geografici о a motivi storici e avere tentato la divisione<br />
in aree, cercando ove possibile appiglio all’uno e all’altro dei suddetti criteri (non<br />
certo con la pretesa di aver fugata ogni perplessità, soprattutto riguardo ai limiti,<br />
per carenza di situazioni ben definite), pare a questo punto opportuno dar notizia<br />
di una regione lombarda, la Brianza, nata esclusivamente dalla tradizione. Essa si<br />
stende ad occidente dell’Adda che è l’unico limite certo del suo territorio. Pare che<br />
il suo nome derivi da un colle e da un villaggio che già in antico sorgeva ai piedi<br />
di esso, e se ne ha conferma nei più antichi documenti come quelli dell’Sió in cui<br />
si menziona un locus Brianzola e del 1107 in cui si accenna a un «loco seu monte<br />
qui dicitur Briantiae». È probabile che il nome dal colle e dal villaggio si estendesse,<br />
per vicende che restano ignote, al territorio circostante, tanto che dagli atti<br />
ducali del secolo XV si accenna a un vicariato о Universitas del Monte di Brianza<br />
nell’àmbito della Martesana (come si chiamava il contado a nord di Milano). Ma<br />
l’estendersi del nome a più vasta regione continuò nel tempo, poiché, mentre nel<br />
Quattrocento al vicariato si assegnava un territorio collinare tra l’Adda e il Lambro,<br />
nell’Ottocento si credeva di potervi includere anche l’oltre Lambro sino alle porte<br />
di Como e di Séveso. Ai giorni nostri poi si vorrebbe da alcuni, non, senza esagerazione,<br />
far giungere la Brianza sino al canale della Martesana e alle porte di Milano<br />
e aggregarvi Lecco. Nel complesso parrebbe ragionevole limitare la Brianza a una<br />
area più omogenea rispetto alla morfologia e quale le antiche carte ci additano,<br />
ossia alla collina dell’anfiteatro morenico abduano alla destra dell’Adda.<br />
178
La divisione amministrativa.<br />
La divisione della <strong>Lombardia</strong> in province, attualmente in atto, può dirsi il risultato<br />
di una serie di mutazioni compartimentali attuate successivamente per esigenze<br />
e sollecitazioni diverse e con variazioni territoriali più о meno radicali da quelle<br />
preesistenti. Senza voler rimontare troppo nel tempo, basterà ricordare l’editto<br />
del 1786 (che si inserisce nel quadro più ampio delle riforme politiche di Giuseppe<br />
II), con il quale veniva dato un forte impulso « al processo di formazione<br />
dell’entità territoriale provincia, accogliendone anche formalmente per la prima volta<br />
la denominazione» (M. Romani). Per tale editto la <strong>Lombardia</strong> austriaca veniva distinta<br />
in otto province aventi come capoluoghi Como, Gallarate, Milano, Lodi, Pavia, Cremona,<br />
Mantova, Bózzolo. Successivamente (1787) venivano soppresse le province<br />
di Gallarate e di Bózzolo e i loro territori venivano incorporati rispettivamente nelle<br />
province di Como e di Mantova.<br />
Con l’avvento della Repubblica Cisalpina tale ordinamento venne sostituito da<br />
una suddivisione dipartimentale, che fu soggetta, per il rapido succedersi degli<br />
avvenimenti politici, a diverse mutazioni. La prima Costituzione del giugno 1897<br />
Utet<br />
I dipartimenti lombardi del<br />
Regno italico.
stabiliva la divisione in otto compartimenti, portati nel novembre (a seguito della<br />
Pace di Campofòrmido) a dodici, ridotti, nemmeno un anno appresso, a sei. Solo<br />
con la formazione del Regno italico si ebbe una fase di stabilità. I compartimenti,<br />
portati a sette, poterono avere allora una vita decennale; essi erano: il Dipartimento<br />
dell’Adda con capoluogo Sondrio, il Dipartimento del Lario con capoluogo Como,<br />
il Dipartimento del Serio con capoluogo Bergamo, il Dipartimento del Mella con<br />
capoluogo Brescia, il Dipartimento dell’Olona con capoluogo Milano, il Dipartimento<br />
dell’Alto Po con capoluogo Cremona, il Dipartimento del Mincio con capoluogo<br />
Mantova. Ciascun compartimento era suddiviso in distretti, cantoni e comuni<br />
di prima, seconda e terza classe in proporzione al numero di abitanti (ossia con più<br />
di 10.000, da 3000 a 10.000 e meno di 3000). I comuni in totale divenivano 2214.<br />
Dopo il Congresso di Vienna e il ripristino della dominazione austriaca, si verificò<br />
naturalmente una nuova ripartizione territoriale che tuttavia rispecchiava l’assetto<br />
maturato nei secoli quasi di compromesso tra le imposizioni geografiche, le tradizioni<br />
storiche e le nuove esigenze amministrative. Vennero ripristinate le circoscrizioni<br />
provinciali come segue: Valtellina con capoluogo Sondrio, poi Como, Bergamo,<br />
Brescia, Milano, Pavia, Lodi e Crema associate con capoluogo Lodi, Cremona e<br />
Mantova. Ciascuna provincia venne suddivisa in distretti e questi in comuni.<br />
I comuni s’accrebbero a 2295-<br />
Con l’unificazione italiana si posero problemi di riordinamento, che tuttavia non<br />
intaccarono profondamente la preesistente ripartizione territoriale: la provincia di<br />
U tet<br />
La divisione in province dopo<br />
la Restaurazione.<br />
180
Lodi e Crema venne soppressa, il territorio lodigiano incorporato nella provincia di<br />
Milano e il territorio cremasco incorporato nella provincia di Cremona. Alla provincia<br />
di Pavia furono aggregati l’Oltrepò e la Lomellina, e i distretti di Abbiategrasso,<br />
di Rosate e di Rinasco, già di Pavia, vennero passati alla circoscrizione<br />
provinciale di Milano. Un decreto (24 dicembre 1859), che ebbe notevole risonanza<br />
locale, stabili il trasferimento della Valcamònica dalla provincia di Bergamo a quella<br />
di Brescia. Il malcontento dei Bergamaschi si manifestò in vibrate proteste formulate<br />
ufficialmente dagli organi provinciali, che rimasero tuttavia senza alcuna eco, sicché<br />
le manifestazioni di rivendicazione rimasero a lungo vivaci.<br />
L ’assetto provinciale così delineatosi, salvo rettifiche di dettaglio, rimase inalterato<br />
sino al 1927, allorché fu deliberata la creazione della provincia di Varese il<br />
cui territorio era precedentemente suddiviso tra Milano e Como. Da allora non si<br />
ebbero fatti nuovi, benché non siano mancate di manifestarsi aspirazioni, tuttora<br />
non sopite, di diverse città come Lecco, Lodi, Crema, ecc. ad ottenere la qualifica<br />
di capoluoghi di nuove province.<br />
Attualmente, dunque, la <strong>Lombardia</strong> annovera nove province; dalla più alla meno<br />
estesa, sono: Brescia, Sondrio, Pavia, Bergamo, Milano, Mantova, Como, Cremona,<br />
Varese. L ’area delle province si espande per lo più attorno al proprio capoluogo;<br />
evidentemente eccentriche rispetto al loro territorio sono soltanto Como e Cremona.<br />
Le province di Mantova, Cremona, Milano e Pavia, che si succedono da oriente<br />
ad occidente, occupano la fascia meridionale della <strong>Lombardia</strong> e quindi, ad esclusione<br />
dell’Oltrepò pavese, si estendono in perfetta pianura. Mantova, a dominio<br />
del Mincio, si espande a sud oltre il Po e a occidente sino all’Oglio. Cremona e<br />
Milano dalla sponda sinistra del Po risalgono per il fertile piano; Cremona compresa<br />
all’incirca tra Oglio e Adda, Milano tra Adda e Ticino. Pavia, a cavallo tra Po<br />
e Ticino, viene dagli stessi fiumi tripartita in Pavese p. d.. Oltrepò e Lomellina.<br />
Brescia, Bergamo, Como e Varese, città pedemontane, estendono i loro territori dal<br />
piano verso le Prealpi e le Alpi: Brescia sino alle sorgenti dell’Oglio, Bergamo sino<br />
al crinale delle Orobie, Como sino all’apice settentrionale del Lario, Varese sino al<br />
confine politico con la Svizzera. Sondrio si distende ad abbracciare la Valtellina sino<br />
allo Stelvio e la valle San Giacomo sino allo Spinga nel cuore delle Alpi.<br />
I comuni, nei quali si suddivide il territorio delle province, vantano pur essi una<br />
loro storia, troppo complessa, tuttavia, per poter essere seguita. Travagliati spesso da<br />
rivalità e antagonismi interni oltreché esterni, il loro numero in alcuni periodi si<br />
accrebbe in tal misura che non pare iperbolico parlare di polverizzazione comunale<br />
del territorio lombardo. Il superamento di tale situazione si verificò decisamente<br />
in seguito alla costituzione dell’unità italiana, sebbene non siano mancate fluttuazioni.<br />
Anche in epoca recente vi sono state sensibili variazioni per numero ed estensione<br />
dei comuni a causa di fusioni e scissioni, quelle soprattutto dopo la prima guerra<br />
mondiale, queste dopo la seconda guerra mondiale. A l censimento del 1951 il totale<br />
dei comuni lombardi risultava di 1476 con una superficie media di kmq. 16,1 ; numero<br />
quindi decisamente inferiore a quello dei periodi passati, ad esempio, tanto per fare un<br />
181
confronto, a quello della restaurazione allorché, pur sottraendo l’Oltrepò pavese e<br />
la Lomellina, si annoveravano 2295 comuni con una superficie media di kmq. 9,4.<br />
Sempre riguardo alla superficie dei comuni è interessante notare che, nonostante<br />
la grande varietà di ampiezza in ogni parte del territorio, la zona montuosa e particolarmente<br />
la alpina vanta i più estesi comuni ; nè ciò può far meraviglia data la natura<br />
accidentata del territorio e la distribuzione dell’insediamento umano. Livigno tiene<br />
il primato con 22.709 ettari; ma a parte questo comune, la cui estensione può essere<br />
giustificata dalla sua posizione isolata oltre lo spartiacque, non mancano altri comuni<br />
valtellinesi di superficie poco inferiore come Val di Dentro con 22.690 ettari e Valfurva<br />
con 21.525 ettari.<br />
I comuni di minima estensione si raccolgono soprattutto nella collina e nella<br />
pianura asciutta, dove più fitta è la popolazione. Tuttavia il più piccolo è Marzio<br />
nella montagna varesina con 130 ettari, seguito da Masliànico con 133 ettari. Può<br />
costituire una curiosità il fatto che, come questi, altri comuni prossimi al confine<br />
con la Svizzera si distinguono per la loro limitata estensione.<br />
Nella pianura irrigua l’ampiezza dei comuni si manifesta notevolmente varia;<br />
nel complesso è inferiore alla media della montagna e superiore alla media della collina<br />
e della pianura asciutta. Non è poi difficile notare un crescendo di estensione<br />
comunale dal Pavese, al Cremonese, al Mantovano, fatto dipendente da cause complesse,<br />
da mettere in relazione soprattutto con l’ambiente umano e agricolo.<br />
E interessante da ultimo notare che, per rispetto di antichi confini comunali e<br />
di antiche consuetudini, vi sono nell’àmbito della <strong>Lombardia</strong> 21 isole amministrative,<br />
ossia frazioni di territorio comunale staccate dall’area principale e situate nel<br />
perimetro d’altro о di altri comuni. Si tratta di un fatto di modesta entità (in<br />
tutto le isole assommano a non più di 15 kmq.) ma di notevole curiosità storica e<br />
geografica. Quei pochi casi che si hanno nella zona montana si giustificano, in genere,<br />
con antichi diritti di pascolo e di bosco. In pianura, invece, numerosi casi son da<br />
mettere in relazione alle variazioni del corso dei fiumi: tale fatto è evidente, ad<br />
esempio, per diverse isole lungo il Po in provincia di Pavia.<br />
182
C apitolo Settimo<br />
LA POPOLAZIONE E LA SUA DISTRIBUZIONE<br />
L ’aumento della popolazione.<br />
Nella protostoria, genti di diversa stirpe e provenienza, Liguri, Celti ed Etruschi,<br />
raggiunsero il territorio lombardo e tutte vi presero stanza senza manifeste capacità<br />
di predominio о qualità di assimilazione, probabilmente anche per la natura stessa<br />
del territorio, che, frazionato da acquitrini e da foreste, a ciò mal si prestava. Tale<br />
fatto fu sicuramente anche causa di un limitato insediamento specialmente nella<br />
bassa, talché ai Romani sopravvenienti la regione dovette sembrare ancora scarsamente<br />
popolata. L ’avvento romano impresse al territorio una profonda trasformazione<br />
e lasciò un’impronta duratura. Già nell’età repubblicana si tracciarono le grandi<br />
strade dirette ai valichi alpini, si affrontarono le prime opere di sistemazione delle<br />
acque, si fondarono colonie allo scopo di vigilare le vie di comunicazione e attorno<br />
ad esse si andò sviluppando l’agricoltura, talché, per quanto esteso fosse ancora il<br />
dominio del bosco e delle acque, la regione, a testimonianza degli antichi scrittori,<br />
poté venir considerata — ma forse non senza esagerazione — la parte più ferace<br />
della penisola con la quale si osava appena confrontare la felice Campania. Certamente<br />
però la colonizzazione romana dovette dare un grande impulso al popolamento;<br />
soprattutto s’avvantaggiarono le borgate ai guadi dei fiumi, come Ticinum,<br />
come Cremona, Hostilia e Mantua, e allo sbocco delle valli, come Comum, Bergomum<br />
e Brixia. Mediolanum, poi, favorita dalla sua posizione geografica, divenne il centro<br />
più degli altri popoloso ed attivo. Anzi, quando Roma decadde, Milano e le altre<br />
città non mostrarono di seguirne oscuramente il declino, ma divennero validi centri<br />
di resistenza, alle cui mura convergevano gli abitanti delle campagne indifese e<br />
insicure. Poi, sommerse dall’orde barbariche sopravvenienti a ondate, vennero anche<br />
183
L ’aumento della popolazione<br />
assoluta<br />
(presente) in Lom <br />
bardia dal 1750 al<br />
1958.<br />
ü tet<br />
esse più volte rase al suolo e la loro popolazione fu decimata e dispersa; ma ogni<br />
volta risorsero più popolose e più vitali.<br />
Quanta popolazione assommasse durante le alterne vicende dei lontani secoli il<br />
territorio che si assegna alla <strong>Lombardia</strong> attuale non è dato di sapere; ma le indicazioni<br />
che si possono trarre dagli scrittori dell’epoca sono tuttavia tali da far sicuramente<br />
ritenere che sin dal Medioevo la <strong>Lombardia</strong> fosse una delle regioni a più<br />
fitta popolazione non solo dell’Italia ma dell’intera Europa.<br />
Solamente con l’Evo Moderno si possono avere alcuni valori sulla consistenza<br />
numerica della popolazione lombarda, ma, almeno nei primi secoli, poco indicativi,<br />
perchè riferiti a superfici territoriali corrispondenti alle divisioni politiche del tempo<br />
e quindi non coincidenti con l’attuale territorio assegnato alla <strong>Lombardia</strong>. Così<br />
l’indagine storica attesterebbe che verso la metà del secolo XVI la popolazione del<br />
Ducato di Milano avrebbe raggiunto 104.000 fuochi, ossia circa 600-700 mila anime;<br />
ma la configurazione territoriale di quel ducato non comprendeva che una modesta<br />
porzione della <strong>Lombardia</strong> attuale, e il dato non permette illazioni. Bisogna giungere<br />
al secolo XVIII per avere un conteggio abbastanza sicuro relativamente alla maggior<br />
parte dell’area attuale. Verso la metà del secolo, ossia all’inizio del regno di Maria<br />
Teresa, il settore di territorio lombardo che costituiva lo Stato di Milano (press’a<br />
poco corrispondente alle attuali circoscrizioni provinciali di Milano, Como, Varese,<br />
e parte di quella di Cremona — escluso però il territorio di Crema — al circondario<br />
di Pavia e al territorio di Treviglio) contava esso solo 1.050.000 ab. (secondo<br />
la valutazione del Bellati, 1.055.155); risulta poi dai «Sommari generali della popolazione»,<br />
compilati dal 1770 per volere di Maria Teresa, che lo stesso territorio<br />
aveva visto accrescersi nel volgere di vent’anni la sua popolazione di poco più<br />
di 50.000 ab., cifra che coincide con il saggio medio d’incremento del medesimo<br />
periodo calcolato da diversi valenti ricercatori. Con l’integrazione dei dati di popo-<br />
184
lazione assoluta del medesimo periodo relativi agli altri territori è stato possibile<br />
valutare la popolazione lombarda, entro limiti territoriali di poco inferiori agli<br />
attuali, a circa 2.100.000 ab., sicché da questa e dalle cifre precedenti pare possibile<br />
dedurre che, verso la metà del XVIII secolo, il territorio della <strong>Lombardia</strong><br />
contasse approssimativamente 2 milioni di abitanti. La valutazione della popolazione<br />
assoluta nel secolo scorso dispone di maggior copia di indicazioni e il suo<br />
Fot. Fotocielo<br />
Il grandioso panorama del centro di Milano dall’aereo.<br />
i8s
aumento può essere meglio seguito. Entro i confini posti dalla restaurazione con il<br />
Congresso di Vienna del 1815 (per cui dal computo restano esclusi la Lomellina e<br />
l’Oltrepò pavese), la popolazione lombarda era di 2.180.000 ab. su circa 21.570 chilometri<br />
quadrati. Alla data del primo censimento generale della popolazione lombarda,<br />
effettuatosi il 31 ottobre 1857, gli abitanti erano 2.843.000 e il dato è ritenuto<br />
lievemente errato per difetto. Nei quarantadue anni intercorrenti, l’aumento<br />
(dovuto soprattutto a incremento naturale) fu quindi di almeno 664.000 anime con<br />
un indice di variazione rispetto al 1770 da 100 a 135. L ’accrescimento demografico.<br />
Veduta aerea di Bergamo alta, che costituisce l’antico abitato,<br />
e di Bergamo bassa, che testimonia il successivo sviluppo.<br />
Fot. Fotocielo<br />
186
Fot. Fotocielo<br />
Magenta e la pianura a oriente dell’abitato, disseminata di centri.<br />
già manifesto nel secolo precedente, si andava dunque accentuando con il progredire<br />
del tempo. Infatti le indagini compiute ce lo rivelano negli ultimi decenni del<br />
secolo XVIII ancora saltuario e poco marcato, con un saggio di aumento oscillante<br />
attorno a una media di 2,4%o, poi continuo e deciso, con un saggio di aumento<br />
che tra il i8io e il 1857 (se si escludono le funeste conseguenze della crisi economica,<br />
che ha caratterizzato i primi anni della restaurazione, e del colera, che ha<br />
imperversato nel 1836 e 1837) si mantenne intorno a una media del 7,2%o, con<br />
massimi superiori al 9%o. È da tener presente che tale aumento devesi soprattutto<br />
attribuire ad incremento naturale, a proposito del quale si deve pure aggiungere<br />
che, mentre nei primi decenni del secolo scorso l’incremento demografico fu ugualmente<br />
intenso sia nelle aree rurali che nei centri di commercio, nei decenni seguenti<br />
l’incremento nella campagna e nella montagna si andò accentuando sì da superare<br />
nettamente ogni valore riscontrabile nelle città.<br />
187
Compiutasi l’unificazione italiana, la <strong>Lombardia</strong>, da quell’anno, si trovò ad essere,<br />
per popolazione assoluta la prima tra le regioni italiane. Entro i nuovi limiti regionali,<br />
che, salvo lievi modifiche, corrispondono agli attuali, il Censimento generale della<br />
popolazione d’Italia le assegnò 3.261.000 ab., pari al 13% della popolazione del<br />
Regno (entro i confini del tempo), mentre il rapporto territoriale della regione era<br />
dell’8% rispetto allo Stato.<br />
L ’accrescimento della popolazione assoluta della <strong>Lombardia</strong> dal 1861 agli albori<br />
del nostro secolo continuò nel complesso ancor più imponente che non nel passato.<br />
Infatti il Censimento del 1901 dava una popolazione presente di 4.282.728 con un<br />
aumento complessivo esattamente di 1.021.728 ab. nel volgere di soli 40 anni, vale<br />
a dire con un aumento medio annuo dell’8,7°/oo. Ma, per una migliore valutazione<br />
della situazione, è opportuno tuttavia sottolineare che l’accrescimento della popolazione<br />
della <strong>Lombardia</strong>, a partire all’incirca dalla seconda metà dell’Ottocentò,<br />
non si deve attribuire unicamente all’incremento naturale. Com’è noto, nel volgere<br />
di quel cinquantennio in tutta la Penisola vennero prendendo consistenza intensi<br />
movimenti di masse, in conseguenza degli squilibri arrecati dall’accresciuta popolazione<br />
nei confronti delle risorse locali e del richiamo determinato dal progressivo<br />
incremento dell’industria. Nell’àmbito della <strong>Lombardia</strong>, per la stessa varietà geografica<br />
del suo territorio, si manifestarono perturbazioni più complesse che altrove,<br />
perchè accanto ad aree che si potrebbero chiamare, per intenderci, di repulsione<br />
demografica, come quelle della montagna dove infatti si manifestavano i primi sintomi<br />
di esodo, si venivano via via delineando aree di attrazione, il cui richiamo, a<br />
causa del progressivo sviluppo industriale, si espandeva dalla regione lombarda all’intera<br />
Penisola. Rispetto alle direttrici degli spostamenti di popolazione nell’àmbito<br />
della regione (che verranno meglio lumeggiati nelle pagine seguenti) si può notare<br />
sin d’ora un abbandono delle aree rurali non solo della zona montuosa in genere<br />
e alpina in particolare, ma altresì della bassa, e nel contempo una convergenza,<br />
sempre più vivace, nell’area industrializzata о in via di industrializzazione, che<br />
corrisponde all’alta pianura e alla collina, e in particolare nei centri di esse. Ma<br />
non si trattava solo di trasferimento di popolazione locale dalla campagna alla città:<br />
contemporaneamente si accresceva anche il flusso dei lombardi che emigravano in<br />
cerca di lavoro nei vicini Stati europei о si avventuravano oltreoceano, il cui numero,<br />
tuttavia, era assai più esiguo di quello dei connazionali che giungevano dalle altre<br />
regioni.<br />
Pertanto nel primo decennio del nostro secolo il saggio di aumento della popolazione<br />
lombarda raggiunse le sue maggiori punte con una media annua deH’ ii,8°/oo<br />
per stabilizzarsi poi sull’8°/oo nei decenni successivi. In totale la popolazione lombarda<br />
presente al Censimento del 4 novembre 1951 risultò di 6.518.421 con un<br />
aumento, rispetto al 1750, della impressionante cifra di quattro milioni e mezzo di<br />
anime, delle quali ben 2.335.000 a partire dall’inizio del nostro secolo, nonostante<br />
che questo sia stato particolarmente generoso di crisi gravissime di ordine politico<br />
ed economico, culminate nelle due guerre mondiali. Dai rilevamenti annuali com-<br />
188
Fot. Fotocielo<br />
Rho e l’alta pianura milanese.<br />
piuti dopo il 1951 risultò che, a distanza di cinque anni, la popolazione lombarda<br />
era già di 6.879.000 e il ritmo di accrescimento non manifesta flessioni, ma una<br />
progressione costante, sicché è facile presumere che in breve volgere di anni saranno<br />
raggiunti valori notevolmente elevati di addensamento.<br />
Ovviamente la progressione e l’intensità dell’accrescimento numerico della popolazione<br />
ha manifestato notevoli differenze da zona a zona, in quanto, come già s’è<br />
accennato, alcune, come la pianura asciutta e la collina intensamente industriali,<br />
sono più ricettive ed altre, come la montagna e anche la pianura intensamente irrigua,<br />
sono meno ricettive. Ciò lo si nota del resto anche nella statistica per provincia.<br />
Quella che denuncia un aumento più notevole della popolazione assoluta, com’è<br />
facile intuire, è la provincia di Milano, che tuttavia ha un incremento naturale assai<br />
modesto; essa nei novant’anni intercorsi tra il Censimento del 1861 a quello del 1951<br />
è cresciuta di 1.557.318 ab. (popolazione presente) e ciò pur sottraendo i circa<br />
200.000 ab. del circondario di Varese che nel 1927 passarono a far parte della<br />
provincia omonima. Per contro l’aumento numerico di popolazione più modesto lo<br />
registra la provincia di Sondrio (che pure vanta un incremento naturale tra i più<br />
189
alti); per essa i dati statistici denunciano nel volgere di novant’anni (1861-1951) un<br />
accrescimento di sole 44.128 unità.<br />
Nel complesso la zona dove la popolazione ha manifestato un più forte aumento<br />
è quella compresa approssimativamente tra il margine delle Prealpi e la linea dei<br />
fontanili, ossia quella della pianura asciutta e della collina, che corrisponde, come è<br />
illustrato altrove, alla zona di maggior sviluppo industriale. Minore è stato l’aumento<br />
della pianura irrigua e ancor minore quello della montagna, l’una prevalentemente<br />
agricola e quindi meno ricettiva di quella industriale, l’altra, agricolo-pastorale e,<br />
almeno in parte, comprensibilmente repulsiva.<br />
Il movimento naturale.<br />
L ’accrescimento della popolazione lombarda, come già s’è fatto cenno, non si<br />
deve attribuire al solo incremento naturale o, meglio, si deve attribuire in prevalenza<br />
ad esso soltanto, sino al periodo in cui la prosperità economica della regione,<br />
conseguente allo sviluppo commerciale e industriale, non cominciò ad esercitare<br />
un forte richiamo sulla popolazione di ogni parte d’Italia. Non ci si potrebbe spiegare<br />
infatti così forte aumento di popolazione, specialmente negli ultimi decenni,<br />
se si dovesse far riferimento solamente all’incremento naturale, non solo per il fatto<br />
che l’accrescimento è così cospicuo, ma anche perchè le statistiche dell’incremento<br />
naturale denunciano in media un progressivo e deciso regresso.<br />
A tal proposito è anzitutto da notare che l’andamento della nuzialità è tra tutti<br />
i fattori del fenomeno naturale il più stabile nel tempo, per quanto denunci anche<br />
esso una continua sebbene lenta regressione. Infatti la media lombarda nella seconda<br />
metà del Settecento è stata calcolata di 9 matrimoni annui su mille abitanti; nella<br />
prima metà dell’Ottocento di 8,5 matrimoni su mille abitanti. E tali dati paiono<br />
fondati, perchè nella seconda metà dello stesso secolo la media, calcolata su statistiche<br />
ormai sicure, oscillava attorno agli 8 matrimoni annui per mille abitanti con<br />
una leggera superiorità rispetto alla media generale dell’Italia. Pur regredendo lentamente<br />
entrambe le medie, tale vantaggio si mantenne nel nostro secolo sin verso<br />
il 1940, dopo il quale la media lombarda, flettendosi sui 7 matrimoni annui ogni<br />
mille abitanti, si trovò al di sotto del livello medio nazionale. Quest’ultimo sensibile<br />
regresso viene attribuito a diverse cause concomitanti: anzitutto alla contrazione<br />
della natalità durante e dopo la prima guerra mondiale, contrazione che in <strong>Lombardia</strong><br />
fu più sensibile che altrove, per cui a distanza di due decenni si ebbe un<br />
minor numero di individui in età matrimoniale; poi anche all’aumento del livello<br />
medio di età degli sposi dovuto a motivi d’ordine generale, cui devono aggiungersi,<br />
per la <strong>Lombardia</strong>, motivi dipendenti dallo sviluppo regionale, quali l’accresciuta<br />
indipendenza economica della donna, le esigenze di arredamento della casa, ecc.<br />
190
Fot. Ferrari<br />
I grandi palazzi di Metanopoli,<br />
presso San Giuliano Milanese, a pochi chilometri a sud della metropoli.<br />
Ovviamente si potrebbe obiettare che se tali motivi valgono per le aree più progredite<br />
della pianura e della collina lombarda, meno dovrebbero valere per la montagna<br />
dove gli abitanti conservano legami più saldi alle tradizioni. Tale situazione<br />
non è chiaramente deducibile dalle statistiche, per quanto i dati della nuzialità nelle<br />
circoscrizioni di montagna presentino talvolta (salvo il periodo che riflette le conseguenze<br />
della prima guerra mondiale) medie leggermente superiori a quelle delle<br />
circoscrizioni di pianura e di collina. Ad ogni modo vi può essere una giustificazione<br />
nel fatto che già dallo scorso secolo la montagna è teatro di un esodo (di cui si danno<br />
indicazioni appresso) che riguarda soprattutto i giovani in età matrimoniale.<br />
E evidente che la situazione riguardo alla nuzialità non possa che avere riflessi<br />
negativi sulla natalità, per quanto essa sola non sia sufficiente a spiegarne il cospicuo<br />
calo. È da notare infatti che il coefficiente medio della natalità lombarda non solo<br />
presenta, com’è fenomeno diffuso, una costante tendenza decrescente a cominciare<br />
dalla seconda metà del secolo scorso, ma manifesta, nella contrazione, un andamento<br />
tra i più accentuati. Lo possono rilevare con evidenza alcune medie a distanza di<br />
tempo: così mentre dalla metà del secolo XVIII alla metà del X IX si hanno quozienti<br />
oscillanti tra 40 e 42 nati l’anno per mille abitanti, nel 1872-75 la media<br />
del 37°/oo già dimostra una notevole contrazione, pur rimanendo superiore a quella<br />
del Regno (з6,8%о) nello stesso periodo; all’inizio del secolo (1901-05) la media<br />
191
Fasano, stazione climatica del Garda,<br />
sul delta formato dal torrente Bornico.<br />
Fot. Enit<br />
era discesa al 34,8^/00 ; nel 19 25-29 al 24,8%о e quindi ormai nettamente inferiore<br />
a quella dello Stato (27,2°/oo); nel 1949-53 la media lombarda era addirittura<br />
del i5,4°/oo- E per quest’ultimo dato si noti che in esso si riflette il rialzo compensatore<br />
del dopoguerra, per cui è immaginabile che il coefflciente subisca ancora un<br />
calo, come già fanno intravvedere i dati di anni successivi. Nel complesso, soltanto<br />
nel nostro secolo, la media della natalità in <strong>Lombardia</strong> si è contratta del 56 % , contro<br />
il 43% per l’intera Italia.<br />
Riguardo alla situazione della natalità nelle diverse zone della <strong>Lombardia</strong> risulta<br />
interessante notare anzitutto che, sino al tramonto dello scorso secolo, la provincia<br />
di Milano teneva un primato nella natalità (з9,2°/оо nel 1872-75) seguita da Bergamo<br />
e Pavia (rispettivamente 38,5^/00 e 37.6°/oo nel medesimo periodo); Brescia invece<br />
aveva i valori più bassi (зз,4°/оо nel medesimo periodo). Lo scarto da zona a zona<br />
non era dunque molto marcato. Ai giorni nostri la situazione è ben differente. Le<br />
province di Bergamo, Sondrio e Brescia, pur registrando tutte un regresso nel tempo,<br />
mantengono coefflcienti superiori non solo alla media lombarda e alla media italiana,<br />
ma anche e soprattutto alla media di altre province della regione; la loro media nel<br />
192
quinquennio 1949-53 è stata rispettivamente del 22,i% o, 20,9%o, 20,8%o, che<br />
dimostra un netto distacco dalle medie delle province di Milano con il i2,7%o<br />
e di Pavia con il 10,8^/00 per lo stesso periodo. Non si può far a meno di rilevare<br />
che i tre coefficienti massimi di natalità riguardano tre province i cui territori, adiacenti<br />
tra loro, si estendono in buona parte о in tutto nell’àmbito delle Prealpi e<br />
delle Alpi. Non si tratta di una coincidenza casuale; a giustificazione si può ricordare<br />
che nella montagna la tradizione patriarcale, benché non manchino attualmente<br />
segni del suo affievolirsi, ha più profonde radici. Ancor pochi anni or sono un’indagine<br />
sulla popolazione della Valfurva metteva in evidenza il gran numero di<br />
famiglie con una discendenza da io a 14 figli. Ma se tali tradizioni hanno potuto<br />
conservarsi più a lungo lo si deve anche alla tranquillità di cui ha goduto, per la<br />
sua situazione geografica, la maggior parte di questo territorio al limite della frontiera<br />
alpina; e lo dimostrano chiaramente, come esempio, gli avvenimenti dell’ultimo<br />
grande conflitto, durante il quale la zona fu più delle altre risparmiata.<br />
Fot. Fracchi<br />
Il centro di Dervio, sul grande<br />
delta a ventaglio allo<br />
sbocco della vai Varrone.<br />
13 — L e R e g io n i d ’ I t a lia - L o m b a rd ia .<br />
193
All’estremo opposto per valori di natalità si trova il Pavese, sul cui minimo<br />
contribuisce notevolmente la Lomellina, dove — si legge in una recente indagine —<br />
si è instaurato un regime di natalità propriamente francese, non solo nelle città ma<br />
anche nella campagna, come ugualmente si verifica nel vicino Piemonte. La contiguità<br />
geografica della Lomellina al Piemonte, e di questo alla Francia, costituisce<br />
un fatto geografico forse non trascurabile per spiegare la situazione demografica,<br />
tanto più se si tien conto delle vicende storiche e, tra queste, dell’appartenenza della<br />
Lomellina al Piemonte sino all’unità d’Italia e del legame tra essi vivissimo per la<br />
contiguità e le caratteristiche del territorio. Il regime di controllo delle nascite,<br />
ormai stabilizzatosi nel Pavese, manifesta per diversi segni di espandersi progressivamente<br />
in altre parti della pianura lombarda, soprattutto, com’è comprensibile,<br />
nei centri industriali, che sono in così gran numero a occidente dell’Adda, e<br />
particolarmente in Milano, la cui modesta natalità, che di poco supera la mortalità,<br />
porta un peso notevole sul coefficiente medio della provincia.<br />
Rispetto alla mortalità il coefficiente medio per la <strong>Lombardia</strong> ha subito, di pari<br />
passo a quello nazionale, un regresso continuato nel tempo. Nella seconda metà del<br />
secolo XVIII, pur con oscillazioni di una sensibile ampiezza, la mortalità registrava<br />
una media di 37 morti per mille abitanti, mentre nella prima metà del secolo scorso,<br />
nonostante le epidemie del 1817 e del 1836, si manifestava una tendenza al declino<br />
con medie oscillanti sul 3S°/oo- Nel 1872-75 l’indice medio annuo era del зо,4%о;<br />
poi, riducendosi ancora più nel nostro secolo, giunse nel 1949-53 a un livello medio<br />
del io,7°/oo, di solo qualche punto, quindi, superiore alla media annua dello Stato<br />
(io,i°/oo per lo stesso periodo). Si ritiene comunque che la media lombarda non<br />
possa ulteriormente diminuire, poiché su di essa si riflette la composizione per età<br />
della popolazione che, in <strong>Lombardia</strong>, per il contrarsi della natalità, presenta percentuali<br />
di adulti nettamente superiori a quelle dei giovani. Le differenze di mortalità<br />
tra zona e zona non sono molto sensibili; tuttavia è facile rilevare che essa è<br />
nel complesso leggermente superiore nell’area di montagna, minore in quella di<br />
pianura; così alle medie annue del io%o e del io,2°/oo delle province di Milano e<br />
di Mantova (calcolate nel periodo 1949-53) fa riscontro un i2,4°/oo della provincia<br />
di Sondrio. L ’eccezione di Pavia per la zona di pianura, con un i2,i°/oo, avvalora<br />
l’affermazione precedente riguardo all’invecchiamento della popolazione conseguente<br />
alla bassa natalità. La stessa cosa non può dirsi ovviamente per la zona di montagna<br />
dove si registra invece un’alta natalità; quivi la maggiore mortalità si deve<br />
al fatto che i morti nel primo anno di vita sono ancora assai numerosi rispetto alla<br />
pianura, per le minori provvidenze di assistenza ginecologica, ostetrica e pediatrica;<br />
ma il distacco di mortalità infantile tra pianura e montagna è attualmente meno<br />
forte che nel periodo precedente la guerra e va progressivamente attenuandosi. Ciò<br />
avrà l’effetto — rileva giustamente un’indagine eseguita dalla Gassa di Risparmio<br />
delle Province Lombarde — « di mettere a nudo statisticamente il contrasto tra<br />
province ‘ giovani ’ e province ‘ vecchie ’, tuttora mascherato dagli indici della mortalità<br />
infantile ».<br />
194
Com’è ovvio tutte le precedenti considerazioni scaturiscono anche dall’esame<br />
della situazione riguardante l’incremento demografico, derivato dall’eccedenza dei<br />
nati vivi sui morti. Il suo indice medio annuo (cui s’è già fatto cenno per i<br />
secoli XVIII e XIX) non poteva essere molto elevato nel passato per l’alta mortalità<br />
e non può essere elevato neppure ai nostri giorni per la bassa natalità. La<br />
media annua più alta si è avuta all’inizio del nostro secolo (ii,8 % nel periodo 1901-<br />
1905), allorché gli accentuati progressi della scienza medica giovarono a ridurre<br />
vieppiù la mortalità e il controllo delle nascite non aveva ancora accentuato il freno<br />
alla natalità; da allora la media d’incremento è venuta via via riducendosi sino a<br />
segnare 4,7%o come media degli anni 1949-53, nettamente inferiore alla media annua<br />
generale dello Stato (pari a 8,6°/oo per lo stesso periodo).<br />
I dati medi d’incremento annuo per provincia mostrano notevoli disparità. I più<br />
elevati (alcuni superiori anche alla media generale italiana) riguardano le province<br />
di Bergamo, di Brescia e di Sondrio con rispettivamente l’ ii,2°/oo, il io,3%o<br />
e l’8,s°/oo (media 1949-53). contro i più bassi riguardano le province di Milano<br />
con il 2,7°/oo e di Pavia che denuncia addirittura un indice negativo di — i .3°/oo,<br />
il che vuol dire che la mortalità supera la natalità. Ancora una volta quindi balza<br />
all’occhio la profonda disparità della situazione demografica tra le regioni montane<br />
Fot. Sef<br />
Laveno, il maggior centro lacustre della sponda lombarda del Verbano.<br />
195
e pianeggianti, al cui chiarimento ritornano utili le considerazioni precedenti. Ad<br />
esse si possono far seguire alcune considerazioni conclusive. Anzitutto che dall’esame<br />
dei dati regionali e provinciali pare di potere con fondamento asserire che,<br />
sotto l’aspetto demografico, la <strong>Lombardia</strong> si presenta come un’area di transizione<br />
tra il Piemonte e le Venezie. Infatti mentre la sezione occidentale della <strong>Lombardia</strong>,<br />
sia nella porzione di pianura come in quella di montagna, e cioè dalla Lomellina<br />
e dall’Oltrepò al Varesotto, presenta netti caratteri о evidenti prodromi di quella<br />
decadenza della natalità e quindi dell’incremento naturale che si è affermato come<br />
normalità nelle regioni piemontese e ligure, la sezione orientale, soprattutto nella<br />
porzione di montagna, ma anche, seppure in minor misura, in quella di pianura,<br />
e cioè dalla Valtellina al Mantovano, conserva coefficienti di natalità e quindi di<br />
incremento naturale ancora elevati che si accentuano come normalità nel Veneto<br />
e nel Trentino. E non par possibile fare tali constatazioni e considerazioni senza<br />
trovare un nesso, sia pure in forma interrogativa, con le vicende storiche regionali<br />
sino all’unità d’Italia, che a loro volta dan motivo di correlazioni, sia pure generali,<br />
con l’ambiente geografico.<br />
E infine un’ultima considerazione che vuol avvalorare quanto precedentemente<br />
esposto circa l’aumento della popolazione assoluta. A proposito di incremento demografico<br />
risulta che nel quinquennio considerato 1949-53 l’eccedenza dei nati sui<br />
morti per la <strong>Lombardia</strong> è stata in cifra totale di 155.329, mentre per lo stesso<br />
periodo si registra un aumento di popolazione assoluta di 251.642. E evidente che<br />
la differenza di 93.313 rappresenta il saldo positivo del movimento migratorio, ossia<br />
il flusso di connazionali giunti in quel periodo da ogni parte d’Italia a prender dimora<br />
in <strong>Lombardia</strong>. Generalizzando si può dunque dire che in anni recenti all’aumento<br />
della popolazione assoluta lombarda ha contribuito per circa il 60% l’incremento<br />
naturale e per il 40% l’immigrazione.<br />
La densità di popolazione.<br />
Addentrandoci nell’esame distributivo della popolazione lombarda giova anzitutto<br />
esaminare la situazione riguardo alla densità. Come informazione generica si<br />
può ricordare che sin dal Trecento la Padania insieme con le Fiandre costituivano le<br />
due aree di maggior addensamento di popolazione dell’Europa. Per quanto approssimativamente<br />
indicativo, può essere utile ricordare anche che, verso la metà del Cinquecento,<br />
sui circa 16.000 kmq. di territorio del Ducato di Milano si aveva, secondo<br />
un’indagine accreditata (Beloch), una densità media di 62 ab. per chilometro quadrato.<br />
Tale media (in considerazione della distribuzione del territorio del Ducato<br />
tra montagna, collina e pianura) non doveva scostarsi di molto da quella reale del<br />
territorio propriamente lombardo. È probabile che risulti molto vicina alla media<br />
196
Utet<br />
Rappresentazione schematica della densità media per kmq. in <strong>Lombardia</strong>.<br />
Nella zona alpina e prealpina la densità è indicata entro i limiti dell’insediamento<br />
umano permanente di cui è segnata qualche quota indicativa.<br />
reale anche la cifra di 93 ab. circa per chilometro quadrato ottenuta sui valori<br />
dedotti per la popolazione assoluta della <strong>Lombardia</strong> verso la metà del Settecento.<br />
Tale cifra trova convalida pure in dati successivi derivati da calcoli più sicuri,<br />
secondo i quali nel 1770 la densità sarebbe stata di 97 ab. per chilometro quadrato<br />
e nel 1815 di lo i. I valori di densità media s’accrescono con ritmo progressivo e<br />
197
La sponda lombarda del Benaco a Gardone.<br />
Fot. Fotocielo<br />
ininterrotto negli anni successivi: nel 1836, ad esempio, la densità media era già di<br />
114 ab. per chilometro quadrato.<br />
Dopo l’unità d’Italia, delineatosi nei suoi limiti fondamentali e ormai stabilmente<br />
il territorio delle province lombarde, il ritmo ascendente della popolazione relativa<br />
attraverso i censimenti decadali si manifesta con maggior precisione: 145 ab. per<br />
chilometro quadrato nel 18 71; 182 all’inizio del nostro secolo; 233 nel 19 31;<br />
273 nel 1951. I calcoli annuali dopo tale anno rivelano che nel 1957 si erano<br />
superati i 290 ab. per kmq. e l’ascesa continua in proporzione all’aumento della<br />
popolazione totale. Naturalmente i suddetti valori di densità subiscono un note-<br />
198
vole accrescimento se, anziché sulla superficie territoriale vengono calcolati sulla<br />
superficie agrario-forestale: in tal caso nel 1951 già si raggiunge un valore di<br />
327 ab. per chilometro quadrato. Nel primo caso, in una graduatoria per regioni<br />
d’Italia, la <strong>Lombardia</strong> si pone al terzo posto dopo la Campania e la Liguria, nel<br />
secondo caso invece la nostra regione si pone immediatamente dopo la Campania<br />
precedendo la Liguria.<br />
Il quadro della densità per province manifesta notevoli differenze. Al Censimento<br />
del 1951 i valori della circoscrizione di Milano detenevano il primato con 907 ab. per<br />
chilometro quadrato (di superficie territoriale), seguita a distanza da Varese con 396.<br />
Como aveva una densità poco inferiore alla media (272 ab. per kmq.), quindi, con<br />
Fot. Fotocielo<br />
Menaggio, sulla sponda occidentale del Lario,<br />
e la soglia che immette nella valle di Porlezza e al lago di Lugano.<br />
199
decrescendo sensibile, seguivano nell’ordine Bergamo (244 ab. per kmq.), Cremona<br />
(217 ab. per kmq.), Mantova (179 ab. per kmq.), Brescia (177 ab. per kmq.), Pavia<br />
(170 ab. per kmq.) e da ultimo Sondrio con una densità di soli 46 ab. per chilometro<br />
quadrato. Rispetto alla totalità delle province italiane la circoscrizione di Milano si<br />
trovava al secondo posto nella graduatoria per densità, mentre Sondrio stava con<br />
Bolzano al terz’ultimo posto, seguita cioè da Nuoro (35 ab. per kmq.) e da Aosta<br />
(29 abitanti per kmq.).<br />
Per quanto le circoscrizioni provinciali non coincidano con le attuali, sembra<br />
tuttavia interessante e utile notare la situazione che si aveva invece, secondo i calcoli<br />
di M. Romani, nella prima metà del secolo scorso e precisamente negli anni 1816 e<br />
1848. Sin d’allora la provincia di Milano risaltava per il suo primato (225 e 286 abitanti<br />
per kmq.); ad essa seguivano le province occidentali della pianura irrigua: Lodi<br />
con il territorio di Crema (162 e 179 ab. per kmq.), Cremona (126 e 146 ab. per kmq.),<br />
Pavia (135 e 156 ab. per kmq.) e ultime erano quelle che s’estendevano dalla collina<br />
alla montagna: Brescia (91 e 102 ab. per kmq.), Bergamo (73 e 86 ab. per kmq.)<br />
e Sondrio (24 e 28 ab. per kmq.).<br />
Il confronto di questa con la precedente situazione sembrerebbe permettere<br />
un’utile osservazione: che, nell’ascesa dei valori di densità, le province della pianura<br />
irrigua occidentale della <strong>Lombardia</strong> abbiano avuto un crescendo assai meno vivace<br />
di quelle il cui territorio si estende dalla pianura asciutta alla montagna. Poiché in<br />
queste non è stata certo la zona montuosa a influire positivamente (e i dati di<br />
allora e di oggi per la provincia di Sondrio lo dimostrano) occorre dire che l’aumento<br />
del loro valore di densità si debba attribuire esclusivamente alla pianura<br />
asciutta e alla collina.<br />
A completamento delle precedenti osservazioni può giovare l’esame distributivo<br />
della popolazione lombarda per le tre aree morfologiche: pianura, collina, montagna.<br />
A tal proposito ci si può avvalere, per il secolo scorso, dei dati del Cattaneo riferiti<br />
al 1836. Però, è da tener presente che le superfici delle tre zone calcolate dal Cattaneo<br />
differiscono da quelle attualmente adottate; ma più che della differenza di area, che<br />
del resto è di poco inferiore all’attuale, occorre tener conto delle varianti rispetto ai<br />
limiti tra una zona e l’altra. Tali varianti tuttavia, per l’evidenza morfologica, non<br />
sembrano sostanziali al punto da vietare un confronto con la situazione recente dato<br />
che in tutte e due i casi nel tracciato del limite tra montagna e collina si assegnano<br />
a quest’ultima i grossi centri pedemontani di Varese, di Como, di Bergamo e di<br />
Brescia. Orbene, dall’elaborazione dei dati del Cattaneo risulta che nel 1836 la zona<br />
di montagna sommava 504.000 ab., la collina 322.000 e la pianura 1.644.000.<br />
A distanza di quasi un secolo (Censimento del 1931) la popolazione di montagna<br />
risultava di 716.000 ab., quella di collina di 1.075.000 e quella della pianura<br />
di 3-7S3-000. Riguardo alla densità, per il 1836 si contavano 58 ab. per chilometro<br />
quadrato nella zona di montagna, 150 nella collina, 153 nella pianura; per il 1931<br />
risultavano invece 76 ab. nella zona di montagna, 333 nella collina e 339 nella<br />
pianura. Particolarmente interessante si presenta il confronto statistico sia distinta-<br />
200
Fot. Wells; E.P.T., Bergamo<br />
elusone (648 m.) il maggior centro della media e alta valle Seriana,<br />
a dominio della morbida e ampia insellatura tra le valli del Serio e del Sodezza.<br />
mente per le due date, sia congiuntamente. È anzitutto facile rilevare, alle due date,<br />
l’altissimo popolamento della pianura; ma di particolare interesse risultano le varianti<br />
delle zone di montagna e di collina; quest’ultima, infatti, inferiore nel 1836 per<br />
numero assoluto di abitanti alla prima, a distanza di un secolo soprawanza la montagna<br />
con un distacco tanto netto da esser significativo, nonostante il lieve divario<br />
dei limiti divisori tra le due parti. Del resto, anche se non si vuol dar peso al precedente<br />
confronto statistico, le deduzioni sono corrispondenti alla realtà (risultante<br />
da varie testimonianze e da diversi particolari), e si può anche aggiungere che la<br />
mutata situazione del popolamento delle due zone è lo specchio della mutata situazione<br />
economica delle stesse. Di fatto, la popolazione della zona collinare, nel primo<br />
Ottocento, aveva come fondamentale e grama risorsa la coltivazione del terreno<br />
arido ed avaro; ma nella seconda metà dello stesso secolo e più ancora nel nostro<br />
secolo lo sviluppo delle comunicazioni e delle industrie profuse la prosperità. Per<br />
contro lo stesso periodo portò nella zona di montagna la povertà, chè l’allevamento.<br />
201
dal quale un secolo fa il montanaro traeva la sua modesta prosperità, non ha potuto<br />
eguagliare, con il suo reddito, le esigenze dei montanari del tempo nostro, anche<br />
e soprattutto in conseguenza dell’altissimo incremento naturale.<br />
Rimane a questo punto ancora un fatto da chiarire; se davvero, come s’è prospettato<br />
precedentemente, la decantata fertile e pingue pianura non abbia tenuto,<br />
nel progredire del popolamento, un ritmo pari a quello della collina, problema per<br />
il quale le precedenti considerazioni non danno alcun apporto utile. Ma a tal proposito<br />
è anzitutto necessario ribadire una distinzione tra alta e bassa pianura, chè<br />
il quesito, se ha fondamento, può averlo solo nei riguardi della bassa, non dell’alta<br />
pianura che in ogni tempo è stata luogo dei massimi concentramenti.<br />
È un fatto che l’insediamento nella preistoria, secondo quanto attesterebbero i<br />
reperti, si diffuse maggiormente nella collina e nell’alta pianura; forse anche in<br />
periodo protostorico i popoli sopravvenuti nella nostra regione mostrarono di preferire<br />
le medesime aree; ciò che è comprensibile se si tien conto che allora la bassa,<br />
dove non era dominata dalla foresta, era invasa dagli acquitrini. M a l’attrazione о<br />
la repulsione delle diverse zone sulle antiche popolazioni non serve ovviamente a<br />
spiegare il quadro distributivo della popolazione nei secoli più recenti, soprattutto<br />
se si tien conto, nei riguardi della bassa, che il lavoro e l’ingegno, risolvendo mirabilmente<br />
il problema della regolamentazione delle acque, determinarono lentamente<br />
Ponte di Legno (1258 m.)<br />
nell’ampia conca alla confluenza dell’Oglio Frigidolfo e dell’Oglio Narcarello.<br />
Fot. Fotocelere<br />
202
ma progressivamente, a partire dall’epoca della colonizzazione romana, la bonifica<br />
di vaste aree. La bassa venne dunque via via trasformandosi in area fertile e ricca<br />
e, di conseguenza, si è indotti a supporre, anche di richiamo sulla popolazione. La<br />
fase avanzata della bonifica della bassa lombarda può dirsi raggiunta agli albori dell’Ottocento,<br />
se non prima, e non può far dunque meraviglia di trovarvi, come<br />
risulta dalle statistiche del i8i6 e del 1848, un’addensamento che, se pur sempre<br />
inferiore a quello dell’alta pianura sede del massimo centro lombardo, sopravanza<br />
nettamente quello della collina, nè molto fertile nè suscettibile, almeno nel passato,<br />
d’irrigazione. Era quello un periodo in cui le massime risorse economiche si fondavano<br />
sull’agricoltura e quindi nessun’altra parte della <strong>Lombardia</strong> e dell’Italia<br />
poteva vantare una ricchezza pari a quella della bassa lombarda. Ma dopo la metà<br />
dell’Ottocento veniva delineandosi il felice connubio dell’agricoltura e dell’industria<br />
che si affermò dapprima nell’alta pianura e poi anche nella collina, favorite entrambe<br />
anche da più fitte vie di comunicazione. Di conseguenza, mentre in queste la nuova<br />
associazione di attività favoriva l’addensamento di popolazione, e tanto più intensamente<br />
quanto maggiore diveniva lo sviluppo industriale, nella bassa, meno favorevole<br />
per le sue stesse caratteristiche alla localizzazione degli impianti industriali, si stabiliva<br />
un ritmo di accrescimento demografico più moderato che ha portato alla situazione<br />
attuale. Questa scaturisce eloquente dalla rappresentazione cartografica costruita<br />
sui dati di popolazione residente offerti dal Censimento del 1951.<br />
Dalla rappresentazione è facile anzitutto rilevare il sensibile variare della densità<br />
per fasce grossolanamente parallele tra loro e dirette da oriente a occidente. Di fatto<br />
spicca l’esistenza di una fascia mediana alla regione lombarda, allungata tra il corso<br />
del Chiese, nel tratto tra lo sbocco pedemontano e Montichiari, e le sponde del Verbano<br />
e del Ticino, nel tratto tra il limite prealpino e la linea alta dei fontanili, più<br />
espansa a occidente che a oriente, in cui la densità media oscilla tra i 200 e 500 abitanti<br />
per chilometro quadrato, più uniforme nella parte orientale che in quella occidentale<br />
e nel complesso con rarissime e piccole oasi al di sotto del minimo e vaste<br />
aree al di sopra del massimo e anche con più di 1000 ab. per chilometro quadrato.<br />
A lato di questa si dispongono rispettivamente a sud e a nord due altre fasce a densità<br />
minore: quella meridionale con densità media oscillante tra i 100 e i 200 abitanti<br />
per chilometro quadrato, pure con uniformità maggiore nella parte orientale e<br />
minore in quella occidentale; quella settentrionale con densità nel complesso oscillanti<br />
al di sotto dei 100 ab. per chilometro quadrato, ma con notevoli variazioni.<br />
E evidente la corrispondenza approssimativa di queste zone di addensamento<br />
con quelle altimetrico-morfologiche : quella mediana di altissime densità corrispondente<br />
grosso modo all’area dell’alta pianura e della collina compresa tra il limite<br />
superiore dei fontanili e la linea pedemontana; quella meridionale di medie densità<br />
corrispondente alla bassa; quella settentrionale di minori densità corrispondente alla<br />
montagna. Si potrebbe cioè dire, in via di prima approssimazione, che la variabilità di<br />
addensamento secondo la suddetta distinzione è riflesso della variabilità altimetrico-morfologica,<br />
per concludere ovviamente mettendo in rilievo l’influenza di questa su quella.<br />
1<br />
203
Bormio (1225 m.),<br />
nella vasta conca<br />
dell’alta Valtellina,<br />
alla confluènza<br />
del Frodolfo nell’Adda.<br />
Fot. Rocca<br />
Ma, fatte queste considerazioni generali, le tre zone si prestano a osservazioni<br />
particolari. Nella zona mediana spicca per la sua estensione l’area ad altissima densità<br />
del Milanese. Quivi l’area comunale di Milano ha, com’è ovvio, il primato<br />
con 7011 ab. per chilometro quadrato; ma densità ugualmente altissime presenta<br />
tutta l’area dei quadranti a settentrione della città, specialmente lungo le vie di<br />
comunicazione verso le città pedemontane, dove sono disseminati gran numero di<br />
centri industriali formanti una conurbazione, ossia centri molto ravvicinati tra<br />
loro e con tendenza a riunirsi l’un l’altro per mezzo di sobborghi lineari, talché in<br />
una rappresentazione cartografica, necessariamente sommaria, risulta un aggregato<br />
unico di altissimo addensamento; ma la stessa rappresentazione non manca di testimoniare<br />
del peso delle comunicazioni, mettendo in evidenza le ramificazioni di maggiore<br />
densità che a guisa di stecche di un ventaglio irradiano lungo la via di Varese,<br />
di Como, di Lecco e di Bergamo. La stessa cosa del resto si nota, seppure con<br />
diverso livello di densità, nel settore a sud di Milano. Quivi la linea dei fontanili,<br />
subito a sud della città, segna un netto calo di densità, ma ramificazioni e oasi<br />
di maggiore densità s’allineano lungo le vie di comunicazione specialmente dirette<br />
a Pavia, a Lodi e Codogno e lungo le congiungenti di queste città tra loro e infine<br />
tra Bergamo, Crema e Codogno, città che vanno assumendo via via un ruolo sempre<br />
più importante nel recente sviluppo industriale, favorito in parte dalle vicine sorgenti<br />
di metano. La maggiore uniformità dei valori di densità, che, fatta eccezione<br />
per i grandi centri, caratterizza, come già s’è accennato, la <strong>Lombardia</strong> orientale, è<br />
il riflesso di una maggiore uniformità di attività economiche e della palese insuffi-<br />
204
Gromo (675 m.), nell’alta val Seriana.<br />
Fot. Sef
Nucleo ( = piccolo agglomerato<br />
di più di cinque<br />
case) sui prati-pascolo presso<br />
Campo Tártano (vai Tártano)<br />
a 1050 metri.<br />
làl.<br />
Fot. Fracchi<br />
cienza delle comunicazioni. Di fatto è un’area ancorata per vaste zone quasi esclusivamente<br />
all’agricoltura, che, per quanto progredita e redditizia, pone pur sempre<br />
un limite alle possibilità di popolamento. Situazioni di disagio non mancano, ma<br />
non si prospetta, almeno per ora, una situazione acuta come quella della Lomellina<br />
in cui l’esodo di popolazione e la denatalità giustificano le vaste aree con densità<br />
nettamente al di sotto dei 100 ab. per chilometro quadrato.<br />
Nella zona di montagna il quadro della distribuzione della popolazione rispecchia<br />
con evidenza le caratteristiche dell’altimetria e della morfologia. È facile infatti<br />
rilevare come l’insediamento accompagni i fondivalle e la rappresentazione cartografica<br />
delinea bene tali zone a guisa di punte penetranti dalla fascia di collina nella<br />
zona della montagna, con sviluppo maggiore о minore in relazione alla maggiore<br />
о minore lunghezza della vallata stessa. Ma le diverse caratteristiche di altimetria<br />
e di morfologia della fascia prealpina nei confronti di quella alpina danno un’impronta<br />
diversa alla manifestazione nelle due zone. Si può dire, in breve, che, nell’àmbito<br />
della fascia alpina, l’area di più intenso insediamento si restringe tanto più<br />
206
vicino al fondovalle quanto più il solco si addentra tra i colossi montuosi e ne sono<br />
caratteristici esempi le valli di Chiavenna, la Valtellina e la Valcamònica. Nella fascia<br />
prealpina, invece, l’insediamento si espande maggiormente dal fondovalle su per i<br />
versanti, sui terrazzi, sui poggi, e l’area di maggiore densità, quindi, si espande dal fondovalle<br />
alla montagna. Caratteristico è l’esempio delle Prealpi bergamasche. Naturalmente<br />
il fatto non va oltre un certo limite; l’altimetria ovunque s’impone, sicché rimane<br />
sempre valida la legge per cui con l’altimetria l’insediamento dirada e scompare.<br />
Il limite massimo dell’insediamento permanente (se non si tien conto dei rifugi<br />
aperti tutto l’anno, tra i quali il « Casati », nel Cevedale, segna il massimo con 3267 m.)<br />
è costituito da Trepalle, frazione di Li vigno, sotto il passo di Foscagno dal lato<br />
danubiano. Il centro è a 2079 m., ma la più elevata delle sue diverse dimore sparse<br />
si trova a circa 2200 metri. In versante padano il limite massimo è costituito da<br />
Montespluga, a 1908 m., alla testata della vai San Giacomo. Ma nel complesso il<br />
limite delle abitazioni permanenti oscilla su quote meno elevate; per quanto esso vari<br />
da luogo a luogo, si può ritenere che nell’àmbito alpino oscilli in media tra i 1000 e<br />
i 1200 m. con punte di maggior elevazione alle testate delle valli; nelle Prealpi tra<br />
i 700-900 m. con punte massime sino a 1600 m., pure alle testate delle valli.<br />
Fot. Fracchi<br />
Trepalle, frazione di Livigno,<br />
l’abitato permanente più elevato<br />
della montagna lombarda.<br />
207
L ’esodo dalla montagna.<br />
La popolazione assoluta della montagna, come già s’è messo in evidenza, manifesta<br />
da almeno due secoli un ininterrotto progresso numerico, ma tale aumento<br />
da forse un secolo non sembra proporzionato all’incremento naturale, che conserva<br />
valori piuttosto alti, e ciò a causa dell’esodo di una parte della popolazione e soprattutto<br />
dei giovani. Il fatto non è esclusivo della montagna lombarda, e qui, come<br />
altrove, esso ha avuto origine allorché si è manifestato uno squilibrio dipendente<br />
da cause complesse, ma originato in fondo tra quello che le risorse locali potevano<br />
come massimo offrire e quello di cui gli abitanti necessitavano о che aspiravano ad<br />
avere e, sia per il loro numero sia per le accresciute esigenze, non potevano ottenere;<br />
situazione che è indice di superpopolamento. A tal proposito i valori di densità non<br />
hanno significato, per cui anche il dato medio per la provincia di Sondrio, pur così<br />
basso, non contraddice. Più significative semmai possono essere le statistiche di reddito:<br />
la stessa provincia, ad esempio, nonostante la sua economia prevalentemente<br />
agricola, concorre con il 2,86% al reddito totale agricolo della <strong>Lombardia</strong> e soltanto<br />
con l’ i% al reddito totale della regione; nè in situazione molto più vantaggiosa, di<br />
quella che denunciano i suddetti dati per il territorio di Sondrio, si trovano le altre<br />
zone di montagna. Di conseguenza, poiché le risorse locali non sono suscettibili di<br />
notevole incremento, è ovvio che volendo conservare un reddito pro capite corrispondente<br />
alle già modeste esigenze del montanaro, una parte della sua numerosa<br />
famiglia cerchi lavoro altrove e che siano i giovani ad affrontare il trasferimento.<br />
Quando sia iniziato il fenomeno è difficile precisare anche per un àmbito ristretto<br />
come quello della montagna lombarda; comunque, nel 1931, un’analisi particolare<br />
sui risultati dei censimenti accompagnata da un’indagine accurata in luogo hanno<br />
permesso di studiarne l’andamento dal 1871 e di notarne l’accentuarsi di anno in<br />
anno sino al decennio 1921-31, che per le manifestazioni di intensità del fenomeno<br />
non mancò di destare allarmi. Complessivamente il 53% dei comuni della montagna<br />
lombarda avevano denunciato un regresso più о meno forte di popolazione. Ma più<br />
che l’entità numerica dell’esodo, preoccupava il vero e proprio spopolamento della<br />
montagna, ossia l’abbandono delle dimore isolate permanenti, che nei casi migliori<br />
divenivano dimore temporanee ma spesso andavano in rovina, lo svuotarsi via via<br />
di frazioni più elevate e disagevoli che finivano in un desolato abbandono e, di conseguenza,<br />
Г inutilizzazione a cui erano destinati i terreni già coltivati e produttivi;<br />
insomma, l’abbassarsi progressivo dei limiti altimetrici dell’insediamento umano e<br />
dell’agricoltura in tutta la zona di montagna. Il fenomeno tuttavia non raggiunse<br />
le manifestazioni che si notarono nella montagna piemontese, ma non fu tuttavia<br />
208
Dimore in rovina in seguito<br />
ad abbandono a<br />
Campagnana nella valle<br />
Veddasca.<br />
Fot. Nangeroni<br />
così blando come nella montagna trentina e veneta: tra queste e quella lo spopolamento<br />
della montagna lombarda ebbe quasi un aspetto di transizione.<br />
Data la situazione del 1931, era ovvio, allora, presumere un progressivo aggravarsi,<br />
o, nella migliore delle ipotesi, un permanere inalterato della situazione. Invece,<br />
i dati del Censimento del 1951 dimostrano un sensibile attenuarsi, nel ventennio<br />
intercorrente, del fenomeno di esodo. Infatti, secondo una valutazione compiuta<br />
per tutta la regione montana della <strong>Lombardia</strong> nel periodo 19 31-51, solamente il 12%<br />
dei comuni montani — contro il 23% del precedente periodo 19 21-31 — denuncia<br />
una diminuzione superiore del 10% della rispettiva popolazione e, nello stesso ventennio,<br />
solamente il 22% dei comuni montani — contro il 30% del precedente<br />
decennio — accusa una diminuzione della popolazione inferiore al 10% . In totale<br />
dunque una riduzione tra i due periodi da 53 a 34%. Da controlli sporadici eseguiti<br />
in diversi luoghi risulterebbe tuttavia che l’abbandono delle dimore e dei<br />
coltivi non si sarebbe arrestato, pur non aggravandosi nella misura del passato.<br />
L ’intensità dell’esodo dalla montagna lombarda non si presenta, ovviamente,<br />
uniforme, ma, al contrario, con notevoli differenze da zona a zona, da comune a<br />
comune; grosso modo si può dire che, secondo le indagini condotte nei 1934, esso<br />
fosse più accentuato nel settore occidentale e più attenuato in quello orientale; ma<br />
l’indagine sui risultati del Censimento del 1951 sovverte un poco tale generica caratteristica;<br />
infatti, mentre l’esodo risulta ancora vivace nel settore centrale della montagna<br />
lombarda e vivacissimo specialmente nella valle Brembana, al contrario risulta<br />
attenuato nel Varesotto da un lato, nel Bresciano dall’altro.<br />
Nelle montagne del Varesotto l’esodo ebbe impulso dall’apertura della ferrovia<br />
del Gottardo (1882) che accrebbe il richiamo verso la Svizzera, anche per il fatto<br />
che in quegli stessi anni si manifestava in modo ruinoso l’invasione della fillossera.<br />
14 — L e R e g io n i d 'I t a lia - L o m b a rd ia .<br />
209
La zona più colpita dall’esodo della popolazione fu la vai Veddasca, naa non furono<br />
esenti la Valcuvia e la Valganna. La prima è ancor oggi tra le zone lombarde di più<br />
intenso spopolamento, mentre altrove il fenomeno è notevolmente diminuito in<br />
relazione, probabilmente, allo sviluppo industriale della fascia pedemontana varesina<br />
e, in più modeste proporzioni, delle valli ad essa sboccanti. Nella montagna<br />
comasca la migrazione stagionale, già assai vivace sin dal secolo scorso, agevolò forse<br />
l’esodo definitivo di parte della popolazione. Il fenomeno si manifestò con particolare<br />
intensità — e tuttora continua, seppure con qualche attenuazione — nelle valli del<br />
Ceresio e dell’alto Lario quali la Valsolda, le valli del Liro, del Livo e di Albano.<br />
Nella valle Brembana l’esodo della popolazione è divenuto intensissimo dal 1921<br />
al 1931 e, per quanto manifesti nel seguente ventennio una tendenza a decrescere,<br />
si mantiene tuttora il più intenso della regione lombarda. Ancor oggi la diminuzione<br />
numerica degli abitanti, che, con esodo spesso di imponente proporzione, colpisce<br />
oltre il 60% dei comuni, « è accompagnata dall’accentuarsi del carattere antirurale<br />
della popolazione; non solo il montanaro trasporta i centri della sua vita dalla alta e<br />
media montagna nel fondovalle, ma abbandona i terreni coltivati о li lascia degradare<br />
a forme meno attive e intense. Cosi non è infrequente incontrare terreni terrazzati in<br />
Fot. Pasina<br />
Gerola Alta (1051 m.), nella<br />
valle del Bitto, che nel decennio<br />
1921-31 denunciò lo spopolamento<br />
più forte della Valtellina<br />
(32%)-
A n tichi opifici di<br />
lavorazione del ferro<br />
e del rame in rovina,<br />
a Gemmo (Valcamònica).<br />
Fot. Magnolini<br />
ottime esposizioni, un tempo vitali, adatti a piantagioni legnose, attualmente ridotti<br />
a prati stabili e persino a pascolo cespugliato e a incolto produttivo» (I.N .E.A .).<br />
La situazione muta sensibilmente nella adiacente valle Seriana, dove i segni esteriori<br />
dell’abbandono delle terre e delle abitazioni mancano о sono rari, come rari erano<br />
anche venti anni or sono, quando il fenomeno era più accentuato che non oggi. In<br />
realtà nella vai Seriana solo 3 comuni su 22 presentavano nel 1951 una diminuzione<br />
di popolazione; tutti gli altri, in compenso, presentavano un accrescimento di popolazione<br />
di notevoli proporzioni, cui non è probabilmente estraneo lo sviluppo industriale<br />
della valle. Ad accentuare il fenomeno in quella zona contribuiscono però<br />
la vai Borlezza e la vai Cavallina, dove l’esodo è sempre vivace. Nelle montagne di<br />
Sondrio e di Chiavenna l’esodo, già in atto da lungo tempo, non ha mai presentato<br />
una intensità uguale a quella della valle Brembana, nè mai ha manifestato segni<br />
esteriori di abbandono e di degradazione. Dopo l’accentuarsi del fenomeno nel<br />
decennio 19 21-31, si constata nei decenni successivi una tendenza stazionaria, in<br />
conseguenza probabilmente dell’intensificarsi delle comunicazioni vallive, dello sviluppo<br />
del turismo e dell’incremento industriale della valle, non soltanto nel ramo<br />
idroelettrico. Un caso particolarmente interessante è quello della Valcamònica<br />
dove l’esodo, che pure tra il 1921-31 si era manifestato con notevole intensità, si è<br />
contratto al punto che nessun comune nel 1951 denuncia più, rispetto al 1931, una<br />
2 1 1
diminuzione di popolazione. Da ultimo è interessante ancora notare come lo spopolamento<br />
rimanga vivace sulle sponde lacustri così del lago d’Iseo, come del lago d’Idro,<br />
come anche del lago di Garda.<br />
Se il fenomeno di abbandono della montagna ha richiamato l’attenzione degli<br />
studiosi per la sua maggiore evidenza, non si può tralasciare di notare che esso<br />
non può considerarsi fenomeno limitato a quella sola regione. Anche le aree agricole<br />
della pianura, anche della parte più pingue, ne sono contagiate. Le manifestazioni<br />
più accentuate si avvertono nelle aree agricole della <strong>Lombardia</strong> occidentale e<br />
particolarmente nel Pavese. Nella Lomellina, ad esempio, tutti i comuni e in particular<br />
modo quelli intensamente risicoli (fatta eccezione per Vigevano), sino al 1931 denunciavano<br />
un esodo a volte impressionante di popolazione. In epoca più recente il<br />
fenomeno sembra essersi attenuato, sia per l’insediarsi e lo svilupparsi in luogo di<br />
notevoli industrie, che assorbono gran numero di mano d’opera, sia per la crisi<br />
degli alloggi che, specialmente in seguito alla guerra, si è manifestata ovunque e<br />
soprattutto nelle città, sia infine per l’intensificarsi delle comunicazioni, che permettono<br />
trasferimenti quotidiani verso i centri industriali.<br />
Le stesse osservazioni possono valere anche per altre zone agricole del Cremonese,<br />
del Mantovano, del Milanese, della Bergamasca e del Bresciano, sebbene in<br />
esse il fenomeno si sia manifestato con più ritardo e in forma più attenuata. In<br />
ogni caso sono soprattutto i salariati e i giovani che si muovono: i primi spinti dallo<br />
stato di disagio economico, i secondi dalla ribellione al lavoro dei campi. L ’attrazione<br />
è costituita, in genere, dall’industria e dalla città e in tal modo si dà vita a<br />
due fenomeni concomitanti: l’urbanesimo e l’emigrazione.<br />
Emigrazione e immigrazione.<br />
Riguardo all’emigrazione si può anzitutto asserire che nel complesso il flusso<br />
emigratorio della <strong>Lombardia</strong> è stato, in proporzione al totale della popolazione ivi<br />
insediata nei diversi tempi, numericamente piuttosto modesto; ancor più modesto<br />
appare al confronto con altre regioni, anche adiacenti come il Veneto, e con il totale<br />
dell’emigrazione italiana. Si può altresì aggiungere che al flusso emigratorio dalla<br />
<strong>Lombardia</strong> fece riscontro in ogni tempo un flusso immigratorio, numericamente<br />
superiore, da altre regioni anche lontane, verso la <strong>Lombardia</strong>.<br />
L ’emigrazione lombarda si manifestò fievolmente nella prima metà del secolo<br />
scorso con carattere stagionale о comunque temporaneo. In quel periodo il legame<br />
politico con l’Austria favoriva l’emigrazione verso di essa e colà si recavano quindi<br />
i lavoratori lombardi, in prevalenza muratori, fornaciari, scalpellini, manovali e piccoli<br />
commercianti. Per l’indole dell’economia alpestre era poi normale il trasferimento<br />
stagionale oltre confine di alpigiani.<br />
2 12
Dopo l’unificazione dell’Italia, il flusso lombardo di emigrazione, già più cospicuo<br />
per numero, ma ancora con un netto carattere stagionale, deviò dai Paesi tedeschi<br />
verso la Francia e, in misura minore, verso la Svizzera. In breve volgere di tempo<br />
il flusso prese notevole consistenza, sicché i primi accertamenti del 1876 presumono<br />
un contingente di emigrazione di 21.000 lombardi, pari a un sesto circa della totalità<br />
degli emigranti italiani, che, com’è noto, in quel periodo erano prevalentemente<br />
settentrionali. Mentre però andava via via aumentando e inflne prevalendo nel quadro<br />
generale della emigrazione l’apporto meridionale, il flusso migratorio lombardo,<br />
posteriormente al 1876 e per circa venticinque anni (cioè sino alla flne del secolo)<br />
rimase oscillante attorno ai 20.000 emigranti l’anno, con percentuali, quindi, rispetto<br />
al totale dell’emigrazione, nel complesso progressivamente decrescenti. È interessante<br />
notare come in tale venticinquennio fine secolo il numero degli emigranti lombardi<br />
diretti sulle vie tradizionali, e cioè verso i Paesi europei, sia man mano decresciuto<br />
mentre andava ingrossando il numero degli emigranti diretti oltre Oceano. Difatti,<br />
se ancora nel 1880 (anno che conserva le caratteristiche migratorie dei decenni precedenti),<br />
su 17-575 partenti dalla <strong>Lombardia</strong>, il 77,4% era diretto nei Paesi europei<br />
e il 21,9% nei Paesi d’oltre Oceano, quattro anni dopo, e cioè nel 1884, le percen-<br />
Fot. Magno<br />
Di frequente sulla montagna, a sopportare disagi e fatiche,<br />
rimangono i vecchi, poiché i giovani sono inclini a cercare lavoro nelle industrie<br />
e a trasferirsi nella pianura.<br />
213
tuali pareggiavano (i); quindi l’anno seguente il flusso transoceanico prendeva decisamente<br />
il sopravvento con il 70,9% (contro il 28% dell’emigrazione verso i Paesi<br />
europei). Tale situazione si conservava inalterata sino al 1898, anno in cui nuovamente<br />
e altrettanto bruscamente avveniva un capovolgimento (2) che riportava stabilmente<br />
gli emigranti sulle direttrici tradizionali (3).<br />
Nei primi tre lustri del Novecento anche per la <strong>Lombardia</strong> avvenne la grande<br />
emigrazione: infatti dal 1899 il flusso emigratorio lombardo si ingigantiva progressivamente<br />
sino a raggiungere il massimo assoluto nel 1913 con 87.133 emigranti,<br />
che rappresentavano un decimo dell’emigrazione totale italiana. In quell’anno, degli<br />
emigranti lombardi, il 73,6% muoveva verso i Paesi europei e specialmente verso<br />
la Francia e verso la Svizzera, il 25,2% verso l’America e specialmente verso l’A r<br />
gentina, il Brasile e gli U. S. A., e il restante 1,2% verso le altre parti del mondo.<br />
È particolarmente interessante notare che, contrariamente a questa situazione generale<br />
per la <strong>Lombardia</strong> e per la massima parte dei territori di essa, la provincia di<br />
Pavia ha dato in ogni tempo un più elevato contributo all’emigrazione transoceanica<br />
che non a quella europea (4).<br />
Il flusso di emigrazione dalla <strong>Lombardia</strong>, per quanto consistente, non rappresentò,<br />
nemmeno al suo acme, una preoccupante emorragia demografica per questa<br />
nostra regione, tanto più che esso veniva largamente compensato da una contemporanea<br />
e più cospicua immigrazione di connazionali confluenti verso la <strong>Lombardia</strong><br />
da altre regioni. La simultaneità dei due movimenti, che può apparire in se stessa<br />
irragionevole, serve in parte a chiarire i motivi dell’emigrazione lombarda. E evidente<br />
che, se al flusso emigratorio si contrapponeva un flusso immigratorio ancor<br />
più consistente, non poteva esserci carenza, in un quadro generale, di possibilità<br />
Fot. Nangeroni<br />
Il soggiorno estivo<br />
all’alpe (vai<br />
Varrone).<br />
2 14
di lavoro. Ma queste erano variamente ripartite per i diversi settori di attività: crescenti<br />
in quello industriale, calanti in quello agricolo, e il trasferimento della mano<br />
d’opera da questo a quello non è soltanto problema di semplice buona volontà. Meno<br />
duttile a inserirsi nell’industria e nel commercio si dimostrò il montanaro ed è precisamente<br />
la montagna lombarda, dove più acuta si manifestava la crisi, che diede<br />
il maggior contributo all’emigrazione.<br />
Un quadro abbastanza dimostrativo della situazione per le singole zone della<br />
<strong>Lombardia</strong> lo può dare il calcolo delle medie di emigrazione per provincia negli anni<br />
culminanti del fenomeno: tra il 1908 e il 1912 per ogni mille abitanti della <strong>Lombardia</strong><br />
vi era una emigrazione media di 12,9 unità contro la media generale per<br />
lo Stato di 17,5. Nel 1912 tra le singole province lombarde quella di Milano<br />
precedeva ogni altra per il coefficiente più basso, di 7.3°/oo. Seguivano nell’ordine<br />
le province di pianura: Cremona (con 8,6%o), Mantova (con io,i°/oo), Pavia<br />
(con i3,9°/oo); poi quelle che comprendono anche territorio di montagna: Brescia<br />
(con i9,9°/oo), Como (con 2б,з°/оо), Bergamo (con зо,і°/оо); da ultimo Sondrio<br />
con ben 47,40/00.<br />
Il flusso emigratorio dalla <strong>Lombardia</strong> deve quindi ascriversi a un complesso di<br />
cause concomitanti connesse con la particolare morfologia del territorio e con la<br />
relativa economia, con il rapido sviluppo delle industrie di vario tipo e con la qualificazione<br />
della mano d’opera da queste richiesta. In un quadro geografico si deve<br />
soprattutto alla varietà naturale del territorio se mentre alcune zone erano e sono<br />
economicamente povere e quindi demograficamente repulsive, altre, al contrario,<br />
erano e sono economicamente ricche e quindi demograficamente attrattive, cosicché<br />
mentre in quelle si è verificata una forte emigrazione, in queste si è manifestata una<br />
altrettanto vivace e anzi numericamente più cospicua immigrazione.<br />
215
Ricovero notturno di pastori<br />
sui pascoli alti delle Alpi lombarde.<br />
Fot. Nangeroni<br />
Interessante è il consolidarsi in questo<br />
periodo di alcune correnti migratorie<br />
tipiche per il particolare mestiere esercitato<br />
e per la provenienza ben circoscritta,<br />
quali ad esempio, quella dei cuochi dalla<br />
vai Veddasca (Varese), di ombrellai dalla<br />
montagna del lago Maggiore e del lago di<br />
Como, di stuccatori da San Fedele Intel vi<br />
(Como), di bottai e di arrotini da Caspoggio<br />
(Sondrio), di fornai da Morbegno<br />
(Sondrio) e di coltellinai da Premeno<br />
(Como).<br />
Dopo la parentesi determinata dalla<br />
prima guerra mondiale, l’emigrazione lombarda<br />
(come quella italiana) riprese nello<br />
stesso 1918 con vivacità, ascendendo nel<br />
19 19 a 47.836 emigranti, per ridursi<br />
quindi a una media poco superiore ai<br />
30.000 emigranti l’anno nel decennio 1920-29. Nel decennio seguente il flusso emigratorio<br />
prese via via a diminuire, in <strong>Lombardia</strong> come in ogni altra regione, in relazione<br />
alla particolare situazione politica, sino a interrompersi del tutto con l’inizio<br />
della seconda guerra mondiale. La caratteristica più evidente dell’emigrazione lombarda,<br />
nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, è data dal progressivo<br />
ridursi sino a discendere a cifre irrisorie del flusso transoceanico; non che la Lom <br />
bardia avesse dato antecedentemente un alto contributo all’emigrazione oltre Oceano,<br />
ma il progressivo contrarsi e il quasi annullarsi di questa, denuncia chiaramente il<br />
prevalere del carattere di temporaneità dell’emigrazione, in quanto il lavoro nei vicini<br />
Paesi europei conveniva maggiormente. E da sottolineare infatti (e l’osservazione<br />
vale per l’emigrazione lombarda di qualsiasi periodo) che solo una bassa aliquota<br />
degli emigranti lasciava il Paese con un deflnitivo addio; i più rientravano dopo un<br />
periodo anche molto prolungato di lavoro all’estero.<br />
Dopo la seconda guerra mondiale l’emigrazione rinacque, ma, com’è noto, con<br />
caratteri nettamente differenti dai periodi precedenti, differenti soprattutto dal periodo<br />
dell’emigrazione antecedente la prima guerra mondiale. Dopo un primo momento<br />
di convulsa emigrazione clandestina, che però toccò assai poco la <strong>Lombardia</strong>, vi fu<br />
una moderata ripresa di emigrazione di lombardi della montagna verso i vicini Paesi<br />
europei e particolarmente verso la Francia per lavori di ricostruzione edilizia e di<br />
lavori agricoli; verso il Belgio e il Lussemburgo per lavori di miniera; verso la<br />
Svizzera per lavori agricoli e, limitatamente all’elemento femminile, per lavori domestici.<br />
Verso l’America meridionale il flusso emigratorio, numericamente esiguo, si<br />
distinse tuttavia qualitativamente, poiché costituito da tecnici e da operai specializzati<br />
(setaioli da Como, cotonieri da Busto, Legnano, Gallarate, meccanici da<br />
216
Milano, ecc.) destinati a divenire l’elemento di avvio e di sostegno dell’organizzazione<br />
industriale dell’Argentina, del Brasile, del Venezuela, ecc., e destinati quindi,<br />
a insediarsi definitivamente nei Paesi di immigrazione ($).<br />
Condizioni sociali.<br />
La profonda evoluzione economica, che, soprattutto a causa dello sviluppo industriale<br />
e commerciale, ha caratterizzato la vita della <strong>Lombardia</strong> da un secolo a questa<br />
parte, ha dato indubbiamente uno straordinario impulso al progresso nel campo<br />
sociale della regione. Tale progresso non può essere compendiato facilmente in forme<br />
о dati concreti, ma traluce per mille aspetti. Nel complesso non sembra esagerato<br />
riconoscere alla <strong>Lombardia</strong> un primato tra le regioni italiane, che si riflette beneficamente<br />
su queste anche come stimolo. Un indice significativo è dato dal tenore di<br />
vita che è difficilmente misurabile, ma che può essere indicato in parte dal reddito<br />
che è considerato come risultato ultimo dell’attività svolta dalle categorie produttive<br />
e costituisce pertanto un indice del grado con cui una comunità può soddisfare le<br />
sue aspirazioni. Esaminando la produzione della ricchezza che si manifesta in <strong>Lombardia</strong><br />
« ci si avvede che, tanto nel settore agricolo come in quello industriale, la<br />
nostra regione occupa un posto preminente per la molteplicità e il valore dei beni<br />
materiali e dei servizi dai quali il reddito è costituito, non soltanto nella destinazione<br />
finale al consumo ma anche nel ruolo complesso dei beni aventi carattere strumentale.<br />
Sorgono così legami innumerevoli con i processi produttivi che si svolgono nelle<br />
altre regioni d’Italia, legami evidenti nella tendenza all’incremento del reddito nazionale.<br />
Lo sviluppo economico e con esso le alterne vicende di prosperità e di depressione<br />
si manifestano chiaramente nel valor totale del reddito prodotto in <strong>Lombardia</strong>,<br />
del quale i singoli individui si attribuiscono quote sotto forma di salari, stipendi,<br />
rendite, interessi, profitti, ecc. In particolar modo si riconosce che la posizione dominante<br />
della <strong>Lombardia</strong> — dal punto di vista geografico e da quello produttivo —<br />
consente, fra l’altro, la formazione di ingenti redditi commerciali, i quali riflettono<br />
gli scambi, sia diretti che indiretti con altre regioni d’Italia » e ciò contribuisce notevolmente<br />
all’alto livello di reddito della nostra regione (C. R. PP. LL.). Per dare una<br />
valutazione compendiata in qualche cifra si può notare che il reddito globale della<br />
<strong>Lombardia</strong> nel 1952, come già nel 1938, rappresentava circa un quarto del reddito<br />
nazionale e, tra le province, Milano tiene da gran tempo un netto primato. Quanto<br />
al reddito pro capite è interessante rilevare che, fatto uguale a 100 il reddito medio<br />
per abitante dello Stato nel 1952, per la <strong>Lombardia</strong> si aveva nel medesimo anno un<br />
indice medio di 168, contro 139 per l’Italia settentrionale, 102 per l’Italia centrale<br />
e 53 per l’Italia meridionale e insulare. Milano deteneva ancora il primato tra le<br />
province lombarde con 230.<br />
2 17
Pavia. L ’Università degli<br />
Studi.<br />
п I ’ :l<br />
«<br />
1 1 ^ 1<br />
r 1 1 1 ì 1<br />
' ' ■ Ш<br />
■ ' ' 1<br />
«nsi<br />
m i<br />
Fot. Chiolini<br />
Ovviamente al livello del reddito si adegua il livello del consumo, il flusso dei<br />
risparmi e degli investimenti, aspetti che non consentono, per la loro complessità<br />
e per la loro dinamica, una facile misurazione riassuntiva che agevoli una visione<br />
sintetica. A titolo di curiosità riguardo ai consumi, si può ricordare che le statistiche<br />
relative alla spesa di acquisto di pane e pasta trovano la <strong>Lombardia</strong> in posizione di<br />
coda nella graduatoria per regioni, mentre per la spesa di carni la trovano in testa<br />
alla graduatoria. Così su loo lire spese in complesso per alimentazione e tabacco,<br />
ne vanno al pane e alla pasta circa i i in <strong>Lombardia</strong>, circa 13 nell’insieme delle regioni<br />
settentrionali e centrali e circa 20 nelle regioni meridionali e insulari; per contro<br />
sulle medesime 100 lire ne vanno alle carni 28 in <strong>Lombardia</strong>, 18 nelle regioni settentrionali<br />
e centrali e 15 nelle meridionali. Se si tien conto che la spesa media per<br />
218
pane e pasta è sempre più alta nella popolazione povera che in quella relativamente<br />
prospera (che ha possibilità di consumare idrati di carbonio più costosi come zuccheri,<br />
dolci, ecc.) e che l’inverso avviene per le carni, si può aver un indice significativo<br />
della situazione lombarda. Del resto le stesse deduzioni si possono trarre dai<br />
confronti dei consumi per spese voluttuarie, spettacoli, attrezzatura delle abitazioni,<br />
trasporti, ecc. Più significativo appare il fatto che in media nel flusso dei depositi<br />
a risparmio la <strong>Lombardia</strong> contribuisce per circa un quarto del totale nazionale.<br />
Questi pochi cenni non possono certo prospettare la situazione sociale che caratterizza<br />
la regione lombarda nel suo complesso, ma servono tuttavia a far intuire la<br />
condizione di prosperità economica che della situazione sociale è un aspetto di notevole<br />
peso. Essa non manca di far sentire il suo influsso anche nelle istituzioni culturali<br />
; non solo infatti il benessere sollecita ad un affinamento culturale, ma indirizza<br />
verso le specializzazioni che lo stesso sviluppo economico richiede. In ogni grado di<br />
scuola « è infatti manifesto — si osserva giustamente in un’indagine regionale della<br />
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde — quel particolare carattere della<br />
cultura lombarda diretta più a scopi pratici che a scopi teorici, carattere espresso<br />
da un costume e da una mentalità tipicamente mercantili e industriali ».<br />
Istituti culturali.<br />
A conferma delle precedenti osservazioni può valere l’alta percentuale di individui<br />
forniti di titolo di studio: al censimento del 1951, si aveva l’89% (esclusi i bambini<br />
sotto i 6 anni), indice di poco inferiore al Trentino-Alto Adige, che tiene il primato<br />
tra le regioni italiane. Nello stesso anno gli analfabeti costituivano in media<br />
poco meno del 3% ; tra le province si segnalavano quelle agricole della pianura per<br />
percentuali superiori alla media (Mantova S%), mentre inferiori erano quelle di<br />
montagna (Sondrio 2%). Oltre a una preminenza per numero di scuole e di alunni,<br />
giustificata dall’entità della sua popolazione assoluta, la <strong>Lombardia</strong> vanta un’affluenza<br />
agli istituti d’istruzione tecnica e professionale nettamente superiore a qualsiasi altra<br />
regione e ciò in relazione precisamente alla sua caratteristica economica. La fondazione<br />
di questi istituti è antica: sin dal secolo XVIII sorsero i primi con carattere<br />
ben definito, quali le Scuole di lavoro propugnate da spiriti illuminati. Nel 1838,<br />
pure per iniziativa di commercianti e industriali, fu fondata a Milano la Società di<br />
incoraggiamento d’arti e mestieri (che ebbe come primo segretario Carlo Cattaneo)<br />
attualmente frequentata da più di 5000 allievi. Nel 1844 sorse a Bergamo la Società<br />
d’incoraggiamento per l’industria manifatturiera, da cui derivò l’Istituto tecnicoindustriale.<br />
Nel 1851 venne istituita dal Municipio di Milano una Scuola reale superiore<br />
a indirizzo commerciale, trasformata poi nell’Istituto tecnico per geometri<br />
«Carlo Cattaneo»; nello stesso anno ebbe vita la Scuola d’arti e mestieri di Brescia,<br />
divenuto poi l’Istituto industriale «Moretti». Al 1862 risale l’istituzione a Varese<br />
219
Pavia. Il cortile dell’Università con il monumento ad Alessandro Volta.<br />
Fot. Stefani<br />
dell’Istituto tecnico-commerciale «Francesco Daverio », divenuto statale nel 1919.<br />
Nel 1866 fu fondata, auspice la Camera di commercio, la Scuola di setificio di Como,<br />
primo Istituto nel mondo per lo studio della tessitura della seta. In provincia di Como<br />
merita una segnalazione la Scuola d’arte del mobile e del merletto istituita a Cantù<br />
nel 1883. Ma, delle numerose iniziative di enti e privati, sono qui segnalate solo<br />
alcune tra le più antiche e significative; di molte altre, ugualmente benemerite, sorte<br />
nello stesso periodo e in seguito, è giocoforza tralasciare l’elenco. Insieme esse formano<br />
oggi un mezzo insostituibile di preparazione dei tecnici e delle maestranze<br />
cui è affidato in buona misura la prosperità della regione.<br />
Nel quadro della cultura superiore la <strong>Lombardia</strong> vanta cinque grandi complessi<br />
universitari, di cui quattro a Milano e uno a Pavia. Quest’ultimo è in ordine cronologico<br />
il più antico; la sua istituzione avvenne con diploma di Carlo IV nel 1361<br />
e la sua fama progredì nel tempo, nel campo delle scienze mediche, matematiche,<br />
fisiche e naturali. Vi tennero cattedra Alessandro Volta, Lazzaro Spallanzani, Antonio<br />
220
Scopoli nelle discipline fisico-naturali, Lorenzo Mascheroni e Antonio Bordoni nelle<br />
discipline matematiche, Antonio Scarpa nella chirurgia e Carlo Forlanini nella medicina,<br />
Vincenzo Monti e Ugo Foscolo nelle lettere, per non dire che dei più noti.<br />
Ad agevolare gli studenti più meritevoli sono stati istituiti sin dal secolo XVI due<br />
collegi: il « Ghisleri » e il « Borromeo », che godono di grande fama per gl’ingegni che<br />
ne furono ospiti. Complessivamente gli studenti iscritti nelle diverse Facoltà e nei<br />
diversi Istituti sono più di 5000.<br />
A Milano il più antico complesso universitario è il Politecnico istituito nel 1859<br />
e organizzato nel 1863. Agli inizi il Regio Istituto tecnico superiore, come allora si<br />
Fot. Sef<br />
Il palazzo dell'Università degli Studi a Milano<br />
(antica sede dell’Ospedale Maggiore).<br />
2 2 1
chiamava, ebbe la sezione di ingegneria civile cui si aggiunse ben presto la sezione<br />
di ingegneria meccanica, chiamata poi più propriamente di ingegneria industriale,<br />
con le specializzazioni di meccanica, elettrotecnica e chimica; nel 1933 si aggiunse<br />
anche la facoltà di architettura. Per la serietà di studio, l’estensione delle ricerche,<br />
il contributo di scienza, il Politecnico milanese gode di fama internazionale e lo<br />
dimostra il crescente afflusso di studenti che negli ultimi anni, nonostante la severa<br />
selezione, sono saliti a circa 3000.<br />
Accanto al Politecnico figura degnamente l’Università Bocconi, fondata nel 1902<br />
per il mecenatismo di Ferdinando Bocconi, che volle onorare con l’istituzione la<br />
memoria del figlio Luigi, disperso nella battaglia di Adua. La Bocconi ebbe fin<br />
dall’inizio come obiettivo principale la preparazione e la ricerca nel campo degli<br />
studi economici e commerciali e solo nel 1947 si è aggiunta una sezione speciale per<br />
le lingue straniere, frequentata da più di 2000 allievi. Per i soli studi economici la<br />
Bocconi è frequentata da altri 2000 studenti e, con la accurata preparazione che<br />
fornisce in questo campo, essa dà un sostanziale contributo alla vita e al progresso<br />
economico della regione.<br />
Un complesso universitario imponente è costituito dall’Università cattolica del<br />
Sacro Cuore, con sede in un antico convento cistercense (restituito al primitivo<br />
I moderni palazzi dell’Università Bocconi a Milano.<br />
'<br />
Î<br />
Fot. Ferrari<br />
2 2 2
Fot. Bromofoto<br />
Uno dei chiostri bramanteschi<br />
della sede dell’Università cattolica di Milano.<br />
splendore bramantesco) prossimo alla Basilica di Sant’Ambrogio. Fu fondata nel 1920<br />
quale emanazione dell’Istituto di studi superiori « Giuseppe Tomolo » voluto da un<br />
gruppo di cattolici milanesi capeggiati da padre Agostino Gemelli, medico e psicologo<br />
votatosi a vita religiosa. In breve tempo l’istituzione, sostenuta dal contributo<br />
di offerte dei cattolici italiani, divenne meta di studenti di ogni parte d’Italia; il loro<br />
numero attualmente è di oltre 9000, distribuiti tra le Facoltà di giurisprudenza,<br />
scienze politiche e sociali, economia e commercio, lettere e filosofia, magistero e<br />
agraria; quest’ultima, istituita nel 1953, con sede a Piacenza.<br />
Ultima in ordine di tempo, ma già ricca di nobile e severa tradizione, è l’Università<br />
degli Studi, istituita, per sollecitudine di Luigi Mangiagalli e per aspirazione<br />
di eletti spiriti milanesi, con decreto del 1923. Essa si compone di quattro Facoltà:<br />
giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze naturali e medicina, ed è frequentata complessivamente<br />
da oltre 8000 studenti. Tra il complesso di edifici dotati di moderna<br />
attrezzatura, si distingue la sede principale sistemata degnamente nell’antico palazzo<br />
dell’Ospedale Maggiore milanese, restituito al suo primitivo splendore architettonico.<br />
Tutti gli istituti universitari milanesi dispongono di ricche biblioteche specializzate;<br />
complessivamente le Università milanesi custodiscono quasi un milione e mezzo<br />
223
di pubblicazioni, cui vanno aggiunte oltre 600.000 opere della Biblioteca nazionale<br />
Braidense, ricca altresì di 2344 incunaboli e di 1636 manoscritti. L ’Università di<br />
Pavia ha pure una ricca dotazione di circa 350.000 opere, di incunaboli e manoscritti.<br />
Notevoli sono altresì la Biblioteca governativa di Cremona, e le Civiche di<br />
Milano, Bergamo, Brescia, Como e Mantova.<br />
Ad affiancare e ad integrare l’attività della scuola vi sono in <strong>Lombardia</strong> numerose<br />
istituzioni culturali di alto livello, tra le quali va innanzitutto ricordato l’Istituto<br />
lombardo di scienze e lettere. Esso deriva dalla Società patriottica fondata nel 1776<br />
per volere di Maria Teresa d’Austria e aperta ufficialmente con una prolusione di<br />
Pietro Verri nel 1778. Tale istituzione venne soppressa durante il periodo della<br />
Repubblica Cisalpina per risorgere poi nel 1797, per volere di Napoleone Bonaparte,<br />
con il nome di Istituto nazionale. Con il variare delle condizioni politiche, l’istituzione<br />
mutò varie volte denominazione e sede e nel 1863 assunse la sua definitiva struttura.<br />
L ’attività scientifica si compendia in due pubblicazioni continuative, le Memorie e<br />
i Rendiconti che raccolgono studi e contributi regionali, e in pubblicazioni straordinarie<br />
quali quella riguardante le Opere di Alessandro Volta.<br />
Altro ente culturale di notevole livello è l’Istituto di alta cultura, ente privato<br />
con il fine di promuovere iniziative scientifiche di importanza regionale, nazionale<br />
e internazionale; si deve, ad esempio, all’Istituto di alta cultura la creazione dell’Università<br />
degli Studi di Milano e l’impulso alla pubblicazione della monumentale<br />
Storia di Milano della Treccani.<br />
Infine tra le istituzioni notevoli devono essere ricordate: l’Istituto per gli Studi<br />
di politica internazionale, fondato nel 1933, e l’Istituto per gli Studi di economia,<br />
sorto nel 1946.<br />
N o t e<br />
( i ; pag. 2 14 ) Rispettivam ente il 5 0 ,4 % per i Paesi europei e il 4 6 ,3% per i Paesi d ’oltre O ceano. Il<br />
resto p er altre parti del m ondo.<br />
(2 ; pag. 2 14 ) E cco le percentuali: a) per i Paesi europei: 18 9 7 : 3 9 ,9 % : 18 9 8 : 6 1,6 % ; b) per i Paesi<br />
d ’oltre O ceano: 18 9 7 : 5 8 ,5 % ; 18 9 8 : 36 ,9 % .<br />
(3 ; pag. 2 14 ) E cco le percentuali:<br />
ANNO 1900 I9OS 1910 1920 1925<br />
a) per l’Europa............................. 74.4% 73.3% 72.4% 81,5% 87.2%<br />
b) per l’oltre O ceano.................. 23.1% 25.2% 26,3% 17.7% 10,5%<br />
(4 ; pag. 2 14 ) E cco le percentuali:<br />
ANNO 1884 1894 1904 1914 1925<br />
a) per i Paesi e u r o p e i......................... 2 ,3 5 % 2,9 6 % 2 0 ,5 1% 3 2 ,3 5 % 39 ,38 %<br />
b) p er i Paesi transoceanici . . . . 9 7 ,6 5% 94.04% 7 9 .4 9 % 6 7,6 5% 6 0,62%<br />
(S; pag. 217) Nel 1947, su 3894 emigranti lombardi verso l’America, ben 3816 (97%) dichiararono di<br />
volersi stabilmente insediare nei Paesi di destinazione.<br />
224
C a p it o l o O t t a v o<br />
L’INSEDIAMENTO URBANO E RURALE<br />
Modi e forme dell’insediamento.<br />
I modi e le forme con i quali si manifesta l’insediamento umano rappresentano<br />
anche in <strong>Lombardia</strong>, come altrove, il risultato dell’influsso di numerosissimi fattori.<br />
Di questi, alcuni, quali ad esempio i naturali, hanno agito e agiscono durevolmente,<br />
sebbene in modo diverso da luogo a luogo in relazione al loro modificarsi nello<br />
spazio, altri, quali ad esempio quelli più strettamente legati alla società umana, hanno<br />
agito e agiscono talvolta solo temporaneamente о solo localmente. Pertanto nei<br />
modi e nelle forme d’insediamento, che la natura di un luogo ha consentito e suggerito,<br />
non è impossibile discernere impronte che rappresentano una singolarità<br />
di tempo e di spazio. Da questa breve considerazione scaturisce di necessità una<br />
evidente deduzione, ossia che le differenze altimetriche, morfologiche, pedologiche,<br />
idrologiche e climatiche in genere tra la pianura e la collina e soprattutto tra queste<br />
e la montagna, già poste in evidenza, non possono non essere state fondamentali<br />
nel differenziare i modi e le forme d’insediamento nel nostro territorio lombardo.<br />
Ma l’insediamento non ci mostra soltanto tale influenza, ma anche quella dei fattori<br />
che sono connessi alla struttura della società nei diversi momenti storici. È bensì<br />
vero che questi non sono tutti e del tutto indipendenti dall’ambiente naturale (basti<br />
considerare, ad esempio, il legame intercorrente tra l’ambiente naturale e gli ordinamenti<br />
colturali e fondiari, che ebbero larghi riflessi sull’insediamento rispondente,<br />
anche in <strong>Lombardia</strong>, almeno in passato, ad esigenze prevalentemente rurali); ma<br />
ve ne sono anche del tutto indipendenti dall’ambiente naturale e che non possono<br />
essere obliati. Non sarebbe possibile spiegarsi, ad esempio, una delle manifestazioni più<br />
caratteristiche dell’insediamento lombardo, quello a corte della pianura, espressione<br />
15 — R eg io n i d 'I t a lia - L o m b a rd ia .<br />
225
Distribuzione della popolazione sparsa (in % sulla residente) (censimento 1951).<br />
Utet<br />
probabilmente delle più intime tendenze della società medioevale. Altrettanto non<br />
ci si potrebbe spiegare la rapida e profonda trasformazione che caratterizza il<br />
paesaggio umano nel nostro tempo. Or senza voler pretendere di affrontare un<br />
esame completo nel tempo e nello spazio, è tuttavia opportuno non trascurare gli<br />
aspetti più suggestivi del problema, ossia le forme di accentramento e di dispersione<br />
e i caratteri della dimora che costituiscono in certo qual modo lo specchio dell’uomo<br />
e dei tempi.<br />
226
Insediamento accentrato e sparso.<br />
E noto e assai spesso ripetuto che la popolazione della <strong>Lombardia</strong> vive agglomerata,<br />
e tal fatto lo si attribuisce spesso allo sviluppo dell’industria. Ciò è senza<br />
dubbio vero, ma è forse più esatto dire che la tendenza all’agglomeramento è stata<br />
accentuata dallo sviluppo delle industrie, in quanto preesistente alle stesse. Inoltre<br />
il dire che la popolazione vivesse agglomerata non significa ovviamente che risiedesse<br />
nelle città. A illuminare il rapporto tra popolazione urbana e villereccia possono<br />
tornar utili, sebbene senza pretese di rigorosità, i rilevamenti della popolazione<br />
compiuti in un lontano passato. Nel 1747, in base alla Tabella della popolazione<br />
dello Stato di Milano, nell’àmbito dello stesso circa il 20% degli abitanti risiedeva<br />
nei centri di oltre 10.000 ab. e l’8o% nei centri di meno di 10.000 abitanti. A distanza<br />
Fot. Fotocielo<br />
L ’addensamento di abitati nell’alta pianura lombarda e nella collina.<br />
In primo piano Gallarate (Varese).<br />
227
di quasi novant’anni (1836) il Cattaneo poteva stabilire un rapporto di 17% per le<br />
città con più di 10.000 ab. (eh’erano le medesime, più Crema e Casalmaggiore)<br />
contro Г8з% per le città con meno di 10.000 abitanti. Non si hanno indicazioni<br />
sulla consistenza della popolazione propriamente sparsa, ma il quadro della vita<br />
urbana si delinea chiaramente: a parte Milano, già per quei tempi notevolmente<br />
popolata (essa sola aveva il 40% della popolazione cittadina della <strong>Lombardia</strong>) le<br />
città con più di 10.000 ab. erano dieci nel 1747 e dodici nel 1836 e precisamente<br />
Como, Bergamo, Brescia, Monza, Lodi, Pavia, Crema, Casalmaggiore, Cremona,<br />
Mantova, Viadana, Gonzaga. Si noti come la maggior parte di esse si trovasse nella<br />
zona della pianura irrigua, ciò che conferma la preponderanza economica dell’attività<br />
agricola. La bassa, per quanto non fosse ancora del tutto bonificata, per i progressi<br />
conseguiti attraverso un’opera secolare di sistemazione suscitava l’orgoglio<br />
bissone, nell’alta pianura milanese,<br />
rivela nell’edilizia il grande sviluppo recente.<br />
228
Fot. Fotocielo<br />
Treviglio dall’aereo; è visibile il nucleo vecchio e l’espansione recente.<br />
dei Lombardi e, come il Cattaneo ci attesta, l’ammirazione degli stranieri. In essa<br />
i villaggi costituiti talvolta unicamente da corti, le tipiche fattorie lombarde, denunciavano<br />
con la loro stessa composizione il carattere agricolo originario. Molti non<br />
vantavano un passato ricco di eventi, ma avevano un presente prospero colmo di<br />
promesse. Tra villaggio e villagio s’intercalavano poi corti isolate che tuttavia, organizzate<br />
com’erano su base unitaria, costituivano esse stesse quasi dei villaggi. La<br />
pianura asciutta e la collina erano pur esse fitte di borghi agricoli, molti dei quali<br />
sorti in antico attorno ai castelli feudali, ma non godevano di uguale prosperità e<br />
già agli albori del secolo scorso cominciavano a sentire lo squilibrio determinato<br />
dall’aumento della popolazione. La montagna infine costituiva ancora un mondo<br />
chiuso in se stesso, legato ad antichissime tradizioni. La popolazione d’inverno<br />
viveva raccolta nei villaggi posti nel fondovalle о sui terrazzi prossimi per lo più al<br />
fondovalle; d’estate sciamava su per i versanti, sostando nelle cascine di mezza montagna<br />
о sui pascoli alti.<br />
A modificare, lentamente dapprima, poi con ritmo sempre più rapido, la situazione<br />
che, nei suoi caratteri generali ora accennati, perdurando ormai da molto<br />
tempo, poteva dirsi ben radicata, si profilava già nei primi decenni del secolo scorso<br />
lo sviluppo dell’industria manifatturiera. Essa tuttavia agì come causa di profonda<br />
trasformazione negli ultimi decenni del secolo e soprattutto nel nostro tempo. Le<br />
industrie sorsero non solo attorno a Milano, ma anche nella pianura asciutta a nord<br />
229
La distribuzione dei piccoli aggregati di case ( = nuclei) nel territorio bergamasco e, in parte,<br />
bresciano. È evidente la moderata frequenza nella « bassa » e la maggiore fittezza nell’alta pianura<br />
e soprattutto nella fascia pedemontana. Nella montagna i nuclei accompagnano i solchi fluviali<br />
e il loro numero è maggiore nelle vallate poco elevate e aperte.
della città e via via nella collina sino ai bordi di tutta la fascia prealpina. Quella che<br />
prima era una zona fitta di piccoli antichi borghi, in cui si viveva nel disagio di una<br />
stentata agricoltura, divenne un’area di attrazione. Gli abitati cominciarono ad espandersi,<br />
spesso inglobando in tal processo dimore agricole che sorgevano isolate, a<br />
poco a poco raggiunsero con i loro tentacoli i borghi vicini, li imprigionarono, divennero<br />
cittadine e le cittadine espandendosi ancora si avvicinarono tra loro e talvolta<br />
persino si congiunsero l’una all’altra. Tale vento innovatore non investì con ugual<br />
vigore la bassa irrigua, о almeno non la investì contemporaneamente. Qui la maggiore<br />
specializzazione dell’attività economica, la solida prosperità agricola, la produttività<br />
del suolo, la frequenza delle grandi proprietà fondiarie, la fittezza del<br />
reticolo irriguo, la minore densità di strade influirono come cause di conservazione<br />
di una situazione raggiunta attraverso un’opera secolare; ma con il trascorrere del<br />
tempo, l’onda di prosperità crescente recata dallo sviluppo industriale nell’alta pianura<br />
e nella collina agì nella bassa con un riflesso che per certi aspetti si può dire,<br />
in breve, deprimente, non estraneo in questo un superpopolamento della campagna.<br />
Fot. Fotocielo<br />
Vigévano, in Lomellina: il vecchio centro e l’espansione periferica recente.<br />
231
Lodi: il centro antico dell’abitato.<br />
Fot. Fotocielo<br />
Le conseguenze son facili a dedursi e se ne fa cenno altrove. Qui basti dire che,<br />
data la situazione, il quadro dell’insediamento della bassa non subì profonde modifiche.<br />
Solo nelle maggiori città si manifestò un notevole sviluppo industriale. È però<br />
necessario aggiungere che proprio ai giorni nostri lungo le maggiori arterie stradali<br />
che da Milano irradiano verso sud, verso Pavia e Voghera, verso Lodi e Piacenza,<br />
verso Crema e Cremona e lungo le loro congiungenti, è in atto uno sviluppo industriale<br />
che va profondamente modificando il quadro tradizionale. Nella montagna<br />
il soffio innovatore recato dall’industria si manifestò soltanto con l’accentuare l’esodo<br />
della popolazione. L ’industria manifatturiera nell’àmbito montano non poteva trovare<br />
sede adatta, nè l’industria idroelettrica, condotti a termine gli impianti, poteva<br />
assorbire mano d’opera. Solo il turismo ha costituito il fatto nuovo, per cui diverse<br />
località di maggiore attrazione nelle valli montane о lungo le sponde lacustri hanno<br />
visto lentamente sorgere attorno al vecchio borgo di antiche case una cerchia di<br />
alberghi e villini moderni. Ma nel complesso la forma dell’insediamento, tradizionalmente<br />
accentrata, non ha subito profonde modifiche.<br />
232
Nel complesso, dunque, per antica tradizione e per moderne esigenze l’insediamento<br />
umano in <strong>Lombardia</strong> presenta una generale tendenza all’accentramento. Anche<br />
i rilevamenti statistici ne danno una conferma: al censimento del 1951 risultava che<br />
ben 1’82,6% della popolazione residente in <strong>Lombardia</strong> (ossia 5.427.000 abitanti<br />
su 6.566.000) viveva in centri. Della restante popolazione il 10,8% viveva in nuclei<br />
(termine inadatto, ma ufficiale, nel quale, oltre i raggruppamenti di dimore con più<br />
di cinque famiglie, si comprendono le corti, le case di cura, i conventi, i collegi, ecc.,<br />
purché isolati) e il 6,6% viveva nelle case sparse. Ma ovviamente non ogni parte<br />
della <strong>Lombardia</strong> si trova nelle stesse condizioni: l’accentramento più elevato della<br />
popolazione si riscontra nella provincia di Milano con il 92,2%, percentuale che<br />
sarebbe probabilmente più elevata se non vi fosse incluso il Lodigiano a cui soprattutto<br />
va attribuito il 6,4% della popolazione dei nuclei e Г 1,4% della popolazione<br />
delle case sparse, risultanti per la provincia; per contro la dispersione presenta dei<br />
valori insoliti, per la <strong>Lombardia</strong>, nel territorio mantovano, dove la popolazione delle<br />
case sparse costituisce il 24,9% e quella dei nuclei il 17,4% della totale e dove i<br />
coefficienti di dispersione in alcuni comuni, come Curtatone, Virgilio, Moglia, superano<br />
il 50%, raggiungendo il 60% a San Giovanni del Dosso. Ma, senza entrare<br />
in dettagli, una chiara visione di assieme della dispersione della popolazione è offerta<br />
dalla rappresentazione cartografica dove, in successione al Mantovano, presentano<br />
percentuali di dispersione ancora sensibile il Bresciano, la Bergamasca e l’Oltrepò<br />
pavese.<br />
E particolarmente interessante notare che, mentre di solito avviene che la dispersione<br />
è connessa con la ruralità, per una parte della pianura la popolazione sparsa<br />
è poco numerosa anche se vi prevale nettamente l’attività agricola. La Lomellina,<br />
il Pavese, il Lodigiano, il Cremasco si trovano in questa condizione. Ma occorre<br />
tener presente che queste sono regioni di dominio della corte e che la corte, anche<br />
Distribuzione altimetrica in percento della popolazione<br />
accentrata e sparsa nella montagna lombarda.
se isolata, non può essere considerata, per le sue caratteristiche, tra le case sparse;<br />
orbene, il valore percentuale della popolazione dei nuclei per le regioni suddette<br />
non appare affatto trascurabile, oscillando tra il 14 e il 18% , ciò che mette in risalto<br />
la forma mista dell’insediamento di queste regioni singolarmente caratterizzate dalle<br />
corti, cui si fa cenno appresso.<br />
I centri.<br />
I centri della <strong>Lombardia</strong> manifestano ancor oggi con la stessa vivacità di un<br />
tempo il loro richiamo, non solo sugli abitanti della montagna о della bassa lombarda,<br />
ma su Italiani di ogni parte della Penisola. Sopra ogni altro, vivace è sempre<br />
stato il richiamo di Milano. Così, ad esempio, si è calcolato (F. Coletti) che in Milano,<br />
nei tre decenni del secolo scorso (1872-81, 1882-91, 1892-1901), siano immigrati.<br />
Desenzano sul Garda.<br />
Fot. Fotocielo<br />
234
Fot. Fotocielo<br />
Lecco e l’Adda dall’aereo.<br />
per ciascun emigrato dalla città, rispettivamente g, 19 e 16 individui. Nel 1901<br />
sopra 1000 ab. presenti a Milano alla data del censimento (io febbraio), 220 risultavano<br />
nati fuori dal comune ma nell’àmbito delle province della <strong>Lombardia</strong>,<br />
III risultavano nati in regione finitima e 34 in regioni lontane; complessivamente<br />
il 36,5% della popolazione presente non era nativa della città. Ancora: nel 1921, alla<br />
data di quel censimento (1° dicembre), la popolazione presente di età superiore<br />
ai 21 anni non nativa di Milano era il 72% e di questa un terzo circa era proveniente<br />
dalle varie regioni dell’Italia. Infine nel 1953, sopra circa 1.290.000 residenti della<br />
metropoli, un terzo risultavano nati nel comune, un altro terzo nell’àmbito della<br />
235
Pizzighettone : borgo fortificato a controllo del ponte sull’Adda.<br />
Fot. Galimberti<br />
regione lombarda e il residuo terzo era costituito da immigrati da altre regioni;<br />
i meridionali risultavano 86.000.<br />
Il richiamo di Milano è indubbiamente eccezionale e, sotto questo aspetto, la<br />
città eccelle, assieme a Roma, sopra le altre città d’Italia; ma anche altri capoluoghi<br />
о centri della <strong>Lombardia</strong> non mancano di esercitare una particolare attrazione,<br />
benché in proporzioni assai più modeste e in un raggio meno ampio. Non si potrebbe<br />
comunque spiegare altrimenti il raddoppio о quasi della popolazione di città nel<br />
volgere di appena mezzo secolo (1901-1951). Si distinguono anzitutto le città pedemontane;<br />
Brescia (142.059 ab. nel comune), Bergamo (103.256 ab.), Como (70.447 ab.),<br />
che nella graduatoria dei capoluoghi per entità di popolazione seguono Milano; poi<br />
Varese (53.115 ab.) e Lecco (42.454 ab.), pure centri pedemontani. Ugualmente<br />
notevole è l’attrazione dei numerosi centri dell’alta pianura tra il Ticino e l’Adda,<br />
centri tutti in forte e rapido aumento di popolazione: Monza (73.114 ab.). Busto<br />
Arsizio (52.607 ab.). Sesto San Giovanni (44.936 ab.). Legnano (38.003 ab.). Gallarate<br />
(29.728 ab.), Rho (24.428 ab.), Seregno (24.371 ab.), Saronno (21.243 ab.),<br />
Lissone (18.931 ab.). Desio (16.824 ^b.) e decine di altri centri fervidi e popolosi.<br />
236
Minore, ma comunque non trascurabile è il richiamo dei capoluoghi della bassa:<br />
Cremona (68.636 ab.), Pavia (63.683 ab.), Mantova (53.810 ab.) e di altri centri in<br />
via di sviluppo industriale della stessa zona, quali Vigévano (43.805 ab.). Lodi<br />
(35.320 ab.), Voghera (32.260 ab.). Crema 27.889 ab.), Mortara (12.607 ab.), Codogno<br />
(12.253 ab.), ecc.<br />
Particolarmente interessante, riguardo all’addensamento dei centri, risulta la zona<br />
dell’alta pianura che si stende tra Ticino e Adda con un’appendice, al di là di questa,<br />
che abbraccia Bergamo. A ll’incirca dal limite dei fontanili sino al piede delle Prealpi<br />
il territorio, vera regione urbanizzata, è caratterizzato dalla frequente presenza di<br />
città e cittadine alle quali s’interpongono numerosissimi centri minori. Si potrebbe<br />
portare il paragone di un limpido cielo notturno nel quale tra le stelle di maggiore<br />
grandezza s’intercala un fitto tessuto di stelle minori; ma come nel cielo appaiono<br />
anche stelle di maggiore grandezza ravvicinate tra loro, così nella regione urbanizzata<br />
si individuano raggruppamenti di centri urbani, vicini tra loro e con tendenza<br />
a riunirsi, che con termine geografico si indicano con il termine di conurbazioni.<br />
Fot. Fotocielo<br />
Bellagio, a ridosso dello sprone<br />
che separa i due rami meridionali del lago di Como.<br />
237
La regione urbanizzata è ovviamente un’area ad altissima densità di popolazione<br />
e basta uno sguardo alla rappresentazione cartografica di questa per rendersene<br />
conto; è anche un’area con popolazione prevalentemente dedita ad attività non<br />
agricole, soprattutto industriali ; di fatto là dove la densità comunale supera i<br />
400 abitanti per chilometro quadrato, la frazione di popolazione non agricola si<br />
mantiene superiore al 75%, tranne rari casi, e spesso supera Г85 о il 90%.<br />
Entro i limiti precedentemente indicati, l’area urbanizzata, comprendente 343 comuni<br />
(appartenenti a quattro diverse province: Milano, Varese, Como, Bergamo) per<br />
una superficie di 2863 kmq., assomma una popolazione di 3.242.435 ab., che<br />
costituisce poco meno della metà della popolazione lombarda. « Il comune di Milano<br />
(1.274.245 ab.) raccoglie da solo quasi i due quinti della popolazione totale della<br />
zona (39,3%), ma comunque rimane cospicua l’entità demografica degli altri comuni,<br />
poco meno di 2 milioni di abitanti (1.968.190)» (A. bestini).<br />
Nell’àmbito della regione urbanizzata è agevole distinguere la conurbazione milanese<br />
che dalla grande città si espande verso nord sino a comprendere Giussano,<br />
Meda e Rho, per « un complesso di 37 comuni su un’area di 477 kmq. ed una<br />
popolazione di 1.703.2i i abitanti. In questa conurbazione milanese la metropoli<br />
lombarda ha peso assolutamente preponderante; tuttavia anche escluso il comune<br />
di Milano si assommano 428.966 ab. (25,2%). I centri con più di 5000 abitanti<br />
sono 23, di cui 8 con popolazione tra 10.000 e 25.000 ab., e 2 con oltre 40.000 (i).<br />
Questi centri (calcolando solo la popolazione degli aggregati urbani) raccolgono<br />
1.558.220 ab., circa il 92% del totale della conurbazione. La popolazione attiva non<br />
agricola raggiunge о supera, nei singoli comuni, il 94% (eccettuati i piccoli comuni<br />
di Muggiò, Cesano Boscone e Pero: 93, 90 e 87) col massimo di 99,4 a Milano ed<br />
a Sesto San Giovanni» (A. bestini). Altre minori conurbazioni sono: quella che<br />
gravita verso Legnano e Busto Arsizio, in cui la saldatura tra i vari centri è in fase<br />
avanzata, e quella che gravita su Bergamo e che dalla città si espande verso il<br />
Brembo e verso il Serio, meno progredita ma in rapido sviluppo.<br />
Caratteristiche dei centri.<br />
Anche in <strong>Lombardia</strong>, come da per tutto, i centri abitati presentano loro peculiari<br />
caratteristiche di sviluppo, di forma, di aspetto, di composizione, di posizione, di<br />
struttura, per le quali ciascuno possiede un’individualità propria che lo distingue<br />
dagli altri. Ciò risulta evidente soprattutto per le città, ma non è esclusivo di queste;<br />
anche i centri minori possiedono loro caratteristiche distintive. Le cause sono molteplici;<br />
tanto per citarne alcune tra le più evidenti, si possono ricordare: l’altitudine,<br />
la forma del terreno su cui sorge il centro, il paesaggio che si stende attorno, il<br />
clima, le colture che prosperano nella campagna circostante, l’origine e le tradizioni<br />
238
Fot. Preda<br />
Salò e, sui delta, Barbarano, Fasano e Maderno.<br />
degli abitanti, le vicende storiche, la singolarità о la pluralità dell’attività umana;<br />
ma queste e tutte le altre che si potrebbero citare confluiscono, com’è facile arguire,<br />
nei due fattori fondamentali: la natura e l’uomo.<br />
Senza voler qui penetrare in una ricerca particolare, giova (per meglio comprendere<br />
il paesaggio lombardo nel suo assieme) richiamare l’attenzione su alcune caratteristiche<br />
più evidenti dei centri lombardi e soprattutto sulla loro forma e sulla loro<br />
posizione.<br />
Nella montagna non vi sono grandi centri. Sondrio stessa, capoluogo della provincia<br />
alpina della <strong>Lombardia</strong>, annovera poco più di lo.ooo ab. (popolazione presente<br />
nel 1951). In prevalenza, nella montagna e soprattutto nella zona abitata<br />
altimetricamente più elevata, vi sono villaggi. Questi nella loro parte antica conservano<br />
in generale alcune caratteristiche ricorrenti. Le dimore sono in prevalenza<br />
costruite in pietre accuratamente cementate e talvolta rivestite di malta nelle parti<br />
che servono a dimora; spesso si affiancano una accanto all’altra, sicché sembrano<br />
sorreggersi reciprocamente. Lo spazio occupato dalle vie è angusto, il più delle volte<br />
quanto basta per il passaggio di un carretto agricolo; ancora più strette sono le<br />
viuzze a scalinata; tutte si snodano di solito tortuosamente e tutt’al più fa eccezione<br />
(ma non sempre) l’antica via maestra, ai margini della quale il villaggio si distribuisce.<br />
Gli spioventi del tetto, assai sporgenti per proteggere i ballatoi dalla pioggia, avvicinano<br />
le loro gronde l’una all’altra e schiudono sulla via poco spazio di cielo. Così<br />
239
Lonato, su un colle al<br />
margine dell’anfiteatro<br />
morenico del Garda.<br />
Fot. Micheletti<br />
come si presenta, la strada sembra non essere parte separata ed estranea alla dimora,<br />
ma addirittura una parte di essa. Si trae insomma l’impressione di una vita di comunità,<br />
con un vivo senso di solidarietà (come spesso in realtà si verifica), e ciò si<br />
giustifica, oltre che con i legami di parentela più о meno stretta intercorrenti spesso<br />
tra le famiglie originarie del villaggio, anche con l’isolamento prolungato invernale<br />
e quindi con la necessità di reciproco aiuto nelle avversità. Tale impressione risulta<br />
attenuata nei villaggi della zona meno elevata della montagna e soprattutto di fondovalle,<br />
poiché ivi le dimore prendono più spazio e spesso sono precedute о affiancate<br />
dalla curt, area talvolta cinta da un muricciolo, nella quale si svolgono i lavori<br />
agricoli. Le strade risultano più ampie, più aperte, più divisorie delle singole dimore.<br />
In ogni caso, tuttavia, la pianta del nucleo antico dei villaggi della montagna<br />
lombarda è intricata, tortuosa, bizzarra. Senza dubbio vi sono le eccezioni. L ’esempio<br />
più caratteristico è dato da Livigno, le cui dimore sono distribuite, con netta separazione<br />
l’una dall’altra, per circa 2 km. lungo la strada che percorre il fondovalle;<br />
si tratta però di un centro in versante danubiano e con case tutte in legno. Anche<br />
nella montagna, seppure in misura minore di quel che avviene nella pianura e nella<br />
collina, accanto alla parte antica del centro (in conseguenza delle mutate condizioni<br />
di vita, dell’emigrazione stagionale e del turismo) sono venute sorgendo e sorgono<br />
tuttora nuove costruzioni, che normalmente differiscono nell’aspetto dalle precedenti,<br />
anche se si tratta di dimore di abitanti del luogo. Esse si trovano presso<br />
l’antico villaggio, ma opportunamente distanziate da questo e tra di loro; sia nella<br />
architettura che nella struttura riflettono le concezioni moderne della dimora, anche<br />
se tendono a non obliterare del tutto i modelli tradizionali, e nel complesso presentano<br />
una concreta testimonianza del profondo rivolgimento portato dalla nostra età<br />
nel mondo, sino a pochi decenni or sono chiuso e statico, della montagna.<br />
240
Presso i villaggi situati nelle località più pittoresche e soprattutto più rapidamente<br />
raggiungibili dai centri della pianura vi sono spesso ville e villette di recente<br />
costruzione, proprietà, di solito, di residenti delle città. Queste costruzioni normalmente<br />
sorgono discoste dal villaggio, dove disperse, dove invece a piccoli gruppi;<br />
esse per lo più rimangono disabitate per la maggior parte dell’anno e servono solamente<br />
per la villeggiatura estiva. In alcuni luoghi il loro numero va crescendo in<br />
tal misura da conferire un aspetto nuovo al paesaggio.<br />
La posizione dei centri montani è molto varia. La maggior parte dei più popolosi<br />
si trova lungo il fondovalle. Si è calcolato che le sedi di fondovalle nelle Alpi rappresentino<br />
approssimativamente il 30% dei centri permanentemente abitati, con<br />
oltre il 50% della popolazione della montagna (G. Nangeroni). Tale situazione si<br />
verifica anche nella montagna lombarda e semmai, per questa, la stima generale<br />
può ritenersi in difetto. Infatti una statistica per la provincia di Sondrio calcola a<br />
47% i centri di fondovalle (C. Verga). In compenso una statistica per la valle Brembana<br />
ne assegna al fondovalle il 30% e per la valle Seriana il 25% (A. Piras).<br />
Le sedi di fondovalle, specialmente dove la valle si allarga, sono per lo più marginali,<br />
ossia non lungo la linea più depressa, ma al piede dei versanti montuosi e<br />
ciò per sfuggire al pericolo causato dalle piene dei corsi d’acqua. Molte si trovano<br />
su antichi e stabilizzati conoidi alluvionali (specialmente se questi sono a lento<br />
pendio) allo sbocco di valli confluenti; si tratta di una posizione vantaggiosa in<br />
quanto i terreni di deposito sono sciolti e fertili e permettono più agevolmente<br />
l’irrigazione. A volte il villaggio è all’apice del conoide, a volte al margine laterale,<br />
a volte nella parte mediana e a volte, invece, sul bordo periferico più basso e ciò in<br />
relazione a situazioni particolari del luogo. Gli esempi potrebbero essere numerosi.<br />
Fot. Micheletti<br />
Schilpario (1125 m.),<br />
centro di terrazzo della<br />
valle di Scalve.<br />
16 — Le Regioni d ‘Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
241
Si possono citare, tra i più tipici, Bormio nell’alta e Morbegno nella bassa Valtellina,<br />
Vezza d’Oglio nell’alta e Rogno nella bassa Valcamònica.<br />
Un buon gruppo di centri si trova su terrazzi, ossia su quei ripiani che di frequente<br />
interrompono a varia altezza i pendi! montuosi, ove più ove meno ampi;<br />
alcuni sono tagliati nella roccia, altri formati da morene di antichi ghiacciai, altri<br />
ancora, generalmente più prossimi al fondovalle, da alluvioni. E ovvio che i terrazzi,<br />
proprio per la loro forma, offrano condizioni favorevoli all’insediamento, ma<br />
il loro richiamo è tanto maggiore se la valle si incide angusta e profonda in modo<br />
che i raggi solari, specialmente d’inverno, vi giungano per breve tempo e l’aria<br />
fredda vi ristagni a lungo anche d’estate. Questo medesimo motivo, la ricerca del<br />
sole, è fondamentale pure per le sedi di pendio, ossia per quei villaggi che si trovano<br />
su versanti privi di terrazzi; ve ne sono molti, anche nelle valli, come le<br />
bergamasche, non modellate dalle grandi colate glaciali pleistoceniche. Così, secondo<br />
le indagini precedentemente citate, le sedi di terrazzo e di pendio sarebbero complessivamente<br />
il 65% nella valle Seriana e il 60% nella valle Brembana. Un tipico<br />
esempio di insediamento su terrazzi e su pendio a solatìo lo presenta con evidenza<br />
la Valtellina nel suo tronco longitudinale; ivi il versante retico, completamente<br />
aperto all’insolazione (e in prevalenza coperto da vigneto), sugli ampi ripiani che<br />
si susseguono da Teglio a Cino e talvolta sui pendi!, è tutto un susseguirsi di<br />
villaggi; il versante opposto, a bacìo, presenta pochi e sparuti villaggi sommersi nel<br />
Selvino (962 m.) centro di sella tra la valle Seriana e la valle Serina.<br />
Fot. Fotocelere<br />
242
osco ceduo. Oltre alle sedi di fondovalle, di terrazzo e di pendio, che sono complessivamente<br />
in assoluta maggioranza, vi sono rare sedi di sella, come Selvino, tra<br />
la vai Seriana e la vai Serina nelle Prealpi bergamasche, Magreglio alla testata della<br />
Valassina nelle Prealpi comasche. Mancano invece del tutto le sedi di poggio.<br />
Le sedi lungo le sponde dei laghi prealpini presentano alcune caratteristiche<br />
particolari. Un buon gruppo di centri tra i più popolosi si trova su ampi delta formati<br />
dai depositi alluvionali provenienti dalle valli confluenti. Sedi di delta sono,<br />
con evidenza, Gravedona, Domaso, Dervio, Bellano, Menaggio, Mandello, sul lago<br />
di Como, Castro sul lago d’Iseo, Fasano e Maderno sul lago di Garda; ma l’esempio<br />
più grandioso è quello di Lecco il cui centro cittadino si espande su due vasti delta<br />
accostati, dei torrenti Caldone e Gerenzone, con, tendenza a espandersi verso un<br />
terzo delta vicino, formato dal torrente Bione, di guisa che la topografia dell’abitato<br />
tende a diventare, da bilobata qual era, trilobata. Non sempre le alluvioni trascinate<br />
al lago dai torrenti che in esso sfociano manifestano evidente la forma lobata<br />
del delta; ma l’attenuazione della pendenza del versante, che i depositi determinano<br />
sulla riva dello specchio lacustre, ha offerto di frequente buone possibilità d’insediamento.<br />
In tal caso, com’è ovvio, la sede manifesta l’adattamento alla topografia,<br />
allungandosi in fascia lungo il lago e talvolta addirittura frazionandosi in diversi<br />
agglomerati. Un esempio caratteristico può essere offerto da Lèzzeno, sul lago di<br />
Como, diviso nei nuclei rivieraschi di Villa, su un delta ben disegnato, e di Sossana,<br />
Rozzo, Pescaù, su minuscoli lembi alluvionali laterali.<br />
Nella collina, zona in genere di grande afflusso di popolazione e di grande sviluppo<br />
edilizio recente, l’espansione progressiva dell’abitato ha spesso alterato quelle<br />
che erano le caratteristiche topografiche degli antichi centri. Occorre quindi rifarsi<br />
a questi per poter coglierne le caratteristiche del passato. In genere i vecchi abitati<br />
rivelano nella struttura e nell’edilizia la loro originaria funzione agricola; sono per<br />
lo più formati da cassine in parte in pietra, specialmente nelle zone moreniche, e in<br />
parte in cotto. Ogni dimora ha per solito uno spazio riservato ai lavori agricoli, la<br />
curt, che dà respiro all’ambiente. Però in complesso le costruzioni stanno l’una vicino<br />
all’altra e le vie sono di frequente ombrose e strette, benché non nella misura di<br />
quel che si nota nei villaggi di montagna. A spiegazione si affaccia l’ipotesi che tale<br />
angustia sia da mettere in relazione con la preoccupazione di sottrarre il minor<br />
spazio possibile all’arabile e comunque al terreno in qualche modo produttivo; ma<br />
per rendersene esatta ragione parrebbe necessario non trascurare i motivi storici<br />
e soprattutto l’origine (in prevalenza medioevale) dei villaggi. Certo è che, scaduta<br />
l’agricoltura ad attività secondaria (specie nella vasta area collinare a occidente delrOglio),<br />
ogni preoccupazione, se pure vi è mai stata, di sottrarre terreno all’agricoltura<br />
è venuta meno e gli abitati si sono espansi da ogni lato, spesso congiungendosi<br />
tra loro.<br />
Riguardo alla posizione, la zona collinare presenta una singolarità che le è esclusiva,<br />
ossia la notevole frequenza di centri di poggio, vale a dire di centri posti sulla<br />
sommità di un colle. Come esempio caratteristico può essere indicato Castelmarte<br />
243
Magasa (971 m.), centro di<br />
pendìo nella valle di Vestine.<br />
Fot. Nangeroni<br />
al margine delle Prealpi comasche. Non sempre però si tratta di colli isolati; negli<br />
anfiteatri morenici infatti i depositi sono disposti spesso in arcuate dorsali dal profilo<br />
morbidamente ondulato e su questo, intervallati, si susseguono centri e nuclei.<br />
Caso tipico, nel cuore della Brianza, la morena a occidente del Montevecchia con<br />
Torrevilla, Monti cello. Casatevecchio, Montesiro, e la morena più interna con Barrano,<br />
Torricella, Dagò, Villanova, Cortenuova. Spesso nel luogo più elevato domina<br />
la chiesa о un antico castello.<br />
Se i centri di poggio sono caratteristica esclusiva della collina, in questa stessa<br />
zona sono però frequenti anche centri diversamente ubicati: se ne trovano, infatti,<br />
sui blandi pendii dei colli о alle loro falde, sul ciglio di terrazzi affacciati ai laghi<br />
о marginali ai solchi fluviali; raramente nelle conche intermedie alle colline e ciò<br />
per evidenti motivi. Quasi tutti presentano, attorno al nucleo antico, edifici recenti.<br />
Questi hanno però aspetto e struttura totalmente differenti dalle costruzioni della<br />
parte vecchia, ossia non sono edifici rispondenti a esigenze di attività agricola, ma<br />
semplici abitazioni civili, opportunamente distanziate tra loro e spesso attorniate<br />
da giardini. Lo sviluppo edilizio moderno ha in qualche caso determinato la unificazione<br />
di centri precedentemente distinti e, come esempio, si può citare Erba,<br />
Incino e Viirincino, in prossimità del Lambro.<br />
La pianura presenta una grande varietà di situazioni. L ’interesse converge naturalmente<br />
sulle maggiori città (per le quali si rimanda ai capitoli X II e X III); ma<br />
meritano attenzione anche le sedi minori. In una visione d’assieme sembra anzitutto<br />
possibile fare una distinzione tra i centri dell’alta pianura e i centri della bassa<br />
pianura, in relazione al diverso sviluppo recente, che nella prima si manifesta in<br />
modo assai più appariscente che non nella seconda. I centri, anche i più piccoli.<br />
244
1<br />
Fot. Wells; Е.Р.Тч Bergamo<br />
L ’abitato di benna (San Martino de’ Calvi) al margine del fondovalle<br />
presso la confluenza dei due rami principali del Brembo.<br />
dell’alta pianura (come in generale è avvenuto nella collina, ma in proporzioni ancor<br />
più notevoli) negli ultimi decenni hanno avuto uno sviluppo edilizio e di conseguenza<br />
una espansione pianimetrica tale da determinare persino il colmamento degli<br />
spazi divisori tra centro e centro, ossia da determinare la conurbazione, cui s’è<br />
precedentemente accennato. Ne è derivata per questi centri una evidente duplicità<br />
di aspetto: quello del nucleo antico, di dimore in cotto, che in parte si conserva<br />
ancora, almeno in apparenza, agricolo e quello moderno della periferia (dove domina<br />
il cemento armato) che, anche per I’inserirsi di opifici, rispecchia l’evoluzione industriale.<br />
Il distacco tra le due parti appare anche più netto nei casi in cui l’antico<br />
abitato era cinto da mura. Naturalmente il processo di sviluppo demografico ed<br />
245
Morbegno (25s m.), in Valtellina,<br />
sulla grande conoide allo sbocco della valle del Bitte.<br />
Fot. Fotocelere<br />
economico, di cui questa duplicità di aspetto è un riflesso, ha determinato il graduale<br />
passaggio da villaggio a città di parecchi centri minori.<br />
Tale sviluppo rapido e grandioso non ha mancato di manifestarsi anche in alcuni<br />
centri della bassa pianura, specialmente lungo le grandi arterie a sud di Milano.<br />
Ma è meno frequente; soprattutto i centri minori, ancora prettamente agricoli,<br />
della Lomellina, del Cremonese, del Mantovano e anche in parte del Lodigiano e<br />
del Pavese, hanno conservato quasi inalterata la loro estensione e immutato il loro<br />
aspetto.<br />
La forma e la posizione dei centri presenta, come già s’è accennato, una notevole<br />
varietà anche nella pianura. In genere prevalgono quelli compatti. Alcuni di questi<br />
derivano la loro forma dalla cerchia di mura erette anticamente a difesa, come nel<br />
caso di Orzinuovi nel Bresciano; i più, nella bassa, si sono formati spontaneamente<br />
dall’aggregazione di corti, costruzioni rurali di cui si dà la descrizione poco appresso;<br />
come esempio, uno tra i molti, si può indicare Gorbetta, nella pianura milanese.<br />
Nella campagna cremonese e mantovana vi sono diversi centri a catena, ossia con<br />
ediflci (dove a corte e dove no, ma tutti rurali) allineati lungo una strada; tale, ad<br />
246
esempio, Scandolara Ravara nel Cremonese. Nei centri con espansione recente l’allineamento<br />
delle case lungo le arterie che s’irradiano dal centro è frequente e talvolta<br />
ne deriva una pianta a raggiera. Verso questa forma tende Treviglio, cittadina del<br />
Bergamasco. Sul corso dei fiumi vi sono infine numerosi centri doppi, ossia distinti<br />
in due parti, una sulla sponda destra del fiume e l’altra sull’opposta. Alcuni hanno<br />
avuto anche ruolo militare e l’esempio più tipico è offerto da Pizzighettone, sull’Adda,<br />
già eretta a fortezza dai Cremonesi nel 1123 e in seguito cinta dai Visconti<br />
con mura a forma di stella, tuttora in parte esistenti.<br />
Le dimore rurali.<br />
Riguardo all’insediamento rurale è particolarmente interessante rilevare le caratteristiche<br />
formali e strutturali delle dimore, nelle quali, pur nella molteplicità di<br />
particolari aspetti suggeriti da inclinazioni personali, è possibile individuare alcune<br />
costanti che riflettono le soluzioni dei problemi connessi con l’ambiente fisico (in particolare<br />
con la natura del terreno e con le condizioni di clima) e con l’ambiente sociale<br />
(in particolare con l’ordinamento colturale e fondiario), per non dire degli influssi<br />
derivati da situazioni politiche e religiose del passato, cristallizzati nella tradizione.<br />
Fot. Nangeroni<br />
Tipica corte monoaziendale nel Lodigiano (Sordio).<br />
247
•<br />
- di 100 a b it a n t i<br />
о<br />
da 101 a 500<br />
© »»<br />
50 1 1.000<br />
1 »<br />
1.001 ” 2.000<br />
• >»<br />
2.001<br />
T Ч<br />
5.000<br />
® ?)<br />
5.001<br />
lì<br />
10.000<br />
Í»<br />
10.001<br />
il<br />
20.000<br />
20.001<br />
ì »<br />
50.000<br />
□ 50.001<br />
ìì<br />
100.000<br />
■ я 100.001<br />
»><br />
200.000<br />
o ltre 200.000<br />
Distribuzione dei centri della <strong>Lombardia</strong>.
L ’influsso deir ambiente fisico si rileva anzitutto, in un quadro generale, nella<br />
netta differenziazione di forma e di struttura fra le dimore della pianura e quelle<br />
della collina e tra queste e quelle della montagna. Ovviamente non è soltanto un<br />
influsso diretto, ma anche indiretto, in quanto l’ambiente fisico agisce anche nel<br />
differenziare situazioni di ordine umano e sociale (quali, ad esempio, l’ordinamento colturale<br />
e fondiario), che a loro volta contribuiscono ad accentuare la diversità di<br />
struttura e di forma delle dimore nelle tre zone suddette.<br />
Nella pianura il tipo di dimora rurale più singolare e più comune è quello a corte,<br />
chiamata nel dialetto lombardo curt, quando è inclusa nei centri, e cassina, quando<br />
sorge isolata. Essa è costituita da « uno spazio scoperto, generalmente a forma quadrilatera<br />
che, dove non sia da ogni parte circondato dai corpi di fabbrica pertinenti<br />
alle abitazioni e ai rustici, è recinto da muri о da siepi che ne fanno perciò uno<br />
spazio chiuso » (G. Caraci).<br />
Il tipo più caratteristico e forse originario è quello isolato sui fondi della bassa<br />
pianura irrigua; in esso lo spazio quadrangolare, talvolta di un centinaio di metri<br />
e più per lato, è limitato da ogni parte da edifici, nei casi più tipici senza soluzione<br />
di continuità, in modo da formare un complesso edilizio unitario, nel quale però<br />
si distinguono in ogni caso e sempre nettamente la casa padronale, le abitazioni dei<br />
salariati, le stalle-fienili, i rustici. Ad accentuare il carattere unitario della corte<br />
contribuisce l’ingresso unico costituito da un solo grande portone, sicché, salvo la<br />
casa padronale, tutti gli altri edifici hanno i loro ingressi particolari rivolti unicamente<br />
verso lo spazio chiuso. Vero è che ciascun edificio о settore del complesso<br />
edilizio ha una funzione sua propria inerente ad una particolare attività, sicché ne<br />
deriva la tendenza a organizzare lo spazio quadrangolare chiuso in aree di distinta<br />
Fot. Nangeroni<br />
Il lato delle dimore<br />
in una corte lombarda<br />
(cascina Sant’Ambrogio,<br />
Brugherio).<br />
250
Caratteristica dimora<br />
montana a Lèzio<br />
nella valle omonima<br />
(Valcamònica).<br />
Fot. Nangeroni<br />
attività. Tuttavia Tunitarietà dello spazio chiuso non ne risulta spezzata, poiché a<br />
mantenerla contribuisce, in relazione anche dell’isolamento con l’esterno, la funzione<br />
polarizzatrice dello stesso grande cortile nel quale si svolge ogni attività.<br />
A ll’unità edilizia corrisponde l’unità fondiaria. Il dirigente dei lavori (proprietario,<br />
affittuario, fattore) abita con la sua famiglia nella dimora padronale, che talvolta<br />
si distingue, oltre che per una più accurata fattura, anche per la posizione che permette<br />
una migliore sorveglianza sul complesso e in particolare sulla stalla e sul<br />
rustico dove son poste le macchine agricole; nella stessa dimora о adiacente ad essa<br />
trovano posto il granaio e, almeno in passato, il locale d’allevamento dei bachi.<br />
I salariati sono sistemati in un edificio detto cd di paisàn, о di salariò о di ubligà,<br />
a due piani, e ciascun nucleo familiare dispone di un locale adibito a cucina, al<br />
pianterreno, e di un locale, sovrastante la cucina, adibito a camera da letto. Naturalmente<br />
il numero dei salariati (e di conseguenza l’ampiezza dell’edificio) varia a<br />
seconda della vastità del fondo, ma vi sono corti che complessivamente ospitano<br />
anche un centinaio e più di persone, talché in alcune trova posto persino la chiesetta<br />
(con la facciata prospiciente al recinto chiuso) e la scuola; sicché la corte forma,<br />
о meglio formava, una vera e propria comunità con norme comuni di vita, tendenti<br />
« a creare, per gli addetti fissi, condizioni, non soltanto materiali, che vincolassero<br />
all’ambiente e riducessero al minimo le necessità о le possibilità di contatti<br />
con l’esterno », riservati al conduttore (C. Saibene). Così, soprattutto in passato, il<br />
ritmo di vita della corte era normalmente regolato dal suono della campana e il grande<br />
portone d’ingresso veniva sbarrato a sera e solo all’alba riaperto. Non senza fondamento<br />
queste regole di vita sono state riallacciate all’ordinamento feudale e non pare<br />
del tutto arbitrario far derivare la planimetria della corte da quella del chiostro,<br />
tanto più che furono i monaci a dare impulso alla bonifica nel periodo medioevale.<br />
251
Dai tipi dell’Istituto Geografico Militare (autorizzazione n. 902/ST/P del 17 dicembre 1 9 5 9 )<br />
Caratteristica zona a « corti » sparse a est di Cremona tra Malagnino, Bonemerse e Pieve d’Olmi.
Naturalmente la corte non presenta un’assoluta uniformità formale e strutturale<br />
per tutta l’area della pianura nè sorge solo isolata; quello descritto è il tipo più caratteristico<br />
dal quale, forse, sono derivati i tipi con le varianti suggerite dalle necessità<br />
e tendenze locali; è ovvio, ad esempio, che nella zona risicola nel complesso degli<br />
edifici della corte rientri l’essiccatoio del riso, nell’area frumentaria il granaio, nell’area<br />
foraggera il caseificio, ecc. In breve: la corte con abitazione e rustici distinti e<br />
spesso anche disgiunti prevale in Lomellina, nel Pavese, nel Lodigiano, nel Basso<br />
Milanese e nel Cremasco, ma in ciascuna parte con particolari varianti. Così,<br />
ad esempio, nella Lomellina e nel Milanese le abitazioni sono spesso adorne di ballatoi<br />
(un tempo anche in legno) e di scale esterne, mentre altrove i ballatoi sono assenti<br />
e le scale sono interne. Nella Lomellina, poi, vi sono quasi immancabili gli essiccatoi<br />
del riso, mentre nel Milanese prendono grande sviluppo le stalle e gli ambienti di<br />
Fot. Fagnani<br />
Antiche dimore con recenti<br />
aggiunte a San Martino in<br />
vai Màsino.<br />
253
lavorazione del latte. Nel Lodigiano la corte presenta spesso una suddivisione in<br />
cortiletti di disimpegno, cosicché lo spazio rimane più chiaramente destinato a una<br />
particolare attività, tra cui, in particolare, la casearia. Interessante, nella cucina del<br />
salariato, l’angolo presso la grande stufa di mattoni, che viene isolato durante l’inverno<br />
con graticci di legno ed è chiamato, in dialetto, stila. Questo caratteristico<br />
ambiente lo si trova anche nel Cremasco, dove la corte ha normalmente planimetria<br />
rigidamente rettangolare e vi prendono grande spazio i granai. Nel Cremasco è<br />
pure frequente la corte con abitazioni e rustici giustapposti, che prevale nell’area<br />
meno fertile della pianura; la facciata dell’abitazione è spesso rallegrata da un vasto<br />
portico che può allungarsi in altezza sino al tetto, о limitarsi, come nella pianura<br />
bresciana e bergamasca, al pianterreno ed essere sovrapposto da un arioso loggiato.<br />
Anche nel Mantovano si hanno corti con abitazioni e rustici giustapposti, ma per<br />
solito meno tipiche e per lo più aperte su uno о due lati, denunciando in tal modo<br />
il trapasso verso forme diverse; questo fatto si comincia anzi ad avvertire appena<br />
Dimore in legno a Santa Maria dei Monti in Valfurva.<br />
Fot. Fracchi<br />
254
f<br />
Dimora in legno a Livigno.<br />
Fot. Nangeroni<br />
al di là del corso del Chiese e, a valle della confluenza, dell’Oglio, donde ha inizio<br />
un ambiente agrario, a colture promiscue, assai più simile a quello emiliano e veneto<br />
che a quello proprio della bassa lombarda. Nel complesso si direbbe che nella dimora<br />
rurale del Mantovano confluiscono e si fondano elementi architettonici lombardi,<br />
veneti ed emiliani. Il limite meridionale della corte lombarda corre nel complesso<br />
lungo il Po, espandendosi al di là di esso soltanto in limitate aree di pianura dell’Oltrepò<br />
pavese e della provincia di Piacenza, ossia in coincidenza dei passaggi<br />
tradizionali del fiume. A occidente, invece, la corte si espande in tutta l’area di<br />
coltivazione del riso e quindi ben addentro al territorio piemontese.<br />
La pianura asciutta e la collina, sebbene in misura minore, sono ancora zone<br />
di diffusione della corte, ma qui essa assume caratteri differenti; anzitutto è generalmente<br />
inglobata nei centri e inoltre non è più, о lo è solo raramente, esclusiva<br />
di un’unica azienda agricola, ma, per il ridursi di estensione della proprietà, essa<br />
è suddivisa tra due о più aziende e quindi in essa coabitano diversi conduttori<br />
(proprietari, affittuari, mezzadri) con le loro famiglie. L ’abitazione e il rustico sono<br />
costituiti da edifici unitari, ma per lo più di dimensioni minori di quelli della bassa<br />
e non sempre con il loro corpo delimitano per intero lo spazio chiuso centrale, per<br />
cui il recinto si completa con muri о siepi. Insomma, in contrapposizione alla grande<br />
corte о corte monoaziendale della pianura irrigua, questa può essere definita piccola<br />
corte о corte pluriaziendale. In questa ciascun nucleo familiare vive e agisce indipendentemente<br />
dall’altro о dagli altri; ciascuno dispone di una parte stabilita dello<br />
spazio chiuso, di un gruppo di locali dell’abitazione e ha una propria stalla-fienile.<br />
Ormai fuori uso il forno, solo il pozzo è oggi in comune. Anche l’aia, che nelle<br />
corti della bassa occupa una vasta area dello spazio recinto, non è in comune e<br />
non è sistemata nella corte, ma vicino ai cascinotti {cassinòt о casòt), singolari ricoveri<br />
di muratura о di legno о di paglia costruiti sui fondi e utilizzati per riporre<br />
2SS
Forme prevalenti di dimore rurali in <strong>Lombardia</strong>.<br />
I, grandi corti monoaziendali (in prevalenza isolate); 2, piccole corti pluriaziendali (in prevalenza nei centri); 3, piccole<br />
corti pluriaziendali, spesso agglomerate miste a forma di dimore unitarie; 4, dimore a elementi separati; 5, unitarie;<br />
6, in legno (alte valli alpine).<br />
Utet<br />
temporaneamente attrezzi о prodotti di scarso pregio. Forse la netta separazione<br />
di spazi che attualmente si rileva nella piccola corte non esisteva nel passato о<br />
almeno non era in forma così rigida come attualmente; lo può far supporre la tradizione<br />
patriarcale delle famiglie contadine lombarde, per cui non è improbabile<br />
256
itenere che originariamente tra i nuclei familiari coabitanti nella corte esistessero<br />
vincoli di parentela. Affievolitasi nel nostro secolo la tradizione patriarcale, anche<br />
la caratteristica della piccola corte si sarebbe venuta evolvendo. Del resto una evoluzione<br />
di diverso tipo si va manifestando anche sotto i nostri occhi, chè non poche<br />
corti attualmente presentano una forma di coabitazione mista di nuclei familiari,<br />
alcuni con attività contadina altri con attività operaia.<br />
In tutta la pianura sia irrigua che asciutta e ancor più nella collina, accanto al<br />
tipo dominante descritto coesistono tipi diversi di dimora rurale, ma è probabile<br />
che essi siano di epoca meno lontana di quella di formazione della corte e determinati<br />
dall’evolversi nel tempo degli ordinamenti sociali (soprattutto colturali e fondiari).<br />
Nel complesso l’inserimento di questi tipi si nota più frequente in zone di modesta<br />
fertilità, come la collina e le fasce marginali ai fiumi; ivi di frequente le proprietà<br />
fondiarie hanno ampiezza minore di quella dei fondi annessi alle corti e le dimensioni<br />
delle dimore sono in proporzione. Il tipo più diffuso di dimora non a corte è<br />
Fot. Fracchi<br />
Villaggio di dimore temporanee (stalle-fienili) sopra Rezzònico (alto Lario).<br />
17 — L e R e g io n i d 'I t a lia - L o m b a rd ia .<br />
257
Caratteristico fienile sui<br />
prati di montagna in<br />
vai Taleggio.<br />
Fot. Nangeroni<br />
quello con abitazione e rustico congiunti e disposti sullo stesso asse; però nella pianura<br />
che accompagna il Ticino se ne incontrano anche congiunti ma disposti a<br />
squadra о anche, nella collina lungo l’Adda, disgiunti. Gli elementi architettonici,<br />
non privi però di una loro funzione, sono vari: frequente è il porticato, ora esteso<br />
a tutto l’edificio rurale come nell’alta pianura asciutta, ora limitato all’abitazione<br />
come nella collina comasca, ora limitato alla stalla come lungo il corso dei fiumi tra<br />
il T.ambro e l’Oglio, ora interposto tra abitazione e rustico come nel Mantovano<br />
alla sinistra del Po; frequente è pure il ballatoio, che, specialmente se in legno, illeggiadrisce<br />
la dimora come si osserva nella collina del Varesotto e del Comasco e in<br />
alcune parti della Lomellina.<br />
Un’area di particolare interesse è quella Mantovana dove la dimora rurale, con<br />
rustico separato dall’abitazione, disposti tra loro a squadra, presenta analogie con<br />
la dimora tipicamente emiliana.<br />
La dimora rurale nella montagna lombarda ha caratteristiche profondamente<br />
diverse da quelle della pianura. Unico elemento di congiunzione tra le due potrebbe<br />
essere forse la corte che sporadicamente si trova lungo i solchi delle vallate e anche<br />
assai lontano dalla pianura; in Valtellina, ad esempio, gli ultimi esemplari si trovano<br />
in prossimità di Tirano. Ma anche per le corti, il cotto, che prevale come materiale<br />
da costruzione nelle dimore della pianura, cede alla pietra e, in alcune zone,<br />
al legno; sotto questo aspetto la collina, per la presenza saltuaria di roccia in posto<br />
о per l’utilizzazione delle morene, rappresenta un’area di transizione. Ma la differenziazione<br />
tra le dimore del piano e del monte non poggia solo su questo. L ’attività<br />
rurale in montagna è più complessa e più varia che non nella pianura e soprattutto<br />
il reddito è generalmente inferiore. Da ciò nascono particolari situazioni e particolari<br />
aspetti.<br />
258
È stato giustamente rilevato che le dimore rurali della montagna presentano una<br />
grande varietà strutturale. Le dimensioni sono in genere modeste, ma pur in uno<br />
spazio limitato si osserva una grandissima varietà nella disposizione degli elementi<br />
fondamentali. Questa situazione deriva forse dal fatto che nella maggior parte dei<br />
casi la dimora attuale della montagna è il risultato di successive aggiunte e trasformazioni<br />
in dipendenza sia dell’accrescimento del numero dei componenti della<br />
famiglia sia della modestia delle disponibilità finanziarie. È questo un fatto riscontrabile<br />
assai frequentemente: il montanaro raggranella a fatica il suo risparmio e<br />
solo quando ha raggiunto la somma sufficiente procede ai lavori che si manifestano<br />
via via necessari e consentiti dal risparmio stesso, così che nella dimora si nota<br />
una gradualità di aggiunte e di trasformazioni che spesso hanno mutato la concezione<br />
originaria. Ancor oggi del resto è facile notare nelle dimore di nuova costruzione<br />
il progredire lento, magari a distanza di anni, dei lavori di rifinitura dei piani<br />
superiori.<br />
Vi è poi anche un altro fatto: il montanaro, allevatore oltre che agricoltore,<br />
distribuisce il suo lavoro tra i campi del fondovalle, i prati dei maggenghi, il pascolo<br />
degli alpeggi; quindi i trasferimenti stagionali gli impongono oltre alla dimora inver-<br />
Fot. Magnolini<br />
L ’alpe Varadega nell’alta Valcamònica.<br />
La costruzione superiore è adibita alla lavorazione del latte<br />
ed è visibile l’impianto dell’acqua per azionare la zàngola.
naie, che è ovviamente la più attrezzata, altra о altre piccole dimore temporanee:<br />
ecco dunque la bàita о cassina, per indicarle con i termini più diffusi del dialetto<br />
locale, sui maggenghi e l’alpe sui pascoli alti.<br />
Nella pur notevole varietà di forme di aspetti delle dimore invernali si possono<br />
enucleare delle dominanti. Così, riguardo alla struttura, si può notare — oltre il<br />
tipo, tuttavia sporadico, della piccola corte lungo i principali fondivalle — un tipo<br />
nel quale l’abitazione e il rustico costituiscono un unico edificio e un tipo nel quale<br />
abitazione e rustico sono tra loro separati. Nel primo la sistemazione dell’abitazione<br />
e del rustico può presentare due varianti: quella con la stalla al piano seminterrato<br />
о al pianterreno e quindi sottostante alla dimora, che è sovrapposta a sua volta dal<br />
fienile, e quella in cui la stalla, sovrapposta direttamente dal fienile, sorge adiacente<br />
e a contatto con l’abitazione. Entrambe sono frequenti in tutta la media montagna,<br />
e come elemento esterno più caratteristico e più diffuso hanno il ballatoio in legno<br />
(ora sostituito frequentemente dal cemento e dal ferro). Nel secondo tipo si rilevano<br />
pure due varianti principali: quella in cui la stalla-fienile si trova in prossimità<br />
dell’abitazione e quella in cui la stalla-fienile sorge lontano. Di questa seconda variante<br />
offre un esempio caratteristico la vai Varrone, dove le stalle-fienili formano degli<br />
aggregati separati e lontani dai villaggi costituiti quasi esclusivamente da abitazioni.<br />
Però, salvo pochi casi, i diversi tipi con le loro varianti si trovano frammisti e,<br />
meglio che la parola, la rappresentazione grafica può dar l’indicazione dove prevalga<br />
l’uno о l’altro tipo.<br />
Nelle alte valli, come la Valtellina, la Valcamònica e, oltre lo spartiacque, la<br />
vai di Livigno, nonostante il prevalere attuale о la tendenza a prevalere delle dimore<br />
in muratura, rimangono, come ultimi esemplari di un tipo di dimora che probabilmente<br />
è l’originario, costruzioni totalmente in legno che aggiungono un elemento<br />
Fot. Fracchi<br />
Fienile in legno sui<br />
prati montani (vai<br />
di Dentro).<br />
260
Fot. Fracchi<br />
L ’alpe Rescascìa (monte Bregagno, alto Lario);<br />
a destra il ricovero del bestiame, sul fondo il ricovero dei pastori e la casera.<br />
pittoresco alla bellezza naturale dei luoghi. È destino che a poco a poco anche queste<br />
scompaiano, ma lo si annota con rincrescimento. I documenti storici e la tradizione<br />
ci attestano che nei secoli passati numerosi villaggi furono totalmente distrutti dal<br />
fuoco per il fatto di essere costituiti da dimore in legno. Isolacela e Pedemosso in<br />
vai di Dentro arsero per intero nel secolo XVII e Sant’Antonio in Valfurva subì la<br />
stessa sorte nel secolo scorso. Ciò basta a render ragione dell’abbandono dell’uso<br />
del legno per edilizia già dai secoli passati.<br />
Nelle valli alpine e in parte anche nelle valli prealpine il locale più caratteristico<br />
dell’abitazione è la stila. È il locale di soggiorno invernale, sempre accuratamente<br />
foderato in legno, ben arredato e accogliente; in un angolo domina la stufa, grande<br />
parallelepipedo in muratura, alimentata attraverso uno sportello che dà sul corridoio<br />
in modo da evitare che il locale sia invaso dal fumo. Vi è poi il tavolo attorno<br />
al quale si riunisce la famiglia per consumare i pasti e un lato è dominato dal letto<br />
matrimoniale, molto alto, perchè sotto di esso non raramente son collocati ancora<br />
uno о due lettini a rotelle, detti carriole, che a sera vengon levati fuori e servono<br />
per i figli. Il suo stesso arredamento dice come la stila sia il cuore della dimora,<br />
dove la famiglia del montanaro trascorre il lungo inverno. Il sopraggiungere della<br />
261
primavera richiama ai lavori all’aria aperta, e, con il progredire della buona stagione,<br />
ai maggenghi, alle alpi: la stüa rimane, almeno per qualche tempo, deserta.<br />
Nei maggenghi la dimora temporanea (chiamata con diversi termini: munì nel<br />
Varesotto e nel Comasco, cassina e casina nelle Prealpi bergamasche e bresciane,<br />
bàita e cd in Valtellina, preàlp in alta Valcamònica) è di solito, come il prato,<br />
proprietà privata del montanaro; essa sorge generalmente isolata, ma talvolta anche<br />
in aggruppamento a formare quasi dei villaggi temporanei. L ’edificio è costituito<br />
da due elementi fondamentali: la stalla e il fienile, questo ovviamente soprastante<br />
a quella. Raramente è accogliente per l’uomo: vi è normalmente la cucina per preparare<br />
e consumare i pasti, ma non sempre un locale per il riposo notturno; per<br />
questo può servire il fienile o, in caso di intemperie, anche la stalla. Come vani<br />
accessori, ora compresi nella costruzione principale ora come piccole costruzioni<br />
a sè, vi sono sempre quello, ben riparato, di conservazione del latte (sul cui pavimento<br />
si fa scorrere un rivolo d’acqua per accrescere la frescura), e talvolta quello<br />
di lavorazione dello stesso e di conservazione dei latticini; ma spesso a tale scopo<br />
serve la cucina. Nel complesso le costruzioni dei maggenghi sono disadorne e ciò<br />
è comprensibile perchè si tratta di abitazioni temporanee; per lo più sono in muratura,<br />
ma nelle Alpi numerose sono ancora in legno, specialmente nella parte adibita<br />
a fienile.<br />
Sui pascoli alti la dimora temporanea (chiamata generalmente alp о anche munt,<br />
malga, casera, bàita) è normalmente, come il pascolo stesso, о proprietà comunale<br />
Il recinto per il bestiame (baréch) al Pian dell’Avaro.<br />
Fot. Nangeroni<br />
262
о consortile; di solito sorge isolata, ma in Valtellina si trova anche raggruppata<br />
in villaggi. È costituita da uno о più edifici, talvolta di notevoli dimensioni, oggi<br />
per buona parte rimodernati о ricostruiti. Il più importante degli edifici include il<br />
locale di lavorazione del latte, con il focolare e gli attrezzi necessari, un piccolo vano<br />
per la conservazione del latte e un vano per conservare i prodotti caseari; entrambi<br />
questi ultimi vani e soprattutto quello di conservazione del latte sorgono però anche<br />
isolati in luogo fresco. Per l’uomo non vi sono in generale condizioni di agio: per<br />
cuocere le vivande si usufruisce del focolare dove si lavora il latte e per il riposo un<br />
assito nel sottotetto è quanto di meglio si può trovare. Ma la tendenza attuale a<br />
trasferire ai pascoli solamente il bestiame giovane riduce l’importanza dell’attività<br />
casearia e spesso il locale già riservato alla lavorazione del latte viene adattato in<br />
modo da attenuare il disagio del soggiorno dei pastori. Di solito poco lungi dalla<br />
casera vi sono anche stalle о porticati a uso di stalle; sono spesso di grandi dimensioni<br />
ma per lo più non hanno capienza sufficiente per ospitare tutta la mandra e<br />
vi trovano perciò ricovero i soggetti più giovani, più deboli e malati; gli altri pernottano<br />
a cielo aperto, talvolta, come nella montagna bergamasca, entro recinti<br />
chiusi da muriccioli di sassi, detti baréch. Non è raro il caso che nell’alpe vi siano<br />
più stazioni di pascolo; nelle Orobie ve ne sono persino una decina. In tal caso per<br />
ognuna delle stazioni secondarie vi sono soltanto dei ricoveri, permanenti о provvisori;<br />
vi possono essere, ad esempio, solo i muri dell’edificio e il tetto lo si sistema<br />
al sopravvenire degli armenti.<br />
Conclusione.<br />
Sarebbe certamente eccessiva pretesa giungere dalle precedenti osservazioni,<br />
necessariamente sommarie, ad una precisa suddivisione del territorio lombardo in<br />
rapporto alle forme dominanti dell’insediamento umano; è tuttavia possibile giungere<br />
a una semplice distinzione per grandi linee, indicando come particolarmente<br />
estese tra il Po e il crinale alpino: i° la regione agricola della bassa con borghi<br />
rurali e grandi corti monoaziendali ; 2° la regione prevalentemente industriale dell’alta<br />
pianura e della collina occidentale con centri industriali numerosi e spesso congiunti<br />
fra loro (regione urbanizzata); 3° la regione agricolo-industriale dell’alta pianura e<br />
della collina orientale con centri agricoli e industriali, di solito distanziati, e piccole<br />
corti pluriaziendali ; 4° la regione agricolo-pastorale della montagna prealpina con<br />
sedi permanenti in villaggi e sedi temporanee sparse; 5° la regione prevalentemente<br />
pastorale della montagna alpina con sedi permanenti in villaggi e sedi temporanee<br />
in villaggi e sparse. Ciascuna regione è a sua volta suddivisibile in aree minori aventi<br />
individualità proprie. Ad esse poi va aggiunto l’Oltrepò pavese collegabile per più<br />
aspetti alle caratteristiche della regione alla destra del Po.<br />
263
La regione della bassa pianura irrigua è senza dubbio prevalentemente agricola<br />
e d’intenso allevamento ; essa, a parte le grandi città, presenta, sì, alcuni centri in fase<br />
di sviluppo industriale, ma vi prevalgono i borghi agricoli, spesso costituiti da corti,<br />
cui si intercalano grandi corti isolate sulle proprietà fondiarie. In questa vasta area<br />
si devono però distinguere diverse zone e non solo per sfumature: la Lomellina, il<br />
Pavese, il Milanese, il Lodigiano, il Cremasco, il Cremonese e il Mantovano. La<br />
caratteristica precipua di tutta questa vasta regione è costituita dalla corte monoaziendale,<br />
che predomina quasi dovunque. Il primo elemento differenziatore tra<br />
zona e zona può essere offerto dalla frequenza maggiore о minore della corte isolata,<br />
dalle sue dimensioni e dalla sua organizzazione, in connessione con situazioni<br />
locali d’ordine pedologico e idrologico, con lo sviluppo cronologico della bonifica,<br />
con gli ordinamenti colturali e con gli ordinamenti fondiari. Fa spicco in questa<br />
minore suddivisione il Mantovano, in cui la corte si riduce di dimensioni e sorge<br />
di frequente sul fondo, sicché l’entità della popolazione sparsa e dei nuclei equilibra<br />
e talvolta supera quella dei centri. Per tal carattere il Mantovano si differenzia<br />
dalle altre parti della bassa più di quel che queste si differenzino tra loro.<br />
La pianura asciutta e la collina a oriente dell’Adda (esclusa la parte urbanizzata<br />
di Bergamo) hanno un’economia mista, ossia fondata in pari misura sull’agricoltura<br />
e sull’industria. Frequenti sono i centri industriali о in fase di sviluppo industriale<br />
e pur tuttavia numerosi rimangono i centri di antico carattere agricolo. La corte<br />
nella forma tipica della bassa appare sporadicamente ed invece prevale una forma<br />
ridotta della corte, che s’è indicata come piccola corte, in prevalenza pluriaziendale.<br />
Questa si trova con più frequenza nei centri, ma non manca anche isolata e alternata<br />
a cascine, pure isolate, in cui il rustico e l’abitazione sorgono giustapposti. La<br />
dimora rurale conserva le medesime caratteristiche anche nella zona a occidente<br />
dell’Adda, ma qui lo sviluppo industriale ha assunto un carattere dominante trasformando<br />
notevolmente il quadro dell’insediamento. Si tratta di una regione urbanizzata,<br />
prevalentemente costellata di centri in rapida espansione, per cui i caratteri<br />
rurali preesistenti vanno via via estinguendosi soffocati dall’edilizia civile e industriale;<br />
tali caratteri anzi sono ormai quasi del tutto estinti nelle conurbazioni e<br />
specialmente nella conurbazione milanese.<br />
La regione prealpina rappresenta una fascia di transizione, con carattere prevalentemente<br />
agricolo-pastorale, dove le caratteristiche dell’insediamento tipico della<br />
pianura penetrano lungo i fondivalle, ma dove già appaiono le forme dell’insediamento<br />
alpino. La popolazione vive per lo più in centri e nuclei, ma l’accentramento<br />
non si presenta con i caratteri così accentuati della regione alpina, sia per<br />
tradizioni preesistenti sia per lo sviluppo recente, in molti luoghi, delle costruzioni<br />
in funzione turistica о di villeggiatura. Le dimore rurali coordinate attorno ad uno<br />
spazio chiuso del tipo della piccola corte sono ancora presenti lungo i fondivalle<br />
maggiori, ma l’alternanza con dimore di forme varie, unitarie e complesse, è nettamente<br />
più accentuata che non nella collina. Caratteristica esterna più evidente<br />
di ogni dimora è il ballatoio in legno.<br />
264
Schema dei tipi di insediamento in <strong>Lombardia</strong>.<br />
I , stalle, fienili e « casere » di soggiorno temporaneo (raggruppate in villaggi о sparse) dell’alta montagna; 2, villaggi e<br />
borghi rurali di tipo montano; 3, rare città, borghi rurali distanziati con alta frequenza di dimore rurali (anche « corti »)<br />
sparse sui fondi; 4, cittadine, grossi borghi e villaggi in gran numero, intercalati da dimore sparse; s, frequenti<br />
cittadine e borghi rurali di «corti» e grandi «corti» isolate sui fondi; 6, città e cittadine industriali ravvicinate<br />
e spesso congiunte fra loro (conurbazione); a, limite tra Alpi e Prealpi; b, limite della regione di montagna.<br />
La regione alpina, infine, che conserva un carattere prevalentemente pastorale,<br />
è una zona d’insediamento accentrato in piccoli villaggi e nuclei situati prevalentemente<br />
sui fondivalle о sui terrazzi prossimi ai fondivalle. La dispersione rappresenta<br />
casi d’eccezione, come quello di Livigno. Riguardo alla dimora vi sono forme molto<br />
varie : in linea generale a oriente della vai Seriana sembra avere una certa prevalenza<br />
il tipo di piccola corte, mentre a occidente della vai Brembana il tipo unitario e,<br />
nelle valli minori, il tipo a elementi separati. Le costruzioni sono tutte in pietra con<br />
265
tetto di piade, ma nelle alte valli rimangono antiche case in legno che rappresentano<br />
le reliquie del tipo ivi dominante in passato. Nelle dimore delle valli di Chiavenna,<br />
poi, appaiono con evidenza le tendenze dell’architettura engadinese. Ma nella regione<br />
alpina alla dimora invernale fanno riscontro sui prati-pascoli e sui pascoli alti la<br />
dimora primaverile-autunnale e quella estiva, rappresentate rispettivamente dalle<br />
cascine e dalle casere, per cui si rileva una distinzione dell’insediamento anche<br />
per zone altimetriche.<br />
N o t a<br />
( i ; p. 2 38) C en tri m aggio ri: M ilano, 1 . 126.609 a b .; M onza, 6 3.6 2 5; Sesto S. G io van n i, 4 1.9 4 1 ; Seregno,<br />
2 2 .6 6 1; R ho, 1 8 .3 8 1; bisson e, 1 6 .5 5 1 ; D esio, 14 .6 0 0 ; C inisello Bàlsam o, 12 .16 6 ; Cesano M adern o, 10 .8 18 ;<br />
M eda, 10.276 . I dati di popolazione si riferiscono al solo aggregato urbano.<br />
266
C a p i t o l o N o n o<br />
TRADIZIONI E DIALETTI REGIONALI<br />
Declino delle tradizioni.<br />
Senza dubbio (soprattutto se si fa il confronto con altre regioni dell’Italia)<br />
risponde al vero I’affermazione che le tradizioni popolari in <strong>Lombardia</strong> non abbiano<br />
avuto, neppure in passato, una spiccata caratterizzazione regionale. Ciò dipende<br />
probabilmente dalla situazione geografica della <strong>Lombardia</strong> (che, come è stato precedentemente<br />
accennato, rappresenta quasi una zona di transizione nella parte<br />
mediana della valle padana) e dalle vicende storiche in parte derivate da tale situazione.<br />
E un fatto accertabile che le antiche tradizioni popolari della <strong>Lombardia</strong>,<br />
pur non essendo affatto un bagaglio inconsistente e insignificante, più che autoctone<br />
furono allotoctone, ossia, più che germinate per un processo di formazione spontanea<br />
nel grembo del popolo stesso, furono apporto (ma certo non in senso assoluto e ovviamente<br />
con adattamenti locali) dall’esterno e per ciò stesso di adozione frequentemente<br />
non generale a tutta la regione. Forse anche per tale motivo l’attaccamento<br />
alle tradizioni si è dimostrato meno saldo che in altre parti dell’Italia e quindi<br />
risulta comprensibile il declino nei tempi nostri. L ’inizio di tale declino può farsi<br />
risalire alla fine del secolo scorso, allorché si manifestò lo sviluppo dell’attività<br />
economica; poi, con l’accrescersi progressivo di questa, che ha modificato nettamente<br />
il ritmo della vita lombarda e ha determinato un forte afflusso di elementi<br />
eterogenei nazionali, il processo di afiflevolimento si è accentuato; più rapido è stato<br />
nelle città e specialmente a Milano, più lento nelle campagne della pianura; maggiore<br />
resistenza ha opposto la montagna e specialmente la Valtellina e le valli bergamasche<br />
e bresciane, dove le tradizioni avevano potuto affermarsi in forma più<br />
autonoma e originale per l’isolamento che l’ambiente naturale offriva. Ma anche<br />
267
qui, ormai, sia per una più stretta partecipazione alla vita della pianura, sia per<br />
l’intensità del movimento emigratorio stagionale che disperde per periodi più о<br />
meno lunghi gran numero dei nativi in vaste porzioni del territorio nazionale ed<br />
europeo, il patrimonio delle tradizioni si è quasi del tutto annullato. Si può dire che<br />
il tramonto sia sopraggiunto con l’estinguersi della forma patriarcale della famiglia.<br />
Si fondava, questa, sulla supremazia familiare del vecchio genitore sui discendenti,<br />
figli, nipoti e loro consorti, che riconoscevano nel regiù (termine dialettale che ha<br />
quasi suono di regalità) il loro capo; per lo più la figliolanza era numerosa, anche<br />
di quindici e più figli, e con i generi, le nuore e i nipoti, che convivevano assieme<br />
sotto il tetto paterno, si avevano comunità familiari di alcune decine di componenti.<br />
Ma le grandi famiglie numerose, già da molto tempo eccezione nella pianura, sono<br />
ormai rare anche nella montagna e comunque i membri delle superstiti sono per<br />
lo più dispersi per esigenza di lavoro. Forse ultime in ordine di tempo ad estinguersi<br />
sono state le tradizioni legate alla parabola della vita e alle sue vicende liete<br />
e tristi, in particolare quelle legate al culto dei morti. Qualche vecchio abitante delle<br />
alte valli alpine ricorda ancora il tempo in cui era in uso tener viva la fiamma del<br />
focolare durante la gelida notte dei morti e disporvi attorno le seggiole, perchè i<br />
trapassati, tornando, potessero riscaldarsi; di solito si curava anche che la tavola<br />
Fot. Dulevant<br />
Caratteristiche di un antico costume<br />
del Lecchese. Sono evidenti<br />
le varianti portate dall’adattamento<br />
moderno.<br />
268
Fot. ENAL<br />
Danze di un gruppo folcloristico : « I bei » di Erba.<br />
fosse imbandita, che il secchio fosse colmo d’acqua e il fiasco di vino, perchè potessero<br />
altresì sfamarsi e dissetarsi. Ma, raccontando le antiche credenze, anche i<br />
vecchi d’oggi sorridono come di ingenuità di un tempo lontano.<br />
Insomma, di tutti i diversi modi con i quali si manifesta l’anima popolare<br />
— usanze, credenze, cerimonie, feste, spettacoli, canti, leggende e fiabe — ben poco<br />
о nulla oggi rimane. Ovviamente a Milano il processo di declino delle tradizioni<br />
è più evidente che altrove; e non è senza rimpianto che il vecchio e schietto Milanese<br />
ricorda le morte usanze della città provinciale del tempo dei navigli scoperti,<br />
della passeggiata sui bastioni, del carnevalone ambrosiano. Ancora un secolo fa, il<br />
Lombardo e specialmente il Milanese tipico era rappresentato laborioso e di cuore<br />
aperto, ciarliero e un poco ridanciano, ma poco proclive all’arguzia. Meno di un<br />
secolo fa, « quando l’Italietta provinciale incominciava a prendere coscienza di<br />
se stessa, un milanes in mar era un borghesuccio pacifico, amante della buona tavola<br />
e dei propri comodi, un tantino anche ingenuo e pusillanime ». Questo ritratto è<br />
molto cambiato e oggi si usa compendiare il mutamento in una parola, ossia dicendo<br />
che il Milanese si è americanizzato, termine che vuol significare non solo una propensione<br />
agli affari e al progresso, ma anche la perdita di quelle caratteristiche regionali<br />
che lo distinguevano. Se da un lato l’espressione può dunque sembrare un<br />
269
Donne in costume a Cimbergo (Valcamònica),<br />
Fot. Magnolini<br />
elogio, dall’altro può pesare come una condanna; e tanto più meritevole appare<br />
l’attività della Famiglia Meneghina, associazione ambrosiana che si propone di mantener<br />
vive le tradizioni e le caratteristiche locali, e in primo luogo gli aspetti più<br />
apprezzabili del Milanese, quali la generosità, la schiettezza, la serenità e l’equilibrio.<br />
Sarebbe però del tutto errato considerare Milano e il Milanese proclivi a<br />
« standardizzarsi » sullo stampo di una qualsiasi città e di un qualsiasi cittadino<br />
americano. Se, infatti, le tradizioni esteriori sono scomparse, rimangono tuttavia<br />
tendenze spirituali, formatesi attraverso millenni di storia, che difhcilmente sono<br />
soggette a scomparire e delle quali è possibile cogliere la sottile essenza solo vivendo<br />
lungamente nell’ambiente. In misura diversa e in diverso modo le precedenti considerazioni<br />
per Milano valgono anche per le altre città lombarde.<br />
Non molto diversa, come già s’è accennato, è la situazione della campagna. Il<br />
richiamo di lavoro delle industrie spinge una parte dei residenti nella campagna al<br />
viaggio quotidiano verso la città e il riflesso della vita cittadina si manifesta ovunque<br />
evidente. Un esempio manifesto può essere quello dell’abbigliamento. Le fogge<br />
locali sono da tempo in disuso e persino del tutto dimenticate. Solitamente si indi-<br />
270
cano come costumi più rappresentativi e quasi per antonomasia lombardi, benché<br />
non fossero di tutta la regione, quelli con i quali si sogliono raffigurare Renzo e<br />
Lucia; ma tanta fortuna è conseguenza del romanzo manzoniano. In realtà le varie<br />
parti della <strong>Lombardia</strong> avevano costumi diversi e in genere assai belli anche se non<br />
molto vistosi, che talvolta vengono riesumati (ma purtroppo con evidenti trasformazioni)<br />
in occasione di sporadiche manifestazioni folcloristiche, fatte soprattutto<br />
per richiamo turistico. Come vero e proprio residuo dei costumi lombardi rimangono<br />
gli scialli di lana, ampi e frangiati, stampati a fiori dai colori vivaci su sfondo<br />
scuro, che oggi vengono spesso utilizzati come tappeti, a ornamento della dimora.<br />
Più di frequente le valli alpine tuttavia, come ad esempio, Grosio in Valtellina, riservano<br />
ancora la sorpresa di qualche rara donna in costume completo anche nei giorni<br />
di lavoro.<br />
Carnevali e danze campestri, cortei e processioni un tempo frequenti e spesso<br />
grandiosi, se ancora sussistono sono una pallida e non raramente cattiva copia delle<br />
antiche manifestazioni. Di quel che rimane, tuttavia, qualcosa è di buon gusto: non<br />
si fa torto a nessuno portando come esempio i firlinfö di Cantù, gruppo musicale<br />
con strumenti a fiato costituiti da molte cannule, opera dell’artigianato locale.<br />
Usanze collegate con il lavoro dei campi e con l’allevamento sono nella maggior<br />
parte in declino e alcune vanno quasi del tutto scomparendo. Per il baco da seta si<br />
usava propiziare il buon andamento in diversi modi: nel Pavese donando alla chiesa<br />
un ramo carico di bozzoli, in Brianza benedicendo i graticci nella notte di Natale,<br />
nel Comasco recando le carte forate di muta al Grocefisso miracoloso di Como, ecc. ;<br />
scomparso l’allevamento son caduti gli usi. E chi ormai celebra più al 24 aprile,<br />
giorno di San Giorgio, la festa del latte, durante la quale si concordavano i contratti<br />
annuali ? Son tutte tradizioni ormai appartenenti al passato e anche gli<br />
aspetti più infantili di esse, come le favole e le filastrocche, sono caduti in disuso.<br />
Forse unico elemento ancora vivo, per quanto anch’esso in sensibile declino,<br />
è il dialetto.<br />
I dialetti lombardi.<br />
Graziadio I. Ascoli nel suo saggio famoso L ’Italia dialettale collocò il lombardo<br />
fra i dialetti che si staccano dal sistema italiano vero e proprio, ma non entrano a<br />
far parte di alcun sistema neolatino estraneo all’Italia, e più particolarmente fra i<br />
dialetti gallo-italici, divisi in quattro gruppi: ligure, pedemontano, lombardo, emiliano.<br />
Se però ricerchiamo fra i tratti fonetici che l’Ascoli isola come peculiari dei<br />
singoli dialetti, quelli che caratterizzano il lombardo, ci avvediamo che la messe<br />
non è copiosa. Vediamo caratteristiche comuni al piemontese-lombardo-emiliano<br />
oppure al piemontese-emiliano о al piemontese-ligure о a tutti i gruppi insieme;<br />
2 7 1
vediamo delle peculiarità liguri (quali il dileguo di r intervocalico che tuttavia si<br />
riscontra anche nell’alto Milanese); ma quali peculiarità esclusive del lombardo<br />
non vediamo che la risoluzione del gruppo consonantico latino et in c (esempio:<br />
noe, fac, lec) che però varca i confini di <strong>Lombardia</strong> estendendosi a paesi in cui<br />
già son notevoli i tratti piemontesi о emiliani. Evidentemente un tratto fonetico, pur<br />
esclusivo di un dialetto, non può riassumerne in sè tutta la fisionomia che è molto<br />
più ricca e complessa. Anche in una frase del tutto priva di quell’elemento caratteristico<br />
(senza tracce di noe, fac, ecc.) si può chiaramente riconoscere in un parlante<br />
l’accento lombardo, che pur varia di paese in paese. Esistono infatti, più che<br />
un dialetto, г dialetti lombardi che si diversificano, pur conservando una fondamentale<br />
somiglianza. Le divergenze sono il riflesso del relativo isolamento in cui<br />
vissero, specialmente in certi tempi, i singoli paesi; le somiglianze scaturiscono sia<br />
da un’origine comune, sia da processi di livellamento, provocati da contatti e scambi<br />
tra le diverse località, e soprattutto dal prestigio culturale di cui hanno goduto e<br />
godono i centri più importanti. L ’origine comune è, come tutti sanno, nel latino<br />
volgare quale fu appreso e parlato dalle popolazioni celto-liguri di questa regione<br />
dopo la conquista romana, le divergenze attestano sia l’isolamento, sia la vitalità<br />
dei singoli centri, la loro resistenza contro i processi di livellamento, la capacità di<br />
adattare al proprio sistema linguistico le innovazioni giunte da fuori. Il centro che<br />
esercitò la più forte azione livellatrice, specialmente nella <strong>Lombardia</strong> occidentale,<br />
oltrepassandone anche i confini, è Milano; nella orientale spicca per una particolare<br />
vitalità Bergamo; ma, soprattutto in questo secolo, è andato crescendo con ritmo<br />
sempre più rapido l’influsso della lingua nazionale, favorito da strumenti di diffusione<br />
straordinariamente efficaci quali la stampa, il cinema e le trasmissioni radiofoniche<br />
e televisive. La situazione odierna nei centri più popolosi e industrializzati<br />
cosi si presenta: i bambini imparano l’italiano; i genitori, quando non siano immigrati<br />
(e l’immigrazione contribuisce a favorire l’italiano come mezzo comune di<br />
scambi linguistici), parlano un dialetto livellato sul milanese; i vecchi conservano<br />
più о meno le caratteristiche locali. Per fare un esempio, a Legnano molte persone<br />
dicono italianamente il latte con una gamma di sfumature che interessano l’oscuramento<br />
(velarizzazione) di a e l’indebolimento di tt; molti dicono ul latt alla milanese,<br />
ma con l’articolo locale (ul invece del milanese el) e con a sempre più scuro<br />
che a Milano; solo pochissimi si ostinano ad usare l’autentico indigeno ul laci.<br />
Anche a Milano el latt ha, credo, completamente scacciato con l’aiuto dell’italiano<br />
latte, il vero milanese lace, mentre resiste un po’ meglio face non tanto nel senso<br />
di « fatti », quanto di « faccende ». Il che mostra come nella tendenza a modificare<br />
un determinato suono in un altro, tendenza che accomuna tutti i vocaboli in cui<br />
compare il detto suono, ogni vocabolo ha una sua vicenda e lotta con inaspettati<br />
nemici e alleati. Il milanese e l’italiano sono dunque due modelli linguistici vivi<br />
nella coscienza dei parlanti e tali da esercitare un’azione corrosiva sui lineamenti<br />
più caratteristici dei singoli dialetti. Una ragazza della valle Anzasca interrogata se<br />
al suo paese « sempre » si dicesse soimpar, rispose, scoppiando a ridere, che solo i<br />
2 7 2
vecchissimi « usano tale pronuncia, noi giovani parliamo ormai milanese e diciamo<br />
sempar » (il milanese invero dice semper).<br />
Queste esemplificazioni vogliono chiarire la situazione attuale dei dialetti lombardi,<br />
variabile da luogo a luogo. Vi sono paesi più isolati e più attaccati alle proprie<br />
tradizioni linguistiche, altri più aperti ai contatti e agli scambi culturali, più pronti<br />
a dimenticare il proprio passato per avvicinarsi a forme ritenute culturalmente e<br />
civilmente superiori. Ma entro ogni paese esistono varie stratificazioni linguistiche<br />
rappresentate ora dai conservatori delle forme più indigene, ora dagli individui più<br />
permeati di cultura extramunicipale e nazionale. Accade pure che uno stesso individuo<br />
si serva di piani linguistici diversi a seconda che conversi con la vecchia madre<br />
о col giovane amico о col forestiero. Chi fa un’indagine sui dialetti tende naturalmente<br />
a isolare gli strati più arcaici, la parlata dei vecchi conservatori, trascurando<br />
volentieri la massa dei parlanti più о meno italianizzati. Ciò, anche se altera il<br />
quadro reale della situazione linguistica attuale, è pienamente giustificabile non già<br />
perchè i romantici fondatori della linguistica scientifica la concepirono come uno<br />
strumento per ricostruire le fasi più remote della lingua e solo in tempi recenti si<br />
sono affermate tendenze più attualistiche, ma perchè l’aspetto caratteristico e individuale<br />
attira il nostro interesse più del generico e del comune; ed è estremamente<br />
necessario salvare un materiale così prezioso prima che il progressivo livellamento<br />
culturale ne cancelli la memoria.<br />
Caratteristiche dei dialetti lombardi.<br />
L ’Adda divide linguisticamente la <strong>Lombardia</strong> in due settori; occidentale e<br />
orientale. Quest’ultimo occupa le valli bergamasche e scende lungo il Garda e il<br />
Mincio verso il Po, che solo nel Cremonese segna il limite dei dialetti lombardi.<br />
L ’occidentale varca anche largamente il Ticino, ma il territorio tra questo e la<br />
Sesia costituisce una specie di condominio lombardo-piemontese. (Consideriamo, per<br />
esempio, una desinenza verbale della prima persona plurale: -urna. Essa caratterizza<br />
il Piemonte e giunge fino al Ticino; ma per quella dell’infinito della prima coniugazione,<br />
-are, che in Piemonte è -è e in <strong>Lombardia</strong> -d, noi troviamo -d, come<br />
cantd, andd, in tutta la Lomellina e persino oltre la Sesia, sotto Vercelli). Ma è<br />
naturale che nelle zone confinanti con le altre regioni si trovino le infiltrazioni di<br />
fenomeni tipici dei territori d’oltre confine. Per esempio, nella stessa città di Pavia,<br />
appena passato il Ticino, nel cosiddetto Borgo, si nota che parole, quali vin, fin, ben,<br />
suonano vei, fei, bei. Si tratta del dittongo emiliano da in, én con la caduta del suono<br />
nasale. Anche il Mantovano risente dell’Emiliano, oppure, col Bresciano, del vicino<br />
Veneto. Vi si dice infatti veda, oreda, che a Milano о Bergamo suonano vegia,<br />
oregia. (Possiamo precisare; a Crema si dice ugiada, da Soresina verso est si dice<br />
i8 L e R e g io n i d 'I t a lia - L o m b a rd ia .<br />
273
Costume valtellinese.<br />
Fot. Stefani<br />
ociada). A settentrione i dialetti delle valli alpine risentono della vicinanza dei territori<br />
ladini e, specialmente nella zona di Bormio, gli elementi ladini e lombardi<br />
si intrecciano fortemente.<br />
Consideriamo ora alcuni fenomeni che il lombardo ha in comune con gli altri<br />
dialetti dell’Italia settentrionale. Cominciamo con la tendenza a semplificare le consonanti<br />
doppie. Si confronti l’italiano « coppa », « bocca », « matta » col lombardo<br />
cupa, buca, mata. La grafia tradizionale del dialetto nasconde alquanto questo fenomeno.<br />
Il milanese infatti scrive quel gran dottor, ma pronuncia quel grà dutùr con<br />
l’ultima vocale lunga. Piuttosto le consonanti finali subiscono a Milano e in altre<br />
località un rafforzamento articolatorio per cui talune consonanti sonore diventano<br />
sorde: tücc, véce, göp, donn. La Lomellina è forse la zona in cui il raddoppio delle<br />
consonanti è più vivacemente sentito.<br />
Un suono caratteristico della <strong>Lombardia</strong> (unita però al Piemonte, alla Liguria,<br />
a parte dell’Emilia, del Trentino e dei territori ladini) è il cosiddetto ü lombardo,<br />
derivato da ü latino; füm, lüna, brut, fumo, luna, brutto. Tuttavia nel settore<br />
occidentale questo ü in molte parole si è aperto in ö senza una regola precisa, per<br />
cui si dice bröt, so, ma diXr, crii. In certe zone alpine ü avrebbe perso il suo carattere<br />
palatale tornando al suono latino e toscano u.<br />
274
Fenomeno importante e comune a gran parte dei dialetti settentrionali è la lenizione<br />
delle consonanti intervocaliche. Mentre l’italiano dice pepe, seta, formica, il<br />
milanese dice pever, seda, furmiga. Questo raddolcimento può avere ulteriori sviluppi,<br />
arrivando fino alla scomparsa della consonante stessa. Invece del toscano<br />
« cognata », il milanese dice cügnada, ma in Brianza abbiamo cilgnàa, e a Varese per<br />
impedire la confusione delle due vocali si inserisce una consonante nuova: cügnava.<br />
Tanto in <strong>Lombardia</strong>, quanto in Piemonte ed Emilia (e, si può aggiungere, in<br />
Francia) le vocali finali non accentate sono tutte scomparse all’infuori di -a. Mentre<br />
l’italiano dice « tempo », « orbo », « latte », il lombardo dice temp, orb, lat (о lac). (Certi<br />
gruppi di consonanti richiedono una vocale di appoggio, come scendra). Esiste però<br />
nell’alto Milanese una zona abbastanza estesa e gravitante su Legnano e Busto Arsizio,<br />
in cui le vocali finali non sono cadute: tempu, orba, laci. Condizioni analoghe si ritrovano<br />
a Sant’Angelo Lodigiano e, appena passato il Ticino, a Galliate, a Borgomanero.<br />
La <strong>Lombardia</strong> è in buona parte circondata da regioni che conoscono in varia<br />
misura il passaggio a e della vocale a in fine di sillaba accentata (per cui « trave »,<br />
«sale », «Natale» suonano tref sei, Nadèl).<br />
Questa alterazione è scarsamente conosciuta<br />
in <strong>Lombardia</strong> : vale a dire in alcuni<br />
paesi della Valtellina e in una piccola<br />
area della Brianza attorno a Carato (Carè).<br />
Tuttavia il passaggio a è di à seguita da n<br />
si trova anche nel contado di Busto<br />
Arsizio (pèn, mèn : pane, mano) e nel<br />
Vogherese (räna, gämba). Invece è assai<br />
diffusa, specialmente nel settore occidentale,<br />
la tendenza a oscurare a sotto<br />
accento tonico, spostandolo verso o; tendenza<br />
comune ben diffusa anche in Piemonte.<br />
(Anche quando parlano in italiano<br />
molti lombardi e piemontesi pronunciano<br />
ogni a sotto accento, quasi come о aperto).<br />
Comune a quasi tutta la <strong>Lombardia</strong> è<br />
l’alterazione di al davanti a consonante<br />
in ol ; per cui « caldo », « salta » suonano<br />
cold, solta. (A oriente si arriva fino a<br />
tacere l: oter: altro).<br />
Sempre nel settore orientale si verifica<br />
la tendenza ad aprire fino a e quella<br />
vocale i sotto accento che nel latino<br />
classico era lunga; per cui a Bergamo<br />
si dice ostarea, sea, leber : osteria, sia,<br />
libro.<br />
Fot. Fracchi<br />
Rari costumi ancora in uso<br />
in Valtellina (Grosio).<br />
275
Consideriamo ora le due vocali chiuse, toniche, del latino volgare e, o. La prima<br />
è generalmente conservata in <strong>Lombardia</strong>, ma in un piccolo gruppo di parole si<br />
chiude in i: sira, tila, scira, candila; fenomeno assai più esteso nel settore orientale,<br />
come a Bergamo: mis, nif, bif, pir, pii, ecc. Questa tendenza a una maggiore chiusura<br />
si rivela assai più intensamente nell’altra vocale, о (ossia о lungo, и breve del<br />
latino classico), che in molti luoghi passa a и sia in <strong>Lombardia</strong> che in Piemonte e<br />
Liguria. La grafia tradizionale del dialetto milanese vuole che si continui a scrivere о<br />
in luogo di u, per cui si scrive so, pozz ma si legge su, puss. Questo stesso fatto e la<br />
persistenza di о in molti luoghi induce a credere che si tratti di un processo abbastanza<br />
recente e non compiuto.<br />
Le due vocali aperte corrispondenti (ossia e, о brevi del latino classico) quelle<br />
che prime e più largamente si dittongarono in fin di sillaba (si pensi a « piede »,<br />
« fuoco ») e anche, per quanto riguarda i dialetti ladini, nell’interno della sillaba,<br />
presentano una situazione complessa. Generalmente suonano aperte in sillaba chiusa<br />
(fèsta, tempèsta, avèrt; sòpp, mòli, òss), mentre in sillaba aperta e suona chiuso e о<br />
si turba in Ö. Questi due risultati presuppongono però una dittongazione ie, uo che<br />
spiega l’esito i in qualche punto della Valtellina (Albosaggia) e del Bresciano: fil,<br />
mil: fiele, miele. Ma il processo non dovette seguire una linea di sviluppo così<br />
chiara, quale si ebbe in Francia, perchè riscontriamo ö anche in sillaba chiusa (entrano<br />
in giuoco influsso di palatale e metafonia) in un gruppo di vocaboli che si allarga<br />
quanto più saliamo a settentrione verso le valli del Ticino, dove troviamo ö anche<br />
al posto di 0 chiuso del latino volgare. Per esempio, in vai Veddasca « gola »,<br />
« cote » suonano gòra, kòt. In taluni luoghi di queste stesse valli ö è mal tollerato e<br />
mutato in e. Così abbiamo in brevissimo spazio una molteplicità di esiti: kör, ker,<br />
kor: cuore; lanzó, lanzé, lanzó: lenzuolo; foja, feja, foja: foglia; nòe, nec, noe: notte;<br />
kòl, kel, kol: collo; ecc.<br />
Le alternanze morfologiche dovute a metafonia (ossia all’influsso prodotto sulla<br />
vocale tonica dalle vocali finali i, u), quali vec-vié vecchio-vecchi; denciu-dinci:<br />
dente-denti; fiòl-fiola: figlio-figlia resistono ancora nelle valli e nel ceto contadino,<br />
ma spariscono rapidamente nei centri più popolosi. Un fenomeno di armonia vocalica<br />
inverso alla metafonia è quello che si verifica in alcune valli ticinesi (come<br />
Leventina e Veddasca). L ì la vocale d’uscita si intona о si assimila alla vocale tonica:<br />
oco invece di « oca », parolo invece di « parola », siri invece di « sera », ecc.<br />
Anche il lombardo conosce la scomparsa della vocale postonica nelle parole<br />
sdrucciole (carisna, melga, ecc.) ma non ama le violente contrazioni dell’emiliano<br />
e piemontese, dovute alla caduta di altre vocali protoniche о controfinali (e perciò<br />
avremo telàr, finestra e non tlé, finestra come in Piemonte).<br />
Vari sono gli aspetti della nasalizzazione delle vocali che precedono n г m finali<br />
di sillaba о di parola. A Milano tali consonanti sono completamente assorbite dalle<br />
vocali : pä, tëp, Ьй, vi, ѵй, ecc. ; a Bergamo scompaiono invece per denasalizzazione :<br />
pa, tep, i, mut: pane, tempo, vino, monte (anche nel Vogherese e Pavese i ricordati<br />
vei, fei). Al contrario l’articolazione delle consonanti nasali può rafforzarsi spo<br />
276
standosi (bum: buono, a Legnano); pan, pön con n velare, che può persino far udire<br />
dopo di sè о trasformarsi in un’occlusiva sorda: nünk: noi, a Milano e pök, kök:<br />
pane, cane, a Càmeri appena varcato il Ticino. (Più a sud, in Piemonte, lungo la<br />
Bòrmida troviamo la fricativa invece dell’occlusiva velare: veih, leih: vino, lino).<br />
A sua volta la vocale per influsso della nasalizzazione può mutar colore : a diventa è, ò<br />
(pè, pon); i può diventare e (vë: vino a Busto Arsizio), ü può diventare ö (vöna,<br />
scorna, lona: una, schiuma, luna).<br />
Un importante fenomeno che unisce gran parte della <strong>Lombardia</strong> occidentale<br />
con la Liguria e parte del Piemonte è il passaggio di -l- tra vocali a -r- : ara, scara,<br />
candirà: ala, scala, candela. La scomparsa totale di -r- intervocalico si ha, come a<br />
Genova, nelle pievi di Busto Arsizio e Dairago. Anche l davanti a consonante<br />
diviene r: curtél, sarvadig, carcagn.<br />
Il fenomeno ladino dell’intacco palatale di ca e ga è presente nelle sue varie<br />
fasi in vari distretti del Canton Ticino ; ma veramente sorprende riscontrare a Busto<br />
Arsizio in bocca a qualche vecchio chian, ghiambi: cane, gambe. Nell’alta Valtellina<br />
e in alcune valli bergamasche о bresciane si riscontra invece l’altro fenomeno ladino<br />
che riguarda la conservazione di l dopo le consonanti c, g, p, b, f (per es., ciaf,<br />
glanda: chiave, ghianda), mentre l di norma diviene j nel lombardo (biank, fià:<br />
bianco, flato; e quindi ciaf, gianda: chiave, ghianda). L ’esito ligure che uniflca<br />
cl, gl, pi, bl in c è presente con le sue fasi intermedie in alcuni distretti settentrionali:<br />
pcof: piovere e cui, canta: pianta, ecc.<br />
C seguito da vocale anteriore (e, i) dà ora c ora s pura о schiacciata, ora z.<br />
Certamente l’influsso dell’italiano tende a sostituire e dilatare c contro gli altri esiti.<br />
A Milano cimiteri ha ormai soppresso scimiteri; mentre nell’estremo settore orientale<br />
si ha anche la fricativa interdentale.<br />
G seguito dalle stesse vocali dà l’affricata о la fricativa palatale sonora, ma nel<br />
Bergamasco e in Valtellina (Albosaggia) si ha anche d: dümei: gemelli; do: giù (in<br />
vai Imagna).<br />
Fenomeno importante nel territorio bergamasco è la trasformazione di s (originario<br />
о proveniente da c) in h (fricativo velare): hura: sopra; hul: sole; hervèl: cervello).<br />
Lo stesso fenomeno si trova anche nelle valli ticinesi (Malvaglia, Piero e<br />
Lozzo) ma limitato a s palatale: higula: cipolla; purhèl: porcello; brah: braccio (ma<br />
sass: sasso). Anche / può essere continuato da h a Gorduno (Ticino), Germasino<br />
(Como), Borno (Brescia): her: fiele; harina: farina.<br />
Altro fenomeno caratteristico del bresciano e bergamasco è la scomparsa di v<br />
iniziale e intervocalico: i: vino; ida: vita; cadi: cavallo, ecc.<br />
Del milanese va pur ricordata l’epentesi di n davanti a g: minga, leng: leggere;<br />
Unger: leggero; rungia: roggia.<br />
Per quanto riguarda la morfologia va segnalata la formazione del plurale mediante<br />
mutamento di suffisso: berì-berìtt, tusa-tusànn. Quest’ultimo suffisso un tempo era<br />
molto più diffuso; oggi lo è ancora solo nel Ticino: nonàn: nonne; galinàn: galline;<br />
ecc. In vai Mesolcina il caratteristico plurale — però di origine diversa — la<br />
277
vaken: le vacche; la gamben: le gambe. Nel caso di dona-donn, mama-mamm, il<br />
rafforzamento della vocale al plurale è dovuto, non a esigenze morfologiche, ma<br />
alla scomparsa della vocale finale. Infatti il plurale di lett, orb e simili è uguale al<br />
singolare. Naturalmente nella zona dove le vocali finali sono mantenute, il plurale<br />
è -i per i due generi, mutandosi in i la desinenza -ae del latino (-e nel latino volgare):<br />
saku-saki, scarpa-scarpi. A Bergamo il plurale femminile è in -e: i orege longhe.<br />
Per quanto riguarda il participio passato si hanno numerose estensioni analogiche:<br />
rumpü, legiü, scriva : rotto, letto, scritto. Le terminazioni -ato, -ito, -uto nel settore<br />
occidentale perdono la consonante e la vocale accentata assorbe l’ultima vocale<br />
allungandosi (nel Canton Ticino abbiamo invece -au, -ou, -о); nel settore orientale<br />
la consonante viene ristabilita: cantàt, estìt: cantato, vestito. Qui il plurale risente<br />
dell’effetto palatalizzante della desinenza -i, che poi è caduta: -ac, -ic (anche an:<br />
anno, al plurale risente dello stesso effetto: añ).<br />
Nella coniugazione verbale è notevole il rafforzamento dei pronomi personali.<br />
A Milano: mi disi, ti te diset, lü ’I dis (parallelo al -t della seconda persona singolare<br />
è il -V oppure - f della seconda plurale limitato però a certi tempi : füdessuv, a Milano,<br />
e portuf, a Como). La zona che conserva le vocali finali, non tollera -t della seconda<br />
persona ; in compenso fa un grande uso di a (derivato dal pronome di prima persona) :<br />
mi a disu, ti (a) te disi, Ш al dis, nüm a disum, violtar a disi, lur a (oppure i) disan.<br />
Anche il lessico ha le sue peculiarità, fra cui si può ricordare biott : nudo ; borlà già :<br />
cadere; catà: cogliere; basèll: gradino; scanscia: gruccia; ciapp: cocci; purtà cundisiùn:<br />
portare il lutto, ecc. La <strong>Lombardia</strong> si unisce, tramite l’Emilia, alla Toscana<br />
nell’uso di zio, mentre in Liguria, Piemonte, Veneto, Grigioni e parte del Ticino,<br />
prevale barba. Ma vi sono vocaboli che si dividono il dominio lombardo. Così<br />
« ragazza » si dice tusa a Milano (e a nord di Milano anche il maschile tus, tusü,<br />
sempre con s sonoro, oltre a bagai, pinola, ecc.) a Bergamo invece predomina s-cèt,<br />
s-cèta. Abbiamo scusd: grembiule, a occidente; bigaröl a oriente; «falegname» è<br />
legnamé a ovest, mentre la parte orientale preferisce, assieme al Veneto, mar angón;<br />
«chioccia» è pita a ovest; dosa, krosa a est. Dalla Francia jambon si è esteso a<br />
tutto il Piemonte e la <strong>Lombardia</strong> occidentale (giambùn). Dalla Sesia a oltre Milano<br />
«cresta» si dice scestra, a oriente gresta si espande fino al Veneto e Trentino. L ’antico<br />
vocabolo germanico skirpa: dote, resiste ancora con una certa vitalità solo lungo<br />
le sponde del Ticino.<br />
La letteratura dialettale.<br />
Il contributo degli scrittori lombardi agli albori della letteratura italiana è, almeno<br />
quantitativamente, notevole pur non brillando per singolari pregi estetici. Cremona<br />
è il primo centro che si distingue per la produzione di Girardo Patecchio, Ugo<br />
da Persico e forse dello stesso Uguccione da Lodi. Segue Milano coi Sermoni di<br />
278
Pietro da Barsegapè e i numerosi scritti volgari di Bonvesin da la Riva. Bergamo<br />
non ha nomi tanto illustri, ma soprattutto i suoi testi anonimi, come il De ve salve,<br />
virgena Maria, hanno un forte colorito dialettale. Diciamo colorito perchè tutta<br />
questa letteratura « volgare » non può definirsi sic et simpliciter « dialettale ». Sul<br />
carattere « illustre » о meno di questi « volgari » non esiste oggi un giudizio pienamente<br />
concorde e solo un esame linguistico rigoroso e condotto sui singoli testi<br />
potrebbe sviscerare esaurientemente il problema, ma si dovrà comunque ammettere<br />
che l’ideale linguistico a cui mirano questi scrittori non è semplicemente il<br />
dialetto. La scelta del volgare e l’esclusione del latino era dovuta alla necessità о<br />
volontà di comunicare con la gente non « litterata », ma la cerchia dei lettori era<br />
molto più vasta di quella racchiusa tra le mura d’una città qualsiasi; gli argomenti<br />
esposti, per lo più religiosi e anche solenni, richiedevano una lingua sostenuta da<br />
una cultura non casalinga ma più largamente addottrinata. L ’ampiezza del pubblico<br />
e lo stimolo culturale dovevano condurre a una lingua sovramunicipale, che tendenzialmente<br />
smussava i tratti più angustamente locali e non poteva non sentire<br />
le sollecitazioni esemplari del latino, la lingua universale per eccellenza, e di quella<br />
che dalla Francia aveva esteso il suo prestigio su gran parte d’Europa. Il dialetto,<br />
come espressione caratteristica di una ristretta comunità, è una base di partenza,<br />
un centro da cui più о meno ci si allontana per essere accetti in uno spazio geografico<br />
più vasto. L ’atteggiamento di Dante è significativo. Le citazioni dialettali<br />
del De Vulgari Eloquentia, mirando a individuare gli elementi più caratteristici e<br />
disgustosi del « turpiloquio » municipale, esprimono una risoluta condanna dei dialetti,<br />
paragonati alla musica levigata, alla grazia del parlar gentile di quelle persone<br />
che, sparse in tutta Italia, la cultura ha con una certa uniformità raffinato. Gli scrittori<br />
lombardi sopraindicati vivono in ambienti e tempi diversi, hanno forze troppo<br />
più deboli, ideali più modesti, ma vorrebbero camminare in una simile direzione.<br />
Un rovesciamento di posizioni, cominciato nella seconda metà del secolo XV,<br />
si afferma decisamente nel secolo successivo, quando gli scrittori non muovono più<br />
dal dialetto verso la lingua, ma, forti ormai di una ricchissima esperienza artistica<br />
e linguistica, talora ripiegano sul dialetto per ragioni forse non ancora pienamente<br />
chiarite. Sarebbe difficile dimostrare, come è stato detto, che la spinta verso il dialetto<br />
venga da una coscienza regionale dopo che il consolidamento delle signorie<br />
ha formato in Italia dei distinti blocchi politici. La produzione dialettale si afferma<br />
proprio quando gli stati regionali cadono in balìa dello straniero e quando la cultura<br />
nazionale afferma con maggior convinzione l’unità della lingua italiana, richiamata<br />
ai grandi modelli toscani. Se poi osserviamo i libri contenenti opere in dialetto,<br />
notiamo che i dialetti preferiti non rappresentano delle precise entità politiche ma<br />
la grande e colorita varietà del mondo italiano. Il Trofeo della vittoria sacra ottenuta<br />
dalla Christianissima Lega contra Turchi nell’anno iS 7^, rizzato da’ più dotti<br />
spiriti de’ nostri tempi nelle più famose lingue d’Italia con diverse rime disposte da<br />
L. Grato (Venezia, 1572) contiene poesie in veneziano, in lingua « graziana », nel<br />
dialetto della vai Brembana, in padovano, e in gergo slavo; le Nozze del Zane (forse<br />
279
Venezia, 1540 circa) sono in bergamasco, napoletano, milanese, genovese, veneziano,<br />
bolognese, ferrarese, romagnolo, piacentino, modenese, mantovano, con versi in<br />
francese, spagnolo, tedesco e gergo slavo. Quasi tutti i dialetti italiani compaiono<br />
nelle Disgratie del Zane narrate in un sonetto di diciasete linguazi (circa 1550). Si<br />
aggiungano gli scritti in lingua « pedantesca », maccheronica, nei vari gerghi degli<br />
alloglotti slavi, greci о tedeschi.<br />
Quest’orgia di linguaggi diversi denuncia un fine di comicità che nasce osservando<br />
chi è rimasto fuori dalla norma comune, ossia la norma linguistica della gente<br />
incivilita da una certa quantità di cultura. Perciò il contrasto dei più vari dialetti<br />
alternati dalle signorili inflessioni delle battute in italiano, si ritrova largamente nel<br />
teatro comico e caratterizza, non meno del costume e delle altre particolarità fisiche,<br />
le maschere della commedia dell’arte. Ma la comicità non esaurisce la spinta verso<br />
il dialetto. Il ceto colto e signorile si diverte della « garrulitas », della « rozza asprezza »<br />
delle plebi già condannate da Dante. Ma Dante condannava con severità perchè<br />
voleva insegnare a distinguere la parola « ispida » da quella « pettinata », ora invece<br />
si distingue con facilità e ci si compiace della facilità con cui si distingue. L ’ironia<br />
è temperata da una viva simpatia, da una curiosa esplorazione di un mondo vario<br />
e vivacissimo. Ritroviamo qui ciò che si nota in altri campi. Il Quattrocento ha ricercato<br />
la forma ideale, unica, razionale, universale; i pittori la trovavano nella concezione<br />
matematica dello spazio, gli umanisti nella lingua più razionale, universale<br />
Caratteristici festoni di pannocchie di mais<br />
appesi ai ballatoi nelle dimore rurali (Borno, Valcamònica).<br />
Fot. Nangeroni<br />
280
Firlinfö di Cantil.<br />
Fot. Stefani
e, nella sua perfezione, immobile: il latino. Poi ci si accorse che tanto le rigide trame<br />
prospettiche dei pittori, quanto la rigorosa razionalità del latino о la rarefatta atmosfera<br />
della lirica petrarcheggiante non coglievano pienamente il vario fluire della<br />
vita; e si cominciò di questa a ricercare le manifestazioni più individuali ed empiriche,<br />
e il movimento e i vari momenti della labile passione. La scelta squisita della<br />
forma più eletta è ora sentita come rinuncia a tanti elementi di cui pur s’intesse la<br />
realtà, e le si oppone una ricerca analitica del particolare realistico, di sapori nuovi,<br />
di vivezza, di evidenza, di concretezza, che si vendica (anche con l’ironia del latino<br />
maccheronico) di quel tanto di gelido che la ricerca di idealità supreme aveva conferito<br />
all’arte.<br />
Questo è il motivo più serio e profondo; ma, purtroppo, v ’è dell’altro ancora.<br />
La tecnica letteraria così affinata attraverso l’esperienza umanistica si compiace di<br />
se stessa e vuol fare le sue prove coi materiali linguistici più diversi. La varietà dei<br />
linguaggi chiamati a celebrare la vittoria di Lépanto (nel libro surricordato) non<br />
può avere un intento comico. I lessicografi allineano elenchi di vocaboli francesi,<br />
spagnoli, ecc., travestiti all’italiana e i poeti sfoggiano la loro capacità di comporre<br />
« nelle più famose lingue d’Italia » e di fuori. I Rabisch del milanese Lomazzo si<br />
aprono con una ghirlanda di poesie di amici in lode dell’autore scritte in italiano<br />
aulico, in latino maccheronico, in greco, in lingua graziana, « gierga », francese, spagnola,<br />
in siciliano e genovese. E evidente come questa via conduca dirittamente<br />
aU’artificio: puro sfoggio di capacità tecniche. Perchè un sonetto sia siciliano о romagnolo,<br />
non occorre che l’autore possegga perfettamente quel linguaggio particolare;<br />
basta ch’egli includa nel giro toscano delle sue frasi qualche vocabolo caratteristico<br />
di quella regione о che vi faccia risuonare l’eco di un caratteristico fonema di quel<br />
dialetto, con una evidente artificiosità e superficialità (« tucci tucci sotto il ùccio »<br />
oppure « le ravisce quoccie chol confeccio » è forse quanto di meglio si possa trovare<br />
nei sonetti « milanesi » del Dei). Il movente satirico che sta all’origine di questa<br />
produzione dialettale spiega sufficientemente come i precursori della letteratura<br />
milanese non siano milanesi, ma i fiorentini Luigi Pulci e Benedetto Dei coi loro<br />
sonetti « milanesi » (o pseudomilanesi) e l’astigiano G. G. Alione coi versi quasi<br />
milanesi della sua farsa Bracco e come si riscontrino anche nel celebre sonetto di<br />
Lancino Curti dei tratti bergamaschi. La satira si serve più volentieri di un dialetto<br />
rustico che di quello cittadino. L ’esempio più evidente di quest’uso satirico e artificioso<br />
di dialetti non cittadini è nell’opera deWAccademia della vai di Bregno, che<br />
sotto la direzione del compà Zavargna, ossia del pittore G. P. Lomazzo, produsse<br />
i noti Rabisch (Arabeschi) pubblicati a Milano nel 1580 (2“ ediz., 1622). Col<br />
Lomazzo si divertivano diversi nobili milanesi a comporre sonetti, mattinate, strambalugh<br />
e barcelett nel dialetto alpino di Bienio rifatto con una tecnica semplicistica<br />
e artificiosamente parodistica. Le regole sono indicate nel volume : con « questa<br />
lingua... potrai dire tutto quello che ti verrà in pensiero e per far questo piglierai<br />
li vocaboli... che finiscono... in an, en, in,... gli farai all’ultimo un g e un n » e così<br />
nascono magri (mano), vign (vino), ecc.; fra due vocali contigue si interporrà gl,<br />
282
ottenendo triglionf (trionfo), invencigliogn e perfino, con l’aiuto di altre leggi, Slurigliagn<br />
(Giuliano), Sluregligl’ (Aurelio). Naturalmente queste e le altre leggi hanno<br />
un fondamento nella fonetica reale del dialetto ma sono applicate meccanicamente<br />
e con esagerazioni parodistiche. Molto meno artificioso sembra invece il linguaggio<br />
di un’altra accademia. La gran Badie Antighe di fechin dol Lag mejò о di Vali d'Intragna,<br />
che sfilavano nelle mascherate di Carnevale distribuendo al pubblico le loro<br />
poesie rusticane. Invece il milanese cittadino tra la fine del Cinquecento e il principio<br />
del Seicento afferma orgogliosamente la sua dignità col Varón Milanes de la<br />
lingua de Milan di G. Capis e il Prissian de Milan de la parnonzia milanesa di<br />
G. A. Biffi. Il primo è un lessico che aiutandosi con le etimologie empiriche del<br />
tempo vuol rivelare nel latino e nel greco le nobili scaturigini del dialetto ambrosiano;<br />
il secondo è una descrizione dei suoni e dell’ortografia del milanese.<br />
Lombardo è pure il linguaggio di alcune tra le più illustri maschere della Commedia<br />
dell’Arte. Bergamo ha un indubbio primato come patria d’Arlecchino, Brighella<br />
e doppino. Milano crea Meneghino che offusca la coppia assai più modesta<br />
di Baltram e Baltramina da Gaggiano (verso Abbiategrasso). Chi rifinisce e fissa<br />
la figura di Meneghino è C. Maria Maggi nelle sue quattro commedie: I consigli<br />
di Meneghino, Il Barone di Birbanza, Il manco male, Il falso filosofo. Ormai il dialetto<br />
ha finito di essere un’invenzione satirica di gente che lo conosce dall’esterno e diventa<br />
un modo d’espressione che ha radici più profonde nelle abitudini linguistiche dello<br />
scrittore, una maniera d’esprimere il proprio attaccamento all’ambiente in cui si<br />
è nati e in cui si è modellato il nostro modo di vivere. Il Maggi fa un elogio affettuoso<br />
del milanese: « Fee splend i eleganz del Meneghin !... L ’è ona lengua correnta,<br />
averta e ciara / che apposta la par faa / per dì la veritaa ! / S ’cetta e gajarda per<br />
pientà in di anem, / insci a la bona, i verità del semper!... Ma el so don principal /<br />
l’è la felicitaa del fa capì / cont esempi, panzanegh e proverbi / i pu sublimm conzett<br />
I di gran filosofon fina in Brovett ». E anche le invenzioni lessicali del Maggi<br />
(per es., il verso: Nasess, nasin, nason, nasott, nasari) sono invenzioni autentiche<br />
e non storpiature о sforzature linguistiche. E nemmeno sforza la lingua la Villotta<br />
di P. C. Larghi (morto nel 1755): «Degià che sont chignova in su la strava, / e voo<br />
passand ol temp senza dormirò... », poiché dormirò, sentirò, fustono, polmono e basitti<br />
sono espressioni, come già osservava l’Ascoli, naturali nel contadino che tenta di<br />
parlare « in punta di forchetta ». Col Larghi il Settecento allinea G. Birago (con la<br />
commedia in tre atti Donna Perla), E. G. Corio, C. A. Tanzi (che tentò anche la<br />
composizione in lingua furbesca milanese) e D. Balestrieri. Sono letterati esperti<br />
che cercano di trasferire nel dialetto le scaltrezze metriche della poesia italiana. (Il<br />
Balestrieri tentò un « nuovo endecasillabo » il cui primo emistichio è un quinario<br />
sdrucciolo; lavoro arduo in una lingua ricca di parole tronche. « Ceri Г è difficila olter<br />
de pocch, I e fors sta moda nissun le seguita j d’uni fras sdrucciola col parlà mocch »).<br />
Col Balestrieri fa pure la sua apparizione il sciur Marchionn di gamb avert (che sarà<br />
immortalato dal Porta). Non mancano i traduttori fra cui si può ricordare F. Beilati.<br />
I suoi rifacimenti dell’Orlando Furioso e soprattutto dell’Eneide travestono la<br />
283
solennità dell’originale con una quantità di particolari realistici, con espressioni popolaresche<br />
che producono un tono giocondo, un misto di ironia e simpatia quasi maccheronico,<br />
che è un risultato caratteristico di molte versioni dialettali (« Staven li<br />
tucc con tant de bocca averta / per sentì Eneja a comenzà l’istoria; e la regina, anch<br />
lee, la stava a l’erta / che nissun no vegness a romp la gloria / e per fagh spiret, la ghe<br />
fa l’offerta / d’on biccerin che Jutta la memoria »).<br />
Col Romanticismo matura la pienezza dei tempi anche per la letteratura dialettale<br />
milanese che offre al mondo il suo grande Carlo Porta (1775-1821). Con lui il<br />
bisogno romantico di schiettezza, di calore, di libertà da ogni convenzione о artificio<br />
letterario trova nel dialetto milanese una delle soluzioni più felici; e il dialetto<br />
riprendendo motivi e figure della sua lunga tradizione, rivela una ricchezza e una<br />
duttilità quasi insospettate. (Dal linguaggio italianizzante delle dame : Convengo appien<br />
nella di lei paura, oppure Avria suppost che essendo lur sacerdott; al francese maccheronico<br />
di Giovannin Bongeé, alle più schiette espressioni della plebe, con sfumature<br />
finissime e rivelatrici). Non c’è posto in questi rapidi cenni per ogni indugio<br />
che sarebbe sempre sproporzionato alla grandezza del capolavoro; basterà dire che<br />
questa fa impallidire gli altri non pochi e cospicui cultori del dialetto che scrissero<br />
in quel secolo, quali G. Bossi, T. Grossi e G. Ventura. Ma non si può non ricordare<br />
il più grande animatore del teatro dialettale milanese, E. Ferravilla (1846-<br />
1915), il quale con la genialità improvvisatrice dei grandi comici della Commedia<br />
dell’Arte creò figure di enorme successo, come Tecoppa, Massinelli, el sciar Panera.<br />
Le città che maggiormente gravitano su Milano, ebbero cultori della musa dialettale<br />
che alternarono l’uso del milanese con quello del « bosino » о di altre varietà<br />
locali; ma i centri più importanti conobbero una produzione autonoma. Bergamo<br />
vanta la tradizione più antica, più ricca e continua, che ebbe la massima diffusione<br />
nazionale nel teatro comico del Cinquecento e nella Commedia dell’Arte. Nel Settecento<br />
si distinsero G. Rota e G. B. Angelini, nell’Ottocento P. Roggeri ed E. Trizzini,<br />
il fondatore del foglio dialettale tuttora vivente d o p i. Due altri centri copiosi<br />
furono dal Settecento in poi Mantova, ricca anche di numerosi giornali dialettali,<br />
e Pavia (che nel Settecento vide la fondazione deWAccademia della Basletta e nel<br />
secolo successivo diede il suo poeta più celebrato, S. Carati). Meno copiosa la produzione<br />
di Brescia (l’autore più apprezzato è A. Canossi), di Crema e Cremona.<br />
Oggi la produzione dialettale trova dei centri animatori e di raccolta in associazioni<br />
che promuovono il culto delle tradizioni e del linguaggio locale, come a Milano<br />
la « Famiglia Meneghina » (e non c’è bisogno di ricordare come la produzione degli<br />
scrittori milanesi viventi sia ancora ricca per quantità e qualità), a Bergamo il<br />
« Ducato di Piazza Pontida », a Varese la « Famiglia Bosina », a Busto Arsizio (la cui<br />
tradizione risale al settecentesco G. Belotti e si fonda su un vernacolo di particolare<br />
vitalità) la « Famiglia Bustocca », mentre il dialetto di Legnano ha trovato in questi<br />
ultimi anni un largo successo nelle moderne « riviste » della « Compagnia Musazzi ».<br />
284
C a p i t o l o D e c i m o<br />
L’AGRICOLTURA, L’ALLEVAMENTO<br />
E I LORO ASPETTI GEOGRAFICI<br />
Le attività economiche.<br />
« È una sleale asserzione — osserva Carlo Cattaneo a chiusa della sua bella<br />
Introduzione alle Notizie naturali e civili sulla <strong>Lombardia</strong> — quella che attribuisce<br />
ogni cosa tra noi al favore della natura e aU’amenità del cielo; se il nostro Paese è<br />
ubertoso e bello e nella regione dei laghi forse il più bello di tutti, possiamo dire<br />
eziandio che nessun popolo svolse con tanta perseveranza d’arte i doni che gli confidò<br />
la cortese natura ». In tale affermazione, non dettata da semplice affetto alla<br />
propria terra, ma da amore di verità, non vi era, un secolo fa, nulla di iperbolico<br />
e non vi è, oggi, alcunché di esagerato: il volto del territorio lombardo è chiaro<br />
riflesso di un intelligente e tenace lavoro e ciò non solo per il mirabile congegno<br />
irriguo, che ha dotato il suolo di una eccezionale fecondità (e al quale, particolarmente,<br />
faceva riferimento il Cattaneo), ma anche per il complesso industriale che<br />
si espande in parte della pianura e della collina, ravvivandola di un intenso fervore<br />
di vita. Generazioni e generazioni di Lombardi hanno profuso le doti del loro ingegno<br />
pronto ed aperto e della loro operosità tenace e concreta in questa complessa opera<br />
di trasformazione, la quale inoltre, da un secolo a questa parte, ha assunto un ritmo<br />
di crescita così straordinariamente rapido e multiforme da determinare, nel quadro<br />
economico, una netta differenziazione tra la <strong>Lombardia</strong> e le altre regioni d’Italia.<br />
Una chiara conferma risulta dal quadro d’assieme delle attività economiche svolte<br />
dalla popolazione e anzitutto dall’alta concentrazione delle forze lavorative nella<br />
regione. Dal censimento del 1951 risulta che il 48% della popolazione residente<br />
era da annoverarsi come attiva. Anche se tra le più elevate d’Italia, tale percentuale<br />
285
L ’alta percentuale della popolazione non agricola,<br />
sul totale di popolazione economicamente attiva (valori arrotondati all’unità)<br />
nell’alta pianura e nella collina della <strong>Lombardia</strong> occidentale (da A. Sestini).<br />
Utet<br />
però è solo parzialmente significativa, poiché in essa giuoca anche l’invecchiamento<br />
della popolazione, che, come s’è accennato in precedenza, per il contrarsi della natalità<br />
già risulta sensibile in <strong>Lombardia</strong>; comunque i 3.145.931 Lombardi attivi nei<br />
diversi rami di lavoro costituiscono il 15% del totale della popolazione attiva dell’intera<br />
Italia, primato che si distacca nettamente anche dalle regioni che pure seguono<br />
in graduatoria come il Piemonte e l’Emilia-Romagna (rispettivamente con poco più<br />
e poco meno dell’8%). Si noti poi che, se si escludono gli anni di guerra, l’accrescimento<br />
delle unità attive è costante e progressivo e all’aumento contribuisce in larga<br />
misura l’afflusso di connazionali di altre regioni. Così, rispetto al censimento del 1936<br />
l’accrescimento nel 1951 era di oltre 400.000 unità e si calcola che nel 1956, ossia<br />
a distanza di venti anni, sia di oltre mezzo milione e ciò nonostante la parentesi bellica,<br />
che ha determinato, oltre la stasi, anche la distruzione di numerosi complessi<br />
industriali.<br />
Riguardo alle diverse branche di attività alle quali la popolazione attiva si dedica<br />
si nota che, a differenza di quanto avviene nell’intera Italia in generale e nella maggior<br />
parte delle singole regioni soprattutto centro-meridionali, in <strong>Lombardia</strong> il maggior<br />
numero di lavoratori è assorbito dall’industria la quale, secondo i dati del 1951,<br />
impiega oltre un milione e mezzo di addetti pari al 49,3% della popolazione attiva;<br />
286
con notevole distacco seguono l’agricoltura, la caccia e la pesca con il 18,7% di<br />
addetti, i trasporti, il commercio e i servizi con il 17,3% , le pubbliche amministrazioni<br />
con il 6,5%, il credito e le assicurazioni con Г і,2 % ; vi è, infine, un gruppo<br />
in attesa di prima occupazione che costituisce il 7%.<br />
Dal confronto con i rilevamenti statistici dei decenni precedenti risulta un fatto<br />
interessante per i due rami principali di attività, ossia il progressivo accrescersi del<br />
numero degli addetti alle industrie e il progressivo contrarsi del numero degli addetti<br />
all’agricoltura: nel 1936, ad esempio, le industrie lombarde assorbivano i.301.351<br />
addetti, mentre nel 1951 ne impiegavano 1.550.768. A ll’opposto l’agricoltura lombarda<br />
nel 1936 dava lavoro a 738.995 unità, mentre nel 1951 ne assorbiva 588.070. Non si<br />
deve desumere da tali dati che in <strong>Lombardia</strong> l’attività agricola, quasi soffocata dal<br />
forte sviluppo industriale, sia passata in secondo piano. Il contrarsi del numero di<br />
addetti agricoli non è fenomeno esclusivo della nostra regione; lo si registra dovunque<br />
e, se in <strong>Lombardia</strong> lo si nota nel complesso in misura più accentuata, ciò è in rapporto<br />
al più rapido diffondersi della meccanizzazione nell’agricoltura e al più sentito<br />
Un aspetto della bassa<br />
pianura lombarda, caratterizzata<br />
dalla notevole<br />
disponibilità di<br />
acque irrigue.<br />
287
1<br />
La Vettabbia nella campagna milanese.<br />
Fot. Bianchi<br />
richiamo esercitato dall’industria. Del resto non tutte le parti della <strong>Lombardia</strong> presentano<br />
le medesime caratteristiche: la pianura irrigua e la montagna conservano<br />
una preminenza numerica di mano d’opera agricola su quella industriale.<br />
L ’agricoltura dunque conserva in <strong>Lombardia</strong> quello sviluppo intensissimo che<br />
le grandi opere di adattamento del suolo, intraprese almeno fino dall’età comunale,<br />
e particolarmente la disciplina delle acque le hanno conferito. Del resto la netta preminenza<br />
dell’industria è piuttosto recente. Fino a oltre la metà del secolo scorso,<br />
l’economia lombarda mantenne, infatti, un’impronta prevalentemente agricola, talché<br />
le industrie della filatura e tessitura della seta, del lino e del cotone e altre minori,<br />
per buona parte del secolo scorso, « fiorirono negli interstizi — come scrive pittorescamente<br />
uno storico dell’economia, il Greenfield — di un sistema agricolo » dominante.<br />
288
L e R e g io n i d ’ I t a lia - L o m b a rd ia<br />
Il Naviglio Grande a Corsico.
y
L e g r a n d i o p e re d ’irrig a z io n e .<br />
Lo sviluppo agricolo della <strong>Lombardia</strong> affonda le sue lontane radici nei secoli<br />
dell’età di mezzo ed è il risultato di una complessa opera di trasformazione del suolo,<br />
legata in primo luogo, nella zona di pianura, alla disciplina delle acque. E probabile<br />
che l’avvio alla sistemazione idraulica avvenisse all’epoca della colonizzazione romana;<br />
ad essa si attribuiscono, ad esempio, la deviazione e la sistemazione dell’Olona, del<br />
Séveso e della Lura per far convergere le loro acque verso Milano. Queste, dopo aver<br />
servito a dar moto alle macine dei mulini, alla lavatura delle lane, delle tele e delle<br />
pelli, allo spurgo della città, attraverso la fossa interna sfogavano nella Vettabbia о<br />
Vecchiabbia che rappresentava forse il tronco inferiore del Séveso. E però in epoca<br />
comunale che si dà l’avvio a un grandioso e durevole sistema di canalizzazione.<br />
Dopo la prima calata del Barbarossa, i Milanesi sistemarono a difesa attorno alla<br />
città l’ampio scavo della Fossa interna, due volte distrutto e due volte ricostruito<br />
nel volgere di pochi anni; poi, l’anno successivo alla vittoria di Legnano sul Barbarossa<br />
(1175), i Milanesi, con il sostegno delle comunità del contado, progettarono<br />
la costruzione di un canale derivato dal Ticino, il Ticinello, che per successivi ampliamenti<br />
diè luogo al Naviglio Grande. Nello stesso secolo nella campagna di Lodi<br />
esisteva già un fosso, detto, dalla famiglia che ne aveva la proprietà. Aqua Mutia<br />
e un altro fosso, il Pan perducto derivato dall’Adda; ma l’inizio dei lavori per la<br />
grande arteria della Muzza quale si è conservata sino a noi risale al 1220. Ancora<br />
al secolo XII, e precisamente al 1180, risalgono le opere di sbarramento del Mincio<br />
che diedero luogo ai laghi mantovani. Nei secoli seguenti, con i Visconti e gli Sforza,<br />
nella bassa si iniziarono i lavori del Naviglio di Pavia (1359), del Naviglio di<br />
Bereguardo (1457) e della Martesana (1457), continuati, anche saltuariamente, sino<br />
all’epoca napoleonica, durante la quale avvenne il completamento del Naviglio di<br />
Pavia. Infine nello scorso secolo la rete dei canali lombardi si arricchì di un’altra<br />
grande opera, il Villoresi, il cui scavo fu iniziato nel 1881. Questi cenni cronologici,<br />
limitati ai maggiori canali, dimostrano chiaramente come la sistemazione idraulica,<br />
cui soprattutto si deve la pingue fertilità della pianura lombarda, sia il risultato di<br />
una tenace opera secolare fondata sul connubio dell’ingegno con il lavoro. Ben giustificate<br />
quindi risultano le parole del Cattaneo con le quali s’inizia il presente capitolo,<br />
tanto più se, assieme ai maggiori canali si considerano fossi e rogge, la cui rete<br />
forma un tessuto fittissimo che s’estende a tutta quanta la pianura.<br />
Nel complesso, secondo la loro funzione prevalente (ma non esclusiva) si possono<br />
distinguere due ordini di canali: gli irrigatori e i colatori. Tra i primi, alcuni,<br />
soprattutto i maggiori, si alimentano dalle acque dei fiumi, altri dai fontanili. Infatti,<br />
come si è accennato in altra parte, la bassa pianura fruisce di un’abbondanza vera-<br />
/<br />
19 — L e R e g io n i d ’ It a lia ~ L o m b a rd ia .<br />
289
mente notevole di acqua anche per via dei fontanili, di cui, sin dai tempi antichi,<br />
si è fatta una razionale utilizzazione a scopo irriguo. Dalle teste dei fontanili, nelle<br />
quali talvolta si agevola Г affioramento dell’acqua con tini senza fondo e anche con<br />
tubi di ferro о di cemento infissi nel terreno, l’acqua fluisce verso l’asta e, guidata<br />
da un sistema ben congegnato di cavi e di cavetti, si distribuisce nelle superfici a<br />
marcita e a risaia. La derivazione di acque dai fontanili non è certo da giudicare<br />
secondaria, soprattutto se si tien conto della utilizzazione per irrigazione iemale;<br />
ma indubbiamente in quanto a portata eccellono i grandi canali derivati dai fiumi.<br />
Si calcola, ad esempio, che soltanto il Ticino e l’Adda, attraverso i canali derivati,<br />
donino alla pianura milanese e pavese oltre sette miliardi di metri cubi l’anno<br />
(A. Desio). Ciascuno di questi grandi derivatori merita indubbiamente un cenno.<br />
Il Naviglio Grande è costituito da due tronchi disposti tra loro ad angolo ottuso<br />
con vertice ad Abbiategrasso ; essi rappresentano due distinti periodi di lavori di<br />
costruzione. Lo scavo del tronco di derivazione dal Ticino, chiamato anticamente<br />
Tesinello о Ticinello, ebbe inizio nel 1179 (o, forse, nel 1177) e si protrasse per più<br />
di un secolo; il solco raggiunse Abbiategrasso e di là passava a bagnar le campagne<br />
I grandi canali tra Ticino e Adda e la rete principale di irrigazione.<br />
Utet<br />
290
Fot. Sef<br />
Il Naviglio Grande presso Abbiategrasso.<br />
confinanti col territorio di Pavia. Nel 1257 ebbero inizio i lavori del Naviglio di<br />
Gaggiano (o, secondo l’antica dizione, di Gazano) tra Abbiategrasso e Milano, condotti<br />
indubbiamente con celerità, poiché le antiche carte attestano che già nel 1271<br />
«navi, cepate e zattere» giungevano dal Ticino sino a Sant’Eustorgio «presso alla<br />
città». Fu appunto attraverso il Naviglio Grande che giunsero a Milano i marmi<br />
rosati delle cave di Candoglia, sul lago Maggiore, con i quali fu eretta la splendida<br />
mole del Duomo.<br />
Il canale attuale misura in lunghezza poco meno di 50 km. (esattamente 49,982).<br />
Dal suo incile presso Tornavento sino a Boffalora, per un tratto di circa 18 km.,<br />
le acque scorrono discretamente rapide, poiché superano i nove decimi della caduta<br />
totale, che é di m. 33,42. Dopo Boffalora il canale si allontana sempre più dal corso<br />
del Ticino e con portata media di 63 mc/sec. si dirige verso Castelletto di Abbiategrasso.<br />
Da qui con un rettilineo di circa 20 km. raggiunge Milano e sbocca nella<br />
2 9 1
Il Naviglio di Pavia alla prima chiusa.<br />
Fot. Fracchi<br />
darsena di Porta Ticinese con una portata media di 12 mc/sec., a causa delle numerose<br />
derivazioni; lungo il percorso vi sono infatti una decina di scaricatori (sei dei<br />
quali di impiego normale) e una serie di 116 tra bocche, luci e stramazzi, denominazioni<br />
locali delle diverse aperture dalle quali si deriva l’acqua che serve a irrigare<br />
circa 50.000 ettari.<br />
Originariamente le acque del Naviglio Grande che giungevano a Milano defluivano<br />
nella Vettabbia; fu nel 1359 che, per ordine di Galeazzo II Visconti, si iniziò la<br />
derivazione, chiamata Naviglietto о Navigliaccio, avente per scopo di portare acque<br />
al parco del Castello di Pavia. Da tale derivazione, con un complesso di lavori attuati<br />
in varie e tra loro lontane riprese, ebbe origine il Naviglio di Pavia, aperto definitivamente<br />
alla navigazione solo nel 1819.<br />
Il Naviglio di Pavia nella definitiva sistemazione ha origine dalla darsena di<br />
Porta Ticinese e attraversa la campagna tra Milano e Pavia con due lunghi rettilinei<br />
che formano un angolo appena accennato in corrispondenza di Binasco. A Pavia<br />
il canale aggira la città fino allo sbocco nel Ticino in località Confluente. Lo sviluppo<br />
complessivo è di 33 km. (esattamente 33,329) con una larghezza di specchio<br />
292
di II metri. La portata oscilla tra gli 8 e i io mc/sec. a seconda della stagione. Il<br />
dislivello tra le estremità è di 58 m., sicché per permettere la navigazione vi sono<br />
14 conche, ciascuna di 33 m. di lunghezza, il cui salto complessivo è di 53 metri.<br />
Dal Naviglio Grande deriva, in prossimità di Abbiategrasso, il Naviglio di Bereguardo,<br />
la cui esecuzione fu voluta nel 1457 da Francesco I Sforza pro beneplacitis<br />
nostris et pro sudditorum nostrorum commoditate. Il canale raggiunge Bereguardo con<br />
uno sviluppo di quasi 19 km. (18,848) e con un dislivello complessivo di 23,80 metri<br />
dei quali 20,67 sono superati da i i conche, chiuse da antiche porte (alcune ancora<br />
in legno) di cui non si prevede il rammodernamento perchè la navigazione nel canale<br />
è in decadenza. La funzione, quindi, del Naviglio di Bereguardo è limitata ormai<br />
all’irrigazione della campagna circostante.<br />
La Muzza è il più antico dei canali derivati dall’Adda. Le vicende storiche legate<br />
al suo nome sono molto complesse. Anche dopo il 1230, anno in cui i lavori furono<br />
condotti a termine, il canale fu oggetto di controversie tra Lodi e Milano, ciò che<br />
dimostra l’importanza della utilizzazione delle sue acque a scopi irrigui. L ’incile<br />
si trova presso il castello di Cassano in un tratto di intenso sfruttamento delle acque<br />
dell’Adda; dopo un paio di chilometri di percorso parallelo al fiume, il canale si<br />
inoltra in direzione sud-sudovest in territorio milanese e lodigiano. Presso Panilo,<br />
Fot. Stefani<br />
La Muzza nella campagna lodigiana.<br />
293
â<br />
AV<br />
r K О.ЫССО<br />
U A IC M<br />
ж<br />
QLC<br />
Bicrvio uMMa<br />
H i'K V N o<br />
imKtsMítí'<br />
РО КТ/ЛЛІЖ<br />
Р Л І9Н 0<br />
AttLAWO<br />
U<br />
t<br />
Іхмллсо<br />
'CERNVJ<br />
cvto V VJUCi<br />
CORG&ZO<br />
Л ' 1.A<br />
_mtt^AGo<br />
Ѣ<br />
к.БТА.<br />
^4 3-I«|<br />
e rD e Lecho d OloLnä Ìonorrùliariiiii.Da<br />
01^ігшмЬгшю>іш-ВаВгіиіг) ¿Uporto de<br />
íherf/^oMí. Dal porto pdicto ale tre Corne TOWA^ff<br />
МЮІ i*tO^<br />
in Acôaéi.Dti le tre Corne doue fe fara U<br />
chima rnAddap far тпоіагеінс^шікcauo<br />
quai fe fade píenle per Ілиаіе de La rochela<br />
P no poterÎL acôaare de nau^are p adda<br />
unpocho defopra dala torréele port/) doue<br />
P dicto сацо Cerciorara ей le ñaue іа adda .<br />
cjualièm тШлгіи,6і dal dicto loco douep<br />
dicto cauo fe rUomarainadiL. fin aTrezo<br />
fono miliarL v. doue c La bocha del Nauílio<br />
dcmarlexana perloaual íenauioa íinaMi<br />
¡anq cdale dicta bocha del naliÍÍío a Mila<br />
no fono тпіімгі.ххѵгіопоіп Гитпта rriUìarL I<br />
КЛНЕЖ<br />
Fb c a g a m m<br />
xl Y», da Lecho a Milano p aqua Per ófln po/<br />
co<br />
che delLóno Герш) iritédere e corwlcerc che<br />
fc ruuiìnara dal laco de Como Ciri a Milano-<br />
TRJEZO<br />
r OEi'Tfíc¿¿<br />
VAVUi<br />
OÒC«SA ilACiVÏ<br />
L A С А Х А ОБ<br />
»oÇÔÉ<br />
a rSb- J ì j<br />
r o í : A В Е Я О А Г ’^<br />
PORTü<br />
L ’Adda e la Martesana in una incisione del see. XVI<br />
(da Decretum super flumine Abdae reddendo navigabili di Pagnano, Mediolani, 1520)-
con un angolo quasi retto piega a sud-sudest mantenendo approssimativamente<br />
questa direzione sino in vicinanza di Cornegliano Laúdense, dove il corso manifesta<br />
la tortuosità di un fiume, determinata appunto da una naturale evoluzione<br />
dell’alveo nel volgere di sette secoli. Dopo lo scaricatore Priora (dal nome dell’ultima<br />
roggia derivata) la Muzza assume funzione di canale colatore e sbocca nel<br />
fiume d’origine presso Castiglione d’Adda. Complessivamente il canale misura in<br />
lunghezza più di 57 km. (per l’esattezza 57,798); di essi 38 del canale irrigatore<br />
e 19 del colatore. Il dislivello nel primo tronco è di m. 39,40 e pertanto la corrente<br />
diverrebbe troppo veloce per un canale d’irrigazione senza le levate, ossia dei piccoli<br />
sbarramenti disposti lungo il corso, che determinano salti in modo da placare<br />
le acque nei tratti intermedi. Le derivazioni dal canale sono numerosissime: nel<br />
complesso si contano 75 bocche e 71 rogge derivate. A differenza di quel che<br />
avviene per il Naviglio Grande e la Martesana, le rogge della Muzza presentano<br />
uno sviluppo notevole; la roggia Codogna, ad esempio, è lunga quasi 150 km. e varie<br />
superano la cinquantina. Ciò è reso possibile dalla disponibilità di acque soprattutto<br />
durante la stagione estiva, durante la quale la portata poco a valle dell’incile<br />
è di 108 mc/sec. Il territorio irrigato dalle acque della Muzza misura 42.000 ettari,<br />
esso può distinguersi in due parti: la prima assai maggiore e più importante si<br />
Fot. Storti<br />
La costruzione del nuovo incile del Naviglio della Martesana a Trezzo.<br />
295
estende dal corso del canale tra Cassano e Panilo (e, in prosecuiiione, dal corso del<br />
colatore Addetta) fino ai terrazzi discendenti rispettivamente verso il Lambro, il Po<br />
e Г Adda; la seconda si estende dal margine dei detti terrazzi e il corso dei fiumi.<br />
Il Naviglio della Martesana (detto anche Naviglio Piccolo in contrapposto al<br />
Naviglio Grande) fu costruito contemporaneamente a quello di Bereguardo per<br />
volere di Francesco I Sforza. L ’opera iniziata nel 1457 fu compiuta rapidamente<br />
e già nel 1465 Bianca Maria, consorte di Francesco, poteva emanare il decreto per<br />
l’utenza delle acque. A quell’epoca però le acque della Martesana non fluivano<br />
ancora nella Fossa interna di Milano e si scaricavano nel Séveso; l’allacciamento<br />
fu compiuto più tardi, forse nel 1496, sotto Ludovico il Moro. L ’incile si apre<br />
presso l’antico castello di Trezzo d’Adda e il canale, sostenuto da alte arginature,<br />
segue da presso il fiume per oltre sette chilometri per superarne l’alto argine.<br />
A Groppello, con stretto gomito, s’inoltra nella pianura in direzione di Milano bordeggiando<br />
la statale per Bergamo. Nel suo percorso interseca il torrente Mòlgora e<br />
il fiume Lambro, le cui acque passano sotto il canale per mezzo di sifoni. Il torrente<br />
Séveso invece sfocia nel canale con bocca aperta. In totale il corso della Martesana<br />
misura in lunghezza 38 km. (38,696) e ha una portata all’incile di 32 mc/sec. Il<br />
dislivello tra gli estremi è di 15 m., dei quali 6 con salti di quattro conche. Le<br />
rogge derivate, per lo più dalla sponda meridionale, superano il centinaio; ma sono<br />
tutte brevi a causa del sussidio che recano all’irrigazione le acque dei fontanili; ad<br />
ogni modo le acque della Martesana si distribuiscono su almeno 14.000 ettari.<br />
Il Villoresi è in ordine di tempo l’ultimo dei grandi canali costruiti tra Ticino<br />
e Adda e si distingue dai precedenti per il suo percorso nell’àmbito della pianura<br />
asciutta. Lo scavo fu iniziato, non senza contrasti, nel 1881 e condotto a termine<br />
dieci anni più tardi; alla grandiosa opera fu dato meritatamente il nome del suo più<br />
eminente progettatore e propugnatore, Eugenio Villoresi. Il canale ha origine dal<br />
Ticino presso Somma Lombarda, segue per un tratto il corso del fiume, poi, nei<br />
pressi di Tornavento, s’interna nella campagna in direzione orientale; passa a nord<br />
di Milano per Lainate e Monza; va infine a innestarsi all’Adda poco a monte di<br />
Groppello. Il percorso misura complessivamente 86 km. (esattamente 86,347);<br />
portata all’incile è di 70 mc/sec., ma, per la notevole emunzione, nella parte mediana<br />
è ridotta a soli io mc/sec. Nel complesso le acque del Villoresi servono all’irrigazione<br />
di circa 46.000 ettari.<br />
L ’opera secolare di sistemazione delle acque nella pianura lombarda non si limita<br />
a questa rete tra Ticino e Adda. Canali d’irrigazione importanti, e anche di antica<br />
data, se ne hanno tra l’Adda e l’Oglio. L ’Adda dona acque abbondanti al territorio<br />
bergamasco e a quello cremonese che si stendono alla sinistra del suo corso. Oltre<br />
alla roggia Vailata, risalente al secolo XIV, al canale Ritorto, del secolo seguente,<br />
e ad altre rogge minori, nei pressi di Comazzo è derivato il canale Marzano<br />
(secolo XIX), che, dirigendosi con lunghi rettilinei verso Crema, ne irriga la fertile<br />
campagna. Dal Serio sono derivate la roggia Serio Grande il cui scavo risale al<br />
secolo XIII, le rogge Convenduna, Trabattoni Morlana del XIV e la roggia Gui-<br />
296
Fot. Storti<br />
Le opere di presa del Villoresi sul Ticino.<br />
dana del secolo XV. Del medesimo periodo sono la Serriola Vetra e le rogge Sale.<br />
Baiona, Rudiana, Vescovata (secolo XIII), Pallavicino, Fusia, Trenzana, Antegnana<br />
(secolo XIV), derivate dall’Oglio. Al medesimo fiume si alimenta il Naviglio di<br />
Cremona che ha origine poco a monte di Calcio e si dirige, attraverso la pianura<br />
soresinese, verso Cremona. Anche il confluente Mella ha i suoi canali, quali la<br />
Fossa Quinzana e il Rio Cambara. La campagna bresciana si giova delle acque del<br />
Chiese dalla cui sponda destra deriva il Naviglio Grande bresciano (20 km.) che<br />
lambendo la zona collinare si dirige verso Brescia e ripiegando poi a sud irriga la<br />
campagna che si stende a mezzogiorno della città. Quando sia stato scavato questo<br />
canale non si sa con precisione, ma sembra probabile che i lavori siano stati compiuti<br />
nella prima metà del secolo XIII. Sembra che almeno sino al secolo XV servisse<br />
non tanto per la navigazione quanto per la fluitazione del legname; ma la sua<br />
importanza preponderante, almeno in epoca moderna, deriva dall’irrigazione che<br />
interessa una superficie di 9500 ettari. Derivano dal Chiese anche la Serriola Donata<br />
(secolo XIV), il Naviglio di Coito e la Fossa Bozzolo (secolo XV).<br />
Notevole beneficio arreca a un lembo della campagna lombarda anche il Canale<br />
Cavour, in quanto la Lomellina (oltre alle rogge derivate dalla Sesia e dal Ticino)<br />
si giova in parte delle acque di alcuni suoi diramatori, quali il cavo Montebello, il<br />
cavo Quintino Sella (con le derivazioni di Mortara e di Pavia) e il diramatore<br />
Vigevano.<br />
Naturalmente, l’abbondanza di acque convogliate verso la bassa pianura lombarda<br />
ha costretto anche alla costruzione di una fitta rete di canali, il cui compito<br />
principale (ma non esclusivo) è quello di raccogliere le acque di scolo e riportarle<br />
297
Di frequente, nella bassa, la roggia, protetta da filari di olmi,<br />
si accompagna alla strada vicinale.<br />
Fot. Celso
alla loro sede naturale. Il sistema di tali canali, detti colatori, è regolato da un<br />
complesso ingegnoso di chiuse e chiaviche, che regolano il flusso delle acque e soprattutto<br />
impediscono il rigurgito in caso di piena dei flumi. Tra i colatori più noti vi<br />
è la Vettabbia, che scola le acque di Milano e si getta nel Lambro a Melegnano; il<br />
Redefossi, che sfoga le acque della Martesana e del Séveso e si scarica, pure a Melegnano,<br />
nel Lambro; il Navigliaccio e il Basso Olona, che scolano parte delle acque<br />
della pianura rispettivamente a oriente e a occidente nel Naviglio pavese; il colatore<br />
Reale, che scola le acque della zona tra l’Olona e il Lambro, scaricandole in una<br />
mortizza del Po; l’Addetta, che accoglie le acque del canale irrigatorio della Muzza<br />
e sbocca nel Lambro; il roggione Mortizza, che sfoga nel Po le acque della campagna<br />
di Casalpusterlengo ; poi, in fascio, il Sillero, il Serio morto, il Cresmero, il<br />
Delmona, il Commessaggio, il Novarolo, il Tagliata, ecc. Ovviamente non si possono<br />
ricordare tutte le centinaia e centinaia di colatori che solcano, con una Atta<br />
rete, la bassa lombarda. Di frequente il loro solco, non più largo di due о tre metri,<br />
protetto da Alari di olmi, si accompagna, talvolta su tutte e due i lati, alle strade vicinali,<br />
e conferisce alla campagna lombarda una inconfondibile impronta di geórgica<br />
opulenza.<br />
Nel complesso la massa d’acqua proveniente dai flumi e dai fontanili è distribuita<br />
per mezzo di 8i canali derivati dai flumi e da 223 sistemi irrigui costituiti da<br />
coli e da fontanili e ne beneflcia una superflcie calcolata in poco meno di mezzo<br />
milione di ettari, che costituiscono il 60% delle zone irrigabili della superflcie<br />
agraria. I fontanili contribuiscono all’irrigazione in proporzioni veramente notevoli,<br />
diffondendo le loro acque su circa il 38% della superficie lombarda irrigata. Notevole<br />
è pure il contributo delle acque dell’Adda (27% della superficie irrigata), del<br />
Ticino (12% ) e deirOglio (io% ) cui seguono, in misure decrescenti, il Serio (5%),<br />
il Chiese (4%), il Mella (3%), il Brembo, ecc.<br />
La pratica irrigatoria lombarda presenta modalità differenti a seconda delle zone.<br />
Riguardo al periodo è ovvio che essa si attui nelle stagioni di minore piovosità e<br />
quindi di maggiore necessità; pertanto, poiché le precipitazioni sulla pianura cadono<br />
in maggior copia nelle stagioni di transizione, l’irrigazione si pratica durante l’estate<br />
e durante l’inverno. In quest’ultimo periodo però l’irrigazione è limitata ai prati<br />
stabili iemali о marcite, mentre nel primo è diffusa a tutta la superficie irrigua a<br />
beneficio della maggior parte delle coltivazioni. L ’irrigazione avviene in continuità<br />
solo per la marcita e, dalla primavera all’autunno, per il riso; per tutte le altre colture<br />
è periodica (ossia a intervalli che vengono detti ruote) in relazione alle esigenze<br />
delle singole specie coltivate. Le ruote più diffuse sono: di 7 giorni nel Bresciano,<br />
nel Mantovano, nel Comprensorio dell’Olona e nel Comprensorio del Consorzio<br />
Villoresi; di 9 giorni nel Bergamasco; varia da 7 a 18 giorni nel Cremonese e da ii<br />
a 15 giorni nel Lodigiano (C. Bonato). In genere il sistema d’irrigazione più diffuso<br />
è quello per scorrimento con modalità varie a seconda delle colture. L ’irrigazione<br />
per sommersione è limitata alle aree coltivate a risaia, mentre l’irrigazione per aspersione<br />
è di recente introduzione e ancora poco diffusa. Il consumo d’acqua varia<br />
299
notevolmente in ragione delle esigenze delle specie coltivate e della natura del terreno;<br />
in genere esso tende a diminuire dall’alta alla bassa pianura: così si calcola<br />
in due litri al secondo per ettaro nel Comprensorio del Villoresi, in un litro al<br />
secondo per ettaro nel Cremonese e ancor meno nelle zone irrigue del Mantovano.<br />
L ’irrigazione ha indubbiamente determinato una profonda trasformazione dell’agricoltura<br />
lombarda, sollecitando anzitutto un progresso nell’ordinamento agrario,<br />
incrementando poi la produzione specialmente foraggera e, infine, conferendo sicurezza<br />
e stabilità ai raccolti. Ma se quanto è stato sin qui esposto può dare, sia pure<br />
per sommi capi, un quadro grandioso della sistemazione idraulica, non è tuttavia<br />
da credere che l’opera non abbia necessità di completamento, oltre che di rammodernamento,<br />
per giungere a una bonifica integrale del territorio. Vi è anzitutto da<br />
notare che ancora due quinti dell’area agricola manca di opere di irrigazione. Si<br />
prevede che con la regolazione delle acque del lago Maggiore la portata del Villoresi<br />
raggiungerà una media stabile di 90 mc/sec. in modo da estendere l’irrigazione<br />
a circa 3000 ettari ancora asciutti; inoltre la stessa regolazione del Verbano permetterà<br />
il completamento dell’irrigazione della Lomellina estendendola di circa<br />
2500 ettari. Infine la regolazione delle acque del lago di Como rende possibile<br />
Le irrigazioni in <strong>Lombardia</strong> (da F. Franceschi).<br />
Utet<br />
300
Chiusa di derivazione da un<br />
canale nella bassa lombarda.<br />
Fot. Sef<br />
l’utilizzazione di acque derivate dall’Adda per completare l’irrigazione dell’alto<br />
Milanese e della bassa bergamasca. Infine la regolazione del deflusso del Mincio<br />
gioverebbe a estendere l’irrigazione, invero ancora limitata, del Mantovano ; il<br />
canale Virgilio, di cui è già compiuto lo scavo del tronco principale, permetterà<br />
esso solo di estendere l’irrigazione su almeno 30.000 ettari. In complesso si valuta<br />
in circa 190.000 ettari la superficie ancora irrigabile in <strong>Lombardia</strong>; di questi almeno<br />
100.000 nel solo territorio della provincia di Mantova e 40.000 in quello della provincia<br />
di Cremona.<br />
Accanto a questo vi è un altro notevole problema: quello di difesa delle acque<br />
di piena, specialmente nel territorio della bassa pianura. Avviene infatti che durante<br />
le copiose piogge primaverili e autunnali vaste estensioni, calcolabili in diverse<br />
migliaia di ettari, vengano sommerse dalle acque che, sia con il loro permanere<br />
prolungato, sia con i depositi melmosi, producono gravi decurtazioni del raccolto.<br />
Le cause vengono attribuite in primo luogo al disordine idraulico della rete fluviale;<br />
i corsi d’acqua, infatti, per le numerose briglie e dighe di sbarramento, hanno subito<br />
in alcuni tratti un progressivo colmamento dell’alveo, una diminuita pendenza e<br />
301
Chiusini di derivazione delle acque d’irrigazione<br />
nella campagna milanese.<br />
Fot. Fracchi<br />
una ridotta capacità di scarico. Secondariamente si ritiene con fondamento che<br />
l’apporto di acque irrigue nei comprensori alti, specialmente in seguito alla costruzione<br />
del Villoresi, abbia determinato un innalzamento di livello della falda freatica<br />
che ha accresciuto il coefficiente di deflusso. Infine non trascurabili sono stati anche<br />
il disboscamento nella zona collinare dei pianalti, l’espansione delle aree coperte<br />
da fabbricati e da strade, ecc. Per ovviare alle dannose inondazioni si è prospettata<br />
l’opportunità di costruire canali colatori per un complesso di circa 200 chilometri.<br />
Il problema della sistemazione idraulica e soprattutto del drenaggio non si limita<br />
alla zona tra Ticino e Adda, ma è comune a quasi tutte le aree incluse nei comprensori<br />
di bonifica. Tali aree sono dislocate sia in zona di pianura che in zona di montagna<br />
e abbracciano complessivamente oltre 600.000 ettari; in circa un terzo i lavori<br />
sono ancora da iniziare, in un altro terzo i lavori sono in corso e in un ultimo terzo<br />
i lavori sono ultimati. È indubbiamente una notevole mole di lavoro che vale la pena<br />
di condurre a termine per i considerevoli risultati che in campo sociale e in campo<br />
302
economico si conseguono, come si rileva là dove i lavori sono stati ultimati. Sotto<br />
questo aspetto la sistemazione dei bacini montani non è meno importante di quella<br />
della zona di pianura, anzitutto perchè assume un carattere di difesa anche per la<br />
stessa pianura e inoltre perchè migliora le condizioni di vita nell’àmbito della montagna,<br />
nel complesso assai disagevoli.<br />
Tra le aree di bonifica in fase avanzata о ormai condotta a termine sono notevoli<br />
quelle dei comprensori della bassa Lodigiana (10.950 ha.), del Cremonese-Mantovano<br />
(53.127 ha.), di Roncocorrente (9536 ha.) e di Révere (13.669 ha.) in provincia di<br />
Mantova, e ancora del territorio a sud di Mantova (11.340 ha.), dove i risultati sinora<br />
conseguiti si rivelano attraverso le rese unitarie che, ad esempio per il frumento e<br />
per il granoturco, sono in qualche caso addirittura raddoppiate. Notevoli estensioni<br />
hanno anche i comprensori mantovani della Fossa di Pozzuolo (41.633 ha.), dell’Agro<br />
Mantovano-Reggiano (23.305 ha. in <strong>Lombardia</strong>), del medio Mantovano<br />
(30.754 ha.), i comprensori bresciani tra Mella e Oglio (62.112 ha.), tra Mella e<br />
Chiese (49.643 ha.) e a oriente del Chiese (99.968 ha.). Ma tutto il territorio della<br />
provincia di Brescia fu a suo tempo dichiarato comprensorio di bonifica e pertanto<br />
Fot. Stefani<br />
Il Piano di Spagna, zona di bonifica.<br />
303
Aratura meccanica<br />
(bassa pianura lombarda).<br />
Fot. Ispettorato Prov. Agricoltura<br />
vi sono da includere le zone vallive dei bacini montani dell’Oglio (120.520 ha.), del<br />
Mella (49.390 ha.), del Chiese (46.101 ha.), in cui tuttavia non si rilevano rapidi<br />
progressi. Anche il bacino montano dell’Adda ha i propri problemi di bonifica e<br />
qui in particolare si possono citare il Piano di Spagna e il Piano di Chiavenna,<br />
pianori alluvionali già ricordati in altra parte.<br />
Nel complesso, secondo il parere espresso nel 1952 da un tecnico, « il programma<br />
di completamento della bonifica idraulica non è imponente e potrebbe risolversi<br />
nel giro di soli cinque anni con il concorso dello Stato nell’ordine di 400 milioni<br />
annui. Sono esclusi da tale calcolo le bonifiche della Fossa di Pozzolo e dei laghi<br />
di Mantova che rappresentano problemi complessi, legati in gran parte anche al<br />
programma irriguo e alla navigazione interna. Per quanto riguarda i gravami che<br />
competono ai privati, vale la pena di far rilevare che gli interessati sarebbero lieti di<br />
affrontarli e che pertanto non attendono che di por mano alle opere » (G. Bonato).<br />
3 0 4
Lo sviluppo deU’agficoltura.<br />
Sembra che gli ordinamenti agrari della <strong>Lombardia</strong> per ciò che riguarda i sistemi<br />
colturali, le forme di conduzione e gli istituti giuridici, si riallaccino ad antiche<br />
consuetudini risalenti almeno all’epoca medioevale; ma si tratta di un legame assai<br />
fragile e secondario, poiché è fuor di dubbio che i fondamenti strutturali degli ordinamenti<br />
attuali trovano, se non altro, la loro premessa nelle riforme risalenti alla<br />
seconda metà del secolo XVIII. Ben è vero che i sovrani austriaci non intesero abolire<br />
i privilegi feudali, che consideravano uno strumento di regno; ma tuttavia essi<br />
condussero a fondo « la lotta per la eliminazione degli autonomi centri di potere<br />
che nel vecchio Stato di Milano s’erano andati formando in corrispondenza dei gruppi<br />
nobiliari (cittadini e feudali) che controllavano la terra о per titolo feudale о come<br />
bene allodiale più о meno libero, e che inevitabilmente ostacolavano il processo di<br />
costruzione di uno Stato reso veramente omogeneo da norme e istituzioni rette da<br />
un’unica volontà politica intesa a procurare il bene di tutti i sudditi: la volontà del<br />
sovrano » (M. Romani). La duplicità di intenti non poteva mancare di rivelarsi,<br />
almeno nella nostra regione, apertamente contraddittoria, e dopo la riforma di<br />
Giuseppe II d’Austria ben poco rimase del complesso di concessioni costituenti il<br />
contenuto del privilegio feudale. Tra le varie provvidenze della riforma meritano di<br />
essere ricordate quelle sulla proprietà fondiaria e sui contratti agrari: in particolare,<br />
le norme limitative dei fidecommissi, che crearono l’ambiente adatto alla piena abolizione<br />
e, di conseguenza, allo smembramento del latifondo; le misure tendenti ad<br />
arrestare l’abuso della manomorta, e quindi a togliere i troppi vincoli sulla disponibilità<br />
della terra; le deliberazioni di alienazione di beni comunali della pianura<br />
e la suddivisione in lotti di dimensioni poderali; le disposizioni per favorire l’affittanza<br />
delle terre, forma ritenuta più proficua, nei risultati produttivi, della conduzione<br />
diretta a mezzo del fattore. Notevole importanza si attribuisce anche alla<br />
riforma del sistema fiscale congegnata in modo da sollecitare una espansione dei<br />
coltivi e un aumento della produzione.<br />
L ’agricoltura lombarda alla fine del secolo XVIII presentava nel complesso condizioni<br />
da suscitare concordi e ammirate espressioni. Significativa rimane la testimonianza,<br />
perchè disinteressata, di Arturo Young, che nel suo Voyage en Italie pendant<br />
Vannée 178g, pur non tralasciando di porre riserva sui sistemi vigenti nella parte<br />
estrema della bassa e sul frazionamento della proprietà nella pianura asciutta, non<br />
lesinava elogi per la struttura fondiaria e i metodi colturali della zona irrigua del<br />
Milanese. Ai risultati conseguiti nell’agricoltura egli attribuiva, forse non senza esagerazione,<br />
lo stato di benessere riscontrato in Milano : « la charme seule fournit à<br />
tout ce luxe ». Certo però nella seconda metà del secolo XVIII l’agricoltura costituiva<br />
la più solida base dell’economia lombarda.<br />
20 —L e R e g io n i d ’ Ita lia - L o m b a rd ia .<br />
305
■>:, . Vf 7' raU -ìkttÉ к<br />
Il trasporto dei covoni alla cascina (campagna cremonese).<br />
A consolidare la struttura deH'economia agricola delia <strong>Lombardia</strong> giovarono le<br />
vicende degli anni dell’occupazione francese tra il 1796 e il 1802. « Fin dal novembre<br />
1796, infatti, l’Amministrazione generale della <strong>Lombardia</strong> con vari provvedimenti<br />
stabilì la piena possibilità di deroga ai vincoli fidecommissarii, di maggiorascato, di<br />
progenitura, mentre la legge 24 luglio 1797 (6 termidoro, anno V), accogliendo i<br />
princìpi affermatisi già in Francia, abolì tutti i vincoli di quel tipo esistenti, proibendo<br />
naturalmente di istituirne di nuovi. Così, dopo il 6 settembre 1796, giorno in cui<br />
l’Amministrazione generale entrò nella libera gestione di tutte le entrate tributarie<br />
e di tutte le proprietà pubbliche (consistenti nei cosiddetti fondi di religione, pubblica<br />
istruzione, ospedalieri, in gran parte ex possessi di manomorta) e fino all’avvento<br />
della Repubblica italiana, si realizzò l’effettiva nazionalizzazione di gran parte<br />
dei beni precedentemente non alienabili se non con autorizzazione governativa, il<br />
loro accrescimento per via di conquista e l’alienizzazione in cospicua misura della<br />
loro prorietà diretta, utile, о piena, mediante vendita, livellamento о affrancazione<br />
di livello» (M. Romani). Per quanto non vi siano precisazioni sulle conseguenze di<br />
tali innovazioni, è certo che queste costituirono un quadro istituzionale favorevole a<br />
306
un deciso mutamento della proprietà e, di conseguenza, a un ulteriore impulso produttivo.<br />
Infatti non solo si poterono acquisire nuove aree precedentemente incolte<br />
trasformandole in risaie e marcite, ma si calcola che nei terreni precedentemente tenuti<br />
dai massari si giungesse ad aumentare i raccolti del 20%. Il Gioia, ad esempio, attribuisce<br />
ai nuovi proprietari (per lo più mercanti desiderosi di investire parte dei loro<br />
averi in beni fondiari), succeduti ai nobili, la redenzione di 120.000 pertiche milanesi<br />
del Dipartimento dell’Olona. E comunque riconosciuto che «lo sviluppo dell’economia<br />
agraria nel ventennio dell’occupazione francese fu innegabile. Basta pensare, oltre<br />
ai progressi dell’allevamento, al rapido accrescere del volume dell’esportazione dei<br />
prodotti agricoli. Il valore delle derrate esportate nel 1814, al netto dell’influenza<br />
monetaria, superava oltre il 50% quello delle esportazioni del 1762 » (A. Sapori).<br />
Dopo il Congresso di Vienna, la situazione determinatasi nella pianura in relazione<br />
al dominio francese non subì ritorni all’antico ed ebbe quindi modo di consolidarsi.<br />
Invece nella montagna alpina e prealpina si accentuò il processo di<br />
frazionamento della proprietà in connessione con le particolari condizioni geografiche<br />
dell’ambiente, con l’aumento progressivo della popolazione assoluta, con l’evolversi<br />
della struttura sociale. Nel complesso la <strong>Lombardia</strong> verso la metà del secolo XIX<br />
Fot. Stefani<br />
Trebbiatura in una corte lombarda.<br />
307
isultava come uno dei paesi d’Europa in cui la proprietà territoriale si ripartiva<br />
sopra un numero relativamente maggiore di abitanti. Dai computi di Stefano<br />
Jacini risulta che in quel periodo vi fosse un reale possidente ogni 8 abitanti e che la<br />
popolazione agricola lombarda ascendesse al 6o% della popolazione complessiva.<br />
Un aspetto interessante della prima metà del secolo XIX è offerto dal notevole<br />
progresso della tecnica colturale, anche per merito di insigni pionieri del miglioramento<br />
agricolo, tra i quali si distinse Vincenzo Dandolo (1758-1819) del quale una<br />
lapide nel Palazzo civico di Varese ricorda l’opera volta a far « prosperare della seta,<br />
del vino, della lana, dei grani, la produzione nazionale; a propagare, benvenuta<br />
alleata del pane del povero, la patata; ad arricchire di queste nostre terre con ignoti<br />
alberi i boschi, con ispane agnelli le greggie, con nuove messi i campi ».<br />
Di fatto proprio nei primi decenni del secolo scorso si diffusero nuove varietà<br />
di specie utili che recarono notevole giovamento all’agricoltura; così per la patata<br />
che trovò un ambiente adatto soprattutto nella collina e nella montagna, per il riso,<br />
di cui fu introdotta la varietà più redditizia già nota nel Novarese, per il gelso, di<br />
cui fu introdotta una varietà che attecchì bene nella pianura, permettendo l’estendersi<br />
di una coltura sino allora limitata alla pianura asciutta e alla collina. Non<br />
sembra invece che si verificassero mutamenti о miglioramenti negli avvicendamenti<br />
о rotazioni delle colture, già in uso con successione adatta ai diversi terreni da molti<br />
secoli.<br />
Una grande mietitrebbia all’opera nella campagna milanese<br />
(Azienda Nèspoli Guido di Vignale).<br />
Fot. Angelo Vitali<br />
308
Fot. Dulevant<br />
Coltivazione di mais nel Pavese.<br />
Un aspetto complesso della situazione agricola presentava il problema dei contratti<br />
agrari. La evoluzione rispetto alla proprietà determinatasi con le riforme non<br />
diede immediati benefici ai reali lavoratori della terra. In genere, il ceto medio, che<br />
delle riforme era stato propugnatore, da esse trasse i maggiori vantaggi, investendo<br />
in acquisti di terre le sue disponibilità; i veri lavoratori della terra, invece, non avevano<br />
la proprietà del suolo al quale dedicavano il loro lavoro; e ciò specialmente<br />
309
nella parte dove più prospera era l’agricoltura, ossia la pianura e la collina. La montagna,<br />
sotto questo aspetto, costituiva un mondo a sè, presentando una grande<br />
varietà di situazioni e ben lo notava il Gioia per il dipartimento del Lario, dove<br />
« l’indefinita varietà dei prodotti, i maggiori о minori travagli necessarj per ottenerli,<br />
la varia distanza delle selve, dei prati, de’ vigneti dalle case, l’incertezza о la<br />
sicurezza del reddito, la minutissima divisione de’ terreni, la generale scarsezza de’<br />
cereali, la stessa annuale emigrazione, hanno realizzato tutti i sistemi possibili di<br />
amministrazione e intralciato in tal maniera i patti che uniscono il colono al proprietario,<br />
che per svolgerli con precisione converrebbe quasi descrivere le comuni ad<br />
una ad una. Li stessi vigneti, principale oggetto dell’agricoltura lariense, li trovi<br />
coltivati a terzo, a metà, a due terzi, ad affitto, per economia, a livello. Il medesimo<br />
paesano è talvolta nel tempo stesso proprietario, mezzatico, affittuario, livellario a<br />
patti diversi con diversi padroni in terreni simili ». Diversa era la situazione della<br />
collina e della pianura asciutta, dove la forma prevalente era la mezzadria, specie<br />
per i poderi di limitata estensione; non mancava però anche la forma d’affitto corrisposto<br />
in denaro о in quantità fisse di grano (detto fitto a biada), in uso specialmente<br />
nell’alto Milanese e nel basso Comasco. Nella pianura irrigua infine l’agricoltura<br />
veniva esercitata — come ben rileva il Cattaneo — « da una classe di fittuari,<br />
ignota presso le nazioni antiche e la maggior parte delle moderne, i quali, piuttosto<br />
che agricoltori, sono imprenditori d’industria agraria; poiché sciolti d’ogni manual<br />
fatica e d’ogni cura servile, dirigono sopra vasti spazi il lavoro dei mercenari, anticipando<br />
grandi lavori riproduttivi al terreno e vivendo in mezzo ai rustici come<br />
cittadini. Questa classe non solo sorse presso di noi più anticamente che in Inghilterra,<br />
ma ebbe radice naturale e spontanea nell’agricoltura irrigatoria. Poiché fatto<br />
costante si é, che, dove questa non dominava, non si formarono le grandi fitterezze».<br />
C ’é solo da aggiungere — nota giustamente il Romani — che gli affittuari ebbero<br />
un ruolo praticamente esclusivo appunto tra Ticino e Adda, dove la coltura asciutta<br />
era un’eccezione, mentre tra l’Adda e il Veneto (pur essendo numerosi) ebbero un<br />
rilievo minore, in quanto molti proprietari, a partire dai primi decenni dell’Ottocento,<br />
vi gestirono direttamente i loro fondi migliori.<br />
Nel complesso l’agricoltura lombarda verso la metà del secolo XIX presentava<br />
un quadro invidiabile per la sua organizzazione e i suoi alti redditi e costituiva ancora<br />
il più importante settore dell’economia regionale.<br />
Dalla formazione dell’unità d’Italia, poi, derivò un motivo di nuovo sviluppo<br />
soprattutto sensibile nel Mantovano e nel Cremonese, che negli ultimi decenni del<br />
secolo si portarono al livello delle zone agricole più progredite. Ovunque poi si<br />
ebbe un processo di assestamento e di rafforzamento attuato — come bene sintetizza<br />
il Sapori — « attraverso un miglioramento dei metodi colturali, a cui giovò,<br />
soprattutto nelle zone di pianura, il crescente ricorso agli strumenti e ai mezzi<br />
offerti dalla tecnologia meccanica e chimica; ad una sempre più razionale combinazione<br />
del lavoro con il capitale; ad un più accurato e stimolante studio dei problemi<br />
agrari; alle provvidenze attuate per aumentare e migliorare il patrimonio<br />
3 10
zootecnico e per dare maggior vigore alle industrie tipicamente agrarie, in primo<br />
piano a quella casearia; al perfezionamento dei contratti agrari, esigenza sempre<br />
più avvertita in rapporto all’importanza assunta dalla questione sociale ».<br />
Negli ultimi decenni del secolo si manifestarono tuttavia anche circostanze generali<br />
sfavorevoli che agirono negativamente anche nei confronti dell’agricoltura lombarda.<br />
In tal senso agì in particolare la crisi europea nel settore agricolo che<br />
cominciò a delinearsi verso il 1880 e che si protrasse per quasi un decennio, determinando<br />
una sensibile flessione dei prezzi. Gravi conseguenze ebbe poi la rottura<br />
dei rapporti commerciali italo-francesi, che colpì soprattutto la produzione casearia<br />
e, di riflesso, l’allevamento dei bovini, la produzione della seta e, di conseguenza,<br />
l’allevamento del bombice. Per di più, con lo sviluppo del commercio continentale,<br />
s’accrebbe il peso della concorrenza, come quella della produzione granaria, per le<br />
esportazioni americane, e della produzione della seta, per le esportazioni giapponesi.<br />
Da tali frangenti critici derivò un impulso notevole (e ciò era più grave per i<br />
riflessi sul futuro) dell’emigrazione di molte famiglie rurali, in ispecie della media<br />
e della bassa <strong>Lombardia</strong>.<br />
Fot. Ispettorato Prov. Agricoltura<br />
Una raccoglitrice di mais in funzione nella « bassa » lombarda.<br />
311
Decadenza della ruralità.<br />
Le vicende che nel nostro secolo hanno caratterizzato la vita agricola della nostra<br />
regione sono nel complesso comuni a tutta la pianura padana; vi è qui, tuttavia,<br />
un’accentuazione maggiore di quella decadenza della ruralità, che è fenomeno generale,<br />
per l’attrazione maggiore delle industrie che si trovano in luogo e che nel volgere<br />
di un secolo hanno assunto uno sviluppo veramente notevole specialmente nella<br />
pianura asciutta e nella collina. Ma alla decadenza della ruralità, intesa come abbandono<br />
del lavoro agricolo per altri settori di attività, non corrisponde una decadenza<br />
dell’agricoltura che si mantiene, sia sotto l’aspetto organizzativo, sia sotto l’aspetto<br />
produttivo, a livelli notevolmente progrediti, anzi, sempre più progrediti.<br />
La riduzione dei quadri degli addetti all’agricoltura è di lunga data e presenta<br />
proporzioni veramente notevoli, rivelatrici, più d’ogni discorso, della situazione<br />
che evolve sotto i nostri occhi. E a tal proposito da tener presente la stima che<br />
Jacini credeva di poter fare sui dati della popolazione per il 1854; ^§1^ riteneva che,<br />
comprendendo le donne e i minori di diciotto anni, la popolazione contadina vera<br />
e propria (ossia che effettivamente lavorava nei campi) fosse circa la metà e la popolazione<br />
agricola (ossia comprendendo i familiari, ecc.) circa i tre quinti della popolazione<br />
totale che a quel tempo risultava di oltre 2.800.000. Quanto diversa la<br />
valutazione a distanza di un secolo! Secondo i risultati del censimento del 1951,<br />
infatti, la popolazione agricola (comprese le donne e i giovani al di sopra dei dieci<br />
anni; non rappresentava che il 18% della popolazione attiva della <strong>Lombardia</strong> per<br />
un totale di 588.000 unità. E benché i dati non permettano un’esatta valutazione<br />
della differenza per l’approssimazione di quelli del 1854 ^ soprattutto per il diverso<br />
procedimento di computo, la differenza è troppo forte per toglierle significato.<br />
Del resto anche le valutazioni più prossime, cioè quelle censuarle del nostro secolo,<br />
non sono meno eloquenti, anche se i rilevamenti mancano di uniformità e di precisione<br />
(in relazione all’esclusione dal computo della maggior parte delle donne<br />
dedite al lavoro dei campi). Nel 1901 gli addetti all’agricoltura erano ancora il 48%<br />
circa della popolazione attiva; nel 19 i i erano il 38% ; nel 1921 erano press’a poco<br />
allo stesso livello quasi equiparando ormai gli addetti all’industria; nel 1931 un<br />
nuovo calo portava al 31% gli addetti all’agricoltura, superati ormai nettamente<br />
dal numero di addetti all’industria; e il calo proseguiva sino al 18% , precedentemente<br />
accennato, per il 1951.<br />
È un fatto rilevabile facilmente e dovunque che nella famiglia tradizionalmente<br />
contadina i figli non succedono più ai padri nel lavoro dei campi. I giovani, tutti<br />
i giovani, sia maschi, sia femmine, aspirano a inserirsi nell’industria о in attività<br />
che non siano quelle agricole e, appena le circostanze si delineino favorevoli, diser-<br />
312
Fot. Ispettorato Prov. Agricoltura<br />
Spianamento del terreno per la preparazione della risaia<br />
(Azienda P. Mai, Caselle Lurani, Lodi).<br />
tano. Ciò si avverte non solo nelle aree più prossime ai centri industriali dove si<br />
offrono maggiori possibilità di lavoro industriale, non solo nella zona di montagna<br />
che è la più avara di risorse agricole, ma anche nelle zone più pingui della pianura<br />
con insediamento agglomerato о sparso che sia. Sarebbe certo interessante poter fermare<br />
l’attenzione sulla distinzione per età della popolazione contadina per rendersi<br />
conto agevolmente del progressivo invecchiamento di essa e della diserzione preoccupante<br />
dei giovani.<br />
Ovviamente il rapporto della popolazione agricola sul totale della popolazione<br />
attiva presenta forti differenziazioni da zona a zona: nel complesso gli agricoli sono<br />
in percentuali più forti nella zona di montagna (Sondrio 38%) e in quelle di pianura<br />
prevalentemente agricole (Mantova 51% ); ma ciò non significa che in esse non<br />
avvenga la diserzione dei giovani dianzi denunciata; anzi essa si manifesta in forma<br />
anche più preoccupante. Infatti nelle aree intensamente industrializzate il giovane<br />
che diserta la campagna ha modo di recarsi quotidianamente all’industria sia per<br />
la sua vicinanza, sia per la rapidità e la frequenza dei trasporti; pertanto egli non<br />
si allontana dalla dimora rurale e convive con i genitori contadini, dando luogo a<br />
quelle famiglie ad attività mista, prevalenti nel Milanese, nel Comasco, nel Varesotto,<br />
ecc. Invece nella montagna о nelle zone propriamente agricole, sia per la<br />
stessa mancanza di industrie, sia per le distanze e i servizi che non permettono uno<br />
spostamento quotidiano, i giovani si trasferiscono anche di residenza, se non immediatamente<br />
almeno una volta che sia assicurato l’impiego. Perciò anche se le percentuali<br />
di popolazione agricola rimangono alte, la campagna effettivamente si spo-<br />
313
Pioppeti e risaie presso Magenta.<br />
Fot. Sef<br />
pola a poco a poco degli agricoli di domani. Ciò è confermato anche dal progressivo<br />
ridursi delle famiglie aventi a capo un rurale, che, da 402.000 nel 1921, sono passate<br />
a 357.000 nel 1936, a 309.000 nel 1951.<br />
Di qualche interesse risulta l’accostamento tra le percentuali di popolazione<br />
agricola sul totale della popolazione attiva e la densità della stessa popolazione agricola<br />
calcolata sulla superficie agricolo-forestale. Il territorio della provincia di Milano<br />
risulta, ad esempio, con una percentuale di popolazione agricola sulla attiva tra le più<br />
basse (6%) — facilmente comprensibile dato l’accentramento urbanistico e industriale<br />
—, ma con una densità di addetti all’agricoltura tra le più alte (34 per kmq.)<br />
e ciò si spiega con la sempre intensa e prospera attività agricola del Milanese. Il<br />
territorio della provincia di Varese, invece, non solo ha la più bassa percentuale di<br />
addetti all’agricoltura (5%), ma anche la minore densità (14 per kmq.), che si spiega<br />
con la modesta fertilità dei terreni.<br />
3 14
Fot. Ispettorato Prov. Agricoltura<br />
Mietitrebbia in azione nella risaia.<br />
Nel complesso le due statistiche possono essere utilmente indicative per confermare<br />
i caratteri generali dell’economia delle diverse zone. Il Milanese fa a sè e<br />
si distingue per l’alto sviluppo industriale e l’intensa attività agricola. La bassa si<br />
delinea come area ancora fondamentalmente caratterizzata dall’agricoltura, ma con<br />
tendenza a seguire l’esempio di Milano nella parte a occidente dell’Adda. La collina,<br />
sebbene nel complesso in forme più attenuate, presenta le caratteristiche rilevate<br />
per il Varesotto, ossia con un’attività agricola via via sempre più soffocata dallo<br />
sviluppo industriale. La montagna, infine, è una regione quasi esclusivamente agricola,<br />
ma le cui risorse modeste sono denunciate dalla bassa densità degli stessi addetti<br />
all’agricoltura.<br />
Progresso tecnico.<br />
Benché effettivamente, come s’è esposto in precedenza, la massa dei rurali vada<br />
via via (e non senza preoccupazione) diminuendo, è giudizioso aggiungere che ciò<br />
nonostante la produzione agricola lombarda non ha, almeno finora, denunciato flessioni,<br />
ma, al contrario, costante progresso. Si deve a tal proposito ricordare che,<br />
concomitante al decrescere dei rurali, vi è stato lo sviluppo della meccanizzazione<br />
anche in campo agricolo e in misura per lo più notevole. Per rendersene conto basti<br />
315
icordare che contro le poco più di 6000 trattrici agricole esistenti in <strong>Lombardia</strong><br />
nel 1938, ve ne erano 15.000 nel 1951 e oltre 28.000 nel 1956, ossia un sesto del<br />
totale nazionale. Ovviamente l’adozione e la diffusione della macchina sono connesse<br />
con diversi fattori ambientali: in genere sono più limitate nella montagna che non<br />
nella collina, dove l’uso risulta già notevole nonostante la morfologia movimentata,<br />
e soprattutto nella pianura, dove non vi sono ostacoli naturali, ma eventualmente<br />
soltanto economici, connessi con la capacità variabile di assorbimento di mano<br />
d’opera delle industrie e dell’eventuale riversarsi della disoccupazione nell’agricoltura<br />
con limitate possibilità di difesa, negli anni scorsi, per l’imponibile di<br />
mano d’opera. Senza ciò l’adozione e la diffusione delle macchine agricole nella<br />
pianura sarebbe indubbiamente maggiore dell’attuale, già tuttavia notevole. Infatti<br />
il progresso della tecnica agricola sollecita l’uso della macchina. La lavorazione del<br />
terreno per colture da rinnovo e da avvicendamento non si diversifica così nettamente<br />
come in passato. Anche per il frumento si fanno arature più profonde e gli aratri<br />
bivomeri о trivomeri sono numerosi. Largamente impiegati sono anche gli erpici,<br />
i frangizolle, le spianatrici, le sarchiatrici, ecc. Il frumento, il riso e spesso anche<br />
il mais vengono messi nel terreno da seminatrici meccaniche. Per il trapianto del<br />
riso si esperimentano già diversi tipi di macchine. Le mietitrici meccaniche e le<br />
falciatrici si trovano ormai anche nelle aziende di media estensione. Per il riso non<br />
manca qualche macchina, ma per lo più il raccolto vien fatto a mano. Nella zona dei<br />
foraggi è di comune adozione il ranghiatore per disporre le andane.<br />
Marcita della « bassa » milanese.<br />
Fot. Stefani<br />
3 16
Nel quadro del progresso della tecnica agraria si inserisce con notevole peso<br />
anche l’avvicendamento о rotazione, che nel nostro territorio presenta schemi diversi<br />
in relazione alle tre regioni altimetriche: la pianura, la collina e la montagna. Nella<br />
pianura le rotazioni attualmente in uso hanno subito, rispetto al secolo scorso, notevoli<br />
variazioni, non soltanto con lo scopo di spostare momentaneamente le singole<br />
colture per l’equilibrio economico dell’impresa (in relazione a contingenze che perennemente<br />
si verificano con varia intensità), ma anche « al fine di esaltare al massimo<br />
i fattori produttivi per elevare ancor più la produzione. Non mutazioni di carattere<br />
statico о di equilibrio, ma di carattere dinamico, esaltatrici » (C. Bonato).<br />
Nella pianura irrigua meno abbondante di acque, dove quindi manca in genere<br />
la coltivazione del riso, alla rotazione sessennale (mais-mais-frumento-prato-pratoprato)<br />
si è sostituita per lo più la rotazione settennale e anche ottennale. Nel primo<br />
anno si coltiva il mais, nel secondo il frumento seguito da erbaio, nel terzo il mais,<br />
nel quarto il frumento, poi per tre anni si coltiva prato. Dove si attua la rotazione<br />
ottennale si inserisce al quarto anno dopo il frumento un nuovo erbaio cui succede<br />
il marzuolo dopo di che si esegue la spianata. Con tale successione si favorisce la<br />
coltivazione del frumento a danno del mais e del prato, ma la produzione foraggera<br />
è compensata dall’erbaio.<br />
La tradizionale rotazione settennale del Lodigiano ha pure subito profonde variazioni;<br />
essa era basata sulla successione mais-frumento-prato-prato-prato-prato-lino;<br />
quest’ultimo, già alla fine del secolo scorso, veniva sostituito dal riso, che entrava<br />
in regolare avvicendamento. Ora la rotazione divenuta ottennale si è fatta più complessa:<br />
apre la successione il mais, seguito, nel secondo anno, dal frumento, al cui<br />
raccolto si procede al trapianto del riso, che ha il ruolo di coltura intercalare; poi<br />
si coltiva di nuovo il mais, seguito, nell’anno successivo, dal frumento; nei tre anni<br />
seguenti si coltiva il prato e nell’ottavo, dopo lo sfalcio del maggengo, si trapianta<br />
il riso. Di questa rotazione è in uso anche qualche variante: tipica la rotazione che<br />
inizia dal riso, cui succede il frumento con erbaio о trapianto di riso, poi di nuovo<br />
frumento e, infine, prato per tre anni.<br />
Nelle zone irrigue dove abbonda maggiormente l’acqua erano in uso rotazioni<br />
sessennali con successioni varie tra cui frequente era quella mais-riso-riso-frumento-<br />
(o avena)-prato-prato. Attualmente sono in uso schemi più complessi, per lo più<br />
ottennali, per cui si avvantaggia la coltivazione del frumento e dell’erbaio, che compensa<br />
della riduzione del prato. Un esempio di queste rotazioni può essere dato<br />
dalla seguente successione: mais nel primo anno, frumento con quarantino e cavoli<br />
nel secondo, riso nel terzo e quarto, frumento marzuolo nel quinto, prato nei tre<br />
seguenti. Nel complesso i nuovi procedimenti, che sono entrati a modificare le rotazioni<br />
tradizionali, si possono ridurre essenzialmente a due: i° introduzione dei frumenti<br />
precoci; 2° aumento dei secondi raccolti e, tra questi, soprattutto degli erbai<br />
e del riso di trapianto. « Una simile organizzazione economico-aziendale si presenta<br />
molto più elastica e in grado di meglio adeguare l’ordinamento produttivo alle varie<br />
situazioni di mercato, senza dire della naturale intensificazione colturale ad essa<br />
317
Aspetto invernale della marcita.<br />
L ’irrigazione con acque di fontanile impedisce che la neve ricopra il prato.<br />
Fot. Stefani
conseguente. A proposito di quest’ultima è opportuno sottolineare che Tintensificazione<br />
può anche portare alla riduzione della superficie a prato. Infatti nelle zone<br />
del piano, dove l’abbondanza dei mezzi tecnici, naturali e creati dall’uomo spinge<br />
l’agricoltura verso le forme più intensive, è da considerare come squisita manifestazione<br />
di progresso la rottura dell’equilibrio cereali-prato, a cui si era giunti nel<br />
recente passato. E essenziale, però, che da questa trasformazione derivi un incremento<br />
nella coltivazione delle foraggere in superficie ripetuta, tale da compensare<br />
lo squilibrio che verrebbe a verificarsi nell’economia dell’azienda per effetto della<br />
riduzione del prato » (G. Bonato).<br />
Nella collina e in parte anche nella pianura asciutta (specialmente dove non è<br />
stata introdotta l’irrigazione) le rotazioni agrarie hanno in genere un ciclo più breve;<br />
a ciò contribuiscono, oltre le condizioni pedologiche, situazioni economiche locali,<br />
quali il frazionamento della proprietà e le forme di conduzione familiare dei poderi,<br />
dai quali si vuole ottenere massimamente cereali e prodotti di consumo familiare.<br />
Nella collina del Bresciano e sulle alture del Varesotto, pur non essendovi un tipo<br />
di rotazione dominante, risulta già discretamente diffusa la quadriennale о la quinquennale,<br />
in sostituzione della biennale mais-frumento. Nella rotazione quadriennale<br />
la successione comporta nel primo anno la coltivazione della patata о del mais, nel<br />
secondo il frumento con il trifoglio, esclusivo, quest’ultimo, del terzo anno; nel<br />
quarto anno il frumento seguito da erbaio. Nella rotazione quinquennale l’ultimo<br />
anno è dedicato al prato, ma il prolungamento non è costante e viene più che altro<br />
suggerito in relazione all’andamento climatico. Queste forme di avvicendamento<br />
rappresentano per la collina un progresso, in quanto la coltivazione del frumento<br />
è sempre preponderante e quella delle colture da rinnovo rimane notevole; ma non<br />
dovunque trova facile e rapida adozione. Così nella collina del Comasco e ancor<br />
Fot. Ispettorato Prov. Agricoltura<br />
Raccoglitrice e caricatrice di<br />
foraggio in azione (cascina<br />
Belgiardino, Montanaro Lombardo).<br />
319
Grandi silos in un’azienda moderna (Lainate).<br />
Fot. Ispettorato Prov. Agricoltura<br />
più nella pianura asciutta del Bergamasco è tuttora largamente in uso la deprecata<br />
rotazione biennale con alternanza di coltura a mais (o patata) e frumento, e tutto<br />
al più con il trifoglio e la medica come coltura intercalare. La maggior parte del<br />
foraggio proviene da prati stabili e ciò riduce le possibilità di allevamento.<br />
Nella montagna i cicli della rotazione nei seminativi sono brevi e non sempre<br />
rigidi; l’avvicendamento biennale è, in genere, dominante. Per lo più a una coltura<br />
sarchiata, che può essere quella della patata nella zona altimetricamente più elevata<br />
о del granoturco nella più bassa, segue il frumento о la segale. Nella montagna<br />
320
Fot. Sef<br />
Fienagione in una marcita della Lomellina.<br />
Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>
dell’alto Comasco e della Valtellina si usa intercalare anche il grano saracino tra<br />
la segale e la coltura sarchiata. Le colture foraggere non rientrano nella rotazione<br />
e la loro produzione proviene in assoluta prevalenza dai prati stabili. In posizione<br />
di maggior progresso si trova la montagna prealpina del Bresciano, dove già dal<br />
secolo scorso si attua una rotazione quinquennale in cui si susseguono il mais associato<br />
con lupini da sovescio nel primo anno, il frumento con trifoglio pratense nel<br />
secondo, prato nel terzo, frumento con lupini da sovescio nel quarto e, infine, frumento<br />
e granoturco quarantino nel quinto. Nella montagna alpina del Bresciano<br />
è inoltre frequente un avvicendamento triennale costituito da patate consociate a<br />
fave e fagioli nel primo anno, frumento (o segale) seguito dalla rapa da foraggio nel<br />
secondo, frumento (o orzo) nel terzo anno.<br />
In conclusione però il quadro generale degli avvicendamenti colturali della Lom <br />
bardia presenta una netta differenziazione tra la zona della bassa e la zona comprendente<br />
la pianura asciutta, la collina e la montagna. In queste gli schemi delle<br />
rotazioni sono piuttosto rigidi e dominati dalla coltura dei cereali; in quella invece<br />
gli schemi tendono (grazie soprattutto all'irrigazione) verso una maggiore elasticità,<br />
la quale, pur facendo perno sul binomio cereale-foraggio, è indice di quel progresso<br />
indispensabile affinchè, senza sovvertire i precetti tecnici, l’agricoltura possa adeguarsi<br />
alle contingenze economiche.<br />
La proprietà fondiaria.<br />
Un problema agrario del massimo interesse in <strong>Lombardia</strong>, per i riflessi che comporta<br />
о può determinare, riguarda la proprietà fondiaria che presenta un alto grado<br />
di frazionamento, anzi il più alto grado tra le regioni italiane, come già nello scorso<br />
secolo Stefano Jacini aveva messo ben in evidenza. Occorre aggiungere che dopo di<br />
allora il processo di frazionamento ha mostrato di acuirsi e di assumere un ritmo<br />
accelerato specialmente dopo la prima guerra mondiale. Le cause sono molteplici<br />
e complesse. Quelle naturali connesse con l’ambiente possono agire come sollecitazione<br />
о come freno, non tanto direttamente, quanto in conseguenza della situazione<br />
agricola cui danno luogo e ciò spiega, ad esempio, come nel processo di frazionamento<br />
fondiario la montagna, per l’ambiente ingrato, abbia preceduto in ordine<br />
di tempo la collina e la pianura. Nello stesso modo possono agire le cause demografiche<br />
e può ritenersi per certo che l’aumento progressivo della popolazione favorisce,<br />
entro certi limiti, l’accelerazione della suddivisione, per successione ereditaria, delle<br />
unità fondiarie. Vi sono poi cause tradizionali, come la donazione, ecc. Ma tutto<br />
ciò non sarebbe sufficiente a render ragione delle proporzioni del processo contemporaneo,<br />
quali si rilevano in <strong>Lombardia</strong> e che devono attribuirsi in massima misura<br />
al libero trasferimento di terre. Per averne un’idea si può ricordare, come esempio.<br />
Le Regioni (¡‘Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
321
che negli anni immediatamente seguenti alla prima guerra mondiale vi è stata in<br />
<strong>Lombardia</strong> una somma di compre-vendite pari a complessivi 150.000 ettari di terre.<br />
Non si capirebbe dunque il fenomeno senza tener conto della evoluzione sociale<br />
e, in particolare, economica, che ha caratterizzato più d’ogni altra la nostra regione<br />
nel volgere di poco più di un secolo. Ce ne dà una sintesi il Bonato, il più penetrante<br />
indagatore di questo problema : « La decadenza economica e politica della<br />
nobiltà fondiaria, propria, questa, dell’Ottocento, la nuova borghesia creata dall’industria,<br />
fresca di energie, risparmiatrice, che più tardi ha rivolto alla terra parte<br />
del capitale accumulato, le nuove richieste avanzate dal proletariato contadino sui<br />
‘ diritti del lavoro ’ e per la ‘ giustizia sociale ’ accanto al nuovo ceto rurale, che si<br />
andava man mano formando nell’industria, sono le cause successive e concomitanti<br />
che hanno condotto all’attuale distribuzione della proprietà fondiaria. Non<br />
tutte hanno certamente avuto la stessa importanza, nè hanno agito contemporaneamente.<br />
Nel periodo precedente la prima guerra mondiale, il notevole sviluppo industriale<br />
ha rappresentato una causa molto importante nel frazionamento della proprietà<br />
in collina, sia col creare una nuova borghesia ricca e bramosa di investire i suoi<br />
copiosi risparmi nella proprietà terriera, che col dare alla vita economica in genere<br />
un nuovo e forte impulso, di cui hanno tratto considerevole vantaggio le popolazioni<br />
rurali stesse alle quali si è così presentato più accessibile il mercato della terra.<br />
Numerosi piccoli affittuari hanno realizzato in tali periodi il loro sogno, quello della<br />
proprietà, favorito anche dal progressivo indebolimento economico delle classi nobili.<br />
Irrorazione a macchina di anticrittogamici.<br />
Fot. Ispettorato Prov. Agricoltura<br />
322
Spezzettamento della proprietà<br />
visibile dalla differenziazione<br />
dei coltivi in un villaggio alpino.<br />
Fot. Nangeroni<br />
Il periodo successivo alla prima guerra mondiale ha visto acuirsi sempre più il disagio<br />
economico delle famiglie patrizie. Il blocco dei canoni di affitto, l’inflazione, la<br />
minaccia di rivolgimenti sociali, l’azione svolta dai partiti politici più forti, il popolare<br />
e il socialcomunista, e quella delle Camere del Lavoro, rappresentano sicuramente<br />
le cause ultime che hanno favorito l’acquisto di terre da parte dei contadini. Gli alti<br />
prezzi raggiunti dai prodotti agricoli e la bramosia del possesso hanno spinto gli<br />
affittuari a offrire prezzi anche molto elevati, ai quali i proprietari hanno ceduto<br />
molto volentieri ».<br />
Secondo una accurata e recente indagine, in <strong>Lombardia</strong> nel 1946, su una superficie<br />
censita di complessivi 2.204.667 ettari, si annoveravano 876.190 proprietà,<br />
delle quali il 3% costituite da enti, cui però andava il 28% della superficie. Se si<br />
escludono gli enti, l’estensione media della proprietà fondiaria risultava quindi di<br />
ettari 1,86. Anzi, poiché gli intestatari delle proprietà private risultavano 2.286.291,<br />
ne consegue che la proprietà media per persona fisica proprietaria era addirittura<br />
di ettari 0,70! Questi pochi dati sono sufficienti a dimostrare l’alto frazionamento<br />
della proprietà in <strong>Lombardia</strong>; difatti numericamente dominano in senso assoluto<br />
le proprietà inferiori ai due ettari che costituiscono l’85% del totale. Naturalmente<br />
la situazione risulta assai diversa da zona a zona e la differenziazione si manifesta,<br />
con netta evidenza, connessa con le zone altimetriche, il che conferma l’influsso che<br />
nel processo di frazionamento ha avuto l’ambiente fisico.<br />
Riguardo alla montagna il quadro distributivo della proprietà presenta caratteristiche<br />
inconfondibili. Gli enti, rappresentati nella grande maggioranza dai Comuni,<br />
posseggono vaste estensioni di pascoli alpini e di boschi; i privati si suddividono<br />
piccole particelle distribuite tra seminativo, vigneto e prato. E da sottolineare che<br />
i beni terrieri dei privati e quelli dei Comuni sono necessariamente legati da inscindibili<br />
legami economico-agrari. Ciò deriva dal fatto che l’economia montana è domi-<br />
323
i<br />
Giovane frutteto a filari.<br />
Fot. Ispettorato Prov. Agricoltura<br />
nata dall’allevamento dei bovini da latte, per il quale è indispensabile il concorso<br />
di tre tipi di beni fondiari: il pascolo dell’alpe (di proprietà comunale), il maggengo<br />
(di proprietà privata о anche comunale) e il prato di casa (sempre di proprietà privata),<br />
ciascuno dei quali contribuisce, secondo la stagione, ad alimentare il bestiame.<br />
Si potrebbe, in linea di massima, rilevare una variabilità delle forme di possesso in<br />
relazione aU’altimetria: i seminativi, che con i prati di casa si trovano per lo più in<br />
prossimità degli abitati e quindi nelle zone meno elevate, sono dispersi in mille particelle<br />
unicamente tra i privati; i maggenghi, che si stendono sui versanti montani<br />
alternandosi ai boschi, rappresentano una zona di possesso misto, in parte comunale<br />
(specialmente boschi), in parte privata (specialmente prati-pascoli); infine i pascoli<br />
alti rappresentano vaste proprietà in prevalenza comunali, di godimento collettivo<br />
secondo regole tradizionali. Vi sono, è vero, anche alcune alpi di proprietà privata,<br />
ma in genere il possesso si suddivide tra un numero notevole di comproprietari<br />
sicché il quadro generale, che ha la sua tipica manifestazione in Valtellina, non muta<br />
sostanzialmente.<br />
Nella collina la distribuzione della proprietà fondiaria manifesta una netta correlazione<br />
con la frequenza degli impianti industriali. Ad esempio, nel Varesotto e<br />
nel Comasco, dove le industrie presentano una maggiore densità, si ha un altissimo<br />
324
frazionamento, che va accentuandosi di anno in anno. È interessante notare che<br />
anche da parte di chi è decisamente avviato al lavoro nelle industrie si sogna<br />
l’acquisto di un pezzo di terra. Ciò avviene anzitutto per l’aspirazione, spesso realizzata,<br />
di costruire su di esso la propria casa, ma anche per altre ragioni: per l’amore<br />
alla terra, non sopito anche se la si è abbandonata per altra attività; per un sicuro<br />
impiego del risparmio al riparo dell’inflazione; per un completamento del salario<br />
con la produzione di ortaggi di consumo familiare; per il timore, infine, di una<br />
eventuale disoccupazione e soprattutto la previsione della vecchiaia, indubbiamente<br />
più tranquilla e più sicura se ancorata al possesso di un proprio pezzo di terra.<br />
E ovvio che per queste sollecitazioni non possano formarsi se non minuscole<br />
proprietà, determinando nel quadro agricolo una singolare situazione che può per<br />
alcuni aspetti considerarsi negativa e per altri, invece, positiva. Nella collina bresciana<br />
lo sviluppo industriale non ha manifestato gli stessi riflessi, poiché la viticoltura<br />
aveva già in precedenza favorito il frazionamento fondiario. Una tendenza verso<br />
un’ulteriore accentuazione del frazionamento non manca, ma in complesso è ancora ben<br />
contenuta, sicché le proprietà superiori ai io ettari occupano la metà della superficie.<br />
Nella pianura asciutta la distribuzione della proprietà presenta una situazione<br />
meno soggetta a rapidi mutamenti per influsso dell’industria e ciò a causa della<br />
maggiore produttività del suolo, rispetto alla collina, specialmente nelle aree dove<br />
è intervenuta l’irrigazione. Le proprietà tra i io e i 200 ettari occupano circa i<br />
tre quinti della superficie agraria e non mancano anche proprietà di oltre 200 ettari,<br />
alcune delle quali ancora tenute da famiglie nobiliari.<br />
Nella pianura irrigua domina nel complesso la grande e la media proprietà, con<br />
varianti che sono da mettersi in relazione agli ordinamenti colturali i quali a loro<br />
volta rispecchiano le maggiori о minori possibilità d’irrigazione. La piccola proprietà<br />
è sporadica, con qualche maggior frequenza nelle alluvioni recenti che accompagnano<br />
il corso dei fiumi e che meno fruiscono della rete irrigua. A parte queste<br />
limitate zone di accentuato frazionamento fondiario il piano della bassa può essere<br />
distinto in due parti dall’Adda. Nella zona risicola e foraggera, che si stende a occidente<br />
del fiume, le unità colturali tra i 50 e i 200 ettari predominano nettamente:<br />
frequenti sono pure le unità tra i 200 e i 500 ettari e non sono rare anche quelle<br />
oltre i 500 ettari. A oriente del fiume, nel Cremasco, nel Trevigliese, nella pianura<br />
bresciana e bergamasca, si rileva invece un ridursi dell’estensione della proprietà<br />
fondiaria e ciò soprattutto per le minori possibilità irrigue (particolarmente modeste<br />
sino al secolo scorso), in connessione alle quali muta anche l’ordinamento colturale.<br />
Le unità poderali tra i io e i 50 ettari sono prevalenti, per quanto non ne manchino<br />
anche di estensione superiore; inoltre le proprietà sino a io ettari sono più<br />
frequenti che a occidente dell’Adda. Anche il Mantovano presenta le stesse caratteristiche<br />
generali, per quanto con variabilità maggiore connessa con la minore<br />
uniformità dei terreni e dell’ordinamento colturale. Una situazione particolare presenta<br />
l’Oltrepò pavese dove la pianura, la collina e la montagna si distinguono per<br />
diversa prevalenza di ampiezza della proprietà: nella prima predominano proprietà<br />
325
Vigneti dell’Oltrepò pavese (La Ginestrella, Casteggio).<br />
Fot. Chiolini<br />
inferiori ai IO ettari, benché non ne manchino anche di grande ampiezza; nella<br />
seconda predomina la piccola proprietà; nella terza la proprietà minuscola accanto<br />
alle grandi proprietà collettive dei boschi e dei pascoli.<br />
Le colture e le zone agrarie.<br />
Già da quanto sin qui esposto appare evidente come il volto agricolo della Lom <br />
bardia si presenti molto vario. A darne conferma può giovare anche il quadro della<br />
ripartizione della superficie secondo le diverse colture. A questo proposito occorre<br />
anzitutto osservare che l’elevata altimetria e la frequente asperità del territorio montano,<br />
l’estensione non trascurabile dell’area glacializzata, la vastità dei bacini lacustri,<br />
l’espansione degli abitati, ecc., sottraggono alla superficie produttiva un notevole<br />
spazio. Infatti l’improduttivo si estende per 343.000 ettari, che equivalgono a un<br />
326
poco più del 14% della superficie territoriale. È da notare che tale percentuale risulta<br />
lievemente ridotta rispetto a pochi anni or sono (allorché si calcolava l’improduttivo<br />
a quasi il 15% ) in sèguito a una più esatta valutazione delle aree produttive;<br />
ma essa risulta sempre molto più alta di quella italiana (7,7%). Su tale valore pesano<br />
particolarmente le province di Sondrio e di Brescia che assommano esse sole (in<br />
misura tra loro poco differenziata) quasi la metà dell’improduttivo totale della <strong>Lombardia</strong>.<br />
La ragione è facilmente comprensibile e trova conferma nella percentuale<br />
dell’improduttivo delle tre zone altimetriche rispetto alla superficie territoriale di<br />
ciascuna: la montagna ha un improduttivo pari al 21% , la collina al 12% e la<br />
pianura al 9%.<br />
La superficie agraria e forestale, dunque, risulta nel complesso di 2.036.654 ettari<br />
(pari all’86% di quella territoriale). Quasi tre quarti di essa è dedicata alle colture<br />
erbacee avvicendate, alle colture foraggere e alle colture legnose specializzate; la<br />
restante è occupata dai boschi e, in misura modesta, dagli incolti produttivi. Le colture<br />
avvicendate sono nettamente predominanti nella bassa dove occupano oltre<br />
il 70% della superficie agraria-forestale; tale predominio si attenua progressivamente<br />
nella collina e nella montagna. In particolare nella pianura prevalgono nettamente<br />
le foraggere e i cereali; tra questi prevalgono soprattutto il frumento, il mais e il<br />
riso, tra quelle le marcite e le foraggere di avvicendamento. A notevole distanza<br />
seguono le coltivazioni di ortaggi, di patate, di barbabietola da zucchero, canapa, ecc.<br />
Per quanto nei seminativi siano diffuse, in forma promiscua, le colture legnose,<br />
queste, nella forma specializzata, si estendono particolarmente nella collina e nella<br />
montagna. Normalmente le colture legnose nei seminativi sono costituite da gelsi,<br />
da viti e da alberi da frutto; le colture legnose specializzate sono invece costituite<br />
soprattutto da viti e, in misura notevolmente minore, da castagni. Nel complesso,<br />
da questi pochi cenni, risulta che la <strong>Lombardia</strong> dal punto di vista agrario sia da<br />
considerare come regione soprattutto dedita ai cereali e ai foraggi, con produzioni<br />
totali e unitarie tra le più alte d’Italia. A darne conferma bastano pochi dati. Riguardo<br />
ai cereali la superficie lombarda ad essi dedicata è nel complesso Г85% di quella<br />
dedicata alle coltivazioni erbacee; naturalmente hanno una prevalenza il frumento,<br />
seminato annualmente su circa 300.000 ettari, il mais, seminato su circa 200.000 ettari,<br />
e il riso, seminato su quasi 50.000 ettari. La resa per ettaro è in media di 33 quintali<br />
per il frumento, di 45 per il mais e di 48 per il riso, valori tra i più alti dell’Italia.<br />
La produzione totale è di circa io milioni di quintali di frumento, quasi<br />
altrettanti di mais e di 2 milioni e mezzo di riso; in tal modo la <strong>Lombardia</strong> si pone<br />
ai primi posti nella graduatoria per regioni. Nessuna regione, poi, s’awicina al totale<br />
di produzione di foraggio, calcolata, per la <strong>Lombardia</strong>, in ben 65 milioni di quintali<br />
di fieno normale come media annua, che costituiscono circa un quinto della<br />
produzione nazionale.<br />
Naturalmente, per le differenti condizioni d’ambiente, il quadro rurale e agrario<br />
si presenta notevolmente differente in relazione all’altimetria. Nella zona di montagna,<br />
che occupa il 30% della superficie territoriale della <strong>Lombardia</strong> e accoglie<br />
327
Vigneti in Valtellina (Poggiridenti).<br />
Fot. Zampieri<br />
all’incirca il 15% della popolazione agricola della regione, l’agricoltura trova, nel<br />
complesso, condizioni precarie, in conseguenza non solo dell’ambiente naturale,<br />
di per sè ostico, ma altresì di situazioni economiche quali il frazionamento della<br />
proprietà, l’eccesso di aggravi fiscali; il disboscamento irrazionale, ecc. I seminativi<br />
si stendono soprattutto lungo i fondivalle e sulle pendici più prossime a questi,<br />
spingendosi all’incirca sino all’altezza di 800 m. e, con il favore dell’esposizione, anche<br />
a maggiore altitudine; ma in relazione a questa vanno via via rarefacendosi: come<br />
limite massimo di coltivazioni stabili, per lo più di segale e di patate, si può indicare<br />
l’isoipsa dei 1800 m. (Livigno, alta Valtellina). Nel complesso i seminativi<br />
nella zona montana rappresentano solo il S % circa della superficie agraria-forestale<br />
e, pur con l’aggiunta dell’area dedicata al vigneto che si estende per poco più<br />
dell’ i% della superficie agraria-forestale, rimane sempre evidente la modestia dell’estensione<br />
dei coltivi. La maggior parte della superficie è infatti occupata dai<br />
boschi (36%), dai prati e dai pascoli (37%). Il bosco si estende sui versanti montuosi:<br />
in basso e sui pendii a solatìo per solito a macchie rade e isolate, più su<br />
e sui pendii a bacìo di frequente a mantello fitto e talvolta continuo; esso giunge<br />
328
ad una altezza massima di 2200 metri. Il bosco ceduo (costituito soprattutto dalle<br />
querce, dal castagno, dal nocciolo, dai faggi e dalle robinie) predomina sino a<br />
circa 1200 m. ed è quindi diffuso in particolare nelle Prealpi; il bosco di conifere<br />
Le coltivazioni prevalenti nelle diverse zone della <strong>Lombardia</strong>.<br />
I, zona dei seminativi con prevalenza di coltivi a riso, foraggi e frumento; 2, zona di seminativi con prevalenza di<br />
coltivi a frumento e foraggi; 3, zona di seminativi con prevalenza di coltivi a frumento; 4, zona di seminativi con prevalenza<br />
di foraggi (marcite); 5, zona di seminativi con prevalenza di frumento e mais; 6, zona di seminativi misti erbacei<br />
(mais, frumento, patata) e arborei (vite, gelso, alberi da frutta); 7, zona di seminativi con prevalenza di vite; 8, zona<br />
di seminativi con frequenza di olivi; 9, zona di seminativi di fondovalle (a cereali, patate, vite, ecc.); io, zona di prati<br />
e di pascoli di montagna; ii, zone di brughiera; 12, improduttivo.<br />
Utet<br />
329
(costituito soprattutto dall’abete rosso e dal larice) predomina a livelli superiori<br />
ai 1200 m. ed è quindi più frequente nelle Alpi. Là dove il mantello boschivo si<br />
apre in radure più о meno vaste si estende il prato о il prato-pascolo e, press’a poco<br />
al di sopra dei 1800 m., il pascolo semplice; quest’ultimo si spinge sino al limite<br />
delle nevi persistenti e anche sopra.<br />
In conclusione, nella zona di montagna si possono individuare almeno tre zone<br />
a differente fisionomia agraria: quella che, per intenderci, può essere detta dei fondivalle<br />
(benché non sia rigorosamente limitata a questi) con coltivazioni cerealicole<br />
e frutticole; quella di media montagna, in parte a bosco e in parte a prato-pascolo;<br />
quella più elevata e cioè di alta montagna, a pascolo.<br />
Quasi mai, però, l’alpigiano è uno specialista nel senso che si dedica о solo alle<br />
coltivazioni о solo allo sfruttamento del bosco о solo all’allevamento. Per lo più egli<br />
esplica un’attività mista, che le stagioni regolano col loro avvicendamento. Nella<br />
primavera, normalmente, cura le minuscole particelle di fondovalle, lavorando di<br />
vanga e di falcetto per la semina e la potatura; d’estate divide il suo tempo tra<br />
l’alpe, dove lascia il bestiame al pascolo, e il maggengo, dove raccoglie il foraggio<br />
per l’inverno; l’autunno lo vede affaccendato ai raccolti; l’inverno lo richiama alle<br />
cure del bosco. Nella ripartizione dei seminativi si nota, come già s’è accennato,<br />
la prevalenza dei cereali e, in graduatoria, della segale, del frumento, dell’orzo,<br />
del mais e del grano saracino; estesi sono pure, per rotazione, i coltivi a patata e<br />
a trifoglio. Non manca ovviamente qualche eccezione e tra queste merita di essere<br />
ricordata la bassa Valtellina, dove su ogni altra coltivazione prevale il vigneto, esteso<br />
sui versanti a solatìo, i quali, per quanto ripidi, sono stati meravigliosamente trasformati,<br />
con la erezione di una rete di muretti a secco per trattenere il velo di<br />
terreno a volte accumulato con trasporto a spalla. Il vigneto è assai produttivo e dà<br />
vini di pregio, quali il sassella, l’inferno e il grumello esportati particolarmente<br />
nella Svizzera.<br />
Il quadro dell’allevamento nell’àmbito della montagna lombarda presenta, come<br />
del resto altrove nelle Alpi e nelle Prealpi, un quadro assai complesso, soprattutto<br />
per le migrazioni stagionali che lo distinguono. Queste, nella maggior parte dei casi,<br />
si svolgono fra tre stazioni: quella di fondovalle, con stalle (annesse, per lo più, alle<br />
abitazioni) dove il bestiame trascorre al chiuso l’inverno; quella a media altitudine<br />
con stalle-fienili, dove il bestiame sosta al pascolo in primavera e in autunno; quella<br />
più elevata delle Alpi, dove il bestiame è lasciato libero sui pascoli durante l’estate.<br />
Un quadro agrario inconsueto nell’àmbito della montagna lombarda presentano<br />
le sponde dei laghi; in esse si son venute determinando, per il favore delle condizioni<br />
termiche e per intervento dell’uomo, delle isole floristiche, in cui si associano<br />
armoniosamente le specie alpine con quelle mediterranee: l’abete con gli agrumi,<br />
il larice con l’ulivo, il pino alpestre con la palma. Le colture agrarie più tipiche<br />
sono quelle degli agrumi e dell’olivo. Sono, però, entrambe in declino. La coltivazione<br />
degli agrumi e specialmente dei limoni era un tempo assai florida specialmente<br />
lungo la sponda del lago di Garda; vi si vedono ancora pendii terrazzati recinti da<br />
330
alti muri a protezione del vento e fitti<br />
di colonne sulle quali d’inverno si stendono<br />
graticci a protezione dal freddo;<br />
ma per quanto accolgano ancora limoneti,<br />
la produzione, per la concorrenza<br />
di quella meridionale, non ragguaglia per<br />
quantità e qualità quella del secolo scorso.<br />
Anche sul lago di Como era praticata in<br />
passato la coltivazione del limone e lo<br />
testimonia l’ edificio che nelle dimore<br />
rurali vien ancora chiamato limunera e<br />
che serviva da serra durante l’inverno;<br />
ma attualmente la coltivazione è scomparsa.<br />
In declino è anche, su tutti i laghi,<br />
la coltivazione dell’olivo; tuttavia essa è<br />
ancora assai diffusa sulle sponde del lago<br />
di Garda e del lago di Como.<br />
La zona delie colline lombarde che si<br />
estende per il 13% della superficie regionale<br />
e accoglie il 20% del totale della<br />
popolazione rurale, presenta un quadro<br />
agricolo a sè, differente da quello delle<br />
zone contermini e cioè differente da quello<br />
della montagna e da quello della pianura.<br />
Il terreno che forma le colline, in parte<br />
Fot. Nangeroni<br />
La trasformazione di ripidi versanti montani<br />
in allungati terrazzi a coltivi nelle Prealpi<br />
(Valsàssina).<br />
autoctono e in parte alloctono, non è in nessun caso, per sua natura, troppo avaro ; ma<br />
tanto quello alluvionale che quello morenico sono molto permeabili e per questa ragione<br />
non risultano eccessivamente produttivi. I seminativi sono discretamente estesi,<br />
occupando complessivamente il 49% della superficie agraria-forestale; la parte maggiore<br />
di essa viene data ai cereali (62%) e, com’è ovvio, in particolare al frumento.<br />
Discreto spazio viene pure dato alla coltivazione della patata (che trova nella zona<br />
di collina un ambiente particolarmente adatto) e degli ortaggi. Le coltivazioni<br />
legnose specializzate occupano il 9% della superficie agraria, ma di fatto, la vite,<br />
gli alberi da frutta e il gelso sono specie promiscue ad ogni coltura, e, con la loro<br />
frequenza, conferiscono una particolare impronta alla collina lombarda; però la vite,<br />
a causa della fillossera, e il gelso, per il parziale abbandono dell’allevamento del<br />
baco da seta, hanno in varie plaghe perduto la prosperità di un tempo. Rimangono<br />
tuttavia ancora rinomati i vigneti delle colline del Bresciano, e soprattutto dell’anfiteatro<br />
del lago di Garda, e i frutteti dei colli della Bergamasca e del Comasco. Anche<br />
la zona collinare dell’Oltrepò pavese si distingue per i vigneti, che hanno il predominio<br />
su tutte le altre colture. Rinomate per la produzione di uva da vini prelibati,<br />
bianchi, rosati e rossi, sono le colline da Voghera a Stradella.<br />
331
Dal margine inferiore della zona collinare al corso del Po si estende la pianura;<br />
essa abbraccia complessivamente un’area che è di poco inferiore alla metà del territorio<br />
lombardo (precisamente il 46%) e accoglie poco meno dei due terzi degli<br />
agricoltori della regione (precisamente il 65%). La pianura, da un punto di vista<br />
agrario, non presenta affatto quella monotonia che si potrebbe immaginare; al contrario,<br />
manifesta delle notevoli differenziazioni da zona a zona, connesse particolarmente<br />
con i caratteri del terreno.<br />
L ’alta pianura, costituita da terreni alluvionali grossolani e frequentemente decalcificati<br />
nello strato superficiale, ha tratto un enorme vantaggio dalla irrigazione<br />
artificiale. Alle piante xerofile si sono infatti aggiunte numerose specie irrigue e le<br />
une e le altre hanno avuto un prosperoso sviluppo. La coltivazione dei cereali, specialmente<br />
del frumento e del mais, occupa la superficie maggiore dell’area produttiva<br />
(70%), con un rendimento unitario discretamente alto. Per nulla trascurabile è pure<br />
la produzione della patata e del foraggio. Caratteristica del resto è, come s’è già<br />
notato, la rotazione quadriennale di frumento, granturco, patate e trifoglio. Le<br />
piante del gelso, in lunghi filari, delimitano i coltivi e sostengono le viti; però, con<br />
la decadenza dell’allevamento del baco da seta (che fu per molto tempo una grande<br />
risorsa della famiglia contadina dell’alta pianura) il gelso non raramente viene sradicato<br />
per dar spazio agli alberi da frutto e alla vite. Nel complesso l’agricoltura dell’alta<br />
pianura irrigua offre un quadro di discreta prosperità, in netto contrasto con<br />
la vicina brughiera, il cui terreno ghiaioso, superficialmente ridotto a ferretto, rimane<br />
Fot. Nangeroni<br />
Raccolta di patate in un<br />
coltivo della montagna<br />
alpina (Borno, Valcamònica).<br />
332
in parte ricetto di un groviglio selvaggio di vegetazione arbustiva atta ad essere<br />
utilizzata come legna da ardere.<br />
Sotto il limite alto dei fontanili, il volto rurale della campagna lombarda muta.<br />
Ivi l’economia rurale è nettamente « influenzata da due elementi flsici favorevoli,<br />
la natura del suolo e l’abbondanza delle acque. Il suolo, sciolto, a grana fine, ricco<br />
di elementi azotati, pingue e nerastro, è lavorabile facilmente anche con mezzi meccanici<br />
e si presta ottimamente alle colture erbacee annue intensive. L ’acqua, copiosa<br />
e omotermica, può essere immessa nei campi, о per infiltrazione, о per scorrimento,<br />
о addirittura in quantità tale da causare la prolungata sommersione di alcune colture,<br />
senza tuttavia impaludare, perchè il suolo è sempre, sia pur lievemente, inclinato;<br />
essa, quindi, è un elemento fondamentale per determinare il tipo di colture<br />
che si adatta meglio degli altri a questa regione. Qui, infatti, marcite e risaie prevalgono<br />
tanto da divenire un elemento tipico del paesaggio; ed anche là dove la<br />
coltivazione mantiene lo schema tradizionale della rotazione erbacea quadriennale,<br />
associata alle colture arboree e a filari, la presenza dell’acqua tanto copiosa influenza<br />
la produzione in senso favorevole, accrescendone il rendimento. Ne consegue una<br />
maggiore ampiezza della proprietà, un carattere intensivo delle colture, un più largo<br />
impiego di capitali, di macchine, di bestiame, di braccia; elementi tutti che differenziano<br />
anche sotto l’aspetto economico e sociale questa regione », già tanto diversa<br />
dalle altre plaghe della <strong>Lombardia</strong> sotto l’aspetto fisico (G. Merlini).<br />
La marcita costituisce una singolarità del paesaggio agrario della media pianura.<br />
Essa ha forme diverse, ma per lo più ad ali, ossia a piani adiacenti inclinati a<br />
capanna, ciascuno, di un centinaio di metri di lunghezza e di una decina di larghezza<br />
al massimo; al bordo superiore di due piani contigui con pendenze opposte<br />
(del 2-4%) corre un fossatello detto adacquatore, per il quale l’acqua giunge e trabocca;<br />
questa scorre lentamente sul piano e finisce nel fossatello al bordo inferiore,<br />
detto colatore, che scola il sovrappiù. Si tratta di una irrigazione termale che ha lo<br />
scopo di impedire il raffreddamento e il congelamento del suolo durante l’inverno<br />
e di conseguenza l’arresto dello sviluppo vegetativo del foraggio costituito solitamente<br />
da una mescolanza di trifoglio {Trifolium pratense), di loietto {Lolium italicum)<br />
e di erba pannocchia (Dattilis glomerata). L ’acqua d’irrigazione proviene in buona<br />
parte dai fontanili (dai quali sgorga a temperatura invernale di circa + 13 ° ) e, a sud<br />
di Milano, anche dagli scoli della città, che però in tempi recenti si sono dimostrati<br />
non più del tutto adatti per l’inquinamento di prodotti chimici deleteri alle<br />
colture. Nel complesso da una marcita si possono ottenere otto e anche dieci tagli<br />
di foraggio (quindi anche alcuni invernali) con una produzione anche di 250 quintali<br />
di fieno all’anno per ettaro. Si calcola che in <strong>Lombardia</strong> siano dedicati alla marcita<br />
oltre 22.000 ettari che costituiscono il 90% di tutta l’area a prato marcitorio d’Italia.<br />
Il paesaggio agrario tra il tronco inferiore del Naviglio Grande e il Po, tra la<br />
Sesia e il Lambro riceve un’inconfondibile impronta dalla presenza delle risaie.<br />
Queste cominciano a comparire poco a sud di Milano dove s’alternano con la marcita;<br />
il loro predominio si manifesta incontrastato nel territorio della provincia di<br />
333
Pavia e specialmente della Lomellina. Qui è la maggior parte della superficie lombarda<br />
dedicata annualmente al riso, superficie che, per quanto subisca sensibili oscillazioni<br />
da un anno all’altro in relazione alla situazione di mercato, rimane pur sempre<br />
attorno a una media di 50.000 ettari. Altrove la risaia appare sporadicamente in<br />
modesti appezzamenti dovuti soprattutto a bonifiche locali; così, ad esempio, nel<br />
Mantovano e nel Cremonese. Particolari caratteristiche presenta la sistemazione dei<br />
terreni, eseguiti di solito all’asciutto, poiché è necessario costituire ripiani orizzontali<br />
(la cui ampiezza varia da qualche centinaio di metri quadrati sino a un paio<br />
di ettari) recinti di piccoli argini, in modo che il velo d’acqua vi possa permanere<br />
al livello voluto. L ’immissione dell’acqua avviene in primavera per mezzo di bocchette<br />
che ne regolano il lento afflusso; altre bocchette regolano il deflusso. Particolarmente<br />
importante è anche la temperatura dell’acqua e talvolta, per attenuarne<br />
la frigidezza, la si fa ristagnare о le si fa percorrere un lungo giro prima di immetterla<br />
nella risaia. E compito del camparo di curare nella risaia la temperatura, il<br />
ricambio e il livello dell’acqua ed è compito non trascurabile poiché una disatten-<br />
Fot. Fracchi<br />
ta »-^ 4 -<br />
Prato, pascolo e bosco,<br />
fondamentali risorse dell’alta<br />
montagna (San N i<br />
colò, Valfurva).<br />
334
zione può decurtare il raccolto. La semina e il trapianto avvengono, in aprile e<br />
maggio, ormai generalmente a macchina, ma per la monda è indispensabile una<br />
numerosa mano d’opera ed è per essa che tra maggio e giugno affluiscono nel Pavese<br />
e nel Milanese migliaia di mondine provenienti dal Cremonese, dal Mantovano e<br />
ancor più dal Veneto e dall’Emilia.<br />
Nella pianura a oriente del Lambro il paesaggio agrario è caratterizzato soprattutto<br />
dal frumento e dai foraggi. I rendimenti sono eccezionalmente alti e tra i<br />
maggiori dell’Italia. In alcune zone del Cremonese la media per ettaro può giungere<br />
sino al doppio di quella regionale, che pure è già notevolmente alta (33 quintali<br />
per ha.), e anche superarla. La media di 40 quintali per ettaro è in questa zona<br />
frequente, anzi quasi normale. E da notare che, ancora trent’anni or sono, la media<br />
oscillava sui 20 quintali per ettaro. Ciò indica che i risultati attuali non sono stati<br />
conseguiti per favore di natura, ma per il progresso tecnico nella lavorazione del<br />
terreno, la fertilizzazione attentamente studiata, l’impiego di varietà elette e di sementi<br />
selezionate, insomma per opera dell’uomo. Con ciò si è giunti a una produzione<br />
totale regionale di circa io milioni di quintali annui che costituiscono un decimo<br />
della produzione nazionale.<br />
Il bosco.<br />
Il bosco, che, come s’è accennato in precedenza, dominava anticamente su<br />
gran parte del territorio lombardo, è stato la grande vittima, se così si può dire,<br />
del grandioso sforzo di trasformazione compiuto dall’uomo nel territorio lombardo.<br />
Le superfici boscate nella pianura rimangono ormai soltanto nelle aree meno felici<br />
о per qualità di suolo о per minaccia di acque. Invece nella zona di montagna tali<br />
superfici, benché grandemente ridotte, si espandono ancora in misura non del tutto<br />
trascurabile. Nel complesso la <strong>Lombardia</strong> ha 448.000 ettari di boschi che equivalgono<br />
al 22% della superficie agraria-forestale. Prevalgono i boschi di latifoglie, in<br />
maggioranza cedui, che costituiscono sul totale della superficie a bosco il 64% ; in<br />
più modesta misura si estendono i boschi di resinose, che costituiscono il 25% del<br />
totale; il residuo 11% è costituito da boschi misti di piante latifoglie e resinose.<br />
La composizione stessa del patrimonio forestale esprime chiaramente la modesta<br />
importanza nel quadro economico; infatti la massa maggiore di legname tratto dai<br />
boschi lombardi è utilizzabile solo come combustibile. Tuttavia, nella povertà nazionale<br />
della produzione del legname, anche questo settore dell’economia rurale lombarda<br />
non deve essere sottovalutato.<br />
I boschi di piante resinose, che, come già s’è accennato, prosperano ad altitudini<br />
comprese tra i 1200 e i 2200 m., sono quasi esclusivi della zona propriamente<br />
alpina. Per quanto anche qui come altrove non siano mancate devastazioni e distruzioni,<br />
non mancano di apparire qua e là pendici montane rivestite dal folto man-<br />
335
Preparazione della catasta<br />
per la produzione di legna di carbone<br />
in un bosco delle Prealpi bresciane.<br />
Fot. Stagnoli<br />
tello costituito da abeti (specialmente abeti<br />
rossi) e da pini (particolarmente, in Vaitellina,<br />
pino silvestre e pino cembro), misti,<br />
ai livelli maggiori, con larici. Sono dense e<br />
profumate foreste alla cui ombra, d’autunno,<br />
nasce una notevole quantità di funghi mangerecci,<br />
che, soprattutto in Valtellina, offrono<br />
un non trascurabile raccolto e un<br />
vivace commercio. Lo sfruttamento del<br />
bosco di resinose, per gran parte di proprietà<br />
dei Comuni, è, oggi, condotto con<br />
prudenza e razionalità. I tronchi adulti vengono<br />
trasportati sul filo di teleferiche provvisorie<br />
o, più raramente, trascinati о rotolati<br />
lungo i pendil. Dopo la stagionatura,<br />
i tronchi vengono squadrati sul luogo in<br />
piccole segherie azionate dalla forza di caduta<br />
dell’acqua, о trasportati direttamente<br />
alle più grandi segherie del fondovalle principale,<br />
alle quali converge anche il legname<br />
dei boschi di latifoglie. Di particolare importanza,<br />
soprattutto ai fini della ricostituzione<br />
del mantello boschivo più utile e della<br />
risoluzione dei problemi economici della<br />
montagna, si presenta il rimboschimento.<br />
I tentativi sono molteplici e i risultati sono<br />
stati incoraggianti, non solo in ambiente alpino<br />
ma anche prealpino. Il complesso dei<br />
lavori eseguiti о in corso sembra tuttavia<br />
modesto in confronto anche alle sole necessità; a confronto con le altre regioni<br />
non si può dire che la <strong>Lombardia</strong> occupi in questo campo posizioni avanzate.<br />
Il bosco di latifoglie si estende sulle pendici meno elevate e assai raramente si<br />
tratta di bosco puro, ossia costituito da una sola specie legnosa; solo il castagno e<br />
il faggio formano, qua e là, belle macchie uniformi; ma purtroppo manca spesso la<br />
preoccupazione di conservarne l’integrità. Il ceduo soprattutto semplice è dominante;<br />
per larghi tratti esso accompagna con folte cortine i grandi fondivalle e i<br />
bacini lacustri. I tagli, quadriennali о quinquennali, offrono discrete quantità di<br />
legna da ardere che viene consumata localmente.<br />
Negli ultimi decenni in pianura ha preso notevole sviluppo la coltura dei pioppi.<br />
Essa si è diffusa specialmente lungo i corsi fluviali, in terreni minacciati da ristagni<br />
di acque, specialmente nel territorio delle province di Pavia, di Milano e di Mantova,<br />
che complessivamente assommano 9000 ettari di pioppeta.<br />
.136
L ’allevamento.<br />
Il quadro rurale della regione lombarda rimarrebbe incompleto se si trascurasse<br />
l’allevamento, che costituisce un settore economico di notevolissima importanza.<br />
« Il suo peso si manifesta con la percentuale elevata con cui i prodotti trasformati<br />
concorrono a costituire il valore totale della produzione e con i complessi legami<br />
che intercorrono tra l’allevamento zootecnico e l’azienda agraria. Sebbene vi sia un<br />
largo ricorso alla concimazione chimica, l’importanza fondamentale del bestiame<br />
permane per le laute concimazioni organiche possibili e per il miglioramento che<br />
le conseguenti colture foraggere apportano al terreno. Le elevate produzioni che si<br />
spuntano non sono disgiunte da una più che abbondante letamazione. Così, in<br />
genere e soprattutto in pianura, si può dire che i sistemi agrari intensivi siano<br />
strettamente collegati con gli allevamenti zootecnici » (G. Sonato).<br />
La consistenza del patrimonio zootecnico lombardo è rappresentata in media da<br />
circa 1.600.000 bovini, che costituiscono un primato regionale con un rapporto del 19%<br />
del totale nazionale, e da circa mezzo milione di suini, che costituiscono il 12% del<br />
totale nazionale, percentuale superata solo dall’Emilia-Romagna. Notevole è pure il<br />
numero di equini, in prevalenza cavalli per i quali ultimi la nostra regione detiene<br />
un primato regionale con oltre un quinto del totale nazionale; trascurabile invece<br />
il numero di ovini e di caprini.<br />
Il gruppo dei bovini è tra gli allevamenti quello più importante per la produzione<br />
di latte e di carni, che è fondamentale nell’economia delle aziende agricole.<br />
Vi sono fattorie di pianura in cui i prodotti dell’allevamento bovino, soprattutto del<br />
latte, concorrono per un terzo e anche più nel valore totale annuo della produzione<br />
aziendale. In genere la razza più diffusa è la bruno-alpina, ma in pianura compaiono<br />
accanto a questa con sempre maggior frequenza i capi d’importazione olandese e<br />
svizzera. Tradizionale e generale era in passato la transumanza: durante l’estate le<br />
bestie, dette bergamine, erano inviate ai pascoli alpini e il latte veniva lavorato nelle<br />
alpi. Attualmente l’agricoltura intensiva e industrializzata tende, specialmente nella<br />
pianura irrigua, alla stabulazione permanente, con conseguenze dannose per la sanità<br />
e robustezza degli animali. Per limitare tale inconveniente, dalle stalle di pianura<br />
si invia ancora negli alpeggi delle Alpi e specialmente delle Prealpi il bestiame<br />
giovane; ma gli ostacoli, costituiti dalla difficoltà e dal costo dei trasporti degli<br />
animali, dalla carenza dei ricoveri e dalla manutenzione trascurata dei pascoli dell’alpe,<br />
agiscono in modo negativo, per cui in qualche fattoria di pianura si è risolto<br />
il problema costituendo il cosiddetto pianeggio, recinto in cui il bestiame giovane<br />
vive all’aperto per diversi mesi all’anno. Nella zona di montagna l’alpeggio è insostituibile,<br />
ma anche qui si diffonde la tendenza a inviare ai pascoli alti solo il<br />
22 — Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
337
estiame giovane. Comunque il movimento conserva quasi intatte le sue caratteristiche<br />
tradizionali; in genere nella montagna lombarda esso è costituito da diverse<br />
soste tanto nella salita come nella discesa; per solito il montanaro trae fuori i bovini<br />
dal chiuso delle stalle invernali in aprile о maggio e li trasferisce nelle stalle-fienili<br />
dei prati-pascoli, che per lo più sono di sua proprietà. L ’altimetria delle stallefienili<br />
è molto varia, ma la maggior parte di esse si trova nella fascia compresa tra<br />
gli 800 e i 1300 m. nelle Prealpi e tra i 900 e i 1400 m. nelle Alpi. Qui il bestiame<br />
consuma il residuo del fieno riposto nell’annata precedente о pascola all’aperto nei<br />
giorni più tiepidi, poi, nella seconda metà di giugno, vien portato sui pascoli alti<br />
dell’alpe comunale e affidato al conduttore di essa, dietro adeguato compenso in<br />
denaro se si tratta di bestiame giovane, in prodotto se si tratta di bestiame da latte.<br />
Il soggiorno all’alpe dura da 90 a n o giorni, ossia sino a ottobre. Infine il montanaro<br />
riporta nuovamente il suo bestiame nella stalla-fienile, dove sosta sino alle<br />
prime nevi. A questo movimento stagionale il montanaro è costretto dalla scarsità<br />
dei foraggi, che costituisce una costante preoccupazione; tale scarsità può determinare,<br />
in annate di minor raccolto, anche la riduzione del numero dei capi, che<br />
si riflette particolarmente, com’è ovvio, sui capi giovani d’allevamento. Ciò non si<br />
Un grande allevamento di vacche nella pianura a marcita.<br />
La tettoia, preclusa al bestiame nella parte mediana dalla mangiatoia. La stalla è a destra.<br />
Fot. Angelo Vitali<br />
338
Fot. Angelo Vitali<br />
L ’interno della medesima tettoia della figura precedente.<br />
verifica, о almeno non si verifica in ugual misura, nella pianura ed è precisamente<br />
in questa che si annoverano i quattro quinti del patrimonio bovino della <strong>Lombardia</strong>.<br />
E in essa che si ha quindi la maggiore produzione di prodotti caseari, anche di quelli,<br />
come il formaggio Taleggio, provenienti un tempo solo dalla montagna.<br />
A ll’allevamento dei bovini è in parte collegato quello dei suini, in quanto l’alimentazione<br />
di questi si giova in larga misura dei residui della lavorazione del latte,<br />
oltre che dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali. In tal senso si può dire che<br />
la suinicoltura ha una funzione integrante dell’attività agricola. Il numero dei capi<br />
presenta un crescendo annuale sensibile, ad opera soprattutto degli allevamenti della<br />
pianura, dove si accentrano i quattro quinti del totale regionale. In genere si preferisce,<br />
alle razze pure, l’incrocio tra la razza locale nostrana e le razze inglesi.<br />
A ovviare agli inconvenienti, sia di ordine economico sia di ordine sanitario, determinati<br />
dal commercio dei capi, alcune grandi industrie casearie hanno provveduto<br />
339
Fot. Ispettorato Prov. Agricoltura<br />
I coltivi a foraggio nella pianura non vengono mai utilizzati come pascolo;<br />
questo si effettua talvolta d’autunno sui terreni ove precedentemente sono stati eseguiti i raccolti<br />
di cereali e prima dell’aratura.<br />
a istituire in proprio grandi allevamenti, giungendo poi direttamente anche alla lavorazione<br />
delle carni. Ma in genere sono le aziende agrarie che provvedono all’allevamento<br />
del maggior numero di capi: per solito esse sono provviste del porcile e<br />
nel suo recinto il numero dei suini è in ragione diretta del numero dei bovini ospitato<br />
nelle stalle. Nelle aziende di pianura se ne allevano annualmente anche alcune<br />
decine e, raggiunto il grado richiesto d’ingrassamento, si vendono poi agli incettatori<br />
delle industrie di trasformazione ; nella montagna il numero dei capi è invece modesto,<br />
per solito uno о due, poiché essi servono quasi esclusivamente alle necessità della<br />
famiglia.<br />
340
Gli equini sono rappresentati soprattutto dai cavalli (90%); nel loro complesso<br />
il numero va decrescendo di anno in anno: nel 1956 erano valutati complessivamente<br />
159.000 con una diminuzione di oltre 50.000 rispetto al 1950 e di più<br />
di 85.000 rispetto al 1930. La diminuzione è più sensibile nella pianura e ciò è<br />
in relazione al progressivo diffondersi in essa dell’uso della macchina, che sostituisce<br />
con vantaggio il cavallo. Nella collina, invece, data la morfologia del suolo<br />
il cavallo rimane ancora di grande ausilio nei lavori agricoli. Nella montagna, infine,<br />
il cavallo, e ancor più il mulo о l’asino, sono spesso insostituibili per il trasporto<br />
di persone о cose e per il lavoro dei campi. Particolarmente pregiata e tipica in<br />
Valtellina è da antica data la razza detta, dal luogo d’allevamento, Samòlaco; di più<br />
recente introduzione è l’Avelignese originaria dal Bolzanese e incrociata con la<br />
Samòlaco. Nella pianura invece prevale la razza belga d’importazione.<br />
Fot. Fagnani<br />
Bovini giovani della razza bruno-alpina all’alpeggio<br />
(Alpe Scermendone, Valtellina).<br />
341
I pascoli più elevati della montagna lombarda, disertati dai bovini,<br />
generalmente durante l’estate ospitano greggi, tuttavia non molto frequenti (Cevedale).<br />
Fot. Stefani
La pesca.<br />
La pesca nelle acque interne della <strong>Lombardia</strong> è attualmente un’attività secondaria<br />
delle popolazioni rivierasche dei laghi e dei fiumi. I veri pescatori, ossia coloro<br />
che hanno come unica attività la pesca, sono ormai poche centinaia e si trovano<br />
distribuiti lungo le sponde dei laghi. Per lo più l’attività peschereccia è praticata<br />
come complementare di un’altra attività principale, soprattutto dell’attività agricola.<br />
A ridurre notevolmente l’attività peschereccia sui laghi ha contribuito non solo<br />
lo sviluppo dell’attività industriale e dell’attività turistica, ma anche l’impoverimento<br />
della fauna ittica, dovuto forse a un eccessivo sfruttamento e soprattutto ai modi<br />
distruttivi di pesca, quale, ad esempio, quello con gli esplosivi, oggi ridotto dall’attenta<br />
sorveglianza, ma non del tutto eliminato. A soffrirne maggiormente sono stati i<br />
laghetti di montagna che potrebbero costituire sicuri vivai di trote. Questi pesci<br />
pregiati si pescano tuttavia ancora, specialmente lungo il corso dei fiumi alpini, e<br />
Fot. Stefani<br />
Pescatori nei canneti sulla sponda meridionale del lago di Garda.<br />
343
Pescatori sul laghetto di Annone.<br />
‘ ■ ■ 'Ï<br />
Fot. Stefani<br />
servono al consumo locale. Più varia e più ricca è la fauna dei laghi, che, oltre le<br />
trote, annovera lucci, agoni, coregoni, carpe, tinche, persici, alborelle, anguille, ecc.<br />
Tipico è l’uso sul lago d’Iseo e sul lago di Como di essiccare al sole dell’estate piccoli<br />
pesci, detti missoltini, che possono essere conservati a lungo. Il frutto della pesca<br />
lacustre viene per la maggior parte consumato nei centri rivieraschi. Solo le specie<br />
più pregiate giungono sui mercati delle maggiori città della pianura e specialmente<br />
a Milano.<br />
Per attenuare il progressivo impoverimento della fauna ittica si è provveduto,<br />
oltre che a stabilire norme protettive, a istituire incubatoi, ai quali è affidato il compito<br />
di provvedere all’immissione nelle acque di avannotti di specie pregiate, quali<br />
la trota e il coregone. A Fiumelatte, sul lago di Como, ha sede l’Incubatorio Marco<br />
De Marchi, il maggiore d’Italia, dipendente dal Consorzio provinciale per la tutela<br />
della pesca delle province di Como e di Sondrio. L ’azione di ripopolamento dei<br />
laghi è intensa, ma di efficacia limitata per l’inosservanza da parte dei pescatori delle<br />
norme di pesca e specialmente della disposizione che obbliga al rilascio del pesce<br />
minuto rimasto nelle reti.<br />
Nei fiumi della pianura la pesca è del tutto trascurabile. Lo smaltimento delle<br />
acque di rifiuto delle industrie è la causa fondamentale dell’impoverimento ittico<br />
dei corsi fluviali, nè pare che si possa porre riparo a tale situazione.<br />
344
C a p i t o l o<br />
U n d i c e s i m o<br />
L’ATTIVITÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE<br />
Lo sviluppo industriale.<br />
L ’industria lombarda, che attualmente, con la sua netta preponderanza nel quadro<br />
dell’attività economica (essa infatti assorbe circa la metà del totale della popolazione<br />
attiva), conferisce un’impronta distintiva alla regione, non ha origini molto remote.<br />
E bensì vero che in secoli lontani, specialmente durante la signoria dei Visconti e<br />
più ancora durante la successiva degli Sforza, Milano vantava importanti manifatture.<br />
Ma la loro efficienza si era ridotta in seguito alla situazione determinatasi con il<br />
dominio spagnolo e soprattutto con il trasferirsi del baricentro economico europeo<br />
verso le sponde atlantiche.<br />
I prodromi, dunque, del moderno sviluppo industriale si possono far risalire<br />
tutt’al più al secolo XVIII durante il quale, contemporaneamente al declino delle<br />
corporazioni d’arti e mestieri, si manifestarono i primi tentativi d’industria di tipo<br />
capitalistico, quali il lanificio per produrre tessuti « alla foggia d’Inghilterra e<br />
Olanda» dello svizzero F. Tieffen fondato nel 1703, la tessitura di peli di cammello<br />
e di capra, fondata qualche anno dopo da A. Clerici, la filatura di cotone<br />
fondata dai fratelli Rho nel 1755, la tessitura serica Pensa e Loria fondata nel 1765,<br />
con filatoi sparsi in tutta la Brianza, ecc. Erano le prime avvisaglie di una nuova èra<br />
e « uomini come il Beccaria, il Gioia, il Bellerio e il Pellegrini erano troppo perspicaci<br />
e sensibili per non avvertire (più о meno coscientemente) che pure in <strong>Lombardia</strong><br />
stava per spezzarsi un ponte col passato e che si stava per imboccare una<br />
svolta piena di incognite » (A. Sapori). Il processo tuttavia avvenne molto lentamente.<br />
Si può dire infatti che, nonostante le condizioni favorevoli all’espansione<br />
dell’attività industriale durante il dominio austriaco, l’agricoltura mantenne nell’eco-<br />
345
nomia lombarda un peso nettamente preponderante almeno sino ai primi decenni<br />
dell’unità nazionale.<br />
La preponderanza effettiva dell’attività rurale su tutte le altre forme di attività<br />
economica nei primi decenni del secolo scorso si manifestava in diversi modi e non<br />
soltanto nel ramo tessile, che traeva la materia prima esclusivamente dall’agricoltura<br />
e dall’allevamento e che era connesso per lontana tradizione con il lavoro dei campi,<br />
ma altresì nell’industria estrattiva che attualmente ci appare ben distinta dall’agricoltura<br />
e in certo senso a questa antitetica. Anzitutto strettissima era la connessione<br />
fra agricoltura e lavorazione della seta; questa veniva esercitata in tutto il territorio<br />
lombardo e particolarmente nel Bergamasco, nel Comasco, nel Milanese e nel Pavese;<br />
vi era un gran numero di minuscole filande, nelle quali si procedeva con lavoro<br />
stagionale alla trattura e alla filatura; la tessitura si eseguiva, per lo più, tra le<br />
mura domestiche e durante le pause del lavoro dei campi. Anche la lavorazione del<br />
lino e della canapa, coltivati nella pianura irrigua, era affidata alle contadine; queste<br />
non solo seminavano, coglievano, maciullavano, ma anche riducevano in matasse<br />
la fibra e la filavano a mano, con metodi imperfetti. Anche per la lana (la cui<br />
materia prima veniva in gran parte dal Veneto, dallo Stato Pontificio, dagli Abruzzi,<br />
dalla Calabria e dall’Ungheria) la filatura e la tessitura, esercitate soprattutto in<br />
vai Seriana (Gandino), erano eseguite per lo più a mano con metodi rudimentali<br />
e tradizionali. Industria in parte casalinga era pure quella del cotone, importato dall’India<br />
e dall’America. Rilevante era il numero dei telai sparsi per le case di campagna<br />
soprattutto dell’alto Milanese, ove si può dire non vi fosse abitazione di<br />
contadini senza almeno un telaio.<br />
Anche l’industria del ferro non aveva superato gran che le condizioni di lavorazione<br />
caratteristiche del Medioevo. Non solo le miniere erano eccessivamente<br />
frazionate e su alcune pesava il diritto di comproprietà, a volte ripartito tra moltissimi<br />
proprietari, ma l’estrazione del ferro era esercitata in modo primitivo. Mancando<br />
infatti una classe specializzata, erano gli stessi contadini che nei periodi di<br />
sosta dei lavori di campagna si improvvisavano minatori, scavando il materiale in<br />
gallerie assolutamente inadatte e, talvolta, pericolose. Anche i forni producevano<br />
a periodi, spesso soltanto per dare quel tanto di materiale da lavoro al proprietario<br />
per i bisogni della sua modesta industria. Le valli bergamasche, che, con il Lecchese,<br />
erano le più progredite nell’industria del ferro, contavano nel 1851 appena sei forni<br />
attivi per tutto l’anno, uno riposava tre mesi, altri due riposavano otto, un altro sei.<br />
I lavori di prima fusione presentavano gravi inconvenienti soprattutto per l’imperfezione<br />
con la quale erano costruiti i forni, a sezione quadrata, detti « alla bergamasca<br />
», che impedivano l’accentramento del calore necessario alla fusione di alcuni<br />
tipi di minerale.<br />
La connessione e subordinazione di ogni attività economica all’agricoltura era<br />
evidente « anche nell’industria della concia delle pelli, che era affidata ai contadini<br />
e fatta nelle case di campagna; nella massima parte delle fabbriche di carta, preparata<br />
per lo più con metodi e con attrezzi antiquati; nelle maioliche, lavorate<br />
346
Antica fucina di lavorazione del<br />
ferro in Valcamònica (Bienno).<br />
Fot. Magnolini<br />
nelle 32 fabbriche lombarde, pesanti, permeabili, male verniciate e assai poco resistenti<br />
al fuoco, la cui fabbricazione si limitava a produrre solo oggetti di uso domestico<br />
e grossolani, essendo ignoti i processi tecnici di mescolanza delle varie argille,<br />
della mineralogia e della chimica; nella produzione dei mattoni, che venivano stentatamente<br />
lavorati a mano dai contadini, essendo del tutto sconosciute le macchine<br />
già da decenni in uso nell’Olanda, nella Francia e nell’Inghilterra » (R. Ciasca).<br />
Ma in questa situazione generale si venivano manifestando, sin dai primi decenni<br />
del secolo XIX, convinte aspirazioni verso forme più moderne di industria, quali<br />
erano già in atto oltralpe, e verso i primi tentativi di impianti propriamente industriali,<br />
i quali, per quanto isolati, possono ben essere considerati i prodromi dell’industria<br />
attuale e i sintomi delle condizioni favorevoli dell’ambiente naturale,<br />
antropico ed economico, che costituiranno la ragione del successo dell’organizzazione<br />
industriale lombarda.<br />
Sotto questo aspetto una posizione d’avanguardia ebbe il ramo serico. Dopo la<br />
restaurazione austriaca con il miglioramento della tecnica agraria e con l’aumentata<br />
richiesta di tessuti serici del mercato viennese, si potè incrementare la coltivazione<br />
del gelso, soprattutto nella zona collinare, e in proporzione accrescere l’allevamento<br />
dei bachi. Si calcola che la produzione dei bozzoli da 6 milioni circa all’inizio del<br />
secolo, raggiungesse un quantitativo quasi quadruplo negli anni che precedettero<br />
la crisi del 1848. Tale aumento fu un incentivo verso un progressivo, per quanto<br />
347
Veduta aerea di Busto Arsizio, centro di grandi industrie del cotone.<br />
Fot. Fotocielo<br />
tutt’altro che rapido, miglioramento della tecnica di lavorazione. Nella trattura, pur<br />
lamentando sempre la prevalenza di bacinelle a fuoco diretto, si verificò una loro<br />
maggiore concentrazione in laboratori, e, come fatto fondamentale nella storia della<br />
lavorazione della seta, si ricorda la prima filanda a vapore sorta nel 1815 ad opera<br />
del conte Porro Lambertenghi presso Como. Nel processo di filatura notevole vantaggio<br />
derivò dall’adozione di torcitoi a movimento più regolare e veloce, cui concorsero<br />
cospicui investimenti anche da parte svizzera, e forse tal fatto non fu estraneo<br />
al consolidarsi di tale industria nel triangolo Como, Milano, Bergamo. La tessitura<br />
si veniva decisamente concentrando a Milano e Como dove alcune grandi fabbriche<br />
tendevano a produrre tessuti di qualità che potessero fare concorrenza alle sete di<br />
Lione; esse sole disponevano di telai Jacquard ben altrimenti redditizi di quelli a<br />
mano generalmente diffusi. Ma nel 1856 i 700 Jacquard milanesi e i 130 comaschi<br />
rappresentavano ancora ben poca cosa in confronto dei più di 4000 telai a mano<br />
diffusi nella campagna.<br />
348
Verso il 1830 iniziò un rapido sviluppo anche l’industria del cotone, che andò<br />
concentrandosi lungo le sponde dell’Olona; «se ne videro le lunghe e placide rive<br />
animarsi con un numero infinito di ruote, che mettevano in moto meccanismi per<br />
la filatura del cotone, e convertirsi in opifici modeste case di contadini nei distretti<br />
di Busto e di Gallarate. Persino le miti acque del Lambro furono utilizzate, e<br />
Monza' trovò una nuova sorgente di guadagno. Mentre decadeva l’industria della<br />
lana, aumentava il numero dei cotonifici; e una massa considerevole di operai, che<br />
attendeva ad altri lavori (e, tra i contadini, non pochi giornalieri), passarono a filare<br />
il cotone » (R. Ciasca). Verso la metà del secolo erano già in funzione 33 grandi<br />
filande, nelle quali trovavano lavoro circa 4000 addetti (S. Frattini).<br />
Dopo il 1840, con un certo ritardo rispetto a quella cotoniera, ma in compenso<br />
con una dotazione di attrezzature più perfezionate, prese sviluppo anche l’industria<br />
del lino: precedette la fabbrica di Villa d’Almè sul Brembo cui seguirono poco<br />
appresso quelle di Cassano sull’Adda e di Melegnano sul Lambro.<br />
Progressi più о meno rapidi si ebbero anche al di fuori del ramo tessile. Particolarmente<br />
notevoli furono quelli dell’industria siderurgica il cui passo più notevole<br />
Fot. Pirelli<br />
Stabilimenti Pirelli alla Bicocca (Milano).<br />
349
fu compiuto con la sostituzione dei forni tradizionali con altri a pianta circolare<br />
avvenuta nel 1844 in Valsàssina e negli anni seguenti nelle valli bergamasche. Nello<br />
stesso periodo presero sviluppo gli stabilimenti che producevano fili di ferro e chiodi<br />
a Lecco e sorsero a Milano i primi impianti meccanici (è del 1846 la fondazione<br />
dell’Elvetica) per la produzione di torchi, di attrezzi agricoli, di macchine per la<br />
carta, di macchine a vapore, e soprattutto si vennero affacciando le prime industrie<br />
per la produzione di materiale ferroviario. Un avviamento all’organizzazione industriale<br />
moderna assumevano anche le manifatture di ceramiche Richard e le cartiere<br />
di Brescia e Vaprio d’Adda. E ovvio però che « l’esistenza nei principali rami<br />
dell’industria di qualche grande opificio, se potè rappresentare una tendenza molto<br />
importante e significativa, non contraddiceva al carattere fondamentale dell’economia<br />
lombarda, la quale non era ancora uscita dallo stadio che aveva predominato nell’Europa<br />
d’occidente fino all’introduzione della macchina a vapore: di una economia<br />
cioè, in cui l’industria manifatturiera era ormai molto diffusa in città e in campagna<br />
e costituiva un prezioso complemento dell’industria agraria, ma era frazionata in<br />
medi e minuscoli esercizi con impiego scarsissimo di macchine e di capitali e senza<br />
che vi fosse una netta distinzione tra il lavoro dei campi e il lavoro industriale »<br />
(G. Luzzatto).<br />
Compiutasi l’unità d’Italia, dopo alcuni anni di necessario assestamento dovuto<br />
alla mutata situazione politica, si venne pian piano intensificando il richiamo di<br />
capitali verso ardite imprese industriali, alcune già in efficienza e protese verso nuovi<br />
sviluppi, altre appena nate e destinate, sia per la capacità degli uomini, sia per il<br />
favore dell’ambiente e del momento, a grande avvenire; tali per es.; la Pirelli di<br />
Milano, la Tosi di Legnano, il Linificio Nazionale, ecc. Le «anonime» si costituirono<br />
in sempre maggior numero; così mentre nel decennio tra il i860 e il 1870<br />
se n’erano formate dieci in tutta la <strong>Lombardia</strong> (con capitali per complessivi<br />
17 milioni), nel decennio seguente se ne costituirono trenta (con capitali per complessivi<br />
69 milioni) tra le quali la Società delle Ferrovie Nord, e a queste, prima<br />
della fine del secolo, se ne aggiunsero una settantina (con capitali per complessivi<br />
262 milioni).<br />
Dopo il 1880 diverse circostanze favorevoli, come la grande Esposizione internazionale<br />
di Milano (1881), l’apertura della ferrovia del Gottardo (1882), l’abolizione<br />
del corso forzoso (1882), oltre a migliorare la situazione generale dell’economia industriale,<br />
provocarono la spinta a nuove iniziative e a nuovi sviluppi; particolarmente<br />
notevole in quegli anni fu la costituzione della Società Edison (1884), cui si devono<br />
le prime realizzazioni nel campo idroelettrico. Ormai l’industria lombarda, benché<br />
ancor lontana dal grado di sviluppo, di organizzazione e di concentrazione raggiunto<br />
in altre regioni europee, nella Gran Bretagna, nella Germania e nella Francia, aveva<br />
preso un avvìo sicuro e soprattutto costituito basi solide. Di anno in anno nuove<br />
iniziative e nuovi impianti si aggiungevano a quelli già esistenti ; i quali, a loro volta,<br />
progredivano verso ulteriori sviluppi. L ’alta pianura lombarda e soprattutto l’alto<br />
Milanese andavano lentamente cangiando volto, ossia perdendo l’aspetto connesso<br />
350
a una prevalente ruralità per acquisire quello impresso dalla industrializzazione che<br />
diverrà poi prevalente. Progresso e trasformazione, tuttavia, avvennero non senza<br />
sussulti, che, comunque, non ebbero potere di provocarne l’arresto; difatti, anche<br />
durante la crisi del 1887, l’industria lombarda compì nuovi passi. Ma il periodo<br />
della maggior crescita si manifestò all’indomani della crisi e raggiunse il suo acme<br />
Fot. Fotocielo<br />
Impianti industriali alla periferia di Saronno, nell’alta pianura milanese.<br />
351
tra il 1898 e la vigilia della prima guerra mondiale, anche per le sopravvenute possibilità<br />
di impiego di una nuova forza motrice, l’energia elettrica, la cui prima centrale<br />
sorse a Paderno sulle sponde dell’Adda nel 1898, seguita, dopo pochi anni,<br />
da una serie di altre centrali dislocate nella zona montana.<br />
La prima guerra mondiale, nonostante la gravità dei problemi suscitati, agì come<br />
sprone e come collaudo dell’industria lombarda. Particolare sviluppo assunsero le<br />
industrie metallurgiche e meccaniche che manifestarono anche la tendenza a grandiosi<br />
sviluppi con la concentrazione di grandi capitali. Si calcola che dei 277.370 operai<br />
che alla data dell’armistizio lavoravano sotto la vigilanza del Comitato lombardo<br />
di Mobilitazione industriale, il 48% fosse impiegato nelle industrie meccaniche e<br />
il 17% nelle industrie siderurgiche. L ’armistizio tuttavia ebbe come risultato il crollo<br />
finanziario delle industrie meno robuste; nè la crisi del dopoguerra si abbattè solo<br />
sul ramo siderurgico e meccanico; qual più qual meno, tutti i settori industriali<br />
subirono una difficile fase di trapasso, segnata da dissesti e da disoccupazione, che<br />
toccò il suo vertice nel 1920-21. Ma l’industria lombarda era ormai troppo solida<br />
per non riprendersi rapidamente. Gli anni dal 1925 alla seconda guerra mondiale<br />
segnarono un ulteriore sviluppo (rallentato solo temporaneamente dalla crisi del 1930)<br />
di quasi tutti i settori industriali, che si arricchirono di nuove e moderne attrezzature.<br />
Gli anni che precedettero la seconda guerra mondiale videro la <strong>Lombardia</strong><br />
raggiungere un livello industriale non inferiore a quello delle maggiori concentrazioni<br />
europee; «circa un quarto degli esercizi con forza motrice, un terzo degli<br />
individui ad essi addetti, oltre un quarto della potenza utilizzabile, in cavalli vapore,<br />
di tutta Italia, si concentravano infatti nella regione alla data dell’ultimo censimento<br />
industriale prebellico. Il Piemonte, che dopo la <strong>Lombardia</strong> presenta tra le regioni<br />
nostre i rapporti più elevati, la seguiva solo a notevole distanza » (F. Milone).<br />
Tanta capacità produttiva si esprimeva annualmente nella grandiosa rassegna della<br />
Fiera campionaria di Milano (tenutasi, la prima volta, nel 1920) che richiamava<br />
l’attenzione di tutta l’Europa. La seconda guerra mondiale costrinse l’industria ad<br />
uno sforzo produttivo notevole in condizioni precarie. Ma nonostante il logoramento<br />
e le distruzioni l’industria ebbe nel dopoguerra una meravigliosa e rapida ripresa<br />
in tutti i settori, sicché nel giro di pochi anni la capacità produttiva potè raggiungere<br />
e superare sensibilmente quella del 1938.<br />
Attualmente lo sviluppo industriale della <strong>Lombardia</strong> si presenta davvero imponente.<br />
Al censimento del 1951 le imprese, in numero di oltre 1 12.000, costituivano<br />
il 17% del totale nazionale, e, se varianti vi sono state, si devono ritenere in<br />
aumento, non in diminuzione. Gli addetti poi a tali industrie, circa un milione<br />
e mezzo, costituivano quasi un terzo del totale nazionale. La provincia di Milano<br />
vantava, essa sola, i due quinti delle imprese e il 45% degli addetti di tutta la Lom <br />
bardia. Rispetto al numero di addetti, a Milano seguivano nell’ordine, Varese, Como,<br />
Bergamo, Brescia e, distanziate, Pavia, Cremona, Mantova e Sondrio.<br />
Già questi semplici cenni distributivi degli addetti per provincia manifestano<br />
evidente la prevalenza del raggruppamento delle industrie nel territorio milanese.<br />
352
varesino, comasco, bergamasco e bresciano. In realtà, per quanto non in senso assoluto,<br />
il concentramento delle industrie in <strong>Lombardia</strong> si manifesta nell’alta pianura<br />
e nelle colline, e cioè quasi in un triangolo che ha per lato minore il Verbano e il<br />
Ticino da Laveno a Magenta, e per lati maggiori, a nord la linea pedemontana e<br />
a sud il limite dell’alta pianura, con punto d’incontro in corrispondenza di Desenzano.<br />
Al di fuori di questa area non mancano certamente oasi industriali (come<br />
Pavia, Vigevano, Lodi, Codogno) ma manca quella concentrazione e quella varietà<br />
che si riscontra nel triangolo suddetto. La montagna e la bassa, per quanto riguarda<br />
le industrie, conservano loro distinte caratteristiche prevalenti, costituite per l’area<br />
della montagna da un imponente complesso di impianti idroelettrici, per l’area della<br />
bassa da numerose imprese alimentari, molitorie e casearie in particolare.<br />
L ’industria estrattiva.<br />
Tra i fattori dello sviluppo industriale della <strong>Lombardia</strong> non si può certo annoverare<br />
quello che per altre regioni industriali è stato fondamentale, ossia la presenza<br />
e l’abbondanza delle materie prime. Se si esclude infatti il metano, che è tuttavia<br />
di estrazione recente, la nostra regione ha, in questo campo, assai modeste risorse.<br />
Se in ordine cronologico hanno avuto una maggiore importanza le miniere di minerali<br />
ferrosi, che nelle valli prealpine hanno dato vita a un’antica tradizione di lavorazione,<br />
in ordine d’importanza economica hanno attualmente un peso maggiore le<br />
cave di materiali edilizi quali quelli cementanti, quelli per laterizi e le pietre naturali.<br />
Le pietre naturali cavate in <strong>Lombardia</strong> sono varie e di discreto pregio; esse<br />
provengono ovviamente dalla zona alpina e prealpina. La prima offre prevalentemente<br />
pietre cristalline quali il serizzo ghiandone, granito a grossi cristalli di ortoclasio,<br />
di cui esistono cave ad Ardenno in Valtellina e in vai Màsino. Un altro granito a<br />
cristalli più minuti e di colore più chiaro, detto di San Fedelino, proviene dalle<br />
cave che s’aprono presso la località che dà il nome alla pietra, sulle sponde del<br />
lago di Mezzola in vai Chiavenna. Tipi simili si trovano però anche presso Grosio,<br />
Tirano, Sondalo in Valtellina. In maggior misura si cava il serpentino, dal bel colore<br />
verde intenso; varie sono le cave a Caspoggio, a Chiesa, a Lanzada, a Torre<br />
Santa Maria, tutte in vai Malenco. E qui che si ricavano anche le ardesie, che servono<br />
in valle e anche altrove come copertura dei tetti, e la pietra oliare (o pietra da<br />
pentole) non impiegata nell’edilizia, ma per tipica produzione locale di vasi, piatti<br />
e oggetti ornamentali.<br />
Numerose sono le cave di pietre calcari. Notevole è il marmo saccaroide di Botticino,<br />
compatto, resistente, dai colori delicati. Oltre che a Botticino, ci sono cave<br />
a Marzano, Rezzato, Virle Treponti, Nuvolera e Serie, tutte nel Bresciano; ma ad<br />
ogni località corrisponde una varietà particolare per tinta e venatura. Discretamente<br />
23 — L e R e g io n i d ’I t a lia - L o m b a rd ia .<br />
353
Cava di pietra presso Capodiponte (Valcamònica).<br />
Fot. Magnolini<br />
apprezzato è anche il marmo saccaroide detto Bianco di Musso, dalla località sul<br />
lago di Como dove viene estratto ; è omogeneo, resistente e atto anche alla scultura ;<br />
con esso fu infatti costruito il Duomo di Como. Meno utilizzati sono il marmo nero<br />
di Varenna (detto anche « grand’antico d’Italia ») che si cava sul lago di Como, il<br />
calcare rosato e giallo di Angera sul Lago Maggiore un po’ simile al travertino, il<br />
calcare chiaro di Saltrio, detto appunto pietra di Saltrio, località della Prealpi varesine,<br />
il venato d’Abbazia (Albino), l’ambrato di Gandino, il nero ebano di Endine, ecc.,<br />
nelle valli bergamasche. Discretamente utilizzati sono alcuni conglomerati e alcune<br />
brecce; tra i primi più noto è il ceppo (che si distingue in rustico, mediano e gentile<br />
secondo la grossezza degli elementi) che vanta costruzioni come Palazzo Marino<br />
a Milano, tra le seconde la Breccia Aurora con colorazione policroma. Il ceppo si<br />
trae da diverse cave del Bergamasco e specialmente a Brembate, alla confluenza del<br />
Brembo nell’Adda, a Castro sul lago d’Iseo (Ceppo di Grè) e presso Trescore Balneario<br />
in vai Cavallina. La Breccia Aurora ha le sue cave nel Bresciano e in particolare<br />
a Virle Treponti, Nuvolento, Prevalle Gavardo, Vezza d’Oglio. Altro prodotto<br />
utilizzato largamente per l’edilizia è l’argilla, da cui si ricavano i laterizi.<br />
Numerosi giacimenti, quale più quale meno sfruttato, a volte anche da tempi<br />
lontani, si trovano nell’area della collina e dei pianalti, specialmente nel tratto<br />
compreso tra il Ticino e l’Oglio, e nell’Oltrepò pavese. Rari sono invece lungo i<br />
fondivalle montani e nella bassa; qui, tuttavia, qualche maggior frequenza si veriflca<br />
lungo il corso del Po nel Mantovano. Le fabbriche sono numerose e sorgono<br />
nel luogo stesso dei giacimenti d’argilla; alcune hanno importanza soltanto locale.<br />
354
altre regionale. Ma nel complesso la produzione lombarda non è sufficiente a coprire<br />
il fabbisogno dell’edilizia.<br />
L ’industria dei materiali cementanti, legata agli affioramenti di calcari, di marne<br />
e di gessi, è diffusa in tutta la fascia marginale delle Prealpi; ma, in particolare per<br />
il cemento, il Bergamasco rappresenta la zona di maggiore concentrazione e di<br />
maggiore sviluppo. Albino, Almè, Alzano Lombardo, Calusco, Cisano, Olmo al<br />
Brembo, San Giovanni in Bianco, Villa di Serio e Tavèrnola Bergamasca sono sede<br />
di notevoli cementerio (numerose delle quali della Italcementi). Notevoli sono pure<br />
gli impianti di Cassago, Merone e Missaglia in Brianza (Como), e quelli di Broni,<br />
Stradella, Voghera nell’Oltrepò pavese.<br />
Fot. Sef<br />
Industria del cemento al margine delle Prealpi bresciane.<br />
355
I giacimenti di minerali di ferro, ai quali vanno collegate le origini dell’industria<br />
siderurgica lombarda, sono numerosi; parecchi di essi, già sfruttati nei secoli passati,<br />
sono abbandonati perchè esauriti о per il tenore troppo basso del metallo. Altri<br />
invece, specie nelle Prealpi bergamasche e bresciane, sono razionalmente sfruttati<br />
e i minerali estratti vengono impiegati negli stabilimenti siderurgici regionali e in<br />
parte giungono anche agli altiforni di Cornigliano (Genova). La zona mineraria<br />
attualmente più importante delle Prealpi bergamasche è quella della vai di Scalve,<br />
che conta numerose miniere (Barisella, Ortasolo, Spiazzo, Sopracroce, Pezzolo,<br />
Meraldo, Santa Barbara, Stendada, ecc.) dalle quali si ricavano siderite e soprattutto<br />
ossidi di ferro. La potenzialità complessiva delle miniere della vai di Scalve<br />
e adiacenze è calcolata in 2-І-5 milioni di tonnellate di buoni materiali. Numerose<br />
sono le miniere delle Prealpi bresciane. Notevoli in particolare quelle di Ossi,<br />
Fusio, Serradino, Rizzolo e Terzana Alta, nella vai Trobiolo che confluisce a Pisogne<br />
sul lago d’Iseo; da esse si trae siderite compatta, con discreto tenore di ferro e<br />
di manganese. Molto simile è il minerale estratto dalle miniere della vai Trompia<br />
che s’aprono tutte nel grande giacimento che da Pezzaze prosegue lungo il fondovalle<br />
verso Colilo e il passo di Maniva e, oltre, sino a Bagolino. La zona più proficua<br />
è quella tra Pezzaze e Bovegno, dove vi sono le miniere maggiori denominate Stese,<br />
Regina, Perpetua, Bandiera e Pinotto.<br />
Tra i minerali metalliferi discreta importanza assumono i giacimenti di calamina<br />
e di blenda della vai Seriana. Alcuni affioramenti, conosciuti sin dall’antichità,<br />
furono per certo sfruttati nel Medioevo. Lo sfruttamento su scala industriale ebbe<br />
inizio nel i860. Le miniere, attualmente più proficue si trovano nel territorio di<br />
Parre, Gomo, Prèmolo e Oneta; complessivamente esse danno il 7,5% della produzione<br />
nazionale di minerale, che viene lavorato nel nuovo impianto di Nossa.<br />
Tra i minerali non metallici si trovano nella zona alpina e prealpina la fluorina,<br />
l’amianto, il talco, la baritina e il feldspato. Le cave di fluorina più notevoli si trovano<br />
in vai Brembana e in vai Trompia. L ’amianto e il talco si ricavano da piccole<br />
vene incluse nel serpentino della vai Malenco; la baritina ha discreti giacimenti in<br />
Valsàssina; il feldspato proviene dalla montagna comasca.<br />
Nel campo dei combustibili solidi la produzione è insignificante. Si possono<br />
segnalare, più per interesse geologico che economico, i piccoli depositi torbosi nell’àmbito<br />
degli anfiteatri morenici; essi, tuttavia, sono scarsamente coltivati e solo<br />
per utilizzazione locale. Di crescente importanza è invece la produzione di idrocarburi<br />
gassosi, i cui giacimenti furono individuati nel sottosuolo lombardo nel<br />
1944 a conclusione di un ventennio di ricerche condotte dall’A. G. I. P. In ordine<br />
di tempo le prime trivellazioni suscettibili di larga produttività furono quelle nei<br />
pressi di Caviaga a sud di Lodi; nel 1949 entrarono in funzione quelle di Ripalta<br />
Cremasca, a sud di Crema; a queste si aggiunse nel 1950 la produzione di Cornegliano<br />
Laúdense a occidente di Lodi ; da ultimo furono scoperti altri campi metaniferi<br />
a Bordolano (1951), a Piadena Sergnano e Soresina (1954) in provincia di Cremona.<br />
L ’estrazione del gas ha avuto un crescendo rapidissimo: a dieci anni dall’inizio dello<br />
356
Il metanodotto Cremona-Busto Arsizio al superamento di un canale.<br />
Fot. Publifoto
Metanodotti<br />
La rete dei metanodotti.<br />
Utet<br />
sfruttamento, la produzione annua lombarda, calcolata in circa due miliardi di metri<br />
cubi, costituiva la metà della produzione nazionale. I giacimenti lombardi accertati<br />
pare possano avere una capacità d’erogazione di poco meno di otto milioni di metri<br />
cubi al giorno per una durata di una ventina d’anni. Ma non par dubbio che<br />
riserve non ancora raggiunte possano celarsi nella profondità del sottosuolo. L ’estrazione<br />
avviene attualmente per eruzione naturale sufficiente a permettere il trasporto,<br />
senza necessità di compressione, attraverso metanodotti. Una rete proveniente dai<br />
pozzi lombardi, con rinforzo di quelli di Cortemaggiore (Piacenza), irradia verso<br />
tutti i centri principali della <strong>Lombardia</strong>, che assorbono circa i due terzi della produzione<br />
nazionale. Dell’imponenza e dell’importanza dell’erogazione è espressione<br />
Metanopoli, la città del metano, fondata nel 1951 e sorta in breve volgere di tempo<br />
lungo la via Emilia in prossimità di San Donato Milanese, alle porte di Milano.<br />
In essa, che già si estende per una superficie pari al Principato di Monaco<br />
(kmq. 1,5), hanno sede i centri di studi e di ricerche, gli uffici' amministrativi e<br />
358
i quartieri residenziali, dotati di tutto quanto esige una comunità destinata ad<br />
ospitare alcune migliaia di individui.<br />
La parte maggiore del metano è utilizzata dall’industria manifatturiera e particolarmente<br />
dall’industria tessile, dall’industria metallurgica e dall’industria chimica;<br />
notevole è pure il consumo per la produzione di energia elettrica; non trascurabile<br />
è l’utilizzazione come combustibile per usi domestici. Nelle reti di distribuzione di<br />
alcuni centri come Como, Lodi, Melzo, Brugherio, Cusano Milanino, ecc., in luogo<br />
del gas di carbone è stato immesso il metano. Anche Milano integra la produzione<br />
di gas di carbone con metano.<br />
Purtroppo alla emissione di metano non si accompagna, come spesso avviene, il<br />
petrolio. Questo è tutto di importazione e per agevolarne l’afflusso vi sono oleodotti<br />
che portano il combustibile da Genova alle raffinerie di Rho e di Cremona e<br />
da Marghera alle raffinerie di Mantova.<br />
Fot. Aldo Ballo<br />
Veduta parziale di Metanopoli,<br />
sede, tra l’altro, di una grande centrale termoelettrica.<br />
359
L ’industria idroelettrica e termoelettrica.<br />
Senza alcuna incertezza si può affermare che il grande sviluppo industriale lombardo,<br />
verificatosi a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, fu reso possibile<br />
dall’introduzione dell’energia elettrica. Gli inizi della sua produzione segnano quindi<br />
una data fondamentale nella storia dell’economia della regione. Il merito dell’iniziativa<br />
risale all’ingegnere Giuseppe Colombo, docente del Politecnico di Milano,<br />
che nel 1882 promosse un « Comitato per le applicazioni dell’elettricità sistema<br />
Edison, in Italia» ad opera del quale nel 1883 fu posta in opera, nell’antico teatro<br />
di Santa Redegonda in Milano, una centrale elettrica con macchinario ideato e<br />
costruito da T. A. Edison; essa rappresentò in ordine di tempo la prima centrale<br />
europea e la seconda nel mondo dopo quella di Pearl Street a New York. Nell’anno<br />
successivo il Comitato si trasformò in « Società generale italiana di elettricità, sistema<br />
Edison, anonima per azioni », dando così vita alla « Edison » che ha rappresentato<br />
una delle imprese più notevoli della <strong>Lombardia</strong> e dell’Italia. Sull’esempio si costituirono<br />
altre società che costruirono diverse centrali termoelettriche situate tutte<br />
in prossimità dei centri di consumo, per l’ostacolo frapposto dal trasporto dell’energia<br />
a distanza. I progressi furono però rapidi; memorabili rimangono i primi esperimenti<br />
di trazione elettrica effettuati nel 1893 a Milano, che diedero origine alle<br />
Fot. Meli<br />
Il Lago del Diavolo<br />
(2141 m.)<br />
nell’ alta vai<br />
Brembana, sbarrato<br />
da una diga<br />
per aumentarne<br />
la capienza e utilizzarne<br />
le acque<br />
a scopi idroelettrici.<br />
360
Fot. Azienda Elettrica Municipale<br />
I grandiosi bacini idroelettrici di Cancano II<br />
e di San Giacomo (2000 m. circa) nell’alta Valtellina,<br />
prime tramvie urbane tra Milano e Musocco e tra Varese e la Prima Cappella del<br />
Sacro Monte, entrate in funzione nel 1895. Nel 1896 si costruì a Milano una centrale<br />
termica di oltre 2000 kW e nel 1898 si costruì la centrale di Paderno sull’Adda,<br />
che, con i suoi 10.000 kW installati, rappresentò la più potente centrale idroelettrica<br />
europea del momento; essa poi, per il suo collegamento con Milano per mezzo<br />
di una linea trifase di 32 km. alla tensione di 13,5 kW, costituì per il tempo un’impresa<br />
di eccezionale ardimento. Questi riusciti esperimenti diedero audacia per<br />
nuove e più potenti imprese, ma già in quell’anno la <strong>Lombardia</strong> con una potenza<br />
complessiva installata di 26.000 kW, per circa un terzo termica e per due terzi idroelettrica<br />
si poneva, oltre che in riconosciuta posizione d’avanguardia nella tecnica,<br />
anche in posizione di superiorità produttiva rispetto alle altre regioni italiane, ciò<br />
che di per sè costituiva uno stimolo allo sviluppo delle sue industrie.<br />
Superato l’ostacolo della distanza, impianti sempre più grandiosi vennero costruiti<br />
nell’àmbito alpino e prealpino. « La potenza installata in <strong>Lombardia</strong> si quintuplica<br />
361
I principali impianti idroelettrici<br />
negli alti bacini dell’Adda e dell’Oglio.<br />
Utet<br />
dal 1898 al 1908; si triplica ancora nei dieci anni successivi; si triplica nuovamente о<br />
press’a poco negli altri dieci anni dal 1918 al 1928; ma da quella data i progressi sono<br />
più modesti, sempre tenendosi, tuttavia, intorno a un quarto della potenza installata<br />
in tutta Italia» (F. Milone). Naturalmente con lo sfruttamento della forza di caduta<br />
delle acque, largamente disponibili nell’àmbito montano, gli impianti termoelettrici<br />
divennero un’esigua minoranza, sicché la loro potenza si ridusse sino aH’ ii% del<br />
totale; solamente dopo la scoperta dei giacimenti metaniferi lo sviluppo delle centrali<br />
termoelettriche ebbe una ripresa sensibile. Nel 1956 la potenza complessiva installata<br />
con motori primari nelle 659 centrali di <strong>Lombardia</strong> ascendeva a 2.625.000 kW,<br />
che rappresentavano circa un quinto del totale nazionale; la potenza prodotta dalle<br />
482 centrali idroelettriche costituiva l’84%, la potenza delle 177 centrali termoelettriche<br />
il 16% . La capacità produttiva del complesso totale degli impianti elettrici<br />
lombardi nel 1956 era di poco superiore agli 8 miliardi di kWh che, per quanto<br />
rappresentasse un quinto del totale nazionale, risultava inferiore al consumo regionale.<br />
362
Fot. Aragozzini<br />
Condotta forzata e centrale elettrica in costruzione presso Lanzada (vai Malenco).
Al Censimento del 1951 le imprese elettriche lombarde assommavano a 370 (16%<br />
del totale nazionale); le più (235) imprese elettrocommerciali. Vi erano poi grandi<br />
industrie manifatturiere (134) con produzione in proprio e un’azienda municipalizzata,<br />
l’Azienda elettrica milanese. « Fra le imprese elettriche costruttrici di impianti<br />
situati in <strong>Lombardia</strong> sono soprattutto da ricordare la Società Edison di<br />
Milano ed alcune delle sue consociate (Orobia, Elettrica, Bresciana, ecc.) e la Vizzola,<br />
pure di Milano (ma appartenente al gruppo S. I. P.). In provincia di Sondrio<br />
e precisamente sull’Adda a monte di Tirano ha notevoli impianti l’Azienda elettrica<br />
municipale di Milano che alimenta il territorio del Comune di Milano promiscuamente<br />
con la Società Edison. Inoltre numerose imprese dell’industria manifatturiera,<br />
particolarmente quelle siderurgiche (Acciaierie e Ferriere lombarde Falck, C. Tassara,<br />
Stabilimenti siderurgici Uva, ecc.), quelle tessili (Linificio e Canapificio nazionale. Cotonificio<br />
Cantoni, De Angeli Frua, ecc.) e altre (Italcementi, ecc.) producono energia<br />
elettrica con propri impianti di generazione situati in <strong>Lombardia</strong>» (C. R. d. PP. LL.).<br />
Particolarmente sfruttate per la produzione idroelettrica sono le acque dei bacini<br />
dell’Adda e dell’Oglio, minore contributo recano le acque degli altri fiumi. I serbatoi<br />
si contano a centinaia; alcuni sono imponenti; tiene il primato di capacità quello di<br />
Cancano in alta Valtellina, con un invaso di 240 milioni di metri cubi. Globalmente<br />
l’energia accumulabile nei serbatoi si calcola in poco meno di un miliardo di kWh<br />
cioè circa un ottavo della energia producibile nella regione.<br />
Le centrali idroelettriche maggiori, ossia quelle aventi una potenza superiore о<br />
oscillante sui 50.000 kW di potenza, sono parecchie. Notevoli la centrale di Premadio<br />
(300.000 kW), alimentata dal serbatoio di Cancano, e, pure in Valtellina, le<br />
centrali di Fraele, del Bràulio, di Lòvero, di Grosotto, di Stazzona, di Belviso, del<br />
Venina, di Sondrio; nelle valli di Chiavenna le centrali San Francesco (160.000 kW)<br />
a Mese, della Mera, di San Bernardo a Isolato; nella valle dell’Oglio di Cividate,<br />
di Gedégolo, di Isola, di Sònico e di Temù; nella valle del Brembo le centrali di<br />
Carona, di Bordogna e di San Pietro; nella valle del Serio la centrale di Dossi; nella<br />
valle del Chiese la centrale di Vobarno. E non sono tutte. Si può dire che non vi<br />
è più bacino montano le cui acque vadano del tutto inutilizzate; si calcola, infatti,<br />
che le disponibilità idrauliche ancora suscettibili di sfruttamento siano ormai ridotte<br />
a un’entità assai modesta; ciò che rende economicamente conveniente (anche per<br />
la disponibilità di metano) il ricorso alla produzione di energia termoelettrica. Circa<br />
i due terzi della potenza installata delle centrali termoelettriche si concentrano in<br />
tre centrali: in quella maggiore di Tavazzano, alimentata dal metano, e in quelle<br />
minori di Castellanza e di Turbigo, pure allacciate di recente alla rete di<br />
metanodotti.<br />
La rete di trasporto ad alta tensione si stende dalle centrali verso la pianura<br />
superando con opere audaci montagne e valli; essa nell’àmbito del territorio lombardo<br />
misura oltre 4000 km., ossia circa un quinto del totale nazionale. La pianura<br />
milanese è zona di massima convergenza di linee provenienti non solo dalle centrali<br />
regionali ma anche da centrali piemontesi (soprattutto dell’Ossola) e del Tren-<br />
364
Fot. Azienda Elettrica Municipale<br />
Centrale elettrica di Premadio (Valtellina).<br />
tino. Il complesso reticolo irradia poi dalla pianura ben oltre i confini regionali; la<br />
<strong>Lombardia</strong> infatti rappresenta, per un’aliquota tutt’altro che trascurabile della produzione<br />
idroelettrica, un’area di transito obbligato verso la Liguria, il Piemonte e<br />
l’Emilia.<br />
Il consumo regionale è assai elevato e in genere lievemente superiore alla produzione<br />
locale; esso nel complesso oscilla attorno al 25% del consumo nazionale.<br />
Secondo medie degli ultimi anni circa il 7% del consumo lombardo è utilizzato dall’illuminazione<br />
pubblica e privata; un’aliquota press’a poco pari (8%) è assorbita<br />
dagli usi elettrodomestici e dalle applicazioni in abitazioni private e in pubblici<br />
esercizi; notevolmente modesto appare, rispetto al totale, il consumo per trazione<br />
(S%). nonostante la elettrificazione di numerose linee ferroviarie, e quello per<br />
altri usi (9%) comprese le applicazioni nell’agricoltura. L ’industria costituisce il<br />
maggiore utente assorbendo il 71% del consumo lombardo, e ciò appare comprensibile<br />
dato lo sviluppo industriale della regione e l’alto grado di meccanizzazione<br />
delle aziende. L ’aliquota maggiore del consumo industriale spetta ai settori elettrometallurgico<br />
ed elettrochimico.<br />
Il consumo pro capite in <strong>Lombardia</strong> è tra i più elevati; nel 1951 risultava di<br />
981 kWh all’anno, nel 1956 di 1090 kWh con sensibili variazioni tra zona e zona in<br />
rispondenza della densità di popolazione e della frequenza delle industrie.<br />
365
Le industrie alimentari.<br />
La pianura lombarda, che vanta da secoli una fiorentissima attività rurale imperniata<br />
fondamentalmente sulla produzione cerealicola e sull’allevamento bovino, si<br />
trovava nelle condizioni ideali per dare vita e sviluppo a industrie alimentari; eppure<br />
queste sono state le ultime in ordine di tempo ad organizzarsi su vere basi industriali<br />
e, anzi, alcune tra quelle attualmente più tipiche divennero vere e proprie<br />
industrie solo alcuni decenni or sono. Diverse possono essere le giustificazioni, ma<br />
la principale può forse trovarsi nella difficoltà dell’esportazione dei prodotti agricoli<br />
nella seconda metà del secolo scorso. Le migliorate condizioni degli scambi nel<br />
decennio precedente la prima guerra mondiale, infatti, sollecitarono sensibilmente<br />
l’incremento della produzione agricola e dell’allevamento e spronarono verso l’industrializzazione<br />
del settore dei prodotti alimentari.<br />
Tra le prime a subire una profonda trasformazione fu l’industria molitoria, precedentemente<br />
frazionata in migliaia di molini di modeste capacità di macinazione<br />
sparsi lungo i torrenti e i fiumi delle cui acque fruivano come forza motrice. Via via<br />
il loro numero si ridusse e, in sostituzione, sorsero grandi impianti ad alta capacità<br />
di macinazione in vicinanza dei maggiori agglomerati urbani. Attualmente in <strong>Lombardia</strong><br />
si annoverano 2 1 1 molini ad alta macinazione con una complessiva potenzialità<br />
massima di circa 16 milioni di quintali l’anno. Dei 16 molini con potenzialità<br />
giornaliera superiore ai 700 quintali, 7 si trovano nei pressi di Milano e, dei rimanenti,<br />
6 nella regione urbanizzata indicata precedentemente (Varese, Como, Busto<br />
Arsizio, Saronno, Castellanza, Bergamo) e 3 rispettivamente a Pavia, Cremona e<br />
Brescia. Riguardo al numero totale dei molini, si può aggiungere che il primo posto<br />
è tenuto dalla provincia di Pavia, seguita dalle province di Cremona, Mantova,<br />
Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Como e infine Sondrio. V ’è nel complesso un<br />
decrescere della bassa pianura alla montagna; ma ovviamente più che il numero<br />
conta l’entità delle apparecchiature molitorie; così mentre Pavia vanta un primato<br />
per numero di molini, possiede una attrezzatura complessivamente modesta in confronto<br />
a Milano.<br />
Accanto all’industria molitoria è sorta in <strong>Lombardia</strong> anche una notevole industria<br />
della pastificazione, localizzatasi inizialmente a Como e Bergamo e successivamente<br />
presso i maggiori centri. Si tratta per lo più di medie e piccole industrie con una<br />
capacità totale produttiva che è tuttavia notevole (circa 2 milioni di quintali annui),<br />
ciò che pone la nostra regione al quarto posto dopo la Campania, la Sicilia e il<br />
Veneto.<br />
La produzione dolciaria, che già aveva in <strong>Lombardia</strong> antiche tradizioni con il<br />
torrone di Cremona, gli amaretti di Saronno, ecc., si affermò come industria tra le<br />
366
Fot. Fotocielo<br />
Industrie alimentari alla periferia di Melzo,<br />
centro di produzione di latticini e carni conservate.<br />
due guerre mondiali per iniziativa di Angelo Motta, cui si deve la fondazione del<br />
grande impianto milanese avvenuta nel 1924. Ad esso si aggiunse, pochi anni<br />
appresso, lo stabilimento Alemagna, con sede pure a Milano. La produzione, dapprima<br />
limitata all’ormai famoso panettone, si estese in breve alla gamma completa<br />
di pasticceria, e contemporaneamente, grazie alla rapidità delle comunicazioni, il<br />
367
Reparto autoclavi per fermentazione e stabilizzazione di vini<br />
in un’industria enologica (Cantina sociale di Santa Maria Della Versa, nell’Oltrepò pavese).<br />
Fot. Chiolini<br />
mercato di vendita si espanse ad abbracciare tutto il territorio nazionale; anche<br />
l’esportazione verso l’estero in breve volgere di tempo raggiunse proporzioni veramente<br />
insperate. Sull’esempio dei due grandi complessi dolciari in anni più recenti<br />
sorsero nel Milanese anche altre industrie minori: nel complesso nel solo territorio<br />
della provincia di Milano si contano attualmente un centinaio di imprese con<br />
circa 8000 dipendenti, dei quali 5000 delle due industrie maggiori. La produzione<br />
è imponente: si calcola che durante la campagna natalizia la sola produzione di<br />
panettone si avvicini ai 130.000 quintali (1958) con una esportazione in tutte le<br />
parti del mondo.<br />
Tra le industrie collegate all’agricoltura hanno assunto notevole sviluppo anche<br />
le conserviere, quali quelle della mostarda, per cui vanno famose Cremona e Voghera,<br />
e quella dei vegetali, per cui si distinguono Mantova e Pavia per il pomodoro e<br />
Morbegno per i funghi. Modesta in confronto di altre regioni, ma tuttavia non trascurabile<br />
è l’industria enologica, per la quale sono assai noti l’Oltrepò pavese (Stradella,<br />
Broni e Casteggio), dove si producono barbera e moscato, e la Valtellina, dove<br />
368
si producono vini tipici come l’inferno, il sassella e il grumello. Notevole invece la<br />
lavorazione della birra nella quale la <strong>Lombardia</strong> vanta un primato nazionale di produzione.<br />
La prima fabbrica, la Wührer di Brescia, risale al 1829; nel 1870 seguì la<br />
Foretti di Varese e successivamente le birrerie di Milano, Chiavenna e Bergamo.<br />
Attualmente la produzione lombarda oscilla sui 250.000 ettolitri annui che costituiscono<br />
il 15% del totale nazionale.<br />
Passando dalle industrie collegate propriamente all’agricoltura a quelle derivate<br />
daU’allevamento s’impone in primo luogo, per il suo grandioso sviluppo, l’industria<br />
dei derivati del latte. Per quanto la produzione lombarda dei latticini, divenuti oggi<br />
notissimi sul mercato nazionale, sia antichissima (la produzione del grana nel Lodigiano<br />
risale al secolo XIII), la sua organizzazione su basi industriali è assai recente.<br />
Si può dire che sino all’inizio del secolo e anche dopo la lavorazione fosse prevalentemente<br />
casalinga e limitata al quantitativo consentito dal numero dei capi allevati<br />
in ogni singola fattoria. Aziende commerciali provvedevano, poi, alla raccolta<br />
dei prodotti, all’impacchettatura del burro, alla stagionatura dei formaggi e all’immissione<br />
sul mercato. Tuttavia, proprio agli albori del secolo, nella bassa vennero<br />
costituendosi cooperative e consorzi di produttori del latte, alcuni dei quali diedero<br />
in seguito vita о sostegno alle grandi industrie, sorte dopo la prima guerra<br />
mondiale nella zona dei foraggi e principalmente nel Milanese, nel Pavese, nel<br />
Lodigiano, nel Cremasco e nel Cremonese. Attualmente le imprese a carattere industriale<br />
sono circa 5000 e tra esse hanno acquisito grande notorietà la Polenghi Lombardo,<br />
la Galbani, la Soresinese, la Cademàrtori, ecc. Nel complesso il quantitativo<br />
Fot. Motta<br />
Gli stabilimenti dell’industria dolciaria Motta a Milano.<br />
■н'ііѵяіцр ЩІ Ш Ш Ш<br />
І і і і і і Р І І Я р р<br />
J<br />
24 —• L e Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
369
Lavorazione delle carni suine (prosciutto cotto) in un’industria di Melzo.<br />
Fot. Stefani
di latte lavorato dalle industrie lombarde si aggira sui 15 milioni di ettolitri l’anno<br />
(circa il 30% della produzione lattiera nazionale). La produzione di burro raggiunge i<br />
200.000 quintali annui (pari al 40% della produzione nazionale) e quella dei formaggi<br />
i 900.000 quintali (circa il 37% del totale nazionale). I grandi caseifici oltre ai prodotti<br />
tradizionali della zona, come il gorgonzola (che prende nome dal paese omonimo a<br />
oriente di Milano), il taleggio (dal nome della valle confiuente nel Brembo), la robbiola<br />
(che deriva il nome da Robbio in Lomellina), ecc., i quali hanno dato notorietà e prosperità<br />
ai luoghi da cui provengono, si sono attrezzati anche per la produzione di<br />
formaggi tipici di altre regioni, come il provolone, l’emmenthal, lo sbrinz, e di nuove<br />
creazioni tra i quali i formaggi a pasta tenera come, ad es., il belpaese di Melzo.<br />
« La produzione dei formaggi a pasta molle è per lo più accentrata in grandi imprese<br />
in quanto, in questo genere, risulta determinante il prestigio della marca. Sotto questo<br />
aspetto anzi nel recente dopoguerra l’industria lombarda si è attrezzata con moderni<br />
criteri tecnico-commerciali tali da raggiungere alte produzioni e controbattere ottimamente<br />
la concorrenza dei formaggi fusi della Svizzera » (C. R. d. PP. LL.).<br />
Nell’industria delle carni conservate, sorta cronologicamente dopo quella emiliana,<br />
la <strong>Lombardia</strong> vanta oggi un primato con 86 aziende (che costituiscono il 66%<br />
del totale delle industrie italiane), una trentina delle quali vere e proprie grandi<br />
industrie. Tra queste si distinguono in particolare la Negroni di Cremona e la<br />
Vismara di Casatenuovo (Como) che hanno fama internazionale non solo per la<br />
produzione di insaccati, ma anche di opoterapici derivati dai sottoprodotti della<br />
macellazione. Nella produzione di insaccati la <strong>Lombardia</strong> gode ormai di una meritata<br />
fama, specialmente per alcuni prodotti tipici come il « salame Milano » (imitato<br />
anche da fabbriche straniere), il salame di Cremona, il salame di Varzi e il salame<br />
brianzolo. Apprezzata è pure la bresaola di Valtellina (carne salata). Anche nell’inscatolamento<br />
delle carni bovine lo sviluppo industriale lombardo ha raggiunto un notevole<br />
primato specialmente per gli stabilimenti di Monza e di Crescenzago; in totale<br />
in <strong>Lombardia</strong> si produce il 90% del totale nazionale.<br />
Nel complesso le industrie alimentari lombarde nel volgere di pochi decenni<br />
hanno raggiunto, superando non pochi momenti difficili, un alto grado di sviluppo;<br />
esse, come appare dalle precedenti citazioni, sono in assoluta prevalenza distribuite<br />
nella pianura, dove l’attività rurale offre abbondante copia di prodotti, e specialmente<br />
nella parte compresa tra la Sesia e l’Oglio.<br />
L ’industria tessile.<br />
L ’attività tessile, che è stata tra le prime ad avviarsi verso una salda organizzazione<br />
industriale provocando la scomparsa, quasi totale, delle forme di artigianato<br />
preesistenti, eccelle oggi nel quadro dell’industria lombarda, assieme all’industria<br />
meccanica, per il numero di esercizi e di addetti, per la frequenza e la modernità<br />
371
degli impianti, la varietà e la qualità della produzione. Essa complessivamente annovera,<br />
tra piccoli e grandi, 9678 esercizi (che costituiscono un quarto del totale nazionale),<br />
nei quali trovano lavoro circa 315.000 addetti (pari al 48% del totale nazionale<br />
in questo ramo di attività). La maggior parte degli stabilimenti si distribuisce nella<br />
zona della pianura asciutta e della collina, specialmente occidentale.<br />
Tra le tessili, l’industria cotoniera è la più importante. Essa conta 720 stabilimenti<br />
con poco meno di 6 milioni di fusi da filare, 1.300.000 fusi da ritorcere<br />
e 137.000 telai. Il 75% degli opifici è addensato nel territorio dell’alto Milanese e<br />
nel Varesotto con concentrazione soprattutto lungo la strada del Sempione e in particolare<br />
a Legnano con una trentina di aziende tra grandi e piccole. Busto Arsizio<br />
con circa 170 e Gallarate con una sessantina. Numerosi sono gli opifici lungo il<br />
solco dell’Olona, specie nel tratto superiore dove il fiume scorre incassato. Vari cotonifici<br />
si trovano anche lungo il Séveso, soprattutto tra Lentate e Cesano Maderno,<br />
lungo il Lambro, specialmente a Casiino e a Monza, e nella Brianza. Nel Bergamasco<br />
vi sono numerosi cotonifici sia nelle valli prealpine, e in particolare nella<br />
bassa vai Seriana, sia nella pianura come a Bergamo stessa, a Pontirolo, a Capriate,<br />
Legnano, centro di industrie del cotone e di stabilimenti metallurgici.<br />
Fot. Fotocielo<br />
372
Fot. Snia Viscosa<br />
Stabilimento Snia Viscosa a Varedo (Milano).<br />
a Paiosco. Nel Bresciano vi sono industrie sparse nell’anfiteatro del Sebino e poi<br />
a Pontoglio, Chiari, Villanova sul Clisi e Brescia stessa, dove si accentra la maggior<br />
parte dei calzifici. Nella bassa l’industria cotoniera s’incontra sporadicamente nella<br />
Lomellina (Vigevano, Cassolnovo), nell’Oltrepò pavese (Voghera), nel Lodigiano,<br />
nel Cremonese e nel Mantovano. La materia prima, com’è ovvio, è tutta d’importazione<br />
e, ugualmente, la produzione non serve solo il mercato nazionale; ma, non<br />
ostante le incostanti situazioni di mercato e le non lievi crisi attraversate, lo sviluppo<br />
dell’industria cotoniera lombarda ha avuto nel tempo un costante notevolissimo<br />
progresso. Basti ricordare che all’inizio del secolo l’attrezzatura complessiva era<br />
costituita da 844.000 fusi da filare, 90.000 fusi da ritorcere e 39.000 telai.<br />
L ’industria della seta naturale, un tempo la più fiorente tra le industrie tessili,<br />
ha subito, per cause complesse di mercato verificatesi dopo la prima guerra mondiale,<br />
una sensibile contrazione; di riflesso l’allevamento del baco da seta ha denunciato,<br />
specialmente nella nostra regione, un notevolissimo calo riducendosi da 17 milioni<br />
di chilogrammi, qual era la media annua tra il 1921 e il 1930, a poco più<br />
di un milione negli anni più recenti. L ’abbandono dell’allevamento del baco da seta.<br />
37.3
La grandezza dei simboli è proporzionale al numero di addetti.<br />
strettamente connesso, come s’è accennato, all’agricoltura, è stato quasi totale nel<br />
territorio a occidente dell’Adda; esso resiste ancora, per quanto anche qui assai<br />
ridotto, a oriente del fiume, nella campagna del Bergamasco, del Bresciano, del Cremonese<br />
e del Mantovano. Gom’è comprensibile, delle varie fasi industriali di lavorazione<br />
della seta, ha risentito della decadenza soprattutto quella della trattura,<br />
poiché i settori della filatura e della tessitura han potuto sopravvivere associando<br />
о addirittura sostituendo la lavorazione della seta naturale con quella delle fibre<br />
artificiali e sintetiche. Gli stabilimenti lombardi di trattura, per lo più di modesta<br />
entità, sono appena una trentina con un totale di 2500 bacinelle, che rappresentano<br />
il 15% del totale nazionale. Gli impianti, distribuiti unicamente nel territorio delle<br />
374
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Pavia, hanno un’attività non<br />
continua, impiegando per lo più mano d’opera femminile normalmente dedita all’agricoltura.<br />
Ben diversa è la situazione riguardo alla torcitura e alla filatura, che si<br />
accentrano nella quasi totalità nell’àmbito della nostra regione. La torcitura, costituita<br />
in prevalenza da medie e piccole aziende, è distribuita nel Comasco propriamente<br />
detto, nella Brianza, nella collina bergamasca e varesina e nell’alta pianura<br />
milanese; tutti gli impianti hanno lavoro continuativo, ma solo il 12% circa delle<br />
fibre trattate è costituito da seta naturale, il resto è di materie artificiali e sintetiche.<br />
La tessitura è accentrata in Como, centro tradizionale della seta naturale che vanta<br />
i maggiori complessi industriali; diversi impianti si trovano però anche a Milano,<br />
a Varese e in alcuni centri della pianura asciutta a nord di Milano: Varedo, Cusano<br />
Milanino, Ceriano, Rho e Cesano Maderno, che vanta il più grande stabilimento di<br />
prodotti artificiali. Nel complesso l’attrezzatura lombarda è costituita da 24.000 telai<br />
che costituiscono il 90% del totale nazionale; ma la tessitura della seta naturale<br />
rappresenta solo il 7% circa della totalità delle fibre lavorate, che sono ormai in<br />
assoluta prevalenza artificiali о sintetiche. Rimane, infine, da ricordare l’industria<br />
che lavora i cascami di seta (in buona parte di importazione) i cui maggiori impiantisi<br />
trovano a Rozzano (Milano), a Monza, a Vigevano e a Boltiere (Bergamo).<br />
Fot. Wells; E. P.T., Bergamo<br />
Gandino (vai Seriana) antico centro di lavorazione della lana.<br />
375
Nella lavorazione della lana l’attrezzatura lombarda è nettamente inferiore a<br />
quella del cotone e a quella della seta, ma non è tuttavia trascurabile e tutte le fasi<br />
di lavorazione vi sono rappresentate. Le industrie maggiori e più antiche si trovano<br />
nelle valli prealpine, a Gandino nella valle omonima confluente del Serio e<br />
a Gavardo nella vai Sabbia; altre sorgono nella zona pedemontana, Gavirate, Erba,<br />
Lecco, altre ancora sono sparse nella pianura e nella collina, Milano, Monza,<br />
Mortara, Pavia, Lodi, Desio, Giussano (Milano), Brugherio (Milano), Canegrate<br />
(Milano), Manerbio (Brescia); tra questi centri, gli ultimi tre vantano un’attrezzatura<br />
tra le più progredite e l’impianto di Manerbio possiede una sala di tessitura<br />
che viene giudicata addirittura la più vasta d’Europa. Nel complesso però la produzione<br />
laniera lombarda è modesta e si aggira in totale sul io% di quella nazionale.<br />
Nel ramo di lavorazione della canapa e del lino, che sono intimamente connesse<br />
tra loro, la <strong>Lombardia</strong> torna ad eccellere tra le regioni italiane; infatti essa impiega<br />
l’8o% del totale nazionale degli addetti a questo settore tessile e vanta i più grandi<br />
complessi localizzati nel territorio delle province di Varese, di Como, di Bergamo,<br />
di Brescia e in particolare di Milano. « L ’elevato fabbisogno di capitali, soprattutto<br />
.nella filatura (la quale è stata definita l’industria tessile pesante), ha favorito sin dalla<br />
seconda metà del secolo scorso la concentrazione aziendale, che ha avuto il suo<br />
centro proprio in <strong>Lombardia</strong>, dove nel 1873 venne costituito il Linificio e Canapificio<br />
nazionale: questo, attraverso successivi sviluppi, si confermava quale il maggior organismo<br />
non soltanto in Italia, ma anche in Europa », con una rete di stabilimenti, soprattutto<br />
di filatura e di torcitura, distribuiti in varie regioni italiane (C. R. d. PP. LL.).<br />
Nel campo della tessitura, invece, sono numerose le imprese indipendenti di medie<br />
dimensioni, quali, per la <strong>Lombardia</strong>, quelle di Milano, di Lainate (Milano), di<br />
Bagnano Olona (Varese), di Rescaldina (Milano), di Trezzo d’Adda (Milano), ecc.<br />
Modesta è l’importanza della <strong>Lombardia</strong> nell’industria della lavorazione della juta,<br />
che ha ben maggiore sviluppo in Liguria, in Piemonte e nel Veneto. Ad eccezione<br />
degli Jutifici Riuniti (collegati alla Montecatini), la maggior parte delle aziende è<br />
di piccola e media dimensione: oltre a tre filature (San Pellegrino, Carugo e Besana<br />
Brianza) si sono una decina di tessiture di cui la metà nel territorio dell’alto Milanese<br />
(Monza, Villasanta, Macherio, Busto Garolfo, Besana).<br />
Imponente da ultimo il quadro delle industrie collegate con l’industria tessile,<br />
quelle di tintoria, di stampa, di finissaggio dei filati e dei tessuti, di apparecchiatura<br />
e coesionatura della seta, ecc., sino all’abbigliamento; si calcola che in complesso<br />
le vere e proprie industrie assommino a oltre 200; l’artigianato ha una netta prevalenza<br />
nel campo dell’abbigliamento. Tra le industrie meritano di essere ricordati<br />
per lo sviluppo degli impianti о la qualità della produzione: i maglifici localizzati<br />
specialmente a Milano e a Voghera, i cravattifici a Milano e Como, i nastrifici<br />
a Milano, Monza, Lecco, Como, Busto Arsizio, Varese, ecc., i calzifici a Brescia,<br />
Milano, Pavia, i ricamifici a Busto Arsizio e Gallarate, i guantifici a Varese e a<br />
Milano, i cappellifici a Monza, Bergamo e Cremona, i bottonifici a Gorlago, Chiudono,<br />
Tagliuno (Bergamo), Pontoglio e Palazzolo (Brescia).<br />
376
L ’industria siderurgica e metallurgica.<br />
Nel settore dell’industria metallurgica (in particolare siderurgica) e dell’industria<br />
meccanica il complesso lombardo si presenta imponentissimo e, specialmente per<br />
la meccanica, superiore a quello di ogni altra regione italiana.<br />
La siderurgia, praticata, come s’è accennato in precedenza, in forma artigianale<br />
sino a. tutto il secolo scorso, assunse nella nostra regione un carattere industriale<br />
mercè l’impiego di energia elettrica. Precedentemente la sostituzione dei forni a<br />
legna con altiforni a coke aveva determinato in <strong>Lombardia</strong> una situazione precaria<br />
a causa della mancanza in luogo del combustibile e della posizione geografica del<br />
territorio rispetto ai porti di importazione dello stesso. Il 1912 rappresentò l’inizio<br />
della trasformazione: risale infatti a quell’anno il primo impianto elettrico installato<br />
a Darfo per conto delle Ferriere di Voltri. Durante gli anni della guerra mondiale,<br />
a causa anche dello sforzo produttivo imposto da questa, i forni elettrici si moltiplicarono,<br />
dando un apporto produttivo rapidamente e progressivamente crescente.<br />
Nel 1915 la produzione dell’acciaio lombardo costituiva circa un quinto del totale<br />
nazionale. L ’ascesa, salvo la parentesi rappresentata dalla seconda guerra mondiale,<br />
continuava nei decenni successivi sia con l’aggiunta di nuove unità produttive, sia<br />
con il rammodernamento costante di quelle preesistenti. Notevole è stato soprattutto<br />
lo sviluppo della produzione di acciai, che nel 1956 era rappresentata da<br />
1.767.000 tonnellate pari al 30% del totale nazionale. La siderurgia primaria è<br />
attuata in una quarantina di aziende, delle quali la metà circa esercitano anche la<br />
siderurgia secondaria; per questa poi esistono un altro centinaio di impianti. Delle<br />
industrie attuali, alcune hanno sede sul luogo di quelle tradizionali, legate in parte<br />
allo sfruttamento dei giacimenti ferrosi: tali, ad esempio, quelle della Valcamònica<br />
(Pisogne, Darfo, Breno), della vai di Scalve (Dezzo), della vai Trompia (Lumezzane);<br />
altre sono sorte successivamente nelle vallate alpine più ricche di energia<br />
idroelettrica, come in Valtellina, altre sono dislocate al margine pedemontano come<br />
quelle di Erba, Lecco, Bergamo e Brescia, altre ancora nella pianura come a Sesto<br />
San Giovanni, il maggior centro siderurgico e metallurgico lombardo alle porte di<br />
Milano dove eccellono la Falck e la Breda, a Legnano (Milano), a Dàlmine (Bergamo),<br />
a Bagnolo Mella (Brescia), ecc.<br />
L ’industria che lavora i minerali e i metalli non ferrosi è sorta in <strong>Lombardia</strong><br />
nel volgere dell’ultimo cinquantennio e sempre in relazione alla disponibilità di<br />
energia elettrica. Nella lavorazione dei minerali tratti dal sottosuolo lombardo emerge<br />
lo stabilimento di Nossa in vai Soriana (Bergamo) che produce zinco elettrolitico<br />
trattato dalle calamine locali. Notevole è anche lo stabilimento di Calusco d’Adda<br />
(Bergamo) che produce silicio. Per la lavorazione di metalli in seconda fusione si<br />
377
Le acciaierie Breda a Sesto San Giovanni.<br />
Fot. Breda<br />
annoverano una trentina di grandi stabilimenti che danno alla <strong>Lombardia</strong> un netto<br />
primato sulle altre regioni. La maggior parte degli impianti si addensa a Milano<br />
e nel Milanese e tra essi alcuni danno lavoro a oltre mille dipendenti. La ditta più<br />
antica è la Tonolli che risale al 1904 e possiede a Paderno Dugnano la più grande<br />
raffineria d’Italia. Lfn altro settore metallurgico assai sviluppato è quello della trafilatura<br />
e della laminazione dei metalli, le cui origini (1890) precedono di poco<br />
quelle della metallurgia. In particolare la <strong>Lombardia</strong> eccelle per la lavorazione dell’alluminio.<br />
Gli impianti per le varie lavorazioni sono numerosi: dei maggiori, alcuni<br />
s’accentrano nei dintorni di Milano, altri notevoli si trovano a Solbiate Arno (Varese),<br />
a Mandello Lario (Como), a Membro, a Calolziocorte (Bergamo), a Villa Garcina,<br />
a Lumezzane, a Chiari (Brescia). Altro gruppo di impianti metallurgici in notevole<br />
sviluppo è quello delle leghe (bronzo, ottone, ecc.) di cui la <strong>Lombardia</strong> dà i due<br />
terzi del totale nazionale. L ’origine di questo ramo industriale si può far risalire<br />
all’antico artigianato delle campane che, praticato fin dal secolo XIV, vanta tuttora<br />
diversi stabilimenti nel Milanese (Seregno, Milano) e nel Varesotto, alcuni dei quali<br />
godono di vasta rinomanza. In totale le fonderie metallurgiche con varia specializzazione<br />
sono una ventina e alcune con impianti moderni di pressofusione; notevoli<br />
sono quelle di Ospitaletto, di Cormano (Milano) che è la maggiore d’Italia, della<br />
periferia di Milano e di Jerago (Varese).<br />
L ’industria meccanica lombarda presenta un quadro molto complesso per entità<br />
di sviluppo e per varietà di produzione. Nonostante i gravi problemi di ricostruzione<br />
degli opifici, di rinnovamento degli impianti, di ricerca di nuovi mercati, sopravve-<br />
378
nuti con il dopoguerra, l’industria meccanica lombarda ha ritrovato nel volgere di<br />
pochi anni la sua piena efficienza. Nel 1951 si annoveravano oltre 25.000 esercizi<br />
che costituivano il 20% del totale nazionale, e ben 320.000 addetti (attualmente<br />
ormai 400.000) che costituivano oltre un terzo del totale nazionale in questo settore<br />
di attività. Vi sono almeno una ventina di opifici con oltre 2000 addetti, una<br />
trentina con un numero di addetti tra i 1000 e i 2000, altrettanti con un numero<br />
di addetti tra i 500 e i 1000 e certo più di un centinaio con un numero di addetti<br />
tra i 250 e i 500. Almeno la metà degli addetti presta quindi la sua opera nelle<br />
grandi industrie. Il numero delle piccole e medie industrie è grandissimo, e il<br />
loro contributo non è meno valido poiché giova notevolmente ad arricchire la<br />
grande varietà della produzione, che costituisce un fattore prezioso nell’economia<br />
generale. « La varietà della produzione è tale che se, per una inconcepibile ipotesi,<br />
l’industria meccanica lombarda dovesse fermarsi, per qualche tempo si fermerebbe<br />
tutta о la maggior parte dell’industria italiana, paralizzando la vita della nazione,<br />
alla quale verrebbero a mancare i mezzi stessi della produzione, per la deficienza<br />
di pezzi di ricambio о di altri elementi vitali della sua attività. Lo si è osservato<br />
del resto durante l’ultima guerra, quando troppo difficili erano le comunicazioni<br />
nella stessa Italia settentrionale » (F. Milone). E questa stessa affermazione autorevole<br />
e imparziale (perchè di scrittore non lombardo) serve a sottolineare la<br />
Fot. Dalmine<br />
Le grandi acciaierie della Dàlmine nella pianura bergamasca.<br />
379
fondamentale importanza dell’industria meccanica lombarda nel quadro dell’economia<br />
nazionale.<br />
La distribuzione geografica dell’industria meccanica presenta una grande concentrazione<br />
in Milano e nell’alto Milanese; tale concentrazione sfuma in un’area<br />
di notevole frequenza, anche se non di pari densità, che si estende dal limite alto<br />
dei fontanili al margine pedemontano tra il Ticino e Г Adda e prosegue, ma con<br />
minore ampiezza e continuità, oltre l’Adda sino al lago di Garda, addentrandosi<br />
nei fondivalle più ampi. Nella bassa pianura occidentale vi sono alcune oasi di<br />
addensamento di industrie meccaniche, tra le quali spicca particolarmente quella<br />
di Pavia. Tale situazione può trovare conferma in pochi dati statistici.<br />
La provincia di Milano nel 1951 assommava essa sola circa la metà delle imprese<br />
meccaniche e oltre 200.000 addetti alla meccanica, ossia il 65% del totale lombardo<br />
in questa attività. A sud di Milano e del limite alto dei fontanili la consistenza dell’industria<br />
meccanica è modesta e quindi i suddetti valori sono da attribuirsi per<br />
la quasi totalità alla parte settentrionale della provincia e in misura preponderante<br />
alla zona, caratterizzata da una particolare concentrazione di industrie meccaniche,<br />
che corrisponde press’a poco all’area della conurbazione individuata precedenteindustrie<br />
siderurgiche<br />
sul delta del torrente Borlezza a Castro (lago d’Iseo).<br />
Fot. Magnolini<br />
380
Fot. Magneti Marelli<br />
Stabilimento della Magneti Marelli a Crescenzago (Milano).<br />
mente a proposito della popolazione. La consistenza numerica degli addetti all’industria<br />
nelle altre province non fa che dar maggior luce alla preminenza milanese.<br />
Л Milano segue Varese con 27.000 addetti, Como e Brescia rispettivamente<br />
con 25.000, Pavia con 14.000, Bergamo con 12.000, Cremona con 8000, Mantova<br />
con 4000 e Sondrio con poche centinaia.<br />
Ardua impresa sarebbe quella di far anche solo cenno alle attività dei settori<br />
dell’industria meccanica. Non possono tuttavia tacersi alcuni che hanno assunto<br />
particolare sviluppo. Anzitutto quello degli autoveicoli che annovera tre grandi complessi:<br />
l’Alfa Romeo e la Bianchi a Milano e la OM a Brescia, la cui apprezzata<br />
produzione si affianca validamente a quella della Fiat di Torino. In questo ramo<br />
devono essere pure ricordate diverse officine di Milano e di Varese che si dedicano<br />
alla carrozzeria fuori serie, che trova larghi consensi anche all’estero. Numeroso<br />
è il gruppo delle ditte costruttrici di motocicli e di biciclette. Tra le prime notevoli<br />
quelle milanesi (tra le quali emerge la Bianchi, che per prima agli albori del secolo<br />
iniziò la produzione), la Guzzi di Mandello del Lario (Como), la Gilera di Arcore<br />
(Milano), la M V di Gallarate (Varese), ecc. Ad esse vanno aggregate le costruttrici<br />
di motor-scooters come l’Innocenti di Milano e la Macchi di Varese. Si calcola che<br />
alla produzione nazionale di motociclette la <strong>Lombardia</strong> contribuisca con l’8o%.<br />
Di poco inferiore è il contributo lombardo nella produzione di biciclette, le cui fab-<br />
381
Veduta parziale di un’officina di montaggio di grandi macchine<br />
della Compagnia generale di elettricità (C. G. E.).<br />
Fot. c, G. F-.
iche più note sono la Bianchi, la Legnano, la Dei, la Taurus, la Viscontea, la<br />
Borghi, la Focosi, la Bozzi, la Doniselli di Milano e la Ganna di Varese.<br />
Le industrie che producono macchine motrici formano un complesso molto vario.<br />
Per le turbine idrauliche si distinguono la Tosi di Legnano, la Riva di Milano e la<br />
Moncalvi di Pavia. La Tosi tiene anche una preminenza nella produzione di turbine<br />
a vapore e di motori Diesel; per questi è notevole anche la Motomeccanica di<br />
Milano. Alla costruzione delle caldaie a vapore si dedicano la Breda di Sesto<br />
San Giovanni e ancora la Tosi di Legnano, oltre ad aziende minori a Milano,<br />
Legnano, Saronno, Séveso, Lecco, Pavia e Brescia. Per i motori a combustione<br />
interna di media e piccola potenza vi sono una decina di notevoli industrie a Milano,<br />
una a Lecco e una a Mantova.<br />
Le industrie di macchine utensili sono numerose e varie. La maggior parte si<br />
trovano nel Milanese, a Bollate, a Legnano, a Seregno, a Carugate, a Villasanta,<br />
a Vimercate, oltre che a Milano; altre sorgono a Varese, a Gallarate (Varese), a<br />
Missaglia (Como), a Brescia, a Pavia, a Broni (Pavia). Le macchine per la tessitura<br />
annoverano un nutrito gruppo di grosse aziende localizzate in prossimità dei centri<br />
tessili ossia, per la maggior parte, nel territorio delle province di Milano, Varese<br />
e Como. Notevole è lo sviluppo dell’industria delle macchine da cucire, localizzata<br />
a Pavia, dove emerge la Necchi che è la più antica e la più notevole, a Milano con<br />
la Borletti e la Salmoiraghi, a Monza con la Singer.<br />
La produzione elettrotecnica presenta anch’essa un assieme vario e complesso,<br />
che manifesta un crescente e rapido sviluppo. Il macchinario per la produzione, il<br />
trasporto e la trasformazione di energia, i motori elettrici di diverso tipo, sono prodotti<br />
da grandi aziende, quali la Breda, la Marelli, il Tecnomasio italiano Brown-<br />
Boveri, la Compagnia generale di elettricità, le Industrie elettriche, tutte nel territorio<br />
milanese. Ad esse si affiancano numerose aziende che producono accessori.<br />
Fiorentissimo è il settore di apparecchi radio, televisori e registratori, le cui aziende<br />
si raggruppano attorno a Milano (Marelli, Geloso, C. G. E., Siemens, Philips, ecc.).<br />
L ’industria chimica.<br />
L ’industria chimica lombarda si suol far risalire storicamente all’inizio del secolo<br />
scorso allorché a Milano si pose in opera il primo impianto per la produzione di<br />
acido solforico e a Brescia e Cremona si aprirono le prime fabbriche di acido nitrico.<br />
Ma i progressi nel tempo furono lenti e modesti e suggeriti soprattutto dal progresso<br />
della tecnica agraria che esigeva l’uso di perfosfati. Alla fine del secolo scorso<br />
infatti l’industria chimica lombarda aveva conseguito i maggiori sviluppi in questo<br />
campo con 46 fabbriche di fertilizzanti che davano complessivamente 270.000 tonnellate<br />
di perfosfati. Ad esse si affiancavano impianti ancora modesti per la pro-<br />
383
duzione di colori, vernici, ossigeno, anidride arseniosa, ecc., alcuni dei quali localizzati<br />
alla Bovisa, allora un sobborgo di Milano, che diventerà poi il settore chimico<br />
più appariscente della città. Con il secolo XX non solo lo sviluppo chimico assunse<br />
in <strong>Lombardia</strong> notevoli proporzioni, ma, quel che più conta, si costituirono in Milano<br />
grandi gruppi finanziari che ebbero il merito di agire come centri motori dell’industria<br />
chimica nazionale; l’esempio maggiore è costituito dalla Montecatini, la cui<br />
organizzazione produttiva ha oggi propaggini in tutta l’Italia.<br />
La consistenza dell’industria chimica propriamente lombarda nel 1951 comprendeva<br />
1600 aziende, vale a dire circa un quarto del totale nazionale, con oltre<br />
70.000 addetti, ossia più di un terzo del totale nazionale. Gli stabilimenti più notevoli<br />
erano almeno 400, e per la maggior parte di prodotti di chimica organica, ossia<br />
di medicinali, di coloranti, di materie plastiche, di resine sintetiche, ecc. La distribuzione<br />
degli impianti non presenta grandi concentrazioni salvo un addensamento<br />
maggiore, ma non molto accentuato, nel Milanese.<br />
Fot. Martinotti<br />
i<br />
M H im li r<br />
ДДйііші №<br />
ш<br />
ш<br />
о т . Г<br />
а а ш<br />
, ш ш . ______<br />
■ ^гШ аяв!:<br />
т<br />
La sede della Montecatini a<br />
Milano.<br />
384
Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong><br />
Impianto della « Montecatini » per la produzione di<br />
acido cianidrico a Rho.
I K >ЯІ « s<br />
и » ~ »gJWWI H
Fot. Sef<br />
Rho: le raffinerie Condor.<br />
Collaterale all’industria chimica v’è l’industria delle fibre artificiali e specialmente<br />
delle fibre sintetiche, prodotte con processi di sintesi chimica. Essa ha avuto notevole<br />
sviluppo per le varie applicazioni delle fibre prodotte soprattutto nel campo<br />
tessile. I maggiori impianti si trovano a Cesano Maderno (dove, tra l’altro, si producono<br />
fibre proteiniche e poliamidiche), a Pizzighettone (dove si produce il filato<br />
raion per i pneumatici Pirelli), a Magenta (dove si producono fibre all’acetato), a<br />
Varedo, a Cusano Milanino, tutte in provincia di Milano. Vi sono altresì impianti<br />
notevoli a Pavia, il più antico della <strong>Lombardia</strong>, a Mariano Comense (Como) e a<br />
Bezzo (Bergamo).<br />
A lato dell’industria chimica si può ricordare l’industria della gomma sorta a<br />
Milano nel 1872 per merito di Giovanni Battista Pirelli, cui si deve il primo stabilimento<br />
per la produzione di caucciù. Il sempre più largo impiego di tale prodotto.<br />
25 • Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
385
Cantil, centro famoso per l’industria del mobile artistico.<br />
Fot. Fotocielo
L ’attività commerciale.<br />
È ovvio che, con uno sviluppo sia agricolo che industriale quale si è tentato di<br />
delineare brevemente nelle pagine che precedono, l’attività commerciale in <strong>Lombardia</strong><br />
abbia assunto proporzioni imponenti, che superano di gran lunga quelle di<br />
ogni altra regione italiana. In complesso la <strong>Lombardia</strong>, nel quadro nazionale, appare<br />
come il principale ganglio di produzione, di ricchezza, di affari, di traffico, del<br />
quale risente beneficamente tutto il territorio dello Stato. Alcuni dati regionali<br />
risultano particolarmente significativi, quali quello del reddito netto che, come s’è<br />
avuto occasione di accennare in precedenza, rappresenta circa un quarto del reddito<br />
nazionale, quello dei redditi soggetti a imposta di ricchezza mobile (B e C^)<br />
che ascende al 28% del totale, quello del gettito dell’imposta generale sull’entrata<br />
che ascende a un terzo del totale nazionale, quello dei depositi e impieghi delle<br />
aziende bancarie pari al 30% del totale nazionale. La situazione di preminenza della<br />
<strong>Lombardia</strong> nel quadro dell’attività commerciale italiana dipende da molteplici cause,<br />
ma fondamentale ci pare la posizione geografica della regione e soprattutto di Milano<br />
che, all’incrocio obbligato di importanti vie di comunicazioni, ebbe modo di emergere<br />
sin dal Medioevo come ganglio commerciale, il cui raggio d’influenza si andò<br />
via via ampliando e rafforzando nei secoli, anche per il sostegno dato dalle ricchezze<br />
locali, non offerte dalla natura ma procurate da tenace lavoro. Posizione geografica,<br />
tradizione commerciale, attività instancabile, prosperità agricola prima e agricolaindustriale<br />
poi sono dunque gli elementi fondamentali che stanno alla base della<br />
invidiabile situazione in cui trovasi la regione.<br />
Secondo i risultati del censimento, nel 1951 in <strong>Lombardia</strong> si trovava il 17%<br />
degli esercizi commerciali esistenti in Italia con il 19% del totale degli addetti. La<br />
distribuzione presenta un massimo addensamento di esercizi nella provincia di<br />
Milano e in particolare nel capoluogo; a Milano seguono, a distanza, Brescia, Pavia,<br />
Bergamo, Como, Varese, Mantova, Cremona e Sondrio. Il movimento globale del<br />
commercio al minuto è notevole: l’ammontare degli introiti rappresenta circa un<br />
sesto del totale nazionale; maggiore è però il dato del commercio all’ingrosso che<br />
è di un quarto del totale nazionale.<br />
Difficile è poter valutare l’entità del commercio regionale nei rapporti con lo<br />
Stato e con l’estero senza valersi dell’irta selva di cifre offerte dalle Camere di commercio<br />
che operano attivamente in questo settore. Un sintomo sommario del suo<br />
imponente sviluppo può venire dalle manifestazioni e dalle iniziative, e tra esse in<br />
particolare dalla Fiera campionaria internazionale di Milano che è di gran lunga<br />
la più importante d’Italia e che, nei quindici giorni della sua apertura, porta — come<br />
esattamente è stato scritto — al parossismo quell’ansia di traffici di cui è pur sempre<br />
389
Veduta aerea della Fiera campionaria di Milano.<br />
Fot. Fotocielo<br />
permeata la vorticosa vita milanese. Sintomi ancor più significativi, sebbene indiretti,<br />
possono derivarsi dall’attività bancaria svolta da i86 istituti, tra i quali la<br />
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, la Banca commerciale italiana, il<br />
Credito italiano, e soprattutto dallo sviluppo della rete delle comunicazioni lungo<br />
la quale il traffico fluisce.<br />
Le comunicazioni.<br />
Una data veramente storica nello sviluppo della moderna rete delle comunicazioni<br />
lombarde è quella del 17 agosto 1840, allorché — a pochi mesi di distanza<br />
dall’entrata in funzione della ferrovia tra Napoli e Portici (3 ottobre 1839) — fu<br />
inaugurato il primo tronco ferroviario di 13 km. tra Milano e Monza. Ad esso fecero<br />
390
sèguito sei anni appresso la Milano-Treviglio e, nove anni dopo, in prosecuzione<br />
della Milano-Monza, la Monza-Camerlata (Corno). Nel 1851 Mantova veniva<br />
collegata con Verona e nel 1857 entrava in esercizio la Milano-Venezia. Nel 1859,<br />
infine, si apriva al traffico la Milano-Magenta. Tale si presentava il quadro delle<br />
ferrovie lombarde, in tutto 300 km. circa nell’anno dell’unificazione italiana, il cui<br />
avvento diede impulso al ritmo costruttivo determinando lo sviluppo di una vera<br />
e propria rete. Ciò fu causa del temporaneo declino delle strade, alcune delle quali<br />
servirono come tracciato delle tranvie extraurbane a vapore irradiantesi dai capoluoghi.<br />
A ll’inizio del nostro secolo la rete ferroviaria lombarda aveva ormai raggiunto<br />
il suo completamento e, con l’avvento dell’automobilismo, iniziava un nuovo<br />
periodo di splendore la rete stradale, che, oltre all’ammodernamento dell’antico<br />
tracciato, si arricchiva di nuove arterie tra le quali, nel 1925, la prima autostrada<br />
del mondo, la Milano-Laghi, cui si aggiunsero nel volgere di pochi anni altri tronchi<br />
irradianti da Milano.<br />
Riparate rapidamente le distruzioni determinate dalla seconda guerra mondiale,<br />
attualmente la rete delle vie di comunicazione è costituita da circa 2200 km. di ferrovie<br />
per oltre la metà elettrificati, e per quasi un terzo a doppio binario, da<br />
Utet<br />
BeHinzons<br />
La frequenza del traffico viaggiatori<br />
sulla rete ferroviaria lombarda (escluse F.N.M.).<br />
---- Ferrovie dello Stato<br />
----Ferrovie secondarie<br />
Le rette che affiancano l'indicazione<br />
de! tronco ferroviario rappresentano<br />
una coppia di corse<br />
^-Luino 1- Lavano<br />
3 - Porto Geresio 4 - Gallarate<br />
5 - Oggiono 6 - Lecco<br />
7 - Piazza Brembana 8 - elusone<br />
Vèrteva \^-Seregno<br />
1 1 - Monza 1 2 - Treviglio<br />
1 3 - ÍSBQ 1 4 - Montara<br />
ЛЬ-Lodi<br />
ЛЬ-Godogno<br />
1 7 - Piàdena<br />
3 9 1
Il grande viadotto ferroviario presso Desenzano, sulla linea Milano-Verona.<br />
Fot. Sef<br />
530 km. di tranvie extraurbane, da 1320 km. di strade statali, 3430 km. di strade<br />
provinciali, 16.000 km. di strade comunali, e, infine, da circa 250 km. di autostrade.<br />
L ’ossatura fondamentale della rete ferroviaria lombarda è costituita ovviamente<br />
dalle linee statali. Milano costituisce il nodo più importante in cui convergono due<br />
linee oltralpine, quella del Sempione e quella del Gottardo, allacciandosi nella metropoli<br />
a tronchi fondamentali irradiantisi verso i capoluoghi regionali: Torino, Genova,<br />
Bologna (Roma) e Venezia. Tra queste linee s’inseriscono linee di minore traffico,<br />
ma di importanza notevolissima che fanno capo a Milano, quali la Milano-Lecco-<br />
Sondrio, la Milano-Mortara, о ramificazioni quali la Gallarate-Varese, la Treviglio-<br />
Bergamo, la Treviglio-Cremona, la Brescia-Gasalmaggiore, о infine allacciamenti.<br />
392
quali la Pavia-Casalpusterlengo, la Codogno-Cremona, la Cremona-Mantova, per<br />
non dire, per ora, delle ferrovie in gestione privata. In breve si potrebbe grosso<br />
modo paragonare il disegno della rete ferroviaria lombarda a quello di una ragnatela<br />
il cui centro è costituito da Milano. Ecco un quadro sintetico e significativo<br />
del movimento lombardo e milanese delle Ferrovie dello Stato, che per il fatto di<br />
risalire al 1953, risulta lievemente inferiore alla realtà attuale: «Sulle linee lombarde<br />
dello Stato, le percorrenze dei treni nel volgere di un anno ammontano all’ordine<br />
di grandezza di 30 milioni di chilometri, contro 200 milioni di chilometri percorsi<br />
sull’intera rete nazionale. Oltre 200 milioni sono in un anno i viaggiatori che,<br />
nella sola <strong>Lombardia</strong>, usufruiscono delle Ferrovie dello Stato, dando un introito<br />
di quasi 24 miliardi: la sola stazione di Milano Centrale ha un movimento medio<br />
giornaliero in arrivo e in partenza di circa 150.000 viaggiatori complessivamente.<br />
In certi periodi, come a Natale, durante la Fiera campionaria, a Ferragosto, ecc.,<br />
il movimento si raddoppia. Le Ferrovie dello Stato portano a Milano ogni mattina,<br />
scaricandoli nelle diverse stazioni (Centrale, Porta Nuova, Rogoredo, Lambrate,<br />
Porta Romana, Porta Genova, Certosa, Bovisa, Greco, San Cristoforo), non meno<br />
di 70.000 lavoratori delle località viciniori, occupati nelle industrie nelle varie attività<br />
della metropoli; lavoratori che alla sera, con gli stessi mezzi, rientrano alle loro<br />
residenze. È un trasporto di massa che comporta un impiego imponente di veicoli<br />
e un movimento intenso di treni convergenti su Milano al mattino in un periodo<br />
ristretto di tempo (dalle 7 alle 8,30), e che ne ripartono alla sera (dalle 17,30<br />
alle 19,30): epperciò determinano una ben scarsa utilizzazione del materiale rotabile<br />
e del personale. È peraltro un fenomeno comune oggi a tutti i grandi centri specialmente<br />
industriali, e che a Milano si manifesta con punte particolarmente forti.<br />
Il traffico di merci ammonta sulle ferrovie statali di <strong>Lombardia</strong> a circa 7 milioni<br />
di tonnellate caricate, con l’impiego di 600.000 carri, pari a circa 12 tonnellate<br />
per km/giorno, con una media giornaliera di 1650 carri caricati. I carri scaricati<br />
sono, in un anno, oltre i milione. Da notare che sull’intera rete delle Ferrovie dello<br />
Stato, i carri caricati e scaricati sono rispettivamente 5 milioni e 4 milioni e mezzo<br />
all’anno» (F. A. Jelmoni).<br />
Delle linee statali che fanno capo a Milano quelle più dense di traffico sono la<br />
Milano-Pavia-Voghera-Genova e la Milano-Piacenza-Parma-Reggio-Modena-Bologna<br />
dove converge la maggior parte del traffico centro-meridionale. Delle transalpine<br />
la più oberata è la Milano-Como-Chiasso diretta al valico del Gottardo. La concentrazione<br />
su questa linea del movimento con l’Europa centrale ha anzi sollevato<br />
il problema dei trafori dello Spinga e dello Stelvio: il primo (km. 24) con una ferrovia<br />
d’accesso lungo il Lario, il Piano di Chiavenna e la valle San Giacomo, il<br />
secondo con ferrovia d’accesso da Bergamo e lungo la vai Soriana con un primo traforo<br />
(km. 12) sotto le Orobie e un secondo alla testata della Valtellina (km. 15,5).<br />
Accanto alla rete ferroviaria statale in <strong>Lombardia</strong> vi sono 25 linee ferroviarie<br />
in concessione privata gestite da nove aziende, con un’estensione complessiva di<br />
695 chilometri. Di maggiore importanza e sviluppo sono le Ferrovie Nord Milano,<br />
393
Laveno<br />
Frequenza del traffico viaggiatori sulle F.N.M . confrontato fra il 1930 e il 1959.<br />
Le cifre indicano il numero dei treni nelle ventiquattro ore su ciascuna linea.<br />
Utet<br />
la cui rete di 248 km., tutta elettrificata, si compone di sette tronchi che irradiano<br />
da Milano verso le popolose zone settentrionali giungendo sino a Novara, a Varese,<br />
a Como e ad Asso. Il traffico che esse svolgono è intensissimo, soprattutto connesso<br />
al movimento giornaliero di lavoratori che al mattino raggiungono Milano<br />
in numero non inferiore ai 30.000 e ripartono alla sera. Notevole sotto questo<br />
aspetto è anche la rete della Società Nazionale di Ferrovie e Tranvie, che si stende<br />
per complessivi 184 km. soprattutto nel territorio di Brescia; i tronchi principali<br />
sono quello che da Brescia s’interna nella Valcamònica sino ad Edolo e quello che<br />
da Brescia raggiunge Cremona. Gli altri tronchi in gestione privata sono: la Bergamo-<br />
Piazza Brembana (km. 41) e la Bergamo-Clusone, che percorrono le due principali<br />
valli bergamasche; la Mantova-Peschiera (km. 40); la Rezzato-Vobarno (km. 26);<br />
la Voghera-Varzi (km. 32); la Sondrio-Tirano (km. 26), che fa da collegamento della<br />
Milano-Sondrio con la ferrovia svizzera del Bernina tra Tirano e St.-Moritz; la Varese-<br />
Luino con diramazione a Ponte Tresa, l’unica della <strong>Lombardia</strong> a scartamento ridotto.<br />
Un ruolo ancora notevole nel movimento viaggiatori di massa svolgono le tranvie<br />
extraurbane. Scomparso di recente l’ultimo esemplare con trazione a vapore (il<br />
famoso gamba de legn tra Milano e Magenta), esse sono oggi tutte elettrificate: lo<br />
sviluppo complessivo misura 530 km. con un trasporto annuo di circa 90 milioni<br />
394
di persone. Ma le tranvie non corrispondono in tutto alle esigenze dei tempi, per<br />
cui una parte di esse, in questi ultimi anni, è stata sostituita con autolinee.<br />
I trasporti pubblici urbani, costituiti da tram, filobus e autobus, misurano una<br />
lunghezza complessiva di 650 km. ; ne sono dotati tutti i capoluoghi e centri industriali<br />
come Sesto San Giovanni, Monza, Seregno, Lecco, Gallarate e Busto Arsizio,<br />
ma ovviamente essi hanno il massimo sviluppo a Milano, dove su una rete di<br />
circa 480 km. si svolge un movimento annuo di circa 700 milioni di persone.<br />
La rete delle strade lombarde è tra le più estese d’Italia, eppure essa risulta più<br />
che altrove insufficiente all’intensità del traffico. La rete delle arterie più importanti<br />
rispecchia nell’assieme lo sviluppo ferroviario, ossia radiante da Milano, ma<br />
con le strade minori essa presenta un reticolato assai più fitto. Le strade statali di<br />
maggior traffico sono la Strada dei Giovi da Como a Voghera (e Genova) e la<br />
Via Emilia da Milano a Piacenza (e Bologna-Rimini) ; ma notevolmente frequentate<br />
sono la Strada del Sempione da Milano a Sesto Calende (e Domodossola), la<br />
Fot. Ferrari<br />
L ’« autostrada dei Laghi » a Lainate.<br />
39S
Strada del lago di Como e dello Spluga da Milano al passo per Lecco e Colico (dove<br />
si diparte la Strada dello Stelvio), la Padana superiore (proveniente da Torino,<br />
Novara) transitante da Magenta, Milano, Treviglio (dove si ramifica la Strada per<br />
Bergamo e il Tonale), Brescia, Peschiera; la Padana inferiore da Voghera a Mantova<br />
passando per Piacenza e Cremona, ecc. Ad alleggerire il traffico sulle statali<br />
contribuiscono in larga misura le strade provinciali, alcune delle quali sistemate<br />
396
secondo i requisiti più moderni della tecnica costruttiva. Le strade comunali, che<br />
costituiscono il sistema capillare della circolazione, per quanto di sviluppo tra i più<br />
elevati nella graduatoria regionale, non si dimostrano adeguate, per sistemazione<br />
di fondo, alle necessità attuali. Nel complesso la fittezza media è di 84 km. di<br />
strada ogni 100 kmq. di territorio, nettamente superiore alla media italiana (58),<br />
ma, rispettivamente alle singole categorie, risulta che per le strade statali il dato<br />
lombardo (5,6) è inferiore a quello nazionale (8,3) per le strade provinciali è alla<br />
pari (14,4 e 14,8) e infine per le strade comunali nettamente superiore (84,8 e 58,8);<br />
ciò che dimostra il ruolo notevole che queste ultime svolgono nel quadro della circolazione<br />
lombarda, la cui entità è veramente notevole.<br />
Nel 1956 i mezzi motorizzati immatricolati in <strong>Lombardia</strong> erano un quinto del<br />
totale nazionale, 833.000, con un aumento medio annuo di oltre 100.000 unità: è<br />
dunque certo che il 1958 ha registrato il superamento di un milione di mezzi motorizzati,<br />
il che significa che vi è un mezzo ogni 6 ab. e che vi sono in media<br />
circa 50 mezzi motorizzati ogni chilometro di strade (comprese le provinciali e le<br />
comunali); la provincia di Milano tiene un primato con oltre un centinaio di mezzi<br />
Fot. Fotocelere<br />
Mantova: trasporti fluviali a Porto Catena.<br />
397
L ’aeroporto della Malpensa (Gallarate).<br />
Fot. Sef<br />
per chilometro di strada! Naturalmente il calcolo tien conto anche dei motoveicoli, che<br />
hanno una grande diffusione; ma questi pochi dati permettono di meglio intuire<br />
l’affollamento delle strade lombarde. Ad alleggerire notevolmente la circolazione<br />
su queste contribuiscono le autostrade che comprendono cinque arterie irradianti<br />
da Milano: la più antica (1925) la Milano-Laghi con distinti tronchi per Sesto<br />
Calende, Varese e Como; la Milano-Bergamo, aperta nel 1927 e prolungata poi sino<br />
398
a Brescia (1931) e a Venezia (i960); la Milano-Torino ultimata nel 1932; la Milano-<br />
Piacenza, primo tronco dell’Autostrada del Sole, aperta nel 1958 e la Milano-Serravalle<br />
Scrivia, aperta nel i960 a rafforzare quell’allacciamento con Genova che agevolerà<br />
grandemente il traffico con il porto ligure.<br />
Nel quadro delle comunicazioni della <strong>Lombardia</strong> non si può dimenticare la<br />
navigazione interna sui laghi e sui canali. Sui primi le linee regolarmente in funzione<br />
sono una decina per uno sviluppo complessivo di 350 km.; al servizio, gestito<br />
attualmente dallo Stato, sono adibiti 15 piroscafi e una cinquantina di grossi motoscafi,<br />
con una capacità di trasporto complessivo di circa 17.000 persone. Il movimento<br />
passeggeri è in parte locale e in parte, la maggiore, turistico, e annualmente<br />
il numero totale dei trasporti oscilla tra i 4 e i 5 milioni, con un massimo estivo<br />
e un minimo invernale. Il movimento maggiore si svolge sul lago di Como e sul<br />
lago Maggiore; a grande distanza seguono il lago di Garda e il lago di Lugano.<br />
Nullo о quasi il movimento passeggeri sul lago d’Iseo, dove invece è molto intenso<br />
il movimento di merci collegato soprattutto al traghetto di carri ferroviari tra le<br />
industrie della sponda occidentale e la ferrovia sulla sponda orientale. Un ruolo<br />
notevole hanno svolto nei riguardi di Milano i vecchi navigli, ruolo che rimane ormai<br />
soltanto al Naviglio Grande, lungo il quale i barconi trasportano alla metropoli<br />
ghiaie e sabbie (nella misura di 700.000 tonnellate annue) per lo sviluppo edilizio<br />
cittadino.<br />
Le comunicazioni aeree in <strong>Lombardia</strong> sono, com’è ovvio, gravemente intralciate,<br />
durante i mesi invernali, dalle nebbie persistenti e ciò è stata forse la causa del ritardo<br />
nell’adeguamento dei due maggiori aeroporti, la Malpensa e Linate, alle esigenze<br />
del traffico moderno. L ’aeroporto Forlanini di Linate nel 1937, quando fu inaugurato,<br />
poteva dirsi uno dei più attrezzati dell’epoca, ma dopo la guerra si dimostrò<br />
del tutto inadeguato alla nuova tecnica e quindi, nonostante il vantaggio della vicinanza<br />
con Milano, venne quasi del tutto abbandonato a vantaggio della Malpensa,<br />
già aeroporto militare a 48 km. a nordovest del capoluogo, adattato ad usi civili<br />
nel 1949 e ora scalo di numerose linee internazionali. Ma nonostante l’incremento<br />
del traffico della Malpensa, il problema di agevolare il movimento aereo in Lom <br />
bardia si pose pressante in anni recenti determinando l’esecuzione di lavori di rinnovo<br />
e di ampliamento non solo della stessa Malpensa, ma anche del Forlanini, ciò che<br />
risolverà almeno in parte il problema del traffico aereo che ha gravato pesantemente<br />
dalla fine della guerra.<br />
Il turismo.<br />
Il turismo sembra costituire una componente in apparenza trascurabile nel quadro<br />
economico lombardo; e ciò in relazione all’appariscente sviluppo di altri settori di<br />
attività, quali, ad esempio, quelli industriale e commerciale, che in certo qual modo<br />
399
adombrano i settori meno imponenti, come il turistico, il quale tuttavia non è<br />
affatto insignificante.<br />
I prodromi del turismo lombardo si possono far risalire ad antichi tempi, forse<br />
ai Comuni, certo alle Signorie, allorché nelle famiglie nobiliari era in uso lasciare<br />
il palazzo di città al sopravvenire dell’estate e trasferirsi nelle ville e nelle tenute di<br />
campagna per trascorrervi i mesi più caldi e afosi. In relazione alle vie e ai mezzi<br />
di comunicazione del tempo, il raggio di trasferimento non poteva essere necessariamente<br />
superiore a qualche decina di chilometri e pertanto le sedi di campagna<br />
si trovavano per lo più sulle colline a settentrione delle città di pianura о al massimo<br />
sulle sponde dei laghi. Per i nobili milanesi tre erano le zone di maggiore<br />
richiamo: la Brianza, il lago di Como (specialmente il centrolago) e il lago Maggiore<br />
(particolarmente la sponda occidentale), zone tutte che ancor oggi sono adorne<br />
di vetuste e splendide ville. Basti ricordare, come esempi più famosi, il Palazzo Borromeo,<br />
iniziato nel 1630, sul deserto scoglio scistoso emergente dallo specchio del<br />
lago Maggiore, trasformato in luogo di meraviglie; la Villa Serbelloni, edificata<br />
nella prima metà del Seicento dal nipote di Gregorio XIV a ridosso del promontorio<br />
di Bellagio, sul luogo di una preesistente dimora di illustri tradizioni; la<br />
Villa Pliniana, fatta erigere in luogo di perenne frescura, presso la punta di Torno,<br />
dal conte Anguissola, governatore di Como; la Villa d’Este, voluta dal cardinale<br />
Tolomeo Gallio e fatta erigere in luogo pittoresco e isolato in prossimità di Cernobbio,<br />
sul lago di Como; la Villa Crespi, nel primo bacino dello stesso lago,<br />
edificata nel 1615 per un nipote del medesimo cardinale; infine, in Brianza, la<br />
Villa Beigioioso a Merate, la Villa Albertoni a Montevecchia, ecc.<br />
II secolo XVIII e ancor più il secolo seguente videro una fioritura di nuove e<br />
non meno splendide dimore in luoghi solitari e pittoreschi sino allora dominio di<br />
boschi e di pascoli. Come esempio più famoso si può ricordare la Villa Carlotta a<br />
Tremezzo (oggi proprietà dello Stato), che, per il suo parco meraviglioso e per la<br />
collezione di sculture del Canova, richiama ogni anno folle di turisti di tutto il<br />
mondo. Ma già al tramontare del Settecento il soggiorno sui laghi e sulle colline<br />
tendeva ad allargarsi a una cerchia più vasta che comprendeva, tra gli altri, uomini<br />
d’ingegno, quali poeti, scrittori e musicisti, i quali, per l’interesse suscitato dalla loro<br />
personalità e dalla loro opera, contribuirono involontariamente ad accrescere la fama<br />
ai luoghi del loro soggiorno. Com’è noto, Stendhal, Foscolo, Berchet, Shelley e<br />
Rossini furono ospiti nella Villa Pliniana, Bellini soggiornò a lungo nella Villa Salterio<br />
(Moltrasio) componendovi la Straniera e, forse, la Sonnambula; Stendhal e<br />
Listz dimorarono a Villa Melzi (Bellagio); Pellico soggiornò, poco prima del suo<br />
arresto, a Villa Arconati (Balbianello).<br />
Il lago di Garda esercitò un fascino non minore del Verbano e del Lario. Alle<br />
sue sponde tiepide e fiorite giungevano i nobili sino da Venezia; ancora lo attesta,<br />
tra gli altri, il cinquecentesco Palazzo Martinengo, fatto edificare presso Gardone<br />
da uno Sforza Pallavicino, uomo d’armi della Serenissima. Nei secoli seguenti si<br />
aggiunsero altre ville monumentali (come quella Bettoni del secolo XVIII, a Bogliaco,<br />
400
Fot. Sef<br />
Il battello-traghetto per automobili in servizio sul lago Maggiore<br />
tra la sponda lombarda (Laveno) e la sponda piemontese (Pallanza).<br />
nota per una ricca collezione d’arte), sebbene con un ritmo meno vivace di quel che<br />
si verificò sul Lario e sul Verbano.<br />
La fama dei luoghi aveva ormai varcato anche le Alpi allorché nel secolo scorso<br />
lo sviluppo delle comunicazioni ferroviarie diede l’avvio al vero e proprio sviluppo<br />
del turismo. Fu facile allora agli stranieri raggiungere i luoghi decantati e famosi<br />
ed ebbe inizio un movimento di carattere internazionale. I villaggi presso i luoghi<br />
di maggiore affluenza si trasformarono: i vecchi e minuscoli alberghi vennero abbelliti<br />
e ingranditi, ma, dimostratisi insufficienti, ne vennero costruiti di nuovi, taluni<br />
anche sfarzosi. Ad essi giungevano dal Sempione e dal Gottardo famiglie e gruppi<br />
26 — L e R e g io n i d ’ Ita lia - L o m b a rd ia .<br />
401
La Gardesana occidentale, strada di grande movimento turistico.<br />
Fot. Stefani<br />
di facoltosi stranieri e vi soggiornavano per periodi prolungati, soprattutto in primavera<br />
e in autunno. L ’afflusso internazionale agì come richiamo sulla ricca borghesia<br />
delle città padane, e le sponde dei laghi vennero affollandosi di nuove dimore<br />
di villeggiatura, non così grandiose come le precedenti, ma comunque assai belle.<br />
Non altrettanto avvenne nella collina; il suo fascino non potè emulare quello esercitato<br />
dai laghi e, per quanto non disertata, non si arricchì di ville in misura pari<br />
a quelle delle sponde lacustri.<br />
Nel primo decennio del nostro secolo e soprattutto dopo la prima guerra mondiale,<br />
anche in <strong>Lombardia</strong> come dappertutto, il turismo manifestò una radicale<br />
evoluzione (riflesso di una profonda evoluzione sociale, economica e tecnica), ossia<br />
da turismo di élite si trasformò in turismo di massa. Per tale nuovo aspetto si manifestarono<br />
due fatti notevoli: anzitutto l’afflusso, specialmente domenicale, in luoghi<br />
già da tempo rinomati, primi tra tutti i laghi, che ovviamente perdettero il pregio<br />
della incantata tranquillità, tanto apprezzata dagli ospiti stranieri; poi la penetra-<br />
402
zione del turismo in tutte le vallate prealpine e alpine, che cessarono di essere plaghe<br />
di sovrana solitudine, così decantata dagli alpinisti.<br />
Non mancarono di manifestarsi alcune conseguenze, tanto più sensibili dopo<br />
la seconda guerra mondiale con il diffondersi della motorizzazione. Nelle località<br />
rivierasche dei laghi, già attrezzate turisticamente, come Bellagio, Tremezzo, Cadenabbia,<br />
Menaggio, sul lago di Como, Sirmione, Gardone, Gargnano, sul lago di<br />
Garda, si è contratta sensibilmente la durata del soggiorno individuale dei facoltosi<br />
stranieri, che qui solevano trascorrere la « stagione » ; però in compenso si è accresciuto<br />
il numero di turisti stranieri e italiani di passaggio. Conservano l’antica tradizione<br />
solamente alcuni grandi alberghi, i quali, per i grandi parchi che ili circondano,<br />
possono offrire ancora agli ospiti un netto isolamento. Con tutto ciò si può comunque<br />
affermare che l’intenso movimento determinato dal turismo di massa ha recato giovamento<br />
ai centri di afflusso, poiché ha originato un commercio minuto complessivamente<br />
notevole e benefico per un gran numero di persone.<br />
Normalmente l’afflusso di turisti ai laghi ha inizio con la festività di Pasqua e<br />
continua senza soste sino all’autunno inoltrato. Da un’indagine parziale sembra che<br />
gli stranieri siano i frequentatori dei mesi della primavera e dell’autunno e che gli<br />
italiani siano i frequentatori prevalenti dei mesi dell’estate.<br />
Fot. Stefani<br />
Campeggio turistico a Clusone (vai Seriana).<br />
iг^<br />
> . •<br />
403
Nelle località di montagna e soprattutto della montagna alpina lo sviluppo del<br />
turismo di massa ha portato una ventata di novità e in qualche caso è stato fonte<br />
di vero benessere. Si può dire che non v’è ormai villaggio alpino e prealpino dove<br />
durante l’estate non vi sia afflusso di villeggianti provenienti dall’affollata pianura in<br />
cerca di riposo e di frescura. Talvolta la richiesta induce i valligiani a cedere in affìtto<br />
la loro stessa dimora ed essi, durante la permanenza dei villeggianti, si trasferiscono<br />
nelle stalle-fienile e nelle alpi.<br />
Ma, in genere, solo poche località nelle quali si concentra l’affluenza turistica<br />
hanno beneficiato in modo sensibile; sono soprattutto quelle dove non solo si ha<br />
un turismo estivo di svago, ma anche un turismo invernale per sport. Tali, ad<br />
esempio, Madèsimo nell’alta valle San Giacomo, Bormio nell’alta Valtellina, Aprica<br />
tra la Valtellina e la Valcamònica, Pontedilegno nell’alta Valcamònica, Fòppolo<br />
nell’alta valle del Brembo, dotati di funivie, seggiovie e sciovie, oltre che di una<br />
attrezzatura sportiva specializzata, come trampolini di salto, ecc.<br />
Con il turismo di massa, anche nei centri pedemontani e della pianura si è<br />
determinato un movimento estivo di proporzioni notevolissime ; esso è motivato<br />
anzitutto da necessità di transito, ma è indubbiamente ravvivato dal richiamo dei<br />
numerosi monumenti artistici. Milano, Como, Brescia, Bergamo, Mantova vedono<br />
ogni estate folle di turisti, in cui prevalgono gli stranieri, animare le strade assolate<br />
disertate dai locali. Caratteristico a questo riguardo appare il Sagrato della Piazza<br />
del Duomo di Milano, frequentato quotidianamente da un incalcolabile numero di<br />
turisti frettolosi. Infatti la sosta sia a Milano sia nelle altre città di pianura è di solito<br />
breve, di poche ore о tutt’al più di pochissimi giorni. Tuttavia il movimento complessivo<br />
finisce con l’assumere un significato economico non trascurabile.<br />
Per Milano vi è anche da tener presente un aspetto particolare del turismo, ossia<br />
quello connesso con manifestazioni commerciali. In particolare, durante le due settimane<br />
di aprile in occasione della Fiera campionaria l’afflusso giornaliero di visitatori,<br />
per la maggior parte della provincia, delle città lombarde e dell’Italia settentrionale,<br />
può calcolarsi in centinaia di migliaia e nei giorni festivi addirittura di più<br />
di mezzo milione.<br />
In conclusione, quindi, il turismo in <strong>Lombardia</strong> può considerarsi in fase crescente<br />
e già considerevole. Esso si manifesta in forme diverse per i motivi che lo<br />
determinano e con intensità variabile nel tempo a seconda dei luoghi: nell’àmbito<br />
della montagna vi è un turismo di svago durante l’estate e un turismo sportivo<br />
durante l’inverno; sui laghi, dove da tempo si verifica la massima concentrazione,<br />
il turismo ha durata ininterrotta dalla primavera all’autunno; nella pianura, infine,<br />
vi è un turismo estivo, prevalentemente di transito, per richiamo artistico e culturale.<br />
404
C a p i t o l o D o d i c e s i m o<br />
ATTRAVERSO LE TERRE LOMBARDE<br />
Il Milanese e il Lodigiano.<br />
Se, nelle pagine che precedono, notizie e considerazioni di ordine generale relativamente<br />
ai problemi che distinguono nel suo assieme il territorio lombardo hanno<br />
prevalso (e ciò a causa del significato che i problemi stessi hanno nel quadro regionale<br />
e nazionale), si vuol qui porre riparo cercando di delineare in breve le caratteristiche<br />
e gli elementi che danno un’impronta particolare alle diverse parti e regioni<br />
precedentemente distinte nell’àmbito della <strong>Lombardia</strong>.<br />
E par giusto, in questa successione di quadri che compongono l’armonioso<br />
assieme, dar la precedenza al Milanese che, per la presenza della metropoli (cui<br />
son dedicate alcune pagine del capitolo seguente), ha sentito più vibrante le sollecitazioni<br />
a quel ritmo e a quelle forme di vita che distinguono il capoluogo lombardo<br />
da ogni altra città d’Italia. L ’infiusso del capoluogo è qui più sensibile che altrove,<br />
nè, data la vitalità dello stesso e la sua vicinanza, potrebbe essere altrimenti. Nel<br />
contempo, però, i requisiti più tipici di cui la natura ha dotato il territorio del<br />
Milanese non sono stati obliterati daU’impeto innovatore dell’opera umana, talché<br />
mentre chi da Milano si diriga verso l’alta pianura fatica a distinguere dove cessi<br />
la metropoli, per i tentacoli che allacciano l’un l’altro i centri e per gli opifici che<br />
questi attorniano quasi anelli di un’unica ininterrotta catena, chi invece lascia la<br />
città per la bassa s’interna, pochi chilometri fuori dalla cerchia delle mura spagnole,<br />
in un paesaggio geórgico che l’opera umana ha trasformato per più alti rendimenti,<br />
ma non distrutto. Si può dire che nel Milanese si possa aver rivelazione in poco<br />
spazio della saggia opera che l’uomo ha svolto anche nel territorio lombardo, plasmandolo<br />
nella forma meglio rispondente alle condizioni d’ambiente. In complesso,<br />
405
dunque, il Milanese dal Ticino all’Adda può essere distinto in due parti tra loro<br />
dissimili; la parte dell’alta pianura, industriale, fitta di città e di opifici, la parte<br />
della bassa, agricola, con radi borghi e grandi corti; l’una dall’altra distinta dal limite<br />
superiore dei fontanili. Volti diversi, ma ugualmente animati da un’intensa vita.<br />
La bassa pianura milanese è dominio della marcita, che verso il Pavese cede a<br />
poco a poco alla risaia. I verdi riquadri di prato rigoglioso, cinti dai fossatelli colmi<br />
delle acque tiepide dei fontanili (da cui visibilmente si leva nelle fredde giornate<br />
invernali il vapore che contribuisce a render brumosa l’atmosfera milanese), iniziano<br />
ai margini meridionali della metropoli.<br />
Fot. Stefani<br />
406<br />
L ’Abbazia di Chiaravalle.
Fot. Fotocielo<br />
Veduta aerea di Melzo.<br />
A ll’Abbazia di Chiaravalle, a cinque chilometri da Porta Romana, ebbe inizio tal<br />
tipo di coltura otto secoli or sono ed essa ancora predomina. L ’antico monumento,<br />
il più notevole dei dintorni della città, sorge sul luogo del cenobio fondato nel 1135<br />
da San Bernardo, abate di Clairvaux (da cui il nome di Chiaravalle). I Cistercensi<br />
oltre ad erigere e ad abbellire l’Abbazia (1172-1221) da cui furono cacciati nel 1789,<br />
curarono per secoli la bonifica della campagna circostante. Dopo i danni recati dai<br />
furori rivoluzionari di fine Settecento e l’incuria di un secolo e mezzo, l’antico monastero,<br />
restaurato con il ritorno dei frati (1953), ha ricuperato di recente parte della<br />
sua antica bellezza architettonica che scaturisce dall’armoniosa fusione del gotico<br />
con elementi lombardi. Non è tuttavia quello di Chiaravalle l’unico vestigio lasciato<br />
dai religiosi nella bassa milanese. Lungo il Naviglio di Bereguardo, a sud di Abbiategrasso,<br />
sorge la bella Abbazia di Morimondo fondata un anno dopo quella di<br />
407
Ghiaravalle dai Cistercensi di Morimond (Francia), che si resero benemeriti nella<br />
trasformazione agricola della zona. Più volte saccheggiata nel corso dei secoli, venne<br />
restaurata nel 1950, ricuperando una parte modesta del suo antico splendore. Lungo<br />
la Via Emilia, nei pressi di San Giuliano Milanese, rimane l’Abbazia di Viboldone,<br />
fondata dagli Umiliati nel secolo XII ed edificata nei secoli seguenti, la cui chiesa,<br />
in cotto, associa in bella armonia elementi strutturali del romanico e del gotico.<br />
Lungo la strada Vigentina, presso Noverasco, sorge l’Abbazia di Mirasole, pure<br />
fondata dagli Umiliati nel secolo XII ; ma per lungo abbandono, ha perso gran parte<br />
del suo pregio.<br />
La pingue uniformità della bassa è interrotta dalle grandi arterie di traffico lungo<br />
le quali s’incontrano i centri maggiori, alcuni dei quali di antica origine, tradizionalmente<br />
agricoli e attualmente in via di evoluzione verso l’industria. Sulla Padana,<br />
a 26 km. da Milano, ecco Magenta (12.453 ab.), stazione fondata dagli Insubri,<br />
colonia romana, fortezza medioevale, feudo poi dei Melzi di Milano. Il 4 giugno<br />
1859, attorno all’ancor piccolo centro, si svolse la cruenta ma vittoriosa battaglia,<br />
che determinò il ritiro delle truppe austriache da Milano e dalla <strong>Lombardia</strong>. Pur<br />
non perdendo le sue prerogative tradizionali. Magenta nel nostro secolo ha visto<br />
sorgere notevoli industrie quali quelle dei fiammiferi, della seta artificiale, delle<br />
materie plastiche, delle serrature, ecc. Lungo la strada per Mortara si trova Abbiategrasso<br />
(14.525 ab.), grosso centro agricolo sorto attorno al castello medioevale<br />
(1382) e alla bella basilica rinascimentale di Santa Maria Nuova. Sulla Via Emilia,<br />
si susseguono diversi abitati tra i quali notevole Melegnano (10.806 ab.), l’antica<br />
Marignano, fortezza eretta dai Visconti lungo il corso del Lambro, celebre campo<br />
Monza: la Villa Reale.<br />
Fot. Fotocielo<br />
408
Fot. Fotocielo<br />
L ’Autodromo di Monza con l’anello a curve sopraelevate per alte velocità.<br />
della «battaglia dei giganti» (1515) tra le truppe di Massimiliano Sforza e Francesco<br />
I di Francia. Attualmente accoppia, alle sue tradizionali funzioni agricole,<br />
uno sviluppo industriale notevole per prodotti chimici e metallurgici. Presso il tratto<br />
della Padana Superiore che bordeggia il Naviglio della Martesana s’incontrano Melzo<br />
(8114 ab.) che, con Gorgonzola (5948 ab.), vanta notevoli industrie casearie.<br />
L ’alta pianura milanese è tutto un seguito di centri assai più popolosi di quelli<br />
della bassa. Emergono tra essi Monza e Sesto, quella collegata a questa e questa<br />
a sua volta collegata a Milano da sobborghi lineari disposti lungo l’antica arteria<br />
lunga una decina di chilometri. Monza, che, fatte le debite proporzioni, qualche<br />
scrittore ha chiamato la Versailles di Milano, è città di antica origine; la tradizione<br />
la vuole fondata dagli Insubri e sede, con il nome di Madida, di veterani provenienti<br />
da Magonza. Cominciò ad avere importanza con i Longobardi, la cui regina<br />
409
Teodolinda avrebbe avuto particolare predilezione scegliendola come dimora estiva.<br />
Divenuta Comune, spesso ostile a Milano, con i Visconti entrò a far parte del<br />
ducato e cinta di mura e torri. A ll’epoca dell’unità d’Italia era già una florida cittadina<br />
di 24.662 ab., quasi triplicatisi di numero in meno di un secolo (63.625 nel 1951).<br />
L ’attività economica presenta aspetti molteplici; nel complesso prevale l’industria<br />
e il commercio, ma « la popolazione in generale è di tendenze conservatrici più<br />
vicine alla forma mentis dell’artigianato e dell’agricoltore brianteo che non alla mentalità<br />
più spregiudicata del cittadino milanese o, se il confronto con la metropoli<br />
non regge, di quello della vicina, industrialissima Sesto » (G. M. Rulli).<br />
Questa osservazione, rispondente al vero, non è esclusiva tuttavia di Monza,<br />
ma vale per tutte le cittadine di questa popolosa plaga e ciò è « almeno in parte<br />
spiegabile con la gradualità della trasformazione dell’attività artigiana in quella industriale<br />
che si è inserita quasi naturalmente nella vita del luogo ». Le industrie monzesi,<br />
in prevalenza piccole e medie, sono varie: tessili, meccaniche, del legno e,<br />
tradizionali ma assai decadute, del cappello. Non si può però far a meno di sottolineare<br />
anche l’importanza artistica di Monza; anzitutto notevole è il Duomo edificato<br />
nel secolo IV per volontà della regina Teodolinda, ricostruito poi nel secolo XIII<br />
e riadattato nei secoli XVI e XVIII ; bellissima è la facciata marmorea, opera di Matteo<br />
da Campione, che vi dedicò la sua opera per diversi anni verso la fine del X IV secolo;<br />
di data posteriore è il campanile eretto su disegno del Pellegrini (secolo XVII).<br />
L ’interno è ricco di pregevoli opere d’arte, ma la maggiore attrazione è costituita<br />
dalla Corona ferrea, custodita nella Cappella di Teodolinda. L ’aurea Corona tempestata<br />
di gemme, ma detta ferrea perchè secondo la tradizione l’anello interno sarebbe<br />
forgiato con un chiodo della croce di Cristo, costituisce, oltre che un’opera di antichissima<br />
oreficeria, una curiosità storica, poiché dal Medioevo in poi fu usata per<br />
incoronare i re d’Italia, da Berengario a Napoleone. Di grande interesse e valore<br />
artistico e storico è anche il tesoro custodito nella sagrestia del Duomo stesso. Altri<br />
monumenti notevoli di Monza sono la Cappella Espiatoria fatta erigere sul luogo<br />
del regicidio di Umberto I (29 luglio 1900) e soprattutto la grandiosa Villa Reale,<br />
fatta edificare da Ferdinando d’Austria tra il 1777 e il 1780 su disegno del Piermarini<br />
e fastosamente decorata da insigni pittori lombardi. Nel grandioso complesso<br />
si trovano la Civica Galleria d’Arte, il Museo storico e la Biblioteca italiana per<br />
ciechi con oltre 30.000 volumi in ogni lingua. Dietro la Villa vi è il vastissimo Parco<br />
(800 ha.), attraversato dal Lambro e recinto da un muro di 12 chilometri. In una<br />
parte del Parco sono stati costruiti l’Autodromo (1922) e l’Ippodromo detto di M irabello<br />
(1925); inoltre vi è un campo di golf. Particolarmente notevole è l’Autodromo,<br />
rinnovato nel 1955, formato da due piste (5750 e 4250 m.), di cui quella veloce con<br />
curve sopraelevate che permettono velocità sino a 260 km. orari. Annualmente vi<br />
si tengono importanti manifestazioni automobilistiche e motociclistiche d’interesse<br />
internazionale.<br />
Sesto San Giovanni è una città eminentemente industriale; ancora verso la metà<br />
dello scorso secolo era un borgo di poche case con qualche dimora di villeggiatura<br />
4 10
Sesto San Giovanni: gli impianti industriali della Falck.<br />
estiva e qualche filanda (oggi scomparsa); poi, quasi in sordina, vi si insediarono<br />
altre piccole industrie, una dozzina, sinché agli inizi del nostro secolo sorsero<br />
quattro grandi impianti metalmeccanici che diedero e danno un carattere proprio<br />
a Sesto: la Ernesto Breda, quivi trasferita da Milano nel 1903, la Ercole Marelli,<br />
pure trasferita da Milano nel 1905, la Gamona, antica fabbrica milanese che prese<br />
poi il nome di O. S. V. A., anch’essa trasferita qui nel 1906 e, infine, le Acciaierie e<br />
Eerriere Lombarde Ealck pure qui trasferite nel 1906. Accanto a queste grandi,<br />
il numero delle medie e piccole industrie andò crescendo di anno in anno sino a<br />
costituire un aggregato di 468 aziende, con un totale di oltre 30.000 addetti (1951).<br />
Di conseguenza il centro, che all’inizio del secolo annoverava appena 7000 ab.,<br />
nel 1951 ne contava 41.941, per il prender dimora, presso le industrie in cui erano<br />
addetti, di lavoratori provenienti dal Bergamasco, dal Bresciano, dalla Brianza e da<br />
altre località lombarde, venete, emiliane, ecc. Popolazione, quella di Sesto, di com-<br />
411
posizione molto eterogenea, caratteristica anche di altri centri industriali, ma qui<br />
in una forma più accentuata che altrove. Il numero di lavoratori oggi residenti in<br />
luogo non basta a saturare l’offerta di lavoro: perciò ai 15.000 addetti all’industria<br />
che abitano in luogo si aggiungono altri 15.000 lavoratori provenienti, per lo più<br />
con trasferimento quotidiano, da altre località. « Le località di afflusso della mano<br />
d’opera sono concentrate nel Bergamasco, nel Bresciano e nel Lodigiano, mentre<br />
è minore l’afflusso da quelle parti della <strong>Lombardia</strong> dove sorgono notevoli centri<br />
industriali come Rho, Busto Arsizio, Legnano, ecc., о dalle località briantee dove<br />
prospera l’industria del mobile » (G. M. Rulfi).<br />
Quello che, con precedenza di tempo, si è verificato sulla direttrice da Milano<br />
a Monza, si sta verificando — sebbene, almeno per ora, in misura assai minore —■<br />
anche sulla direttrice da Milano a Rho. Il Comune di Pero, che, sulla strada del<br />
Sempione, si stende intermedio tra la metropoli e Rho, sembra destinato a un notevole<br />
sviluppo industriale con una preminenza nel campo della raffineria dei petroli;<br />
infatti, al grandioso impianto della Condor, alimentato direttamente da un oleodotto<br />
proveniente da Genova, si vanno affiancando nuovi impianti (Shell, Rondine,<br />
Pibigas, ecc.) presagio di futuro sviluppo; se qualche perplessità può sorgere ancora<br />
per le emanazioni sgradevoli disperse nell’aria (che, in particolari condizioni meteorologiche,<br />
investono anche la metropoli), è facile tuttavia presumere l’eliminazione<br />
futura degli inconvenienti e la continuità dello sviluppo industriale della zona,<br />
avvantaggiata particolarmente dalla prossimità di Milano e da una fitta rete di<br />
comunicazioni. Rho, cittadina di antica origine, sede di moderne industrie e importante<br />
nodo ferroviario, potrebbe in tal caso essere paragonata, in piccolo, a Monza,<br />
ossia quale anello di congiunzione tra la metropoli e i centri più settentrionali. La<br />
cittadina ha visto nel volgere di un ventennio raddoppiare la sua popolazione e<br />
attualmente conta oltre 20.000 ab. (18.381 nel 1951). Essa nel campo dell’arte vanta<br />
un bel santuario voluto da San Carlo Borromeo (1584), alla cui erezione prestarono<br />
la loro opera artisti come il Pollale e il Pellegrini.<br />
Nella innumerevole serie di centri dell’alta pianura meritano anzitutto citazione<br />
Legnano, Busto Arsizio e Gallarate, tutti sulla strada del Sempione e associati dalla<br />
medesima preminenza nell’industria del cotone. La celebrità di Legnano è però<br />
anzitutto storica: quivi il 29 maggio 1176 avvenne la famosa vittoria dei Comuni<br />
della Lega Lombarda, stretti attorno al Carroccio, sul Barbarossa, e l’avvenimento,<br />
oltre che eternato nel monumento del Butti (1900), è ricordato ogni anno con una<br />
sagra. La città (38.003 ab.), a 27 km. da Milano, costituisce oggi uno dei centri<br />
industriali più notevoli di <strong>Lombardia</strong> e, oltre le industrie tessili, vanta il grandioso<br />
impianto metalmeccanico della Tosi. Busto Arsizio, distante 3 km. da Legnano, pur<br />
essendo inclusa dal 1927 nella provincia di Varese, geograficamente e storicamente<br />
fa parte del Milanese. La stessa cosa vale anche per Gallarate. Busto, d’incerta<br />
ma sicuramente antichissima fondazione, borgo fiorente nell’arte del tessere (lino,<br />
seta) sin dal secolo XVI, è divenuta dal Settecento il centro all’avanguardia nella<br />
lavorazione del cotone. La città, posta al margine dell’arida brughiera (da cui.<br />
4 12
secondo una tradizione, le venne il nome), ha una popolazione di 48.000 abitanti<br />
(bustocchi) e il loro numero è in continuo aumento. Nel campo artistico vanta, oltre<br />
il duomo del secolo XVII, la bella chiesa di Santa Maria di Piazza, gioiello semplice<br />
e armonioso dell’arte rinascimentale, che custodisce affreschi di Gaudenzio<br />
Ferrari e di Bernardino Luini. Gallarate, a 9 km. da Busto Arsizio, ormai al<br />
margine delle colline, là dove la strada per Varese si stacca da quella del Sempione,<br />
è un centro di origine gallica e borgo medioevale fortificato del contado del<br />
Seprio. Lo sviluppo industriale, specialmente cotoniero, ha conferito un aspetto<br />
moderno alla cittadina attuale, che conta 30.000 abitanti. Tra i suoi monumenti<br />
d’arte merita di essere ricordata la chiesa romanica di San Pietro del secolo XII.<br />
Anche Saranno, per quanto in provincia di Varese, gravita nell’orbita di Milano.<br />
La fiorente cittadina sorge lungo il corso della Lura, là dove il torrente esce dalla<br />
zona collinare, all’incracio di numerose strade; antico mercato e borgo agricolo,<br />
ha tratto grande vantaggio dalla costruzione delle Ferrovie Nord che ne hanno fatto<br />
Fot. Fotocielo<br />
г ~<br />
Veduta<br />
di Saronno.<br />
413
il nodo più importante della loro rete; divenuta nel nostro secolo centro di industrie<br />
(tipica quella dell’amaretto), ha visto lentamente accrescersi il numero dei suoi abitanti<br />
sino a raggiungere i 20.000 nel 1951. In prossimità dell’abitato sorge il celebre<br />
santuario della Madonna dei Miracoli, che fu eretto, in stile bramantesco, a ricordo<br />
di una miracolosa guarigione avvenuta nel 1447. Nell’interno si ammirano celebri<br />
affreschi, tra i quali il Concerto degli angeli, grandiosa opera di Gaudenzio Ferrari,<br />
e alcuni capolavori di Bernardino Luini.<br />
Dalla Dura all’Adda l’alto Milanese è costellato di cittadine, dall’aspetto sempre<br />
più industriale e sempre meno rurale. Tra le notevoli meritano un cenno Desio<br />
(14.600 ab.) che deve la sua maggior fama all’aver dato i natali ad Achille Ratti,<br />
papa con il nome di Pio XI dal 1922 al 1939; bissone (16.551 ab.), centro preminente<br />
nella lavorazione del mobile, sede di una scuola di specializzazione di disegno<br />
e intaglio del legno e di una biblioteca di opere sul mobile e sull’arredamento;<br />
La periferia di Lodi: veduta invernale.<br />
Fot. Stefani<br />
414
Fot. Stefani<br />
Sant’Angelo Lodigiano: il castello.<br />
Seregno (22.661 ab.) centro di industrie meccaniche, tessili e del legno, e poi Sèveso<br />
(7524 ab.). Meda (10.276 ab.), Vimercate (7216 ab.), ecc.<br />
Il Lodigiano, compreso tra l’Adda e il Lambro, dai quali riceve il beneficio delle<br />
acque, conserva il pingue volto agricolo della bassa Milanese; questa sfuma in quello<br />
insensibilmente, ma, a poco a poco, l’impronta di una più moderna opera di trasformazione<br />
agraria offre all’occhio esercitato variazioni di un motivo comune a<br />
tutta la pianura. Amministrativamente il Lodigiano fa parte della provincia di<br />
Milano, quasi appendice di questa sino al Po; ma i legami tra Lodi e Milano, tra<br />
il Lodigiano e il Milanese non appaiono per altri aspetti molto differenti da quelli<br />
tra Milano e le altre terre nel raggio d’influenza della dominante metropoli.<br />
La città di Lodi non sorge sul luogo della romana Laus Pompeia, così chiamata<br />
in onore di Pompeo Strabono; questa, divenuta importante municipio romano, fu<br />
distrutta da Milano nel 115 1, e sulle rovine, di cui ancora si conservano le vestigia,<br />
sorse un modesto villaggio oggi chiamato Lodi Vecchio (3192 ab.).<br />
La città nuova fu edificata nel 1158, per volere del Barbarossa, sei chilometri<br />
ad oriente dell’antica, presso la sponda destra dell’Adda e acquistò rapidamente<br />
nuova importanza. Fu aggregata poi con il suo territorio nel Ducato di Milano<br />
seguendone le sorti. Durante la dominazione austriaca fu per vario tempo capo-<br />
41S
Caratteristico aspetto primaverile nella regione a risaia.<br />
Fot. Stefani<br />
luogo di provincia e nel i860 entrò a far parte della provincia di Milano. La pianta<br />
della città, a strade incrociantesi più о meno perpendicolarmente, ha il suo centro<br />
nella Piazza della Vittoria, cinta di portici e dominata dal duomo costruito a cominciare<br />
dall’anno di fondazione della città e rimaneggiato più volte nei secoli seguenti.<br />
Ma il gioiello artistico di Lodi è l’Incoronata, celebre santuario rinascimentale<br />
costruito nel secolo XV su disegno del Battagio, allievo del Bramante. A nord la<br />
città si affaccia all’Adda presso il cui ponte il io maggio 1796 si svolse la battaglia<br />
che diede a Napoleone il possesso della <strong>Lombardia</strong>. L ’abitato si espande sugli altri<br />
tre lati, dove le abitazioni si alternano alle industrie. Per l’incremento di queste lo<br />
sviluppo della città è aumentato soprattutto in anni recenti. La popolazione del<br />
nucleo urbano nel 1951 assommava a 29.231 abitanti. Tra le industrie è preminente<br />
quella dei latticini, di cui è espressione la Fiera nazionale del latte che si<br />
tiene annualmente ; notevoli sono anche le industrie tessili (canapa-lino) e le<br />
industrie varie che la scoperta dei vicini giacimenti metaniferi ha richiamato in<br />
luogo. Ma l’attività ancora predominante del Lodigiano è l’agricoltura, dedita particolarmente<br />
ai foraggi e ai cereali; tale carattere agricolo conserva ancora la maggior<br />
4 16
parte dei borghi disseminati nel fertile piano, per quanto i maggiori, quali.<br />
San Colombano al Lambro (5504 ab.), Sant’Angelo Lodigiano (8694 ab.), Casalpusterlengo<br />
(8059 ab.), già vadano arricchendosi di moderni impianti industriali.<br />
Il Pavese, la Lomellina e POltrepò.<br />
Attraversato a mezzo dal Po verso cui corre a confluire il Ticino, il territorio<br />
assegnato alla provincia di Pavia è dal corso degli stessi fiumi distinto in tre parti:<br />
del Pavese p. d., della Lomellina e dell’Oltrepò pavese. Di esse, la parte che<br />
manifesta caratteristiche più propriamente lombarde è il Pavese, adiacente al territorio<br />
milanese e lodigiano; per contro, in Lomellina per mille segni si avverte<br />
l’influsso piemontese e nell’Oltrepò, oltre che piemontese, l’influsso emiliano. In<br />
posizione intermedia ai tre territori, sta Pavia, centro anche di attrazione e di<br />
coordinamento.<br />
Il Pavese, disteso lungo il Ticino e il Lambro, percorso dai Navigli di Pavia e di<br />
Bereguardo, ricco di acque fluenti dai fontanili, è una zona di prospera agricoltura,<br />
con caratteristiche di transizione tra l’area spiccatamente foraggera del Lodigiano<br />
e quella precipuamente risicola della Lomellina, e di tal fatto si ha anche visibile<br />
prova attraversando il territorio, fitto, nella parte più interna, di estese risaie. Vaste<br />
sono le proprietà fondiarie, vaste le corti che s’intercalano tra radi e piccoli borghi.<br />
Tra i centri degni di nota Miradolo (2521 ab.), stazione idrotermale di acque salsobromo-iodiche,<br />
e Beigioioso (4068 ab.) dominato dall’imponente castello, eretto forse<br />
da Galeazzo II Visconti, dove soggiornarono Francesco I prigioniero, e, più tardi.<br />
Parini e Foscolo. Ma il luogo del Pavese che gode gran fama per i tesori d’arte,<br />
che richiamano folle di turisti, è la Certosa di Pavia, che sorge a una decina di chilometri<br />
dal capoluogo. Il monumento, iniziato nel 1396 per volontà di Gian Galeazzo<br />
Visconti, che vi ebbe sepoltura, riassume in sè le esperienze rinascimentali lombarde:<br />
la chiesa, dalla mirabile facciata in marmi policromi, con il piccolo chiostro, dall’agile<br />
eleganza, il grande chiostro, aperto e severo, costituiscono un assieme tra i<br />
più suggestivi della <strong>Lombardia</strong>.<br />
La Lomellina, estremo lembo della <strong>Lombardia</strong> verso occidente, si presenta come<br />
un vasto piano, leggermente mosso qua e là da dossi (o sabbioni) appiattiti dall’opera<br />
di trasformazione agraria iniziata nel Medioevo da ordini religiosi e continuata<br />
nei secoli sino ad anni recenti. Ricchissima delle acque dei suoi fontanili, che qui<br />
si espandono in una fascia larga oltre 25 km., dei suoi fiumi, che la cingono<br />
(Ticino e Sesia) о l’attraversano (Agogna e Terdoppio), e dei fossi di derivazione<br />
del Canale Cavour, essa costituisce la zona di più intensa coltivazione risicola della<br />
<strong>Lombardia</strong>. Quivi la coltivazione del prezioso cereale fu introdotta verso il secolo XV,<br />
trovando un ambiente favorevole per l’estensione delle aree acquitrinose e per la<br />
2 7 — Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
417
prevalenza della grande proprietà nobiliare. Gli acquitrini sono scomparsi in seguito<br />
a bonifica, la risaia stabile è stata trasformata in risaia avvicendata, la proprietà si<br />
è conservata invece di grandi dimensioni, come grandi dimensioni conservano le<br />
corti. Ovviamente, se il riso costituisce un tipico prodotto della Lomellina, non è<br />
neppure l’unico; per il fatto stesso dell’avvicendamento notevoli sono le produzioni<br />
di foraggio, di frumento e di ortaggi.<br />
Teatro di notevoli vicende storiche (tra l’altro campo di grandiose battaglie, da<br />
quella del 218 a. C. tra Annibaie e Scipione a quella del 1859 tra Piemontesi e<br />
Austriaci a Palestre) la Lomellina annovera centri di antica origine e di notevole<br />
importanza storica e artistica, quali, ad esempio, Lomello, da cui ebbe nome la<br />
regione. Tra essi, di maggior sviluppo attuale sono Vigévano e Mortara, entrambe<br />
nella parte settentrionale del territorio lomellino.<br />
Vigévano, antico castrum romano, comune autonomo medioevale, cittadina fortificata<br />
durante il Rinascimento, centro in rapido sviluppo industriale in epoca<br />
moderna, conserva nella sua struttura, tipicamente radiale, le testimonianze del suo<br />
evolversi in tempi successivi. Il centro è costituito dalla rettangolare Piazza Ducale,<br />
a eleganti portici, che fu ideata da Leonardo verso il 1494. Su di essa si affacciano<br />
la bramantesca Torre del Castello e il Duomo di stile barocco. Oltre il limite del-<br />
La Certosa di Pavia vista dall’aereo.<br />
Fot. Enit<br />
4 18
Vigevano: la Torre del Castello e la Piazza Ducale<br />
ot. Stefani
Sartirana Lomellina : ii<br />
castello.<br />
Fot. Sef<br />
l’antica linea fortificata si espande la città moderna con le sue notevoli industrie,<br />
quali quelle delle calzature (di cuoio e di gomma), della tessitura del cotone, della<br />
concia delle pelli, ecc., che hanno sostituito quella della lavorazione della seta un<br />
tempo floridissima. L ’aumento della popolazione è stato sensibile: nel volgere di<br />
mezzo secolo è raddoppiata raggiungendo nel 1951 i 37.000 ab. nel solo aggregato<br />
urbano.<br />
Mortara, sorta nel luogo d’incrocio d’antiche strade, conserva ancor oggi un<br />
ruolo notevole come nodo di comunicazioni. Nel corso dei secoli subì più volte<br />
assedi e saccheggi, che tuttavia non ebbero potere di cancellare nella topografla cittadina<br />
lo schema dell’antica struttura. Anch’essa, come Vigévano, fu castrum romano<br />
e città murata medioevale; anch’essa, in epoca recente, va estendendosi di pari passo<br />
con lo sviluppo delle industrie. Nel 1951 la popolazione dell’aggregato urbano era<br />
di 10.000 abitanti.<br />
420
L ’Oltrepò pavese si stende dalla sponda destra del Po a guisa di un triangolo<br />
che, incuneandosi tra i territori delle province di Piacenza e di Alessandria, risale<br />
con un vertice sino allo spartiacque appenninico. Vi si possono quindi distinguere<br />
una fascia di pianura, che dolcemente discende al corso del Po, un’area di<br />
collina dai morbidi profili e una ristretta zona di montagna che non manca di scorci<br />
pittoreschi. L ’attività rurale predomina ovunque, ma con diverse caratteristiche colturali:<br />
prevalgono i cereali nella pianura, i vigneti nella collina, i boschi e i pascoli<br />
nella montagna. Nel complesso dunque un paesaggio molto vario in breve spazio,<br />
che trova tuttavia continuità nei territori delle province subappenniniche adiacenti.<br />
Del resto si può aggiungere che questo dell’Oltrepò è geograficamente il meno lombardo<br />
dei territori delle province che della <strong>Lombardia</strong> fanno parte; da notare che<br />
gli stessi abitanti, se interrogati, rimangono perplessi della loro qualifica di lombardi.<br />
Voghera (26.587 ab.), presso la Stàffora, è il capoluogo dell’Oltrepò. La città<br />
ha antiche origini ed il suo nome moderno deriva da quello del villaggio medioevale<br />
Vicus Iriae. Dopo il Trattato di Worms (1743) fu assegnata al Piemonte cui rimase<br />
aggregata sino al 1859. La sua importanza quale mercato agricolo si è conservata<br />
nel tempo, associata di recente a un promettente sviluppo industriale nel campo<br />
alimentare, tessile e meccanico, in ciò agevolata dalla sua posizione lungo le arterie<br />
ferroviarie e stradali sulle quali si convoglia il traffico da Milano e da Piacenza<br />
verso Genova.<br />
Lungo il margine tra la collina e la pianura, vi sono, oltre Voghera, altri centri,<br />
alcuni particolarmente noti per l’industria enologica, come Casteggio (3730 ab.).<br />
Proni (6421 ab.) e Strabella (7965 ab.), tutti in fase di aumento di popolazione e di<br />
sviluppo industriale. Per contro i centri della collina, ancorati all’economia rurale,<br />
sono per lo più poco popolosi e alcuni soggetti anche ad un esodo, seppure contenuto,<br />
degli abitanti; tra i maggiori Montaldo Pavese (508 ab.) e Godiasco (980 ab.).<br />
Numerose le località di interesse storico о artistico e di villeggiatura; tra queste si<br />
può annoverare Sàlice Terme, ridente stazione termale, con alberghi e ville disseminati<br />
tra il verde, di notevole richiamo estivo.<br />
Il Cremonese e il Cremasco.<br />
Il territorio della provincia di Cremona, compreso all’incirca tra Г Adda e l’Oglio,<br />
i quali delimitano una fascia di pianura allungata dalla zona dei fontanili fino al Po,<br />
può essere diviso nel Cremonese e nel Cremasco, con incerta distinzione dell’uno<br />
dall’altro a mezza via tra Soresina e Castelleone.<br />
Il Cremasco si stende nel lembo settentrionale di un’area anticamente coperta in<br />
parte dal velo di acque di un’estesa palude, il lago Gerundo, e in parte da boschi,<br />
entrambi scomparsi con lenta opera di trasformazione, che, iniziata in antico dagli<br />
4 2 1
ordini religiosi, si completò dopo l’unità nazionale, agevolando Г insediamento rurale.<br />
La zona è oggi caratterizzata da una fiorente attività agricola, rivolta particolarmente<br />
alla produzione frumentaria e foraggera. Numerosi i borghi rurali e i villaggi, tra<br />
i quali sono disseminate dimore dal tipico portico antistante.<br />
Crema (17.603 ab.), sorta forse già fin da epoca etrusca sopra un vasto isolotto<br />
emergente dal lago Cerando, divenne una fortezza romana e poi libero comune<br />
medioevale alleato di Milano contro Lodi, Cremona e Como. Nel 1160, dopo una<br />
epica resistenza, fu rasa al suolo dal Barbarossa. Risorse pochi lustri appresso, passò<br />
ai Visconti, agli Sforza e, infine, nel 1449 alla Repubblica veneta, sotto cui rimase<br />
per due secoli e mezzo, che furono tra i più floridi della vita della città, divenuta<br />
mercato agricolo importante. A questa sua caratteristica predominante, il nostro<br />
secolo va aggiungendo quella industriale, soprattutto nel ramo caseario e alimentare.<br />
La città attuale ha struttura irregolarmente radiale, ha il suo centro nella Piazza del<br />
Duomo cinta da portici e dominata dalla bella cattedrale romanico-gotica (secolo XIII)<br />
opera dei maestri comacini. Ma il gioiello artistico più prezioso di Crema è, appena<br />
fuori dalla città. Santa Maria della Croce, santuario in stile bramantesco di straordinaria<br />
grazia e armonia.<br />
Crema nel 1599. Stampa dell’epoca.<br />
(Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano).<br />
422
Il Cremonese si stende nella parte meridionale,<br />
ancor più florido del Cremasco<br />
nell’agricoltura e nell’allevamento. I suoi<br />
terreni omogenei e naturalmente umidi<br />
hanno favorito le colture del frumento,<br />
del granoturco, del foraggio, del lino, della<br />
canapa. E qui che si ottengono i più alti<br />
redditi unitari di frumento non solo della<br />
<strong>Lombardia</strong> ma dell’ Italia, con massimi<br />
anche oltre i 6o quintali per ettaro. Nella<br />
pingue pianura sono disseminati innumeri<br />
villaggi e agglomerati costituiti da corti,<br />
tra i quali s’intercalano borghi più popolosi,<br />
resi tali per lo più dalla loro posizione<br />
lungo le vie di maggiore traffico. Ecco<br />
Soresina (9108 ab.) centro di importanti industrie<br />
casearie, e Casalbuttano (4165 ab.)<br />
sulla strada tra Crema e Cremona; Pizzighettone<br />
(3578 ab.), diviso in due dal<br />
corso dell’Adda e tuttora cinto da antichi<br />
bastioni a pianta stellare, sulla strada tra<br />
Codogno e Cremona; Piàdena (3617 ab.)<br />
all’incrocio di strade e di ferrovie tra Cremona<br />
e Mantova e tra Brescia e Casalmaggiore.<br />
Ma qui, nella parte inferiore<br />
della pianura racchiusa tra l’Oglio e il Po,<br />
suddivisa bizzarramente tra la provincia di<br />
Cremona e quella di Mantova, il quadro<br />
ambientale muta. Le acque di piena traboccanti<br />
dai due fiumi hanno per lungo tempo<br />
costituito un’insidia, mutando larghe superfici<br />
in acquitrini, che solo da poco tempo<br />
Fot. Stefani<br />
Crema: l’arco del Torrazzo,<br />
a destra il Duomo.<br />
sono stati annullati con un’importante bonifica; ora si attuano coltivazioni di foraggi<br />
e di barbabietola da zucchero. La fascia che accompagna i corsi fluviali accoglie i<br />
centri più popolosi. Oltre Piàdena, vi è lungo l’Oglio (ma già in provincia di Mantova)<br />
Bòzzolo (4009 ab.), antico principato del ramo cadetto dei Gonzaga, e sul Po,<br />
oltre Casalmaggiore (5656 ab.), sede di un importante zuccherificio. Viadana (5587 ab.)<br />
già feudo dei Malaspina e poi dei Gonzaga (sicché, per ragioni storiche, appartiene<br />
alla provincia di Mantova). Al centro della regione vi è altresì Sabbioneta, di grande<br />
importanza storica e artistica, di cui si fa cenno appresso.<br />
423
Campagna mantovana (Ponte Visconteo).<br />
Fot. Calzo<br />
Il Mantovano.<br />
Il Mantovano, che dal margine dei colli benacensi si estende sin oltre il Po e<br />
travalica il Mincio e (come dianzi s’è accennato) l’Oglio, costituisce una vasta zona<br />
per nulla monotona nelle particolarità, ma nel complesso uniformemente pianeggiante<br />
e orientata nettamente verso l’agricoltura. Questa tuttavia non gode dappertutto<br />
di una disponibilità di acque nella misura che si nota (e più volte lo si è rilevato)<br />
nelle altre parti della pianura lombarda; e ciò nonostante le formidabili opere che,<br />
per non dir dei Romani (la cui sistemazione irrigua andò in rovina nel periodo delle<br />
invasioni), si attuarono dal secolo X II sino ad epoca recente. Ad esse va soprattutto<br />
il merito di avere risolto grandi problemi di scolo delle acque che costituivano il<br />
424
presupposto della bonifica. Rimangono i problemi di irrigazione per una superficie<br />
di almeno loo.ooo ettari; è certo che «con la sapiente e integrale utilizzazione delle<br />
masse d’acqua che già solcano le campagne e le altre ancora maggiori che dovranno<br />
essere convogliate, la provincia di Mantova, che basa esclusivamente la sua attività<br />
e la sua prosperità sopra l’agricoltura, è destinata a toccare il vertice massimo della<br />
potenza produttiva e sarà annoverata tra le zone italiane che maggiormente apportano<br />
splendore alla difficile arte di coltivare i campi » (L. Consolini). Ciò trova<br />
conferma in quel che si osserva nei 35.000 ettari che l’approvvigionamento idrico ha<br />
già notevolmente trasformati.<br />
Numerosi centri del Mantovano, per quanto non popolosi, hanno nomi di grande<br />
risonanza: anzitutto Piètole, villaggio sul luogo dell’antica Andes, patria di Virgilio;<br />
poi Curtatone (131 ab.), sul Mincio, che con Montanara (436 ab.), ricorda l’eroica<br />
resistenza del 29 maggio 1848, opposta dai volontari di Toscana alle preponderanti<br />
forze austriache, e Còito (1156 ab.) che il sacrificio dei volontari toscani vide rifulgere<br />
in vittoria nel dì seguente; e ancora Solferino (844 ab.) campo della grande<br />
battaglia che il 24 giugno del 1859 decise delle sorti della <strong>Lombardia</strong>. Per altro<br />
motivo è memorabile Sabbioneta ( 1113 ab.), che, come già s’è accennato, sorge a<br />
Fot. Fotocielo<br />
La torre di San Martino della Battaglia (m. 74),<br />
dominante, al pari della rocca di Solferino, sull’anfiteatro morenico del Garda.<br />
425
Il castello di Villimpenta sul fiume Tione,<br />
all’estremo limite orientale del Mantovano.<br />
Fot. Caholari<br />
occidente del Mincio; la cittadina cinta di poderose mura s’adorna di monumenti di<br />
squisita grazia cinquecentesca che ricordano il soggiorno dei Gonzaga che l’arricchirono<br />
di una accademia, d’una biblioteca, un museo e le infusero un ritmo di così<br />
piena vitalità da meritarsi il nome di Piccola Atene; numerosi i ricordi del brillante<br />
passato e tra essi il Palazzo Ducale, il Palazzo del Giardino, il Teatro Olimpico.<br />
Sulla sponda sinistra del Po, sorge Ostiglia (5759 ab.) centro agricolo di antica origine<br />
(ricordato da Plinio per l’allevamento delle api) oggi sede anche di industrie notevoli<br />
(zuccherifici, caseifici, ceramiche); la cittadina è collegata da un ponte stradale<br />
e ferroviario con l’opposta sponda del fiume, dove sorge Révere (2148 ab.), grosso<br />
borgo agricolo all’ombra del castello fatto erigere dai Gonzaga. Sulla stessa sponda<br />
centri notevoli sono: Sèrmide (2734 ^b.), su cui, con un furioso saccheggio, si sfogò<br />
l’ira del Radetzky (1848), San Benedetto Po (1932 ab.) dal nome dell’insigne Basilica<br />
426
di San Benedetto appartenente aH’ormai quasi millenaria abbazia, e infine Gonzaga<br />
(2394 ab.), patria di Cornelio Nepote, da cui ebbe origine pure la famiglia che per<br />
oltre tre secoli dominò Mantova.<br />
Legato al nome dei Gonzaga vi è, infine, al margine dell’anfiteatro morenico<br />
del Benaco, Castiglione delle Stiviere (5317 ab.), noto come patria di Luigi Gonzaga,<br />
santo esaltato per la purezza di vita. Ma il nome del luogo è legato anche all’opera<br />
di Enrico Dunant, che, soccorrendo qui, dopo la battaglia del 29 giugno 1859, i<br />
feriti, diè vita alla Croce Rossa.<br />
Fot. Calzolari<br />
La Basilica di San Benedetto<br />
a San Benedetto Po, nell’Oltrepò mantovano.<br />
4 27
Il Bresciano.<br />
Le regioni che si susseguono dal Benaco al Verbano s’adagiano tutte tra il piano<br />
e il monte e le loro contrade alla prosperità accoppiano la bellezza: una felice fusione<br />
di ricchezza molteplice e di paesaggi pittoreschi. Ecco il Bresciano dalla sponda del<br />
lago di Garda a quella del lago d’Iseo, cangiante per mille prospettive di serena<br />
leggiadria. La stessa pianura bresciana, continuazione della pianura cremonese e<br />
mantovana, manifesta una maggiore varietà di aspetti per una maggiore variabilità<br />
dei terreni e, di conseguenza, per una più varia composizione di colture e per una<br />
promiscuità più evidente dei tipi di dimora umana, soprattutto rurale, associati pur<br />
sempre alla corte.<br />
Nell’alta pianura poi, benché non con l’intensità che si osserva ad occidente dell’Adda,<br />
al quadro agricolo s’associa quello industriale e nei centri maggiori si può<br />
di frequente notare la vecchia cascina affiancata da moderni opifici. Così, ad esempio,<br />
a Chiari (8868 ab.), a Rovato (6288 ab.), a Rezzato (3384 ab.), a Lonato (3572 ab.),<br />
a Montichiari (4922 ab.).<br />
Dalla pacata distesa della pianura s’eleva tra il Chiese e il Mincio la cerchia delle<br />
colline che recingono il Garda; profili morbidissimi, coperti da un verde mantello<br />
in cui s’alternano messi e vigneti, boschi e parchi, ville e villaggi, e s’adagiano, occhi<br />
di cielo, minuscoli laghetti. Qui domina per largo orizzonte l’Ossario di San M artino<br />
che raccoglie le spoglie di quanti, nell’epica battaglia del 24 giugno 1859, morirono<br />
in tanto splendore di natura per la libertà della Patria. La sponda del Garda<br />
è di sovrana bellezza. Dal vasto arco della costiera meridionale si protende la penisoletta<br />
di Sirmione, già stazione romana (prediletta e cantata da Catullo) di cui<br />
rimangono vestigia in una grandiosa villa romana d’età imperiale, munita fortezza<br />
sotto la signoria scaligera come attesta l’imponente Rocca che domina sul borgo<br />
attuale, centro d’attrazione non solo per le sue bellezze e le sue memorie, ma<br />
altresì per le sue acque termali cloruro-sodiche-solfuree.<br />
La costa bresciana meridionale del lago tutta a seni e a golfi non è da meno per<br />
bellezza e per memorie: dalle stazioni palafitticole di La Polada, alla villa romana<br />
di Desenzano, all’Abbazia di Maguzzano, ai Castelli di Padenghe e Moniga è tutto<br />
un susseguirsi di testimonianze dell’attrazione che la zona ha suscitato in ogni<br />
tempo. I centri attuali più notevoli sono: Desenzano (6150 ab.), cui fanno capo i<br />
servizi di navigazione del Garda, e Salò (5568 ab.), ridente cittadina distesa nell’arco<br />
più interno del golfo omonimo, cinta da un verde anfiteatro di colline e<br />
dominata dalle incombenti Prealpi. Da qui inizia la Gardesana occidentale, strada<br />
nota per le sue grandiose prospettive, ora ridenti, ora orride, per la sua vegetazione<br />
mediterranea, per i suoi centri pittoreschi, le sue ville famose. Ecco Gardone<br />
428
Fot. Fotocíelo<br />
Veduta aerea di Sirmione e della Rocca.<br />
Riviera (1259 ab.) con il Vittoriale, bizzarra dimora di Gabriele d’Annunzio, poi<br />
Fasano e Maderno, centri turistici e di villeggiatura sistemati su delta lacustri,<br />
Toscolano (3936 ab.), l’antica Benacum, forse, allora, capoluogo della regione e poi<br />
culla dell’arte della stampa, Gargnano (970 ab.) e Limone (668 ab.), oasi di uliveti<br />
e limoneti tra precipiti dirupi strapiombanti nelle acque.<br />
Dalla pianura bresciana la visione sui colli che fan da corona alle Prealpi non<br />
appare di primo acchito invitante. Le alture mostrano brulli versanti squarciati da<br />
ampie ferite da cui si traggono calcari che forniscono pietre, tra cui famoso il botticino,<br />
e materiali cementanti. È questa infatti una tra le zone lombarde più tormentate<br />
dal carsismo che a Cariàdeghe, ripiano roso dalle doline, domina tanto da<br />
429
Veduta aerea di Salò.<br />
Fot. Fotocielo<br />
produrre la sensazione di trovarsi sul Carso giuliano. Ma se dal piano ci si addentra<br />
lungo il solco delle valli bresciane si ritrova la quieta bellezza delle Prealpi lombarde.<br />
La vai Sabbia, la cui antica importanza militare è testimoniata dai ruderi di<br />
numerose rocche, s’addentra tortuosa sino al lago d’Idro, ma aperta in ampie conche<br />
dai frequenti roccoli, dove s’alimenta la passione dei bresciani per la caccia, celebrata<br />
nelle osterie paesane attorno al fuoco degli spiedi. Domina l’ingresso alla<br />
valle, Gavardo (3865 ab.), centro di lavorazione della lana; risalendo lungo il Chiese<br />
si susseguono Vobarno (4167 ab.), centro di industrie del ferro, Nozza (594 ab.),<br />
antico capoluogo della vallata in cui si radunava nel dì di Natale il Consiglio dei<br />
Comuni per eleggere il vicario della valle, e Vestone (1276 ab.), l’attuale centro di<br />
430
maggiore importanza, sede di industrie meccaniche e chimiche. Poco appresso ecco<br />
l’antico Eridio, il lago d’Idro, ora trasformato in bacino artificiale, allungato sul<br />
fondovalle tra versanti incombenti. Il pittoresco specchio è dominato dalla sponda<br />
destra dalla Rocca d’Anfo, famosa fortezza costruita dai Veneziani (i486), rifatta<br />
dai Francesi e in seguito dagli Austriaci, rafforzata ancora nel nostro secolo e da<br />
ultimo parzialmente danneggiata dai Tedeschi in fuga (1945).<br />
Alla vai Trompia e alla valle del Garza si accede da Brescia attraverso un ampio<br />
solco percorso dal Mella e dal Garza stesso. Il solco di quest’ultimo è breve e termina<br />
al luminoso Passo di Sant’Eusebio (574 m.); il solco del primo s’addentra più profondamente,<br />
una trentina di chilometri, nel cuore delle Prealpi. La valle è percorsa<br />
da una strada detta delle Tre Valli, poiché risalendo oltre il passo di Maniva (1669 m.),<br />
va ad innestarsi all’altra strada che, per il passo di Croce Domini (1859 m.), congiunge<br />
la valle dell’Oglio con quella del Chiese. La vai Trompia, ora aperta in conche<br />
luminose ora rinserrata tra versanti precipiti sul Mella, ricca di coltivi, di boschi<br />
e di pascoli, è soprattutto nota da gran tempo per i suoi monti « fertili di spade »,<br />
come pittorescamente fu detto per indicare la presenza di giacimenti ferrosi, che<br />
vi han fatto fiorire l’industria del ferro, non unica tuttavia, poiché non trascurabili<br />
sono pure le industrie tessili e del legno. La molteplice attività ha favorito il popolamento,<br />
manifesto in una fitta sequenza di villaggi e di borghi, non solo lungo il<br />
Fot. Stefani<br />
Il lago d’Iseo.<br />
431
solco principale, ma anche nelle vallecole confluenti. I centri più notevoli sono:<br />
Gardone vai Trompia (332 m. ; 7037 ab.), luogo ameno di villeggiatura e sede di<br />
fabbriche di armi, Bovegno (684 m. ; 1079 ab.) e Collio (884 m. ; 1109 ab.), stazioni<br />
climatiche estive nella zona di estrazione del minerale di ferro.<br />
Il lago d’Iseo, dolce e fresco — a dire della Sand — come un’egloga virgiliana,<br />
costituisce lo splendido ingresso alla Valcamònica. In esso decanta le sue acque<br />
rOglio, che n’esce all’apice meridionale, attraversando l’anflteatro dei colli morenici.<br />
Le sponde hanno differente bellezza: più distesa e riposante quella bresciana, più<br />
brulla e tormentata quella bergamasca. Nel centro dello specchio emerge la più<br />
grande isola dei laghi italiani: il Montisela, quasi smeraldo posato su un levigato<br />
turchese, romantico piedestallo alla Madonna della Ceriola che domina dalla sommità<br />
(600 m.). I centri dell’isola. Peschiera, Garzano, Siviano Porto, leggiadri e<br />
luminosi, manifestano, con i festoni di reti al sole, l’attività precipua degli abitanti.<br />
Lungo le sponde che recingono il lago si stendono numerosi centri rivieraschi;<br />
sulla sponda bresciana sono notevoli, Iseo (3515 ab.), là dove la collina cede alla<br />
montagna, e Pisogne (2458 ab.), centro industriale metallurgico. Sulla sponda bergamasca:<br />
Sàrnico (2680 ab.). Castro (1595 ab.), sedi di grandi impianti siderurgici,<br />
e Lòvere (5577 ab.), industre cittadina ricca d’antiche memorie, dominata dall’imponente<br />
basilica quattrocentesca di Santa Maria in Valvendra.<br />
Boario Terme in Valcamònica.<br />
Fot. Stefani<br />
432
Édolo in Valcamònica.<br />
Fot. Sef<br />
Qui ha inizio la Valcamònica che s’allunga per 8o chilometri risalendo sino al<br />
passo del Tonale (1883 m.), tra una cortina di monti sempre più alti, sempre più<br />
erti, dominati dal massiccio deU’Adamello (3554 m.). Ampia e fertile, nel tronco<br />
inferiore essa accoglie centri ricchi di storia e d’arte e fervidi di molteplici attività;<br />
notevole Darfo (221 m. ; 4457 ab.) allo sbocco del Dezzo da cui giunse, in sèguito<br />
al cedimento della diga del bacino del Gleno, la immane fiumana che distrusse parzialmente<br />
l’abitato (1° dicembre 1923); prossime a Darfo, le frazioni di Corna, con<br />
notevoli industrie del ferro, del cotone, del tannino, ecc., di Boario Terme (692 ab.),<br />
stazione idrominerale di acque solfato-calciche-alcaline; poi Cividate Camuno (280 m. ;<br />
1571 ab.), la romana Civitas Camunnorum, antico capoluogo della valle di cui rimangono<br />
vestigia, e la feudale Breno (342 m. ; 2489 ab.), capoluogo della valle imposto<br />
nel 773 da Carlomagno in sostituzione di Cividate. Dopo Breno la valle si fa più<br />
rupestre; le opere imponenti delle centrali elettriche divengono frequenti, quasi<br />
familiari; ma le impronte della industre attività e della lunga storia camunna non<br />
s’attenuano. Ecco, in vista dell’imponente parete della Concarena, Capo di Ponte<br />
(362 m. ; 1227 ab.), dalle caratteristiche case a gheffo; poco lungi dall’abitato le<br />
superfici di arenaria rossa e grigia, levigate dal ghiacciaio, conservano le più stupefacenti<br />
espressioni della preistoria lombarda, ossia incisioni rupestri a migliaia.<br />
28 — L e R e g io n i d 'I t a lia - L o m b a rd ia .<br />
433
che rappresentano figure umane, animali (cervi, bovini, uccelli) e abitazioni a palafitta.<br />
Ormai nell’alta valle, alla confluenza della valle di Còrteno, che porta al<br />
passo dell’Aprica, ecco Edolo (690 m. ; 3067 ab.), pittoresco capolinea della ferrovia<br />
risalente da Brescia, centro di turismo di transito e di villeggiatura estiva. Ancor<br />
più rinomata sotto questo aspetto è Ponte di Legno (1258 m. ; 1274 ab.), in una verde<br />
conca ridente di ville, circondata da boschi profumati di resina, in vista delle imponenti<br />
cime innevate dell’Adamello e del corno dei Tre Signori, mute spettatrici<br />
dell’epica lotta degli alpini nei duri anni della prima guerra mondiale.<br />
Il Bergamasco.<br />
Anche il Bergamasco ha notevole molteplicità di aspetti. Il capoluogo domina<br />
dal margine pedemontano sulla pianura tra l’Oglio e l’Adda e vigila sullo sbocco<br />
delle sue valli che risalgono sino al crinale delle Orobie.<br />
La pianura riceve la sua impronta peculiare dallo sviluppo secolare dell’attività<br />
agricola. A i villaggi rurali assai frequenti, si intercalano numerose dimore sparse,<br />
di struttura varia, talvolta a corte, adorna spesso di portici e di loggiati о di ballatoi,<br />
che attestano l’intensità della vita dei campi. Ma qui (certo meno che nella pianura<br />
milanese, ma assai più che nella pianura bresciana) nel quadro rurale s’inserisce<br />
con evidenza l’industria, specie verso il margine pedemontano e abduano. Nella<br />
stessa famiglia agricola è raro che i membri più giovani in età di lavoro resistano<br />
al richiamo delle officine. Quadro assai vario, dunque, dove, alle impronte di una<br />
tradizione secolare, alle testimonianze di un passato fervido di lavoro, a monumenti<br />
di una storia ricca d’eventi, si accostano le opere prepotenti della nuova civiltà del<br />
lavoro. Ecco accanto alle abbazie di Fontanella e di Pontida, accanto ai castelli di<br />
Malpaga, di Governago, di Romano, di Brignano d’Adda e di Costa di Mozzate,<br />
accanto agli spalti e ai fossati di difesa di Martinengo e di Cologno, sorgere le officine<br />
tra le quali, simbolo di una nuova età, la Dàlmine, fucina fervente del lavoro di<br />
migliaia di braccia.<br />
Nella bassa bergamasca il centro più importante è Treviglio (16.362 ab.), città<br />
agricola e industriale e nodo di comunicazioni stradali e ferroviarie. Poco distante<br />
Caravaggio (8955 ab.), dal celebre Santuario della Madonna, patria di illustri pittori,<br />
tra i quali il Merisi detto il Caravaggio. Notevoli anche Romano (7461 ab.) e M artinengo<br />
(4150 ab.), centri agricoli nella zona dei fontanili. Ponte San Pietro (4606 ab.),<br />
sede di notevoli industrie, e, lungo il margine pedemontano, Almenno San Salvatore<br />
(325 m. ; 1252 ab.), dove ogni anno si tiene la sagra degli uccelli per la caccia, Pontida<br />
(313 m. ; 761 ab.), dalla storica abbazia benedettina, famosa per la tradizione<br />
poetica del giuramento della Lega lombarda.<br />
434
Й і.-<br />
4<br />
s’ .*'» ’.<br />
/■ ♦ »S' ;,^|Ц — Ш'<br />
N5W1P<br />
-1 • '<br />
II lago d’Èndine con l’abitato di Monasterolo e il monte Torrezzo.<br />
Fot. Stefani
Seducente è il quadro offerto dalle valli bergamasche con i loro paesaggi ora idillici<br />
ora alpestri, con le loro memorie storiche, con i loro abitanti schietti e rudi.<br />
La vai Cavallina bagnata dal Cherio, che discende dal lago d’Endine, costituisce<br />
un agevole passaggio tra Bergamo e la Valcamònica. Il suo nome deriva forse dagli<br />
allevamenti di cavalli che vi teneva la Repubblica di Venezia. A ll’ingresso della valle<br />
vigila Trescore Balneario (2525 ab.), frequentata stazione nota per le sue acque<br />
solfuree-clorurate-sodiche.<br />
La vai Seriana è la più importante delle tre valli bergamasche e la più industre.<br />
Allo sbocco ampio e ridente sta Alzano Lombardo (294 m. ; 5410 ab.), centro di<br />
industrie del cemento, della carta e della seta, più a monte Nembro (324 m. ; 5651 ab.)<br />
e Albino (347 m. ; 6028 ab.), sedi di notevoli manifatture tessili. Poi la valle si<br />
restringe e si fa a volte aspra e selvaggia; ma è affiancata su entrambi i lati da aperte<br />
conche confluenti, tra le quali quella di Caudino (553 m.; 3858 ab.), assai nota per<br />
la lavorazione della lana ivi praticata sin dal secolo X III; geologicamente è di notevole<br />
interesse il bacino lignitifero di Leffe, ormai scarsamente sfruttato, ricco di<br />
resti di animali vissuti in epoca preglaciale quali VElephas meridionalis, il Rhinoceros<br />
leptorinus e il Bos primigenius. Seguendo il solco del Serio si giunge a Nossa (465 m. ;<br />
2205 ab.), centro di notevoli industrie metallurgiche (zinco) e cotoniere, e subito<br />
appresso a Ponte Selva (476 m. ; 135 ab.), notevole per il ritrovamento di bronzi<br />
preistorici. Qui un’ampia morena coperta di conifere, detta la Selva, indica il limite<br />
della fronte dell’antico ghiacciaio quaternario che dalle Orobie scendeva lungo l’alto<br />
solco del Serio. Ed ecco l’ampia conca di San Lorenzo, che, dalla località più importante<br />
— tanto nota per i curiosi affreschi quattrocenteschi {Trionfo della morte e<br />
Danza macabra) che ornano la facciata della parrocchiale — vien detta anche di<br />
elusone (648 m. ; 4641 ab.). In questo ameno luogo di svaghi estivi e invernali<br />
ha termine il tronco ferroviario che proviene da Bergamo e inizia la strada che sale<br />
al Passo della Presolana (1289 m.) dominata dal dolomitico pizzo omonimo (2521 m.);<br />
il valico è un luogo estremamente pittoresco, con ville e alberghi, di soggiorno<br />
estivo e di turismo invernale; ma, più che per questo, il passo è notevole per la<br />
possibilità di accesso alla valle di Scalve, confluente, è vero, verso la Valcamònica,<br />
ma ostacolata verso il suo sbocco naturale dalle paurose forre nelle quali s’incide<br />
il Dezzo nel suo corso inferiore. Queste son oggi percorse da una strada, la Via Mala,<br />
minacciata però, nella cattiva stagione, dalle frane. D ’altronde in ogni epoca l’accesso<br />
alla vai di Scalve è stato d’interesse notevole per i giacimenti ferrosi che ivi<br />
si trovano, e il passo della Presolana ha costituito la via più agevole; talché non<br />
fa meraviglia se l’alta valle del Dezzo о vai di Scalve fa parte ancor oggi della provincia<br />
di Bergamo. Schilpario è il centro più notevole (1125 m. ; 1145 ab.) frequentato<br />
come luogo di villeggiatura; sotto questo aspetto gode buona rinomanza anche<br />
Viiminore (1018 m. ; 635 ab.) posto al margine di boschi di conifere. Sottostante<br />
al paese scorre il torrente Gleno lungo il quale il 1° dicembre 1923 si riversò la<br />
fiumana d’acqua, scatenata dalla rottura della diga dell’alto bacino, che rase al suolo<br />
Dezzo di Scalve e seminò lutti e rovine sino in Valcamònica.<br />
436
fei*;<br />
>¥^r<br />
Fot. Nangeroni<br />
La val di Scalve.<br />
L ’alta valle Seriana, a monte di Glusone, ha un aspetto ormai alpino. I versanti<br />
s’incupiscono del verde delle aghifoglie, e verso l’alto cedono il dominio agli alpeggi.<br />
Dopo Ardesio (608 m. ; 1395 ab.), nota per i suoi marmi grigi e rossi mandorlati,<br />
e Gromo (675 m. ; 460 ab.), antico centro di lavorazione dell’acciaio e di fusione<br />
delle armi (secolo XV-XVIII), ecco, presso la testata, Valbondione (891 m.) a piccoli<br />
villaggi distribuiti sul fondovalle, sedi di villeggiatura e luoghi di partenza per<br />
escursioni nelle amene vallecole, cosparse di bacini idroelettrici, e sulle più alte<br />
cime delle Orobie. Nel complesso la valle del Serio costituisce una plaga di notevole<br />
sviluppo industriale per le manifatture di lana e di cotone (Albino, Gandino),<br />
per le industrie dello zinco (Nossa) e per l’abbondanza di acque utili allo sfruttamento<br />
idroelettrico.<br />
La vai Brembana, ugualmente bella, non vanta una copia di risorse pari a quella<br />
della vicina vai Seriana. Ciò è stata la causa dell’esodo di popolazione dalle sue contrade,<br />
che ha raggiunto punte superiori alle altri valli lombarde e tuttora risulta<br />
notevole. La vallata non è priva di industrie, specialmente nel tronco inferiore, ma<br />
basa la sua economia soprattutto sull’allevamento e sull’agricoltura. La valle, che<br />
s’inizia con un’angusta gola, risale verso le Orobie con un alternarsi di verdi bacini<br />
e di forre, ramificandosi in numerose valli confluenti; a Piazza Brembana, dove ha<br />
termine la ferrovia risalente da Bergamo, si apre un ventaglio di solchi, che raggiungono<br />
il crinale oròbico. Qui s’aprono i più ampi orizzonti e le più pittoresche visioni,<br />
ma non da meno sono le bellezze delle valli laterali. Lungo il fondovalle principale<br />
437
si succedono i centri più notevoli: Sedrina (324 m .; 977 ab.), sede di industrie<br />
cementizie e prossima a una delle più belle cavità naturali della <strong>Lombardia</strong>, la<br />
Grotta delle Meraviglie, ricca di concrezioni rese più suggestive dal gioco di luci;<br />
Zogno (334 m .; 2188 ab.), notevole per le industrie tessili; San Pellegrino (354 m .;<br />
2392 ab.), accogliente e ospitale stazione idrominerale di vasta fama per le sue<br />
acque bicarbonato-solfato-calciche-litiose, dotata di terme, di alberghi, di ville e<br />
collegata da una funicolare con San Pellegrino Vetta (653 m.), ridente località di<br />
villeggiatura, nota anche per la Grotta del Sogno, altra cavità naturale ricca di<br />
concrezioni. Più a monte, sempre lungo il tronco principale della valle, vi sono:<br />
San Giovanni Bianco (400 m. ; 1985 ab.), presso le gole dell’Enna, pauroso orrido<br />
formato dal fiume che discende dalla vai Taleggio, Cornelio (490 m.), villaggio originario<br />
della famiglia cui appartenne Torquato Tasso, e Piazza Brembana (536 m.),<br />
località di villeggiatura. Nelle alte valli sono sparse altre località di villeggiatura e,<br />
tra esse, Fòppolo (1515 m.), attrezzata stazione sciistica.<br />
La valle Imagna è, tra le valli confluenti del Brembo, la più prossima allo sbocco;<br />
essa s’apre sulla destra del fiume e risale sino alle falde del Resegone, che da questo<br />
lato, tuttavia, non presenta l’aspetto suggestivo che manifesta a chi lo guarda dai<br />
luoghi manzoniani. Il paesaggio comunque è tra i più ridenti della plaga, animato<br />
San Giovanni Bianco in vai Brembana.<br />
Fot. Stefani<br />
438
Fòppolo (1515 m.) nell’alta valle<br />
del Brembo.<br />
Fot. Secomandi<br />
da ameni villaggi, un tempo industri nella tessitura della seta e della lana. I versanti,<br />
coperti di boschi e di pascoli, offrono un campo di particolare interesse geologico<br />
e geografico per l’abbondanza di fossili nelle formazioni affioranti e per la<br />
frequenza del fenomeno carsico profondo (Tomba dei Polacchi); notevole è anche,<br />
presso Vaisecca, la Fonte Turrigliana, da cui l’acqua scaturisce a intermittenza preceduta<br />
da un rombo dovuto all’espulsione dell’aria. Affiancata alla vai Imagna si<br />
incide la vai Brembilla; essa, angusta verso lo sbocco, s’apre luminosa nella parte<br />
superiore. Alla testata il passo di Bura (884 m.) costituiva la più agevole via di<br />
accesso alla contigua valle Taleggio, prima della costruzione della carrozzabile attraverso<br />
la selvaggia gola dell’Enna. L ’economia ha modeste risorse basate sull’allevamento,<br />
sull’agricoltura e sullo sfruttamento del bosco; talché notevole è l’esodo degli<br />
abitanti dai numerosi e piccoli villaggi sparsi sugli alti pendii. La vai Taleggio,<br />
sopra la Gola dell’Enna, si allarga in un ridente bacino disseminato di villaggi,<br />
coperto da coltivi, boschi e pascoli. La testata della valle fa parte della provincia<br />
di Como (Morterone) e della diocesi di Milano (Morterone e Vedeseta). Nei secoli<br />
scorsi una parte degli abitanti emigrò non seguendo la via discendente della valle,<br />
ma attraverso i passi montani, per raggiungere la bassa pianura milanese dove si<br />
dedicò all’allevamento e alla produzione dei latticini.<br />
Sulla sinistra del Brembo vi sono pure diverse valli confluenti ; tra esse la<br />
vai Serina il cui toponimo comprende il solco percorso dal torrente Parina. Essa,<br />
cinta da belle montagne su cui domina Г Alben (2819 m.), presenta aspetti molto<br />
vari per l’alternarsi di strette gole e di conche apriche. A ll’imbocco, poco a monte<br />
439
di Zogno, in un angusto orrido v’è la Fonte Bracca, sorgente d’acqua alcalina radioattiva<br />
assai nota e sfruttata. La popolazione accomuna il lavoro rurale tradizionale<br />
con quello prestato nelle industrie di Zogno. Nei villaggi più elevati, specialmente<br />
a Serina (825 m.) e a Oltre il Colle (1030 m.), è in notevole sviluppo l’attività<br />
alberghiera per il richiamo esercitato dalla pacata bellezza dei luoghi.<br />
Il Comasco e la Brianza.<br />
Il territorio della provincia di Como include l’intero bacino del Lario, un lembo<br />
del Ceresio e una fascia collinare, che si distingue nel Comasco p. d. e nella Brianza.<br />
Le bellezze naturali di queste diverse parti, e soprattutto della regione lacustre,<br />
sono tra le più note e celebrate della <strong>Lombardia</strong>; quel che più stupisce è la grande<br />
varietà di aspetti per cui ogni angolo presenta una visione nuova con suoi caratteri<br />
particolari.<br />
La parte collinare è costituita dagli anfiteatri morenici costruiti dall’antica fiumana<br />
di ghiaccio, che, proveniente dalle alte valli dell’Adda, s’incanalava lungo il solco<br />
del Lario e, scindendosi in diversi rami, sboccava nel piano dove si apriva in grandi<br />
ventagli. La successione di frequenti colline a dorsali allungate e arcuate, con la<br />
concavità rivolta verso gli sbocchi vallivi, indica il limite in cui, nelle varie fasi, la<br />
fronte si è arrestata per un tempo sufficiente ad accumulare quel materiale trascinato<br />
a valle dal ghiacciaio in movimento. E non fa meraviglia, quindi, di veder<br />
oggi affiorare dall’humus, che riveste il caotico ammasso, grossi massi erratici (detti<br />
trovanti) di ghiandone della vai Màsino, di serpentino della vai Malenco, di micascisto<br />
dell’alto Lario, ecc. Qui, come nella zona montana dove son pure numerosi,<br />
lo sfruttamento delle pietre migliori è stato intenso e molti trovanti sono divenuti<br />
colonne, capitelli, davanzali e gradini. Fortunatamente ancora molti ne rimangono:<br />
se ne sono contati, dei principali, una sessantina nella zona collinare e oltre duecento<br />
sui monti del Lario.<br />
La serie delle arcuate colline, disposte in modo da richiamare negli studiosi la<br />
similitudine di immensi anfiteatri, non è motivo di monotonia, a causa della vastità<br />
degli orizzonti che si gode dalle alture, della raccolta quiete delle conche, della<br />
varietà del rivestimento vegetale, della frequenza degli abitati e delle ville patrizie,<br />
della cornice dei vicini monti prealpini, sui quali dominano le Grigne e il Resegone,<br />
della presenza di conche lacustri. Queste aggiungono al quadro un tocco di romantica<br />
bellezza: a parte il lago di Cariate, formato dall’Adda dopo il ponte di Lecco,<br />
quattro se ne trovano in successione ai margini pedemontani: Annone, Pusiano,<br />
Alserio e Montòrfano; un quinto, il Segrino, s’incunea tra le falde prealpine. I letterati<br />
non sono stati avari nell’esaltazione di queste amene contrade, ma la loro<br />
poesia о la loro prosa par sempre inferiore alla realtà; è una di quelle contrade<br />
4 40
Fot. Stefani<br />
Brianza: panorama da Inverigo.<br />
— afferma giustamente il Linati, scrittore lombardo — che si ribellano ad essere<br />
catturate dalla magia della parola.<br />
La Brianza, che della zona collinare morenica occupa la parte orientale, ossia<br />
quella tra l’Adda e il Lambro, distendendosi dalle falde prealpine al margine della<br />
pianura milanese, è la più attraente e il Baretti non esitò a indicarla come « il più<br />
delizioso paese d’Italia ». Essa fu già, specie nel Settecento e nell’Ottocento, la più<br />
ambita sede di villeggiatura dei Milanesi, che qui potevano godere le gradevoli frescure<br />
delle sere estive, negate alla metropoli, e qui costruirono ville cinte di verdi<br />
parchi, le quali ancor oggi, nonostante l’abbandono per il richiamo di più eccitanti<br />
soggiorni, danno un tono di opulenza al paesaggio. L ’agricoltura, un tempo occupazione<br />
dominante della regione già ricca di gelseti e di vigneti, per quanto ancora<br />
intensamente praticata, cede oggi all’industria, che, specie nel recente dopoguerra,<br />
ha fatto il suo ingresso trionfale, alterando non poco, in alcune parti, la primitiva<br />
bellezza, ma dando lavoro alla popolazione locale.<br />
Dire quali luoghi sian più meritevoli di menzione è difficile, chè tutti hanno<br />
motivo per essere ricordati; meglio sarebbe poter dominare dall’alto del colle del<br />
Montevecchia, о dal Santuario di Imbèvera о dal Santuario di Imbersago о dal<br />
441
poggio di Baciolago о dalla Rotonda d’Inverigo о dal mirabile terrazzo di Elio, il<br />
superbo e affascinante assieme. Spesso sulle alture briantee domina un santuario,<br />
come già un tempo dominava, dall’alto del colle di Brianza (che diede nome alla<br />
regione), la chiesa che la tradizione associa alla regina Teodolinda. Il più elevato<br />
tra tutti è quello di San Genesio, sul monte omonimo (849 m.) al termine della<br />
dorsale che dal Monte Barro (922 m.), quasi ramificazione prealpina, attraversa la<br />
Brianza. Lassù, solitario, sorge un antico convento camaldolese, la cui chiesa è<br />
dedicata al protettore degli artisti (San Genesio). Ai piedi del monte, verso l’Adda,<br />
ecco Merate (288 m. ; 4953 ab.), antico feudo di Ariberto d’Intimiano, luogo ove,<br />
giovanetti, compirono i loro studi il Manzoni, il Verri e il Casati, sede di un osservatorio<br />
astronomico, centro industriale in rapido sviluppo. Presso le falde delle<br />
Prealpi si stende Erba (323 m. ; 8609 ab.) nodo d’incrocio della strada della Valassina,<br />
che da Milano raggiunge Bellagio, e della provinciale da Como a Lecco; particolarmente<br />
a questa posizione il centro deve il suo rapido sviluppo industriale<br />
che l’awia a diventare una città. Sulle alture è di particolare interesse la cavità del<br />
Buco del Piombo, che ha fornito testimonianze dell’età preistorica.<br />
La collina a occidente del Lambro, la collina del Comasco p. d., è meno affascinante,<br />
ma non povera di bellezza. Qui, tra i colli, sorge Cantù (368 m. ;<br />
13.753 ^b.), antico centro d’intensa attività, celebre per i merletti al tombolo e<br />
Fot. Sef<br />
Bosisio Parini : la casa natale<br />
di Giuseppe Parini.
Lecco e il San<br />
Martino.<br />
Fot. Preda<br />
ancor più per i mobili d’arte. Più a sud, altro grosso centro attivo nell’industria del<br />
mobile è Mariano Gómense (250 m. ; 8574 ab.), notevole anche nel ramo tessile.<br />
La regione lariana è dominata dalla presenza del grande lago, il terzo per<br />
ampiezza tra i laghi italiani, il più profondo, curiosamente ramificato a forma di Y.<br />
Il « centro lago », formato dall’incontro dei tre rami, è la parte più aperta, più pittoresca,<br />
più frequentata. Nella sua parte mediana si protende la penisoletta di Bellagio,<br />
che offre spettacolari visioni sui tre rami. Il ramo settentrionale, о alto Lario, si<br />
interna nell’àmbito alpino ed è il più grandioso; i versanti, a boschi e pascoli, lo<br />
recingono con lenti declivi terrazzati che lasciano spaziare lo sguardo su una corona<br />
di alte montagne, tra cui il monte Legnone che costituisce la cima più elevata<br />
(2610 m.) di tutto il bacino. Il ramo di Como è invece stretto e tortuoso, accompagnato<br />
da versanti ripidi e boscosi che producono cupi riflessi sullo specchio delle<br />
acque, simile a un fiordo norvegese; ma è forse il più ridente dei tre rami. Il ramo<br />
di Lecco è invece il più severo a causa dell’aspre pareti che vi incombono dalle<br />
Grigne e dal Morigallo. Quasi dovunque, lungo le sponde, si susseguono villaggi<br />
e borghi; intercalati ora da ville ora da alberghi. Agli apici meridionali due città:<br />
Como (di cui si discorre nel capitolo appresso) e Lecco.<br />
Lecco (214 m.), città natale dello Stoppani e del Cermenati, sorge là dove il<br />
lago — per dirla col Manzoni — « vien, quasi a un tratto, a restringersi, e a prender<br />
corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra<br />
parte... La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata<br />
a due monti contigui, l’uno detto di San Martino, l’altro, con voce lombarda, il<br />
Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una<br />
sega ». La città attuale si stende appunto sulla costiera formata dai delta alluvionali<br />
cui il Manzoni accenna. Ma forse in antico il nucleo originario sorse, come<br />
443
orgo fortificato, alla base dell’aspra e dirupata parete del San Martino. Nel<br />
Medioevo divenne una contea, appartenente dapprima al vescovo di Como, poi<br />
all’arcivescovo di Milano; tuttavia nel 1224 ottenne una discreta autonomia. Nel<br />
periodo delle lotte tra Como e Milano subì gravi devastazioni: nel 1296 Matteo<br />
Visconti rase al suolo il borgo ed esiliò la popolazione. Ma, trascorsi alcuni anni,<br />
l’abitato risorse in nuova posizione, ossia sulla sponda del lago tra i torrenti Gerenzone<br />
e Caldone. Ad Azzone Visconti si deve la fortificazione della città e la costruzione<br />
di un ponte a otto arcate, che in sèguito ai lavori di ampliamento dell’imboccatura<br />
dell’Adda (1440) fu allungato di tre arcate (per complessivi 135 m.). Si<br />
calcola che, all’epoca in cui il Manzoni pone la vicenda dei Promessi Sposi, Lecco<br />
contasse circa 3000 ab.: « un gran borgo che s’incammina a diventar città ». Nel 1861<br />
gli abitanti erano ancora 6960. Alla data dell’ultimo censimento erano 41.684 nel<br />
solo aggregato urbano. La città attuale si è espansa superando il corso del Gerenzone<br />
e del Caldone, risalendo lungo il solco dei torrenti e allungandosi verso la<br />
conoide del Bione su cui sorge Pescarenico, ch’era, ai tempi di Padre Cristoforo,<br />
« un gruppetto di case, abitate la più parte dai pescatori, e addobbate qua e là di<br />
tramagli e di reti tese ad asciugare », ed oggi è un sobborgo industriale di Lecco.<br />
E fuor dubbio che la posizione geografica è stata uno dei fattori essenziali dello<br />
sviluppo della città. Nel secolo XIV, essa vide ampliarsi il suo respiro con la costruzione<br />
del ponte di Azzone che permise al traffico di espandersi verso la Brianza<br />
e il Comasco. « In tal modo su Lecco cominciarono a gravitare molte località e<br />
territori che prima di allora avevano avuto minore facilità di rapporti con questo<br />
centro, il quale vide sempre più fiorire la sua economia. Un ulteriore, radicale<br />
miglioramento nelle comunicazioni si ebbe dopo il 1825 quando a nord della città<br />
fu aperto al transito il tratto lungo il lago di quella che è la strada del lago di Como<br />
e dello Spluga con il conseguente abbandono — da parte del traffico non strettamente<br />
locale — del tortuoso e impervio percorso della Valsàssina, non sempre transitabile<br />
d’inverno » (C. Della Valle).<br />
Nel quadro economico della città, l’agricoltura e l’allevamento hanno scarsa<br />
incidenza; le attività fondamentali sono l’industria e il commercio e in particolare<br />
l’industria del ferro. Tale industria che trae origine dalla lavorazione del minerale<br />
della Valsàssina e dell’alto Lario, effettuata sin dal Medioevo, annovera attualmente<br />
circa un’ottantina di opifici in cui trovano lavoro diverse migliaia di addetti<br />
(12.000 nel 1951).<br />
Com’è noto, il teatro degli avvenimenti raccontati nei Promessi Sposi è soprattutto<br />
Lecco con i dintorni: il castello sopra lo Zueco ha forse ispirato il Manzoni<br />
per il palazzotto di Don Rodrigo, la rupe di San Gerolamo è quella del castello<br />
dell’Innominato, Oíate e Acquate si contendono l’onore di essere stati la patria di<br />
Renzo e Lucia, Chiuso è forse il villaggio del sarto, Pescarenico certamente è il luogo<br />
del convento di Padre Cristoforo.<br />
Nel ramo lecchese del Lario la sponda di gran lunga più popolata e fervida di<br />
attività è quella orientale, dove il centro più notevole è Mandello (4705 ab.), posto<br />
444
sull’ampio delta del Merla, sede di importanti industrie di motociclette. Incombe<br />
sovrastante la Grigna, dalle cime dolomitiche, palestra di ardito alpinismo. Il massiccio,<br />
limitato da un lato dal lago, è recinto a oriente dalla Valsàssina, includendo<br />
sotto questo nome, come s’usa localmente, il lungo solco che da Ballabio sopra Lecco<br />
giunge a sboccare nel «centro lago» sopra Sellano, comprendendo distinti tronchi di<br />
valle, e cioè; la valle di Laorca che discende verso Lecco, ricca di trafilerie e chioderie,<br />
il corridoio di Balisio (700 m.) una specie di canon privo di una chiara idrografia<br />
e che forse in periodo glaciale si sarebbe trasformato in un lago, la bella e<br />
ampia conca di Barzio, ricca di prati e di castagneti, la valle di Introbio e la vai Muggiasca<br />
incisa a forra e sospesa sul Lario. L ’economia della Valsàssina era ed è tuttora<br />
basata sull’allevamento bovino. Qui hanno avuto origine le più famose industrie<br />
casearie che oggi vanta la pianura (Invernizzi, Cademàrtori, Locatelli, Galbani, Arrigoni,<br />
ecc.) e che sorsero in prevalenza per iniziativa di famiglie venute anticamente<br />
in Valsàssina dalla vai Brembana e dalle sue valli confluenti. Fino allo scorso secolo<br />
queste famiglie con i loro armenti, le bergamine, scendevano ancora al piano, ricco<br />
dei foraggi delle marcite, per svernare; oggi gli armenti hanno sede fissa nelle stalle<br />
del piano e solo il bestiame giovane è inviato d’estate sui pascoli valsassinesi. Ma<br />
la bellezza dei luoghi ha dato anche sviluppo turistico ai centri della Valsàssina;<br />
tra essi più popolosi: Barzio (767 m .; 941 ab.), centro d’origine della famiglia di<br />
Alessandro Manzoni, Pasturo (641 m. ; 922 ab.) e Introbio (586 m. ; 998 ab.), centri<br />
caseari, Primaluna (550 m. ; 520 ab.), luogo d’origine dei Della Torre, gli avversari<br />
dei Visconti.<br />
Fot. Fotocelere<br />
Il « centro lago »<br />
del Lario e le Grigne.<br />
445
Lungo le sponde del ramo comasco del Lario numerosi si susseguono i villaggi,<br />
alcuni aggrappati allo scosceso pendìo, come Careno e Blevio, altri allo sbocco delle<br />
valli come Nesso e Argegno, altri appollaiati su terrazzi come Pigra e Véleso. Numerose<br />
e alcune veramente notevoli le ville: a mezza via tra Torno e Faggeta, la<br />
cinquecentesca villa Pliniana, così chiamata per la fonte intermittente che suscitò<br />
l’interesse di Plinio il Vecchio e di Plinio il Giovane; la famosa Villa d’Este, poco<br />
distante da Como, edificio principesco fatto erigere dal cardinale Gallio, trasformato<br />
in lussuoso albergo nel 1873. I centri più popolosi si trovano sulla sponda occidentale:<br />
Cernobbio (6621 ab.), centro d’industrie tessili alle porte di Como, Moltrasio<br />
(2025 ab.) dove, nella Villa Passalacqua, Bellini compose parte della Straniera e<br />
forse della Sonnambula, Argegno (749 ab.) da cui si accede alla valle Intelvi. Sotto<br />
questo nome si comprendono i solchi di due torrenti entrambi distinti col nome<br />
di Telo, ma confluenti uno nel Lario e l’altro nel Ceresio e collegati tra loro dall’ampia<br />
insellatura di San Fedele (732 m.). È una zona ridente, verde di castagneti<br />
e di prati, cosparsa di villaggi attorniati da coltivi. Notevole è l’afflusso estivo per<br />
villeggiatura, specialmente a Lanzo (907 m. ; 999 ab.), il maggior centro della valle,<br />
che con il suo Belvedere s’affaccia sulla sottostante conca del Ceresio.<br />
Il « centro lago » è « una plaga di delizie e in essa stanno raccolte, come in una<br />
coppa ideale, le più delicate meraviglie del creato ». Sulla sponda orientale, scaglionata<br />
su uno sprone roccioso, è Varenna (700 ab.), adorna di ville sommerse nella<br />
vegetazione mediterranea; tra esse Villa Monastero sede dell’Istituta idrobiologico<br />
italiano. Sulla penisoletta protesa in mezzo ai due rami meridionali sorge Bellagio<br />
(1364 ab.) pittoresco centro, molto frequentato in primavera e in autunno da stra-<br />
Fot. Ed. Campirli<br />
Il ramo sudoccidentale<br />
del<br />
Lario (sponda<br />
occidentale tra<br />
Cernobbio e<br />
Carate).<br />
446
Fot. Brunner<br />
Villa d’Este a Cernobbio.<br />
nieri, con imponenti alberghi e stupende ville, tra cui famose la Villa Serbelloni,<br />
edificata sul luogo ove forse aveva la dimora Plinio il Giovane, e la Villa Melzi,<br />
entrambe cinte da parchi ricchi di piante rare. Sulla sponda orientale infine vi è la<br />
ridente Tremezzina splendida di ville, di alberghi e di parchi con Lenno (890 ab.),<br />
al riparo della Punta di Balbianello (dove domina la Villa Arconati in cui soggiornò<br />
Silvio Pellico alla vigilia del suo arresto), con Tremezzo (1100 ab.) che dà il nome<br />
alla splendida riviera, con Cadenabbia e con numerosi e piccoli villaggi sui terrazzi<br />
sovrastanti, tra i quali Giulino dove fu fucilato, neU’aprile del 1945, Mussolini. Tra<br />
le maggiori attrazioni, la settecentesca Villa Carlotta famosa per le sculture del<br />
Canova e per il suo parco, tutto fiorito in maggio di azalee e di rododendri.<br />
Separata dalla Tremezzina dall’incombente Sasso di San Martino, che porta evidenti<br />
tracce dell’esarazione glaciale, vi è Menaggio che chiude il «centro lago». L ’abitato<br />
(2034 ab.), sul delta del torrente Sanagra, è centro di transito poiché alle sue<br />
spalle s’apre l’ampio solco, detto vai Menaggina, che, ampliato e approfondito da<br />
una ramificazione della grande colata glaciale quaternaria, porta agevolmente a Porlezza<br />
(1168 ab.) e al lago di Lugano. Questo, in contrasto con il «centro lago» di<br />
Como, si presenta, nel tratto italiano, chiuso tra alti versanti e soffuso di quella<br />
447
L ’alto Lario, da Rezzònico.<br />
Fot Stefani<br />
malinconica dolcezza che il Fogazzaro, del quale resta la casa di Oria, ebbe cara e<br />
trasfuse nel suo più noto romanzo.<br />
Le sponde dell’alto Lario più degli altri rami conservano intatto, nell’assieme,<br />
il carattere rurale; esse accolgono tuttavia grossi centri rivieraschi di notevole sviluppo<br />
industriale. Sulla sponda orientale, allo sbocco della vai Muggiasca, che ha<br />
formato un impressionante òrrido e un ampio delta, sorge Bellano (2812 ab.) attivo<br />
nell’industria tessile; più a nord, allo sbocco della vai Varrone, sull’ampio delta formato<br />
dal torrente, Dervio (1850 ab.), centro di industrie caratteristiche degli ombrelli;<br />
poi ancora più a nord, porta d’ingresso alla Valtellina, Còlico (1177 ab.). Presso<br />
Còlico, il lago forma una pittoresca insenatura e su uno dei promontori che lo proteggono<br />
sorge l’antichissima Abbazia di Piona, fondata dai monaci cluniacensi e<br />
ora retta dai cistercensi, abili nella distilleria di un gradevole liquore. Sulla sponda<br />
opposta del lago sono notevoli: Dongo (2052 ab.) presso lo sbocco della valle Albano,<br />
sede di industrie del ferro alimentate da piccoli giacimenti locali di minerale, e<br />
Gravedona (2207 ab.) allo sbocco della valle del Liro, capoluogo delle Tre Pievi<br />
(Gravedona, Sòrico e Dongo), di storia antica ed illustre.<br />
448
La Valtellina e le valli di Chiavenna.<br />
A ll’àpice settentrionale del Lario e in continuazione del suo bacino s’aprono i<br />
solchi della Valtellina e delle valli di Chiavenna, che insieme costituiscono il territorio<br />
della provincia di Sondrio. È la parte tipicamente alpina della <strong>Lombardia</strong>,<br />
dove l’elemento naturale predomina e soggioga. Non si può tuttavia dire che l’opera<br />
umana non abbia anche qui lasciato un’orma profonda. Dai vigneti sparsi sui versanti,<br />
risultato di un’opera secolare di trasformazione, ai bacini e alle centrali idroelettriche,<br />
incancellabili monumenti del nostro tempo, è tutta una continua testimonianza<br />
dell’attività umana; qui, anzi, per la più dura lotta contro la potenza delle<br />
forze naturali, le opere dell’ingegno e del braccio prendono più vivo risalto e suscitano<br />
maggiore ammirazione. Già all’imbocco delle due valli il vasto Pian di Spagna,<br />
formato dai depositi dell’Adda, che, espandendosi, hanno decapitato l’antico apice<br />
del Lario e racchiuso il suggestivo laghetto di Mezzola, denunciano una difficile<br />
opera di bonifica in un’area dove per secoli ha dominato l’acquitrino e la malaria.<br />
Nè l’opera di bonifica è stata necessaria solamente nel tratto finale della Valtellina,<br />
ma in diverse parti del fondo della stessa valle, sul quale, i torrenti precipiti dalle<br />
Rètiche e dalle Orobie, specie questi ultimi, hanno riversato gran copia di acque e<br />
di detriti ostacolando non poco il flusso dell’Adda. Ora una parte dei cumuli, stabilizzati,<br />
si distende in ampie conoidi coperte di coltivi e di prati, una parte invece<br />
si presenta a guisa di ferite ancora aperte; tale, ad esempio, quella allo sbocco della<br />
vai Tártano dove la violenza delle alluvioni ha costretto a forare le roccia viva del<br />
monte per dar sicuro passaggio alla ferrovia. La Valtellina nel tratto inferiore<br />
denuncia con i suoi verdi prati, i suoi campi di cereali, i suoi frutteti e i suoi<br />
vigneti, l’attività prevalentemente rurale degli abitanti. Particolarmente notevole è<br />
la cura rivolta alla coltivazione, sul versante a solatìo, del vigneto (i cui prodotti<br />
trovano un buon mercato anche nella Svizzera), e all’allevamento. Ma le risorse,<br />
appunto perchè agrarie, non sono suscettibili di un aumento adeguato all’accrescersi<br />
del numero degli abitanti e da ciò deriva il continuo seppure tenue èsodo della popolazione.<br />
E ciò tanto più in quanto, in relazione all’ambiente naturale, la popolazione<br />
è discretamente fitta, come visibilmente denuncia la frequenza dei borghi e dei<br />
villaggi distribuiti sul fondovalle о sui terrazzi del versante esposto al sole. La<br />
ricerca del sole è qui particolarmente evidente, chè opposto al versante rètico fitto<br />
di abitati e di vigneti s’erge il versante oròbico scarso di abitati e denso di bosco<br />
ceduo e di castagneti. Il capoluogo della valle e della provincia è Sondrio (307 m. ;<br />
10.561 ab.), che si espande sul fondovalle presso la confluenza della vai Malenco.<br />
La città è di origine certamente preromana, ma il suo nome par di conio longobardo<br />
(con significato di terreno coltivato dal padrone); coinvolta nelle lotte tra<br />
29 — L e R e g io n i d 'I t a lia - L o m b a rd ia .<br />
449
le più potenti famiglie comasche, nel secolo XIV subì assedi e distruzioni. Nel 1336<br />
vi si affermò il potere dei Visconti sino a che nel 1512 calarono i Grigioni. Nel 1797<br />
con tutto il territorio valtellinese entrò a far parte della Repubblica Cisalpina. La<br />
città ha ricevuto un notevole impulso dalla costruzione della ferrovia proveniente<br />
da Milano e Lecco e dalla strada dello Stelvio; il suo volto si è rinnovato e ammodernato,<br />
la sua attività incrementata. LFn benefico riflesso ha avuto nell’economia<br />
cittadina anche lo sviluppo dell’industria idroelettrica nell’àmbito della valle. Verso<br />
la zona di sbocco il centro più importante è Morbegno (255 m. ; 4642 ab.), sede<br />
di industrie tessili e alimentari, alla confluenza della valle del Bitto nota per le<br />
località di villeggiatura; verso monte il centro più popoloso è Tirano (430 m .;<br />
5609 ab.), centro di vivace movimento turistico quale stazione della ferrovia svizzera<br />
del Bernina. Famoso in tutta la valle è il cinquecentesco Santuario della<br />
Madonna di Tirano, eretto sul luogo di un’apparizione; esso al richiamo religioso<br />
unisce quello artistico. Nell’alta valle domina Bormio (1225 2687 ab.), stazione<br />
climatica e termale e centro sportivo di soggiorno estivo e invernale, base di partenza<br />
per le ascensioni dell’Ortles-Gevedale, nodo d’irradiazione delle strade dello<br />
Stelvio, del Gavia e di Foscagno. La sua antica storia e il suo vanto di contea<br />
medioevale si rivelano per molti segni: dalla Collegiata, di cui si trova cenno già<br />
La confluenza della Valtellina (a destra) con la vallata di Chiavenna (a sinistra).<br />
Nel piano (in prossimità del vertice dell’ombra) il dosso di Fuentes.<br />
Fot. Fagnani<br />
450
Fot. Sef<br />
Sondrio, capoluogo della Valtellina.<br />
Sullo sfondo il versante oròbico in veste invernale.<br />
in un diploma di Carlomagno, alla Torre del Comune, su cui stava la « baiona » che<br />
convocava i Consigli della valle, alle rovine del Castello che dominava sul borgo.<br />
Le valli di Chiavenna s’aprono con il Piano omonimo, costituito dall’interrimento<br />
dell’antico àpice del Lario ad opera della Mera, serrato in una cerchia di aspre<br />
montagne. L ’abile penna di Giovanni Bertacchi, il poeta di queste valli, ce le presenta<br />
« tutte svolte e sproni violenti, con fondi e scorci di cime che ad ogni tratto<br />
si spostano, s’adimano, dan su; valli convulse, riottose, che pare vogliano fare<br />
da sè ne’ sistemi della natura. Chiavenna giace là in fondo, a’ piedi di quel pietrame<br />
caotico intercalato di verde e dominato a nord dalle rocce pittoresche di<br />
Capiola, ove le marmitte dei giganti serbano l’arcano dei ghiacciai ». La cittadina<br />
(4598 ab.), posta sopra il materiale di una grandiosa frana preistorica precipitata<br />
dal Pizzo di Prata, ebbe sin da epoca romana una notevole importanza quale stazione<br />
obbligata per il transito dei Passi dello Spinga e del Maloggia. Il suo stesso<br />
4SI
La Valtellina a Tresenda. In alto sul terrazzo, Teglie.<br />
Fot. Sef<br />
nome, che par giusto far derivare dal latino clavis, indica la sua precipua caratteristica.<br />
L ’abitato in periodo medioevale si sviluppò soprattutto lungo la strada del<br />
Maloggia alla sinistra del Mera, e nel i486 Bona di Savoia lo fece cingere di mura<br />
(di cui rimane qualche avanzo) per difenderlo dalle insidie che venivano d’oltralpe.<br />
L ’importanza del centro s’accrebbe poi allorché un’immane frana nel 1618 seppellì<br />
il vicino borgo di Piuro. Nel 1882 l’apertura della ferrovia del Gottardo tolse a<br />
Chiavenna parte della sua importanza, ma lo sviluppo dell’attività industriale, quale<br />
quella della birra (che nel 1880 contava ben sette fabbriche), dei latticini, eccetera, continuò<br />
a dar sviluppo alla cittadina, che prese a espandersi verso lo sbocco della<br />
vai San Giacomo. La cittadina è dominata dai ruderi di un antico castello la cui<br />
notorietà è legata soprattutto alla Gaürga, un taglio netto della rupe su cui il castello<br />
poggia e che si ritiene fatto dall’opera dell’uomo per meglio difendere il luogo.<br />
Interessanti sono anche i erotti, cavità sotterranee tra i massi dell’antica frana in<br />
cui circolano forti correnti d’aria fredda, detti sorèl, che servono come cantina.<br />
452
V •;<br />
Val di Dentro.<br />
Fot. Stefani
Pianazzo (1399 m.) nell’alta valle San Giacomo.<br />
Fot. Stefani<br />
Da Chiavenna si dipartono, risalendo verso i Passi del Maloggia e dello Spinga,<br />
rispettivamente la vai Bregaglia, « ricca d’aspetti più che mai, con ogni tono di verde,<br />
bella di vigne e di selve » tagliata a mezzo dal confine elvetico, e la vai San Giacomo,<br />
« selvaggia con torrioni e castelli di rupi ». Lungo questa si snodava la strada<br />
romana voluta da Marco Aurelio e che prese da lui il nome di Via Aureliana, mutata<br />
poi nel Medioevo in Via Regina, forse per corruzione di « regia ».<br />
Dire di quante località attraenti e di quante bellezze naturali sian dotate la<br />
valle di Chiavenna e la Valtellina è vano, chè a cento a cento s’affacciano i nomi<br />
e i luoghi, tutti meritevoli di menzione. A queste sue bellezze s’affida non poco il<br />
territorio della <strong>Lombardia</strong> meno dotato di ricchezze e s’affida poiché tante meraviglie<br />
meritano un afflusso turistico ben maggiore di quello già in atto, che pure non<br />
è trascurabile.<br />
454
Il Varesotto.<br />
Il Varesotto è una plaga somigliante per diversi aspetti naturali ed economici ai<br />
territori contigui: come il territorio di Como esso ha una porzione costituita dalla<br />
montagna prealpina e una porzione costituita dalla collina morenica, come il Milanese<br />
esso ferve di una molteplice attività industriale. Nell’insieme il territorio, pur<br />
mancando di un’unità geografica, si distingue per suoi caratteri particolari. Si può dire<br />
che dappertutto, anche in parte delle basse valli, il decadere della viticoltura prima<br />
a causa della fillossera, e della bachicoltura poi, per complesse vicende di mercato,<br />
ha sospinto la popolazione all’attività industriale, favorita, questa, dalla vicinanza<br />
di Milano e dallo sviluppo delle comunicazioni ferroviarie dirette al Canton Ticino<br />
Fot. Fotocielo<br />
Angera.<br />
455
per la via di Luino (che s’allaccia alla ferrovia del Gottardo) e al Canton Valiese<br />
per il traforo del Sempione. L ’agricoltura ha assunto carattere complementare e<br />
l’artigianato, già fiorentissimo, è declinato dinanzi al trionfo dell’industria che dal<br />
ramo tessile tradizionale si è espansa in altri campi, dal cuoio alle calzature, dalla<br />
carta al legno, ecc. Anche il turismo ha avuto un vivace sviluppo per la bellezza dei<br />
luoghi non inferiore a quella delle più celebrate e note parti della <strong>Lombardia</strong>. Vi<br />
sono infatti alcune plaghe, forse ancora poco note, davvero incantevoli: basterebbe<br />
percorrere le contrade della Gazzada, sul bordo orientale della conca che rinserra<br />
il lago di Varese, о raggiungere la Rocca d’Angera e l’altura di Santa Caterina del<br />
Sasso sulla sponda del lago Maggiore, о dal Sacro Monte e dal Campo dei Fiori<br />
dominare l’ampio orizzonte cui fa da cornice la bianca cerchia delle Alpi sovrastata<br />
dal Monte Rosa, per avere un saggio del fascino di questo lembo di <strong>Lombardia</strong>.<br />
Laveno.<br />
Fot. Fotocielo<br />
456
Fot. Sef<br />
II Sacro Monte (m. 880), celebre località di richiamo<br />
religioso e turistico nelle Prealpi di Varese. Sullo<br />
sfondo le Prealpi comasche.<br />
Le Regioni d ’Italia - <strong>Lombardia</strong>
Santa Caterina del Sasso sulla sponda lombarda del Verbano.<br />
F o t. S e f
L ’ampia zona collinare è opera anche qui, come nella Brianza e nel Comasco,<br />
dell’antico glacialismo quaternario, ma naturalmente di una diversa colata, ossia<br />
di quella che scendeva dalle valli ticinesi e ossolane e, attraverso il solco del<br />
lago Maggiore, giungeva al piano aprendosi in un largo ventaglio il cui settore<br />
orientale copriva il Varesotto, congiungendosi con il bordo alla fronte del ramo<br />
luganese della colata abduana. Ma tra le arcuate morene del Varesotto, forse più<br />
che altrove, emergono qua e là dossi dell’antiche rocce di fondo, che ravvivano<br />
assai la morfologia; a ciò s’aggiunga la presenza dei laghetti di Varese, di Monate<br />
e di Comabbio che aggiungono un tocco di leggiadria al paesaggio.<br />
La parte montana del Varesotto è rappresentata, oltre che dal lembo alpino<br />
a nord della Tresa, da un assieme di gruppetti di monti divisi da un intrico di valli<br />
che curiosamente s’intersecano (chissà mai per quale evolversi di fatti della lontana<br />
storia della Terra) e presentano aspetti molto vari, ma nel complesso assai ridenti.<br />
Ampia e popolosa la Valcuvia, profonda e spopolata la Valganna (nota per le sue<br />
grotte alcune abitate in epoca preistorica, altre lavorate a colpi di martello forse in<br />
epoca romana) ; aperta e boscosa la Valtravaglia, spaziosa e verde la vai Marchirolo. Le<br />
conche sono frequenti e nella parte mediana fan da raccordo tra le diverse vallecole<br />
sicché agevole è il passaggio dall’una all’altra. In tutte, la modestia delle risorse locali,<br />
basate sull’allevamento, sulla silvicoltura e su una stentata agricoltura, è stata causa,<br />
specie nei decenni prebellici, di un notevole disagio della popolazione che in parte<br />
non trascurabile ha abbandonato i luoghi nativi per scendere al piano. Lo spopolamento<br />
si è manifestato in modo ancor più accentuato nella vai Veddasca che, verde<br />
e profonda, s’apre verso il lago Maggiore nell’estremo lembo montuoso del Varesotto.<br />
Numerosissimi sono i grossi centri nella collina e altrettanto numerosi i villaggi<br />
nella montagna. Già nei cenni sul Milanese, in relazione alla posizione intermedia<br />
con il Varesotto, si sono ricordati Saronno, Gallarate e Busto, grossi centri dell’industria.<br />
Nell’àmbito della collina, per quanto meno popolosi sono pure notevoli.<br />
Tradate (303 m. ; 9966 ab.), borgo industriale, poco lungi dalle famose rovine di<br />
Castel Seprio, antico centro longobardo di cui rimangono interessanti reliquie, quali<br />
la chiesa di Santa Maria Foris Portas, raro documento del secolo V I; Malnate<br />
(350 m. ; 5571 ab.), luogo di villeggiatura su un terrazzo della vai d’Olona; Viggiù<br />
(483 m. ; 2147 ab.), centro turistico in amena posizione. Lungo le sponde del<br />
lago Maggiore si succedono da nord a sud Luino (8542 ab.), cittadina di transito<br />
internazionale, sede di notevoli industrie; Laveno (3699 ab.), notevole scalo lacuale<br />
e nota per le rinomate industrie della ceramica, fondate nel 1856; Angera (2901 ab.),<br />
l’antica Vicus Sebuinus, dominata dalla Rocca dei Visconti; Sesto Calende (3863 ab.),<br />
centro di industrie, presso il passaggio sul Ticino della strada del Sempione. Notevoli<br />
località di confine sono Ponte Tresa (588 ab.) e Porto Ceresio (1406 ab.), entrambe<br />
affacciate sul lago di Lugano in amenissima posizione.<br />
458
C a p i t o l o T r e d i c e s i m o<br />
MILANO E LE MAGGIORI CITTÀ LOMBARDE<br />
M ilano.<br />
Quando sia sorto, nel luogo nel quale oggi si stende la metropoli lombarda, il<br />
primo insediamento umano non è dato di sapere. Certo il luogo doveva anche anticamente<br />
presentare dei requisiti naturali di grande vantaggio: si può infatti supporre<br />
con fondamento che il suolo tra il corso del Sèveso e quello dell’Olona, si<br />
presentasse come una prominente appendice della pianura asciutta in mezzo ad una<br />
zona di acquitrini alimentati dall’incerto corso dei fiumi e dall’insorgenza spontanea<br />
di acque dal sottosuolo (rappresentata tuttora dai fontanili). La leggenda, tramandata<br />
da un oscuro cronista del X secolo, vuole che ivi in età remotissima sorgesse<br />
un abitato denominato Alba e, a parte il nome, l’ipotesi di un aggregato preistorico<br />
potrebbe anche configurarsi senza assurdità nel quadro delle più antiche vicende<br />
lombarde. Resta comunque certo che l’antica Mediolanum, come poi venne chiamata<br />
dai Romani con nome di origine celtica che significherebbe « luogo di convegno<br />
» о « luogo di mezzo », già esisteva nel V secolo a. G. quale centro di scambi<br />
dei Galli Insubri con funzione anche di fortezza. Può essere che la fortuna dell’aggregato<br />
derivasse dall’esistenza di un luogo consacrato al culto, ma par più verosimile<br />
che l’importanza dell’antica Mediolanum si accrescesse per la sua partecipazione<br />
con i Boi e i Senoni alla lotta contro i Liguri, contro i Taurini e, soprattutto,<br />
contro la vicina Melpum la cui distruzione, avvenuta nel 396 a. C., arrestava la<br />
pressione degli Etruschi da mezzogiorno. La iconografia più antica di Mediolanum<br />
comincia con il dominio di Roma. Con la conquista effettuata da Roma, avvenuta<br />
stabilmente nel 196 a. C., al villaggio gallico si sostituì la città a pianta quadrilatera,<br />
munita di spalti e circondata da un fossato che i non lontani fiumi dovevano facil-<br />
459
Milano: panorama sulla città dalla torre metallica del Parco.<br />
Fot. Hartman<br />
mente alimentare. Il reimpiego del materiale da costruzione usato dai Romani e le<br />
distruzioni cui Milano fu soggetta nel corso dei secoli, hanno reso tardo e difficile<br />
il riconoscimento della città romana; ma attualmente, in seguito ai profondi scavi<br />
attuati con l’edilizia moderna, è stato possibile ritrovare le vestigia sepolte da millenni,<br />
sicché par fuor di dubbio che il Foro coincidesse con il luogo ove oggi si<br />
trova Piazza San Sepolcro. Quivi s’incrociavano perpendicolarmente i due assi viari<br />
principali che uscivano dalle mura per quattro porte (Romana, Ticinese, Vercellina.<br />
Nuova) sulla cui direttrice si conserva il tracciato di vie quali il corso Roma<br />
e la via Manzoni. Il perimetro del primo castrum, meno facile a individuarsi,<br />
coinciderebbe con parte dell’attuale via Torino, via San Maurilio, via Bocchetto<br />
e via Orefici: ossia un quadrilatero di 360 m. sul lato più lungo, di 200 sul lato<br />
più corto racchiudente un’area di circa 7 ettari. In periodo augusteo furono erette<br />
attorno alla città nuove mura e nel seguente periodo imperiale eseguite varie aggiunte,<br />
allo scopo di includere le parti dell’abitato di nuovo sviluppo rimaste indifese. In<br />
tal modo resterebbe comprensibile l’interpretazione del passo di Ausonio in cui<br />
si accenna a una doppia cerchia. Comunque è certo che, cresciuta la città d’importanza<br />
e divenuta il più notevole centro commerciale nell’Italia settentrionale,<br />
nel 286 d. C. l’imperatore Massimiano Erculeo la elesse capitale dell’Impero<br />
d’Occidente e non solo l’arricchì di pubblici monumenti, la dotò di condotti<br />
di scolo delle acque, ma anche la rafforzò di mura più solide, munite di<br />
460
Milano. Piazza dei Mercanti dalle arcate del Palazzo della Regione.<br />
Fot. Stefani
torrioni, dotate di ingressi fortificati e cinte di un fossato alimentato dalle acque<br />
del Sèveso e del Nirone. Tale cerchia di forma irregolare seguiva press’a poco<br />
il tracciato lungo la congiungente tra le vie Burini, Verziere, Paolo da Canobbio,<br />
Disciplini, Cappuccio, San Giovanni sul Muro, Monte di Pietà, e, a testimonianza,<br />
rimangono nella toponomastica cittadina attuale i nomi di San Giovanni sul Muro,<br />
Santa Maria alla Porta, Ponte Vètero e Carrobbio. Oltre alle posterie vi erano sei<br />
porte principali; la Romana, la Ticinese, la Vercellina, la Nuova, la Comacina e<br />
l’Argentea. Notevoli erano i monumenti entro la cerchia cittadina: oltre al Foro<br />
v’erano il circo, l’anfiteatro, il teatro, il palazzo imperiale e le terme di cui son<br />
rimaste tracce. Una parte dentro le mura, specie verso nordest, era a giardini e a<br />
orti e forse largo spazio era lasciato anche ai carriaggi e agli ordigni di guerra. Il<br />
Cristianesimo, che in quel tempo veniva diffondendosi nella città, non si potè nascondere<br />
nelle catacombe (impossibili a costruirsi per la natura alluvionale del sottosuolo)<br />
e gli adepti trovarono quindi rifugio nei cimiteri cristiani fuori mura. Dopo l’editto<br />
di Costantino (313) presso gli stessi, ossia fuori dalla cerchia, avvenne l’erezione<br />
di numerosi templi, quali quello dei Martiri, poi divenuto Sant’Ambrogio, quello<br />
degli Apostoli, in seguito dedicato a San Nazaro, quello della Vergine, poi divenuto<br />
San Simpliciano, quello di San Lorenzo, di Sant’Eustorgio e altri poi distrutti;<br />
tutti assieme essi formarono attorno alle mura la zona sacra, area, allora a orti suburbani,<br />
della futura espansione cittadina, al cui sviluppo contribuì forse la prima<br />
sistemazione idraulica connessa con la costruzione dei canali di derivazione dei<br />
fiumi dell’alta pianura. Tale opera, per quanto non databile con precisione, avvenne<br />
probabilmente nel periodo del massimo splendore di Milano imperiale. Prima in<br />
ordine di tempo sembra essere stata la derivazione dal vicino corso del Sèveso, le<br />
cui acque per mezzo di un canale furono guidate ad aggirare il lato orientale dell’abitato;<br />
impresa assai più cospicua fu certo la deviazione dell’Olona a Lucernate;<br />
il lungo canale (che per via catturava anche le acque della Dura e della Merlata)<br />
giungeva sul lato occidentale dell’abitato e, aggirandolo, si riuniva a sud con il fosso<br />
colmo di acque del Sèveso, dando origine alla Vettabbia, che nei secoli successivi<br />
fu anche utilizzata come arteria di navigazione. Terzo condotto, forse non in ordine<br />
di tempo ma certo d’importanza, fu quello del Nirone derivato dal Sèveso e dal<br />
Lambro con lo scopo di colmare di acqua fluente la fossa della cinta murata.<br />
Mentre la città si sviluppava e si organizzava all’ombra della croce, sopravvennero<br />
le incursioni barbariche. Le mura e i fossati non ebbero potere di fermare le<br />
orde di Attila che nel 451 saccheggiarono e distrussero l’abitato. La ripresa e la<br />
ricostruzione fu lenta e faticosa, ma dopo mezzo secolo Milano sembrava aver rimarginato<br />
le ferite e ricuperato vigore, allorché Uraia, mandato dal re dei Goti, giunse<br />
nel 538 con forze ingenti e, superate le rafforzate difese, mise a fuoco l’abitato. Quel<br />
che il fuoco risparmiò fu raso al suolo e Milano per qualche anno sembrò essere<br />
stata cancellata dalla faccia della Terra.<br />
Alla ricostruzione provvide Narsete, condottiero dell’Impero d’Oriente; nel 567,<br />
egli, vinti i Goti, ordinò di riedificare le mura e i Milanesi tornarono tra le rovine<br />
462
Fot. Sef<br />
Milano : la basilica di Sant’Ambrogio, soltanto un secolo fa<br />
« fuori di mano », come è detto sulla famosa poesia del Giusti,<br />
ora parte del nucleo centrale della città.<br />
in misere capanne di legno con il tetto di paglia. La città era così scarsamente popolata<br />
che nelle piazze, dette pasquée, cresceva l’erba per il pascolo degli armenti; a<br />
tanto squallore si vuol riallacciare le denominazioni di brolo, orto, era, campo, date<br />
a luoghi del centro cittadino, già abitate, ridotte ad aree coltivate.<br />
In così tristi condizioni Milano non poteva opporre resistenza ai sopravvenienti<br />
Longobardi che la risparmiarono. Declassata nei confronti di Pavia, divenuta capi-<br />
463
Schema monumentale di Milano medioevale,<br />
da un Codice della ((Geografia» di Tolomeo (Parigi, Biblioteca Nazionale).<br />
Fot. della Biblioteca<br />
tale, e anche (di Monza, la città an(dò lentamente risorgencdo (dalle rovine: si e(dificarono<br />
nuove chiese dentro e fuori le vecchie mura, nascondendovi i corpi dei<br />
Santi, per proteggerli dai predoni, si ricostruirono gli edifici in muratura, si diè<br />
inizio a quella che sarà poi detta « la cerchia dei navigli », allora costituita da un<br />
fossato e da un terrapieno i quali, recingendo con più largo raggio l’abitato, davano<br />
possibilità di più salda difesa. Con i vescovi, investiti anche di funzioni pubbliche,<br />
il centro della vita cittadina divenne la Domus (la casa per eccellenza in cui aveva<br />
464
dimora il vescovo) posta in un recinto quadrangolare che inizialmente si estendeva<br />
da piazza Mercanti a piazza della Scala e che successivamente si ampliò in un complicato<br />
sistema che comprendeva diverse chiese, tra le quali la Chiesa Maggiore (poi<br />
Santa Maria Maggiore) sul luogo ove poi sorgerà il Duomo. Nell’879 l’arcivescovo<br />
Ansperto da Biassono provvide a restaurare le antiche mura, ampliandone anche<br />
10 sviluppo per includervi la zona sacra presso le Porte Vercellina e Ticinese; dentro<br />
11 recinto, tra le Posterie di Porta Tosa e del Bottonuto, risultava anche un’area<br />
boscosa, il Brolo vescovile, di proprietà dell’arcivescovo. Poco si sa dell’edilizia<br />
civile: al Gordusio vi era la curia del Duca, presso la Domus sorgeva il primo Broletto,<br />
si formavano caotiche contrade che prendevano nome dai nobili, dei Bossi,<br />
dei Visconti, dei Meravigli, dei Piatti, ecc. I negotiatores avevano i loro mercati<br />
presso la Basilica Maggiore e presso piazza Mercanti; intorno ad essi vi erano le<br />
case degli artigiani, raggruppati secondo il mestiere, in vie particolari: degli Orefici,<br />
degli Armorari, degli Spadari, degli Speronari, delle Àsole, dei Pattari, dei Cappellari,<br />
dei Fustagnari, dei Profumari, dei Pellicciari, dei Borsinari, nomi che in<br />
parte rimangono nella toponomastica attuale. Ciò dimostra come Milano riprendesse<br />
vita anche nel campo commerciale. Fuori dalla città si estendeva la zona detta<br />
dei Corpi Santi, denominazione derivata forse dagli antichi luoghi di sepoltura dei<br />
martiri cristiani: essa aveva un raggio massimo a sud di circa 9 km., e un raggio<br />
minimo a nordest di 900 metri. Era un’area a ortaglie, a frumento, a prato e a<br />
vigna, e la sua popolazione formava una comunità distinta rappresentata in città<br />
da una deputazione provinciale.<br />
Divenuta libero Comune, Milano, ormai forte e ricca, tendeva ad espandere il<br />
suo potere ponendosi in lotta con Como, Lodi e Pavia. Incombendo poi la minaccia<br />
imperiale, tra il 1152 e il 1157, avvalendosi dell’opera di un mastro Guintellino,<br />
Milano rimodernò le sue difese con un più valido fossato e con aggiunte alla cerchia<br />
al fine di includere i borghi circostanti di Sant’Eufemia, di Porta Romana, di Porta<br />
Orientale, di Porta Nuova e di Porta Gomasina. Così rafforzata, Milano seppe resistere<br />
al Barbarossa ma, vinta per fame nel 1162, l’imperatore diè ordine di evacuare<br />
la città e i Milanesi dai Corpi Santi videro la loro fiorente città arsa e distrutta.<br />
La rievocazione che ne fa il Carducci, per bocca di Alberto da Giussano,<br />
è tragica:<br />
« Da i quattro Corpi Santi ad una ad una<br />
crosciar vedemmo le trecento torri<br />
de la cerchia; ed al fin per la mina<br />
polverosa ci apparvero le case<br />
spezzate, smozzicate sgretolate :<br />
parean file di scheletri in cimitero ».<br />
Per quattro anni quel che soppravisse della città rimase deserto, sinché la vittoria<br />
di Legnano diè via libera alla ricostruzione. Le nuove mura vennero erette sul tracciato<br />
ellittico della cerchia dei Navigli con una deviazione fuori Porta Ticinese, per<br />
comprendere la zona dei monasteri di Sant’Eustorgio, che sarà poi nota con il nome<br />
30 — Le Regioni d^talia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
465
Milano : veduta aerea del centro.<br />
A sinistra del Sagrato, i Portici settentrionali con la Galleria.<br />
A destra il palazzo reale e il campanile di San Gottardo.<br />
Fot. Fotocielo<br />
di Cittadella. Lo spirito di ripresa fu tanto fervido che la città risorse in breve volgere<br />
di tempo e si diede anche l’avvio a opere tanto ardite per quei tempi, come la<br />
costruzione del Naviglio Grande. Ultima opera prima del tramonto della libertà<br />
comunale fu la costruzione del Broletto nuovo nell’attuale piazza Mercanti, che<br />
attirò poi attorno a sè altri edifici pubblici, tra i quali il Palazzo della Ragione.<br />
Con i Visconti la città (che forse contava almeno loo.ooo ab. se è vero che la<br />
terribile peste del 1361 aveva fatto, compreso il contado, 70.000 vittime) progredì<br />
in decoro: fu eretta la Badia dei Mercanti (ove ora sorge il Palazzo dei Giureconsulti),<br />
furono costruite le cloache con scarico nei canali, furono riordinate le strade; ma<br />
l’innovazione destinata a maggiori conseguenze urbanistiche fu indubbiamente l’inizio<br />
della costruzione del Castello di Porta Giovia avvenuto nell’anno 1358. Infatti il<br />
castello, tenne sgombro verso la campagna un ampio settore, che, utilizzato<br />
466
allora per gli esercizi militari e in seguito trasformato in parco, resterà la più ampia<br />
oasi di verde nella massa densa e chiusa della città moderna. Con Gian Galeazzo<br />
poi si diè inizio nel 1386 alla costruzione del Duomo, che, espandendosi sull’area<br />
di Santa Maria Maggiore e di Santa Tecla, poneva le premesse urbanistiche della<br />
futura Milano : « ne consacrava cioè il centro (donde la forma urbana, monocentrica<br />
e stellare), stabiliva un nuovo orientamento viario da est a ovest e da nord a sud,<br />
destinato a suggerire agli edili futuri i rigori di un sistema ortogonale. Il millenario<br />
tracciato romano, impiantato di sbieco rispetto all’ago magnetico, subisce un primo<br />
inevitabile smantellamento; di qui tutti i futuri compromessi urbanistici della Milano<br />
moderna » (F. Reggiori).<br />
Pianta di Milano, del 1573. Sono messi in evidenza i bastioni<br />
delle mura spagnole e il Castello (che rispetto al centro trovasi a nordovest);<br />
visibile è anche la cerchia del Naviglio interno<br />
(Torino, Biblioteca Nazionale).<br />
467
Con gli Sforza Milano s’aprì al rinnovamento rinascimentale: si procedette al<br />
completamento del Castello, si diè inizio alla costruzione dell’Ospedale maggiore<br />
(l’attuale sede dell’Università) nel 1456, si intrapresero gli scavi della Martesana<br />
nel 1457, si edificò il Lazzaretto, si rafforzarono le difese cittadine, si elevò il tempio<br />
di San Celso. Con Ludovico il Moro, Milano raggiunse l’apice della prosperità e<br />
dello splendore; i commerci e le industrie prosperavano; uomini insigni di tutti i<br />
campi vi accorrevano, e, tra essi, Leonardo da Vinci che qui lasciò tracce imperiture<br />
del suo genio. La città, secondo il Corio, storico dell’epoca, contava 18.300 case,<br />
per cui si può ritenere che la popolazione fosse di circa 130.000 anime.<br />
Con la caduta di Ludovico il Moro iniziò la dominazione straniera francese e<br />
spagnola, breve e incolore la prima, lunga e triste la seconda. La città andò decadendo<br />
e la popolazione, falcidiata dalla peste, diminuì sensibilmente. Nel 1542 si<br />
sarebbero avuti 11.4 15 fuochi con circa 80.000 anime. Nel 1636 ancora meno,<br />
forse 60.000.<br />
Tuttavia nella struttura urbanistica della città la dominazione spagnola lasciò<br />
tracce profonde. Già dal tempo dei Visconti era stata elevata una linea esterna<br />
fortificata, circondata da un proprio fossato, il Redefosso, che includeva i borghi<br />
fuori dalle mura di Azzone. Ingranditasi però la città, la cortina settentrionale<br />
delle mura risultò avvolta dai nuovi edifici e defilata dai terminali sporgenti dalle<br />
stesse mura, sicché tra il 1525 e il 1527 verso il borgo degli Ortolani, dove entrava<br />
il Nirone ad alimentare il fossato del Castello, si aggiunse un’opera difensiva<br />
« a tenaglia » (nome che restò poi al borgo attiguo). Poi fu la volta del Castello a<br />
trovarsi racchiuso entro l’abitato in espansione, e i borghi a ridosso di esso, oltre<br />
a essere esposti all’offesa, costituivano un intralcio alla difesa; infine l’assieme delle<br />
fortificazioni risultava ormai superato dall’artiglieria. Si imponevano opere nuove<br />
militari e nel 1548 il governatore Ferrante Gonzaga deliberò di edificare i bastioni,<br />
munitissima cerchia poligonale a nove punte, con raggio press’a poco di un chilometro<br />
dal centro, in modo da includere tutti i sobborghi circostanti Г antiche cerehie.<br />
Ne risultarono inclusi anche larghi spazi di verde, a giardini e a orti. Sei porte, sul<br />
prolungamento delle antiche di maggiore importanza, convogliavano tutto il movimento<br />
verso la campagna. L ’antico fossato della cintura medioevale, ormai perduto<br />
il ruolo difensivo, divenne un’arteria di comunicazioni collegata con il Naviglio<br />
Grande e con la Martesana.<br />
La struttura cittadina così delineata non mutò gran che nei successivi secoli sino<br />
all’unità d’Italia. Il fatto più notevole per l’urbanistica milanese fu nel secolo XVIII<br />
la confisca dei possessi ecclesiastici. Ben 46 conventi furono adibiti a usi civili о<br />
abbattuti per lasciar spazio a nuove costruzioni pubbliche; tra queste il Teatro della<br />
Scala. La città intanto si accresceva nell’àmbito delle mura, occupando lentamente<br />
gli spazi verdi ancora liberi tra i borghi lineari allungati lungo le rotabili. Nel 1801<br />
la superficie fabbricata era di 3 milioni di metri quadrati sui circa 7 milioni dell’area<br />
racchiusa dalle mura; nel 1859, vigilia della proclamazione del Regno d’Italia,<br />
l’area fabbricata s’era accresciuta di circa 900.000 metri quadrati. Lo spazio entro<br />
468
Milano: la Galleria Vittorio Emanuele II verso Piazza della Scala.<br />
Fot. Stefani
le mura era dunque più che esuberante alla popolazione di allora, che dalle statistiche<br />
del tempo risultava di iio.ooo ab. nel 1760, di 1 15.000 nel 1801, di 178.000<br />
nel 1841 senza i Corpi Santi. Riguardo a questi (costituiti da borghi rimasti fuori<br />
dalle mura) i molti mutamenti amministrativi lasciano incerti sulla veridicità dei<br />
dati della relativa popolazione. Comunque, volendo assommare la loro popolazione<br />
a quella propriamente cittadina, la popolazione di Milano negli anni precedentemente<br />
specificati dovrebbe modificarsi rispettivamente in 124.000, 135.000 e<br />
207.000 abitanti.<br />
Con l’avvento napoleonico la città subì un notevole rinnovamento. Il Castello,<br />
cessato il suo ruolo militare, fu destinato a usi civili; le difese circostanti furono<br />
abbattute e con i rottami fu colmata la fossa che lo attorniava. Sull’ampio spazio<br />
così formatosi avrebbe dovuto sorgere un grandioso Foro dedicato al Bonaparte e<br />
destinato, secondo il piano regolatore (il primo di una lunga serie) a nuovo centro<br />
di affari per alleviare l’eccessiva concentrazione attorno al Duomo. Il progetto non<br />
fu realizzato e sorse invece, sul luogo dell’antica « tenaglia », l’Arena, la prima di<br />
costruzioni consimili, capace di 30.000 persone. Oltre il Parco fu poi aperta la<br />
Strada del Sempione, ampia arteria sulla dirittura dell’Arco della Pace che costituisce<br />
ancor oggi una della strade più belle e più frequentate di Milano. Notevole<br />
fu anche il rinnovamento cittadino. Il palazzo di Corte Vecchia fu trasformato in<br />
Palazzo Reale e il Corso (antica Corsia dei Servi) venne completamente trasformato.<br />
Popolazione presente, natalità e mortalità a Milano dal 1884 al 1951.<br />
1.300.000'<br />
i l 1.200.000<br />
Milano: il Teatro<br />
della Scala. In primo<br />
piano il basamento<br />
del monumento<br />
a Leonardo<br />
da Vinci.<br />
Fot. Fotocelere<br />
Il Duomo, ormai svettante sulla città con la sua alta guglia centrale (m. 108,50), fu<br />
completato con la contrastante facciata.<br />
L ’unione all’Italia dava inizio a un periodo di grandioso sviluppo, fervido di<br />
iniziative. Nel 1873 avvenne l’annessione definitiva dei Corpi Santi, e in tal modo<br />
si venne a costituire un circondario interno e uno esterno. Nel 1877 venne realizzata,<br />
su progetto dell’architetto Mengoni, la sistemazione della piazza del Duomo<br />
che rappresentò un atto di fede nella futura grandezza di Milano. La grande piazza<br />
rettangolare fiancheggiata da edifici con portici e con la galleria inclusa nel palazzo<br />
settentrionale «sovvertiva l’intero centro cittadino, in contrasto con la superstite rete<br />
viaria, fonte di compromessi per ottenere una saldatura tra vecchio e nuovo »<br />
(F. Reggio ri). Attorno al vecchio centro era un pullulare di artigiani e di piccole<br />
industrie, prodromi del futuro sviluppo. Intanto venivano via via colmandosi i vuoti<br />
nell’interno della cerchia dei bastioni, in un caotico alternarsi di abitazioni e di industrie,<br />
e l’abitato si dilatava anche fuori specialmente lungo le vie di comunicazione.<br />
Ad accelerare la trasformazione cittadina si delineò un altro fattore di notevole<br />
peso: lo sviluppo ferroviario. AU’unità d’Italia le ferrovie in esercizio erano la<br />
vecchia Milano-Monza prolungata sino a Camerlata, la Milano-Magenta, che faceva<br />
capo a una stazione presso l’attuale via Melchiorre Gioia, e la Milano-Peschiera,<br />
che faceva capo a una stazione presso Porta Vittoria. L ’ulteriore sviluppo ferroviario<br />
con Torino, Genova, Piacenza, Gallarate e Lecco impose la necessità del raccordo<br />
di tutte le linee con un’unica grande stazione. Questa venne costruita a nordest<br />
4 7 1
della città poco fuori dai Bastioni e aperta al traffico nel 1864. L ’anno successivo<br />
veniva inaugurata anche la stazione sussidiaria di Porta Genova. Il fatto non fu<br />
senza riflessi: aree prossime alle due stazioni, che sin allora erano dedicate alle<br />
colture, vennero rapidamente occupate da nuovi estesi quartieri. Si rese necessaria<br />
allora anche una rete di comunicazioni cittadine e nel 1881 uscirono i primi tram<br />
a cavalli.<br />
Per quanto la popolazione non crescesse molto rapidamente (nel 1871 Milano<br />
contava ancora 261.000 ab.), il ritmo costruttivo divenne tanto notevole da rendere<br />
necessario un piano regolatore che fu predisposto da Cesare Beruto nel 1884; tale<br />
piano, approvato nel 1889, disciplinò poi sino a tutto il primo decennio del nostro<br />
secolo lo sviluppo cittadino, accentuandone lo sviluppo stellare lungo le vie irradianti<br />
dalla piazza del Duomo. Merito del piano fu quello di avere promosso il<br />
raggruppamento di edifici con uniformità di funzioni in quartieri, preludio di una<br />
« zonizzazione » modernamente intesa. Si formò il quartiere residenziale prossimo<br />
al Parco del Castello (via X X Settembre), il quartiere ospitaliero sull’antico brolo<br />
(via Francesco Sforza), il quartiere degli Istituti universitari (Città degli Studi), il<br />
quartiere degli approvvigionamenti (Porta Vittoria) sul luogo di antiche fortificazioni<br />
austriache. La cerchia delle mura spagnole, ormai superflue, venne parzialmente<br />
distrutta per far posto a un viale spazioso della Circonvallazione interna.<br />
All’esterno delle mura la città si dilatava a macchia d’olio sul disegno di arterie<br />
parallele e radiali ai lati del poligono formato dalle mura. Il presumibile ampliamento<br />
cittadino veniva circoscritto da un ampio anello di strade, chiamato della<br />
Circonvallazione esterna.<br />
Ma con lo sviluppo industriale l’espansione della città assumeva un ritmo imprevisto:<br />
i 261.000 ab. del 1871, nel volgere di soli trent’anni, quasi raddoppiavano;<br />
infatti all’inizio del secolo la popolazione era ormai prossima al mezzo milione di<br />
abitanti e la superficie fabbricata era di ben io milioni di metri quadrati. Già nei<br />
primi anni del secolo circa 300 case d’abitazione e 50 opifici erano sorti al di fuori<br />
del piano Beruto e si rendeva quindi necessario predisporre un nuovo piano che<br />
fu ideato dagli architetti Pavia e Masera e varato nel 19 12; oltre ad opportune<br />
sistemazioni interne, come l’apertura del corso Italia e lo sventramento di parte del<br />
quartiere prossimo a San Bàbila, si diè ordine allo sviluppo dei quartieri ai margini<br />
della città.<br />
Dopo la stasi determinata dalla guerra 1915-18 seguì una formidabile ripresa<br />
edilizia per cui si rendeva urgente una disciplina urbanistica secondo criteri più<br />
moderni. Per questo si presentava anzitutto necessaria l’aggregazione dei comuni<br />
limitrofi ormai compresi nella sfera della metropoli, i confini comunali della quale<br />
si presentavano particolarmente angusti verso le parti di maggiore espansione edilizia.<br />
Milano s’ingrandì quindi con l’annessione dei territori di Baggio, Trenno,<br />
Musocco, Affori, Niguarda, Greco, Gorla-Precotto, Grescenzago, Turro, Lambrate,<br />
Chiaravalle e Vigentino e di alcune frazioni. La superficie comunale si espandeva<br />
così da 75 kmq. a 185 circa e si raggiungevano gli 860.000 abitanti. Si rendeva per-<br />
472
Milano: la facciata originale di Palazzo Marino<br />
e la chiesa di San Fedele, con il monumento al Manzoni.<br />
tanto necessario un nuovo piano regolatore che, elaborato sul progetto Portaluppi<br />
e Semenza, venne approvato nel 1934.<br />
Intanto erano avvenute realizzazioni non trascurabili anche se non tutte adatte<br />
ai nuovi tempi. Tra l’altro nel 1931 era stata aperta al traffico la nuova grandiosa<br />
stazione, edificata sull’antico ippodromo in posizione più arretrata della precedente,<br />
ma purtroppo su progetto, come rivela lo stile, risalente al 1906 e non in tutto funzionale.<br />
Davanti alla stazione si stendeva un nuovo ampio spazio che, abbattuti i<br />
bastioni, venne sistemato in ampia piazza, oggi della Repubblica. Anche altrove<br />
i bastioni venivano a poco a poco spianati sicché attualmente rimangono solo alcune<br />
vestigia. Fu coperta via via anche la fossa interna dei Navigli (non senza rimpianti<br />
per gli scorci suggestivi dell’antica Milano che essa ancora conservava) e sulla<br />
copertura si sviluppò la strada ad anello che ancor oggi conserva il nome di Cerchia<br />
dei Navigli. Sull’area della vecchia Piazza d’Armi veniva sistemata la Fiera campio-<br />
473
naria già ospite precedentemente dei Bastioni di Porta Venezia. Larghi sventramenti<br />
facevano posto al grandioso Palazzo di Giustizia, al nodo stradale di San Bàbila, al<br />
nuovo corso Littorio (ora Matteotti). Così pian piano la vecchia Milano, non priva<br />
di un suo fascino romantico, spariva per dar luogo alla metropoli industriale e<br />
commerciale.<br />
A cancellare il vecchio volto contribuirono crudamente gli indiscriminati bombardamenti<br />
aerei durante gli anni delFultima guerra; più di due quinti dei vani<br />
abitabili furono perduti per crollo о per fuoco, ossia 360.000 su 930.000 esistenti.<br />
Schema degli ampliamenti della città e del comune di Milano.<br />
I, area di Milano romana; 2,1 ampliamento; 3, II ampliamento; 4, cinta delle mura imperiali; 5, cerchia medioevale dei<br />
Navigli; 6, bastioni spagnoli; 7, confini comunali verso il i860; 8, confini comunali nel 1874 (dopo l’aggregazione dei Corpi<br />
Santi) e divisioni in zone; 9, territorio del comune di Greco aggregato nel 1904; io, territori di Morsenchio e Triulzio<br />
aggregati nel 1917; ii, territorio di Turro aggregato nel 1918; 12, territori di Lorenteggio e Ronchetto aggregati dopo il<br />
1923; 13. limiti attuali del Comune; 14, territorio temporaneamente aggregato nel 1923; 15, limite approssimato dell’attuale<br />
aggregato urbano.<br />
Utet<br />
474
Fot. С. R. PP. L L .<br />
Milano: la Ca’ de Sass, sede della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde,<br />
grande e benefico istituto bancario, fondata nel 1823.<br />
Altri 200.000 vennero inoltre danneggiati. Intieri quartieri scomparvero in un cumulo<br />
di rovine, molte vie furono cancellate sotto l’ammasso delle macerie. E, sotto, morti<br />
e morti. Non vennero risparmiati neppure monumenti insigni come il Duomo, mozzato<br />
di diverse guglie, il Cenacolo di Leonardo, la Pinacoteca di Brera, il Teatro<br />
alla Scala, la Basilica di Sant’Ambrogio, il Palazzo Marino, ecc. Sembrarono, allora,<br />
rinnovarsi, moltiplicate smisuratamente, le crudeltà del Barbarossa.<br />
Il dopoguerra diede una superba dimostrazione della capacità di ripresa e della<br />
vitalità della città lombarda. Rimosse rapidamente le macerie, l’opera di ricostruzione<br />
fu immediata. Nel volgere di un decennio le ferite erano in gran parte can-<br />
475
celiate e sulla rinata città cominciarono a levarsi i grattacieli, quasi simbolo di nuovo<br />
ardimento e di indomabile volontà. Il piano urbanistico in atto prevede la costruzione<br />
di grandi assi viari di penetrazione nell’aggregato urbano, la creazione di un<br />
centro direzionale tra la Stazione Centrale e viale Zara, l’arretramento della stazione<br />
delle ferrovie varesine, la più netta delimitazione della città in zone, conservando<br />
alle industrie aree periferiche particolarmente adatte. Il fervore di ricostruzione<br />
e di rinnovamento che ha caratterizzato il dopoguerra non è diminuito con<br />
il passare degli anni, anzi può dirsi accresciuto dalla necessità di continuo adeguamento<br />
alle crescenti esigenze determinate dall’accrescersi della popolazione e dalla<br />
intensa attività commerciale: esempio lampante è la costruzione in atto della metropolitana,<br />
che avrà senza dubbio riflessi per molti aspetti notevoli. Tra questi un<br />
accentuarsi delle caratteristiche distributive della popolazione che già oggi si possono<br />
cogliere con evidenza.<br />
A tal proposito la situazione può essere così brevemente delineata. Il quadro<br />
della Milano ottocentesca ci presenta il nucleo cittadino entro la cerchia dei Navigli<br />
Atto di dimore d’abitazione e di botteghe di artigiani, già saturo di abitanti; nell’anello<br />
compreso tra la Cerchia dei Navigli e le mura spagnole è quindi la zona delle<br />
nuove dimore e delle industrie che vanno colmando i residui spazi verdi; già qualche<br />
gruppo di dimore e di opifici comincia a espandersi fuori le mura, ma si tratta<br />
ancora di modesti borghi. Infatti nel i86i su 242.000 ab. del comune di Milano<br />
solo 46.000 risiedevano fuori dalle mura. In un periodo non precisabile, ma che<br />
può forse collocarsi subito dopo la prima guerra mondiale, anche tra le mura spagnole<br />
si raggiunge la saturazione e lo sviluppo cittadino può aver luogo solo fuori<br />
mura. Tutto sin qui appare ovvio; ma è interessante aggiungere che almeno sin<br />
dall’inizio del secolo le statistiche dimostrano una quasi costante e sensibile diminuzione<br />
della popolazione dentro la Cerchia dei Navigli: da 1 13.000 residenti<br />
nel 1901 si passa a 68.000 nel 1951. Il fatto è spiegabile con lo sviluppo delle sedi<br />
di rappresentanza, degli istituti bancari, degli empori, ecc., nell’àmbito della Cerchia.<br />
Ad ogni rinnovo edilizio alle dimore di abitazione si sostituiscono uffici commerciali,<br />
costretti da esigenze di attività a trovar una sede nel centro e in grado di<br />
sostenere gli altissimi prezzi d’acquisto о gli elevatissimi canoni d’affitto. La zona<br />
dentro la Cerchia manifesta quindi un’evidente tendenza a divenire una city di<br />
affari. E interessante poi notare che man mano che la città si dilata in periferia<br />
anche la city sembra espandersi. Si sarebbe portati a dedurlo dal decrescere progressivo,<br />
anche nell’anello tra la Cerchia dei Navigli e la circonvallazione, della<br />
popolazione dal 1921 in poi: 152.000 ab. nel 1921, 132.000 nel 1931, 129.000 nel<br />
1936, 125.000 nel 1951. La città fuori delle mura spagnole è l’area del grande<br />
aumento: i 46.000 ab. del 1861 sono divenuti 1.082.618 nel 1951! Ciò determina<br />
nel movimento cittadino un’ondata mattutina e pomeridiana di decine e decine di<br />
migliaia, anzi si potrebbe dire, senza tema di esagerazione, di centinaia di migliaia<br />
di lavoratori, soprattutto impiegati, dall’anello esterno della città verso il centro, e<br />
un’ondata in senso inverso al tocco e a sera.<br />
476
Fot. Fotocielo<br />
Milano: Piazza della Repubblica (a destra) e via Vittor Pisani, presentano l’aspetto moderno della città.
Schema dimostrativo della distribuzione<br />
delle industrie in Milano nel<br />
i88i.<br />
Utet<br />
Utet<br />
Schema dimostrativo della distribuzione<br />
delle industrie in Milano nel<br />
1910.
Industrie metallurgiche e meccanich<br />
^ >» chimiche<br />
I «> tessili e abbigliamento<br />
■ »1 alimentari<br />
Ѵ/Л Zone industriali fu tu r e<br />
----------------------------------- - - - km.<br />
U t e t<br />
Schema dimostrativo della distribuzione delle industrie in Milano nel 1958-<br />
Ancor più netta ed evidente è stata la trasmigrazione delle industrie. Verso<br />
il 1880 e negli anni immediatamente successivi le industrie presentavano una<br />
maggior densità entro la Cerchia dei Navigli ed era comprensibile dato che esse<br />
stavano allora sbocciando dall’artigianato e le scarse dimensioni non ponevano<br />
ancora problemi di spazio. Maggiore era il numero delle fabbriche nell’anello tra<br />
i Navigli e le mura spagnole, ma, in rapporto al maggiore spazio, assai meno fitte;<br />
esse si allineavano soprattutto lungo le maggiori arterie e particolarmente lungo<br />
quelle dirette a nord e a sud. Modesto era ancora lo sviluppo industriale fuori dalle<br />
mura; vi erano solo alcuni raggruppamenti presso gli scali ferroviari (Centrale e<br />
Genova) e presso le Porte Ticinese e Tenaglia. Rispetto ai singoli rami industriali<br />
non si notavano raggruppamenti evidenti; si può tuttavia notare che le industrie<br />
che traevano propriamente origine dall’artigianato, quali l’oreficeria, la tipografia.<br />
479
il maglificio, il nastrificio, la lavorazione del legno, delle pelli, ecc., prevalevano,<br />
almeno come numero se non come entità, entro la Cerchia dei Navigli; le industrie<br />
tessili erano dislocate di preferenza lungo i canali, ancora tutti allo scoperto; le<br />
industrie nuove, come le meccaniche e le chimiche, erano prevalenti nella zona periferica,<br />
sia dentro che fuori le mura spagnole.<br />
Alla vigilia della prima guerra mondiale la situazione era già notevolmente modificata.<br />
L ’industria aveva già assunto notevoli proporzioni e i maggiori impianti, sia<br />
per ragioni di spazio, sia per ragioni di costi, sia anche per ragioni d’igiene, avevano<br />
posto la loro sede al di fuori della Cerchia dei Navigli, ma dentro e fuori la<br />
cerchia della circonvallazione. L ’area dentro i Navigli già cominciava a svuotarsi<br />
di industrie. In breve i nuovi palazzi d’abitazione e per uffici commerciali prendevano<br />
in centro il posto delle officine; queste sorgevano ad occupare l’area già<br />
degli orti suburbani e gli orti erano sospinti più all’esterno. Ma la spinta dal centro<br />
verso la periferia non si manifestava uniforme su ogni lato e già il settore settentrionale,<br />
a causa della maggiore asciuttezza del suolo e della maggiore disponibilità di<br />
mano d’opera, aveva assunto un più intenso sviluppo. Comunque, il problema della<br />
zonizzazione non si era sino allora affermato rigidamente e le industrie si erano<br />
andate disponendo ad anello, ciò che sarà causa di gravi problemi in decenni più<br />
recenti. A i nostri giorni le industrie sono sparite del tutto dalla zona interna dei<br />
Navigli. Si sono rarefatte notevolmente anche nell’anello interno alla circonvallazione<br />
e vanno riunendosi in zone all’estrema periferia, cercando anzi spesso una<br />
nuova sede fuori dell’amministrazione del comune milanese.<br />
Questo esodo delle industrie dal territorio comunale (specialmente verso l’alta<br />
pianura e la collina) è un fatto del tutto recente, ma ha avuto i suoi prodromi durante<br />
l’ultimo conflitto, allorché la minaccia di distruzioni aeree sollecitò il trasferimento<br />
(quando naturalmente l’attrezzatura lo consentiva) dalla città alla campagna;<br />
cessata la guerra, non in ogni caso si verificò un nuovo trasferimento nella precedente<br />
sede cittadina. In seguito i criteri restrittivi del piano regolatore del 1953<br />
ispirato al principio di allontanare le industrie dall’aggregato urbano e di raggrupparle<br />
in aree riservate a tale scopo al limite del territorio comunale, hanno avuto<br />
risultati parzialmente differenti da quelli previsti. Infatti, un buon numero di piccole<br />
e medie industrie (nel 1959 se ne annoveravano circa 600) hanno trovato<br />
sede più conveniente, anziché nelle zone all’uopo prediposte, presso i centri<br />
minori al di fuori del territorio propriamente milanese. Perdurando tale fatto,<br />
le conseguenze di ordine sociale e soprattutto economico, potrebbero essere sensibili,<br />
ma non allarmanti nella misura che l’amore cittadino può indurre a prospettare;<br />
piuttosto tale fatto dovrebbe sollecitare l’urgenza di un preveggente coordinamento<br />
tra il piano regolatore urbanistico e il piano regolatore regionale perché<br />
gli sviluppi futuri siano armonicamente indirizzati.<br />
Lo sviluppo industriale di Milano, per quanto imponente, non deve far dimenticare<br />
altre prerogative della città, come quella di centro finanziario, bancario, commerciale<br />
in cui ha una preminenza non solo regionale ma addirittura nazionale.<br />
480
ш<br />
i''?<br />
Ш<br />
• " 'l i '* ''" ! ,»<br />
,1(1«<br />
i«""jííí^rr4<br />
iíí* " ’r u ! i i"*<br />
Fot. Stefani<br />
Milano modernissima: il grattacielo Pirelli.<br />
L e R eg io n i d 'I t a lia - L o m b a rd ia
preminenza che si è affermata sempre più nettamente negli ultimi decenni. La<br />
molteplice caratteristica della città si rispecchia del resto in modo abbastanza evidente<br />
nella struttura cittadina.<br />
Il nucleo cittadino, delimitato approssimativamente dall’anello stradale che sostituisce<br />
l’antica Cerchia dei Navigli, ospita ormai quasi esclusivamente istituti finanziari<br />
e bancari e rappresentanze commerciali. L ’edilizia, profondamente rinnovata<br />
dopo la guerra, non ha alterato la sua struttura fondamentale, adottando tuttavia<br />
opportune soluzioni per agevolare l’intenso movimento. Ne è tipico esempio la via Vittorio<br />
Emanuele che dalla parte absidale del Duomo si dirige verso largo San Bàbila<br />
(dove s’innesta nel corso Venezia diretto alla Porta omonima); si tratta di una delle<br />
vie più frequentate della città e nel rinnovamento recente, che offre una suggestiva<br />
prospettiva di architettura moderna, si sono disposti, affiancati alla sede viaria, due<br />
ordini di portici, dei quali il settentrionale risulta in prosecuzione dei portici della<br />
piazza del Duomo. Nel complesso il nucleo cittadino va rinnovandosi rapidamente<br />
Fot. Publifoto<br />
Milano: la darsena di Porta Ticinese<br />
(a destra in basso, il Naviglio Grande e il Naviglio di Pavia).<br />
31 — L e R eg io n i d ’ Ita lia - L o m b a rd ia .<br />
4 8 1
1<br />
Pianta di Milano.<br />
Utet<br />
e assumendo un aspetto del tutto moderno non certo privo di bellezza; in genere<br />
lo sviluppo edilizio in altimetria è contenuto dalla necessità di dar respiro alle vie,<br />
che, per quanto ampliate, hanno ereditato l’angustia dei vicoli medioevali, e soprattutto<br />
dalla opportunità di mantenere inalterato il dominio della imponente mole<br />
del Duomo. Questo costituisce il monumento massimo della città e con il suo sontuoso<br />
sagrato occupa il centro geometrico del nucleo urbano. L ’immensa costruzione<br />
(coi suoi 11.700 mq. è la seconda chiesa del mondo per superficie), sostenuta da<br />
una potente ossatura in granito (ghiandone) e rivestita dal marmo rosato di Candoglia,<br />
è frutto di sei secoli di lavoro e di collaborazione collettiva mantenutasi fedele, in<br />
complesso, ai princìpi dell’architettura gotica; ne discorda tuttavia la facciata in cui<br />
malamente s’inseriscono elementi di stile classico. La ricca ornamentazione, specialmente<br />
statuaria (di statue ve ne sono 2245 all’esterno e 914 all’interno), s’accentua<br />
verso l’alto in un leggiadrissimo ricamo che dagli archi rampanti fiorisce in una selva<br />
482
di eleganti pinnacoli coronati di statue; domina su di essi, al centro della crociera,<br />
il tiburio che regge in vetta, a m. 108,50, una statua in rame dorato della Madonna,<br />
« la Madonnina », divenuta quasi un simbolo della città. L ’interno del Duomo, nella<br />
tenue luce filtrata dai policromi finestroni, è grandioso e severo; 52 pilastri disposti<br />
su quattro allineamenti distinguono le cinque navate di cui la mediana è di ampiezza<br />
doppia delle laterali. La grandiosa mole richiede un’opera di manutenzione e di<br />
completamento vigilante e continua e ad essa sovraintende la « Fabbrica del Duomo »<br />
cui si devono, in anni recenti, i restauri ai danni portati dalla guerra e il collocamento<br />
dei portali laterali in bronzo.<br />
Fot. Fotocielo<br />
Milano: le attrezzature sportive a San Siro.<br />
483
Il sagrato, a forma rettangolare, affiancato da costruzioni simmetriche a porticato,<br />
costituisce il centro delle manifestazioni cittadine e luogo tradizionale di convegno<br />
dei Milanesi. Sul suo lato settentrionale, s’apre con un grande arco di trionfo la galleria<br />
Vittorio Emanuele, a quattro bracci disposti a croce, coperti da luminose vetrate ;<br />
un braccio s’apre su piazza della Scala in cui si affacciano il cinquecentesco Palazzo<br />
Marino e « La Scala », il più celebre teatro lirico d’Italia. Della parte monumentale<br />
del centro cittadino meritano di essere segnalati il Palazzo della Ragione (1228-33),<br />
l’edificio più insegne dell’antico nucleo medioevale, la vicina piazza dei Mercanti che<br />
costituiva il Foro ed era originariamente chiusa, con sei porte in corrispondenza<br />
dei rispettivi rioni cittadini, e, a fianco, la Loggia degli Osii (1316), in marmi bianchi<br />
L ’idroscalo, bacino artificiale a occidente della città,<br />
sede di manifestazioni sportive.<br />
Fot. Fotocielo
e neri, a loggiati sovrapposti. Notevole, a fianco del settecentesco Palazzo Reale,<br />
che s’affaccia parzialmente sul sagrato, la chiesa di San Gottardo (1336) dal bel<br />
campanile ottagonale in laterizi e marmi, sormontato da un elegante coronamento<br />
colonnare.<br />
Alla periferia del nucleo cittadino i monumenti più insigni delle diverse età sono :<br />
la Basilica di San Lorenzo Maggiore, la Basilica di Sant’Ambrogio, il Castello Sforzesco<br />
e la Ga’ Granda. La Basilica di San Lorenzo, presso la medioevale Porta Ticinese<br />
della cerchia eretta nel 117 1, è uno dei monumenti più notevoli del periodo<br />
paleocristiano. La sua costruzione risale alla metà del IV secolo e i successivi restauri<br />
ne rispettarono sostanzialmente la forma originaria a pianta centrale coperta da una<br />
maestosa cupola. Antistante alla basilica si levano sedici colonne marmoree, con capitelli<br />
corinzi, del II secolo, tratte da un edificio romano per formare un quadriportico<br />
antistante alla chiesa. La Basilica dedicata a Sant’Ambrogio, patrono di Milano,<br />
è una stupenda costruzione di architettura romanica lombarda del secolo X II; sorge<br />
sull’antica area del cimitero cristiano ad Martyres, che, nei primi secoli del Gristianesimo,<br />
trovavasi fuori Porta Vercellina; nel secolo XII venne a trovarsi inclusa<br />
nella cerchia murata e la vicina « pusterla di Sant’Ambrogio », già affacciata sul Naviglio<br />
con doppio fòrnice e doppio torrione, ne è la superstite attestazione. La severa<br />
costruzione basilicale costituisce un’oasi tranquilla nella frenetica vita cittadina e<br />
custodisce auguste memorie della storia milanese; è prevalentemente in laterizi<br />
armoniosamente associati alla pietra; il predominio dell’arcata non intacca la possente<br />
struttura, che ha sfidato non solo il tempo, ma altresì lo scempio dei bombardamenti<br />
aerei. Il Castello Sforzesco è un maestoso complesso di costruzioni in<br />
laterizi restituito alle sue originarie forme quattrocentesche da grandi restauri. La<br />
pianta quadrata, con lati di 200 m., presenta la parte più suggestiva rivolta al centro<br />
cittadino: sopra il grande portale d’ingresso, s’eleva la Torre del Filarete (m. 70),<br />
vigilata agli spigoli da poderose torri cilindriche, che offre prospettive di notevole<br />
bellezza lungo l’ampia via Dante che si' dirige al Duomo. La Ca’ Granda, l’antico<br />
Ospedale Maggiore, è uno dei più insigni monumenti quattrocenteschi della città;<br />
la parte migliore è quella del Filarete, riccamente decorata in cotto, in cui si fondono<br />
elementi gotici e rinascimentali; nella ricostruzione, dopo i gravi danni determinati<br />
dai bombardamenti aerei, si sono rispettate le forme originarie esterne,<br />
adattando modernamente l’interno a sede universitaria.<br />
L ’anello urbano tra la Cerchia dei Navigli e la circonvallazione (che rappresenta<br />
il tracciato delle mura spagnole) è area di sviluppo dei secoli XVIII e XIX, specialmente<br />
di quest’ultimo. La sua più recente età si rivela non solo nell’architettura,<br />
ma altresì nel tracciato delle vie, più ampie e rettilinee (o meno contorte) e nel<br />
miscuglio frequente delle costruzioni industriali inserite tra quelle civili. Il rinnovamento<br />
edilizio procede anche in questa parte, come nella centrale, ma meno<br />
rapido e più sporadico. Anche le costruzioni monumentali sono meno frequenti e<br />
le più insigni rappresentano le sedi religiose preesistenti alla Cerchia spagnola, come<br />
Sant’Eustorgio, sul luogo di un cimitero cristiano del IV secolo, e Santa Maria delle<br />
485
Grazie, convento dei domenicani del secolo XV. La Basilica di Sant’Eustorgio,<br />
eretta nel secolo XII (in sostituzione di una più antica chiesa) e successivamente<br />
completata con il chiostro dei monaci domenicani e con le cappelle gentilizie, è un<br />
prezioso monumento d’arte lombarda; sorge presso il propileo che ricorda la vittoria<br />
napoleonica di Marengo innalzato in luogo degli archi delle scomparse mura<br />
spagnole che, per essere in prosecuzione di quelli dei Navigli, ereditarono il nome<br />
di Porta Ticinese, ed è secolare usanza ambrosiana che i novelli arcivescovi della<br />
metropoli facciano il loro ingresso in città partendo dalla basilica. La Basilica di<br />
Santa Maria delle Grazie si trova sulla direttrice di Porta Magenta; con l’annesso<br />
chiostro, in cui ebbero sede sin dalla fondazione i domenicani, è una delle opere<br />
più suggestive del rinascimento lombardo; in essa il corpo anteriore, del Solari, conserva<br />
le forme originarie di un gotico di transizione, mentre la tribuna, che s’innesta<br />
a guisa di cubo triabsidato, rivela l’inconfondibile impronta del Bramante. Nell’antico<br />
refettorio del convento è custodita la Cena, opera celeberrima di Leonardo<br />
da Vinci, che, nonostante il grave stato di deperimento, conserva intatta la suggestione<br />
delle « divine proporzioni » di composizione.<br />
Fuori dalla cerchia della circonvallazione si espande la città moderna; l’edilizia,<br />
salvo lungo le antiche vie radiali, ha un manifesto carattere di attualità; le vie sono<br />
ampie e per lo più rettilinee, le piazze grandiose e ben dislocate; rare tuttavia le<br />
oasi di verde. Nell’ampia cerchia si possono individuare alcuni settori di più fitto<br />
addensamento industriale, come quelli di San Cristoforo e della Barona a sudovest,<br />
della Gagnola e della Bovisa a nordovest, di Greco e di Turro a nordest, di Lambrate<br />
a est, di Rogoredo a sudest. Il settore di San Siro, a ovest, si inserisce come<br />
area delle manifestazioni commerciali e sportive; vi si trova anzitutto la Fiera Campionaria,<br />
sorta sul luogo della Piazza d’Armi, con il grandioso Palazzo dello Sport,<br />
e, in vicinanza il Velodromo Vigorelli, giudicato tra i migliori d’Furopa; poi il Lido<br />
di Milano, con due piscine e campi di pattinaggio e tennis, il vasto Ippodromo, il<br />
Trottatoio e lo Stadio calcistico capace di loo.ooo spettatori.<br />
Varese.<br />
Varese giace su un ripiano (382 m.) circondato da amenissime colline ai piedi<br />
delle Prealpi occidentali della <strong>Lombardia</strong>, da cui s’erge, in posizione dominante,<br />
il Campo dei Fiori, ospitante su uno sprone il celebre Santuario del Sacro Monte.<br />
La città ha un aspetto moderno ed è infatti città moderna la cui importanza trae<br />
soprattutto origine dal rapido sbocciare di una rigogliosa attività industriale. Per<br />
quanto si trovi in mezzo a una zona di insediamenti preistorici, e in particolare<br />
palafitticoli, la sua storia ha inizio con il Medioevo, quale borgo fortificato del<br />
contado del Seprio; ma esso non si distinse per vicende particolari, soggetto prima<br />
486
all’autorità dell’arcivescovo di Milano, poi a quella dei Visconti e degli Sforza. Dopo<br />
un breve periodo di amministrazione autonoma, in quanto possesso staccato del<br />
Duca di Modena (1765-80), divenne, con la formazione della Repubblica Cisalpina,<br />
capoluogo del distretto del Verbano; ma già nel 1801 rientrava nell’ombra, assorbito<br />
nel Dipartimento dell’Olona. Si trattava del resto ancora di un borgo, con poche<br />
migliaia di abitanti, noto come luogo di villeggiatura, ma di fama minore di quella<br />
che già godeva il soprastante Sacro Monte.<br />
Il 26 maggio 1859 i Cacciatori delle Alpi entravano in Varese dopo una vittoriosa<br />
battaglia a cui i cittadini portarono valido contributo. Con l’unità d’Italia<br />
cominciò il grande sviluppo di Varese, cauto agli inizi e successivamente rapido e<br />
grandioso, favorito in un primo tempo dal moltiplicarsi delle comunicazioni con<br />
Milano poi incoraggiato dall’erezione della città a capoluogo di provincia (1927).<br />
L ’aggregato urbano, che nel 1861 aveva ancora 5000 ab., all’inizio del secolo ne<br />
contava tre volte tanti e, nel 1951, 36.000; ma, essendo, come centro moderno, assai<br />
disperso, occorre computare anche la popolazione dei sobborghi e delle ville sparse<br />
nell’ambito comunale; in totale, nello stesso anno 1951, Varese registrava 53.000 unità.<br />
Il nucleo centrale dell’aggregato urbano ha forma ovoidale allungata da nord<br />
a sud; esso rappresenta il borgo antico che, prima del rinnovamento edilizio, rivelava,<br />
più evidente che non ora, un aspetto cinquecentesco. Di tale periodo è anche<br />
Fot. Fotocielo<br />
Varese: il Palazzo Ducale<br />
(ora Municipio) fatto erigere<br />
da Francesco II d’Este,<br />
duca di Modena, con il<br />
Parco, ora Giardino pubblico.<br />
487
Varese: il centro della città.<br />
Fot. Fotocielo<br />
il rifacimento della Basilica di San Vittore che è al centro del vecchio nucleo. Con<br />
lo sviluppo della città moderna il centro cittadino è stato spostato al margine meridionale<br />
dell’antico aggregato ; esso, ricavato dalla demolizione di un vecchio quartiere,<br />
fa perno ora nella vasta piazza Monte Grappa (1927-35). La città nuova non ha potuto<br />
estendersi a macchia d’olio; l’ostacolo frapposto dalle colline ha determinato l’espansione<br />
dell’aggregato in forma grossolanamente stellare a tre punte, una in direzione sud<br />
e le altre rispettivamente nordest e nordovest. La collina che s’interpone a sudovest<br />
è, sul versante rivolto alla città, ornata di un magnifico parco e in versante opposto è<br />
tutta ville e giardini. Pure a ville e giardini è lo stupendo pendio che dolcemente<br />
488
isale verso nord, a Sant’Ambrogio e al Sacro Monte. Le centinaia e centinaia di<br />
villette linde e aggraziate, che si estendono ininterrottamente fino alle castellarne, о<br />
sobborghi (alcuni dei quali fanno ormai un tutto unico con la città), danno l’impressione<br />
della città-giardino, cui altre città lombarde vanamente aspirano e Varese già<br />
possiede, sicché l’attività industriale, pur così intensa, rimane quasi celata e più che<br />
altro s’awerte nel vivacissimo movimento cittadino.<br />
Como.<br />
Como giace all’àpice del ramo sudoccidentale del Lario, in una conca amenissima,<br />
aperta a settentrione sullo specchio lacustre, circondata sul lato orientale dalle<br />
ultime propaggini delle Prealpi e protetta sugli altri lati da basse colline conglomeratiche<br />
che la immane colata del grande ghiacciaio quaternario ha modellato in<br />
morbide forme. Il fondo della conca su cui la città si espande è almeno in parte<br />
di colmamento morenico e alluvionale e la cimosa marginale lungo il lago è di colmamento<br />
artificiale. Quando il primo insediamento umano sia ivi avvenuto non è<br />
possibile indicare con precisione; ma, considerando la posizione del luogo, naturalmente<br />
riparato e protetto, non si favoleggia presumendolo molto antico; non si sa<br />
tuttavia quanto si possa prestar fede a Plinio secondo il quale la città sarebbe stata<br />
fondata, come Bergamo, dagli Orobi. Ma più che nel luogo ove oggi giace la città,<br />
forse ancora minacciato in parte dalle acque del lago e in parte da quella dei torrenti,<br />
l’insediamento preistorico si distribuì sulle alture circostanti, e si propende<br />
a credere che il Comum oppidum, il centro gallico di cui parla Livio, sorgesse verso<br />
sudovest, tra i centri attuali di Rebbio, Breccia e Albate. Dopo la conquista effettuata<br />
da Marco Claudio Marcello, nella conca fu posta una colonia il cui ricordo<br />
si vorrebbe conservato sino ai nostri giorni dal sito di Coloniola posto alle falde<br />
prealpine di Brúñate. E comunque certo che con l’avvento romano la bella conca<br />
andò trasformandosi, ospitò un castrum, Novum Comum, assai importante a causa<br />
della sua posizione strategica sulla strada dello Spluga, che infine, forse ai tempi<br />
di Cesare, furono edificate mura poderose alte circa sette metri, grosse due, di cui<br />
furono ritrovati interessanti residui, che permisero di ricostruire la pianta rettangolare<br />
con il lato maggiore di 560 m. e il minore di 450. « Quattro porte vi si<br />
aprivano, una per lato, delle quali la pretoria, dal lato meridionale, ebbe poi l’aggiunta<br />
di uno speciale fortilizio, con due fòrnici di passaggio larghi circa m. 3,50<br />
e due torri ottagono (di cui sussistono tuttora i resti) » (C. Volpati). Il cardo e il<br />
decumano si incrociavano a metà dell’attuale via Indipendenza; parallelamente si stendevano<br />
numerose strade, povere di luce, e grossolanamente selciate. Dalle mura si<br />
dipartivano diverse strade; una si dirigeva in Brianza lungo il torrente Cosia, un’altra<br />
si sviluppava verso la larga insellatura detta della Camerlata in direzione di Milano;<br />
489
S'.‘Äei-/^c^237^-<br />
i . .<br />
'’W:-- ;•
manifestando non solo lungo la sponda del lago, dove già si eran formati i grossi<br />
borghi, di Vico a ponente e di Coloniola a levante, ma sporadicamente anche alle<br />
falde dei colli, dove minore era la minaccia delle piene dei torrenti о dei ristagni<br />
d’acqua, e forse specialmente attorno a Sant’Abbondio.<br />
Fot. Fotocielo<br />
Como e il primo bacino del Lario.<br />
Nell’abitato è possibile distinguere il quadrilatero della città medioevale,<br />
la lunga via Milano e sui colli in basso il Castel Baradello.<br />
491
Nella lotta scatenatasi con Milano, Como ebbe a soffrire i maggiori danni, chè<br />
nel 1127, dopo dieci anni di guerra, fu sopraffatta e distrutta; anche le mura e le<br />
torri furono rase al suolo e solo furono risparmiate Sant’Abbondio, San Fedele, e<br />
la cattedrale di Santa Maria Maggiore. In odio a Milano, si pose sotto la protezione<br />
del Barbarossa e potè in tal modo risorgere. La ricostruzione rispettò le tracce della<br />
planimetria romana, « solo la cinta delle mura fu costruita più ampia, tenendosi il<br />
muro venti о trenta metri più in fuori dell’antica cerchia; la vecchia fossa, che<br />
venne a trovarsi nell’interno, fu colmata con terrapieno e si chiamò terraccio.<br />
Furono pure allora innalzate le torri, più alte e più numerose di quanto ora siano,<br />
delle quali la maggiore (quella che si chiamò e si chiama la ‘ torre ’ per antonomasia)<br />
sorse precisamente nell’anno 1192. Otto erano le porte, incastellate, per cui<br />
si entrava in città: quattro a levante, due a mezzodì e due a ponente. Via via sorsero<br />
palazzi, conventi e nuove chiese e andarono infoltendosi le case » (C. Volpati). In<br />
quegli stessi anni sul colle Baradello, che domina l’ampio avvallamento lungo cui<br />
Como: il Lungo Lago, il porto lacustre e il Tempio Voltiano.<br />
Fot. Brunner<br />
492
Como : la facciata<br />
del Duomo, il Broletto<br />
e la Torre<br />
comunale.<br />
Fot. Brunner<br />
passava la via Regina, fu eretta una fortezza la cui torre, ancora esistente, costituisce<br />
un elemento caratteristico del paesaggio attuale.<br />
La sconfitta del Barbarossa a Legnano ebbe un dannoso riflesso per Como, che<br />
penò notevolmente a ritrovare la prosperità dei secoli precedenti. La città del Duecento<br />
presentava un quadro di miseria e di abbandono. Le case erano basse, tetre,<br />
anguste; una parte erano forse di canne, coperte di paglia e poiché il fuoco, per<br />
l’assenza di camini, si accendeva in mezzo alle dimore, spesso ardevano gli incendi;<br />
onde i decurioni nel 1209 diedero ordine di abbatterle. Tuttavia nel volgere del<br />
secolo le condizioni della città migliorarono e, pur attraverso le lotte tra le famiglie<br />
dei Vittani e dei Rusconi, il suo aspetto edilizio andò via via abbellendosi; tra l’altro,<br />
nel 1215, furono iniziati il Broletto, in marmo policromo, e la Torre del Comune.<br />
Nel 1225, poi, fu sistemato il porto cintato da un muro in cotto e sbarrato da una<br />
catena. Nel 1257 furono spurgati e riattati i corsi del Cosia e del Valduce, i quali<br />
(rispettivamente a occidente e a oriente delle mura), colmati dalle alluvioni, formavano<br />
ristagni d’acqua ai margini della città.<br />
Nel 1335 Como entrò nell’orbita del ducato visconteo. I nuovi signori espressero<br />
nell’edilizia il loro potere con la costruzione della cittadella, le cui solide muraglie<br />
cinsero la fascia a lago circostante il nuovo porto, aperto ove oggi si trova piazza Cavour.<br />
493
Ma estendendosi poi il dominio del ducato sino alle Alpi Retiche, Como perse la<br />
sua importanza militare e ogni fortificazione venne abbandonata e lasciata alla rovina.<br />
Nel 1335 avveniva anche un altro fatto di notevole riflesso urbanistico: l’aumento<br />
di oltre un metro e mezzo del livello medio del lago a causa della costruzione del<br />
ponte di Azzone a Lecco. « Benché il suolo della città, tra il secolo XI e XII, avesse<br />
subito, per cause diverse (tra cui demolizioni e alluvioni), un rilevante sollevamento,<br />
il rialzo del livello del lago fece sì che rimanessero col piede nell’acqua tutti gli<br />
edifici prossimi alla riva, onde fu necessità di sopraelevare il pavimento di strade e<br />
di case, di soglie ». Di questo fatto, sino a pochi decenni or sono, erano ancora manifesti<br />
i segni in diverse antiche dimore, nelle quali le aperture di accesso presentavano<br />
un’altezza insufficiente al passaggio di una persona. Tra le nuove costruzioni trecentesche<br />
numerose furono quelle religiose; in particolare fu notevole l’inizio, nel 1396,<br />
del duomo, nel luogo dove eravi la chiesa di Santa Maria Maggiore.<br />
Intanto la città, che, verso la metà del secolo XIV, contava circa 12.000 ab.,<br />
riprendeva il suo ruolo commerciale e artigiano, si rammodernava nell’edilizia,<br />
si sviluppava nei suoi borghi di Vico e<br />
di Coloniola cui vennero aggiungendosi<br />
Como: la Cattedrale,<br />
opera dei maestri comacini.<br />
Fot. Brunner<br />
San Bartolomeo, San Martino, San Rocco.<br />
Con il Cinquecento, essendo Bellinzona<br />
e Lugano passati in possesso degli Svizzeri,<br />
Como ritornò ad essere città di<br />
confine e quindi militarmente importante.<br />
Nel 1507, infatti, i Francesi, impadronitisi<br />
di Como, ne riattarono le mura, abbattendo<br />
le costruzioni che erano state<br />
erette a ridosso, e le circondarono di un<br />
fossato in cui vennero immesse le acque<br />
del lago. Nel 1521 gli Spagnoli posero<br />
l’assedio alla città e, entrati in essa, la<br />
devastarono. Cominciò un periodo di decadenza<br />
economica aggravata da carestie<br />
e da pestilenze. La popolazione, che alla<br />
fine del Cinquecento era di 16.000 anime,<br />
si riduceva nel 1633 a sole 6000. Nello<br />
stesso secolo poi avvennero disastrosi straripamenti<br />
del Cosia (1646, 1667, 1677)<br />
che scalzarono una parte delle difese, alcune<br />
chiese e molte dimore.<br />
La ripresa si manifestò nel secolo seguente<br />
con lo sviluppo dell’attività tessile;<br />
la popolazione s’accrebbe e, da 8000 ab.<br />
nel 1713, aumentò a 15.000 alla fine del<br />
494
w<br />
Como: la Basilica di S. Abbondio del sec. XL<br />
Fot. Stefani
secolo. Fu provveduto alla sistemazione dei torrenti fuori dalle mura e aU’eliminazione<br />
dei ristagni d’acqua, cosicché i borghi presero ad espandersi.<br />
Il secolo scorso, con il progressivo sviluppo delle industrie seriche, che si disposero<br />
l’una appresso l’altra lungo il corso del Cosia, la città fuori dalle mura venne<br />
formando tutt’uno con l’antica. Le iniziative furono molteplici e nuovo impulso<br />
venne dalla costruzione del tronco ferroviario Milano-Camerlata il cui prolungamento<br />
sino a Como avvenne nel 1875. Nel medesimo anno si predisposero i lavori<br />
per il prolungamento per Chiasso, e dieci anni appresso entrò in esercizio la ferrovia<br />
per Saronno. Nel 1894 si costruiva la funicolare per Brúñate, che doveva trasformare<br />
il piccolo paese in un luogo di rinomata villeggiatura. La sistemazione del lungolago<br />
doveva portare anche una profonda trasformazione su quel lato; in luogo dell’antico<br />
porto si fece la bella piazza Cavour e si costruirono bellissimi viali alberati, che costituiscono<br />
tuttora una magnifica passeggiata, prolungata nel nostro secolo sino al<br />
Tempio Voltiano (consacrato alla memoria di Alessandro Volta), al bizzarro Monumento<br />
ai Caduti e, di recente, a Villa Olmo sul lato occidentale e sino alla settecentesca<br />
Villa Geno sul lato orientale.<br />
La città attuale ha invaso tutto lo spazio libero della conca e va espandendosi<br />
verso le alture, specialmente verso Lora e Camerlata sul lato meridionale. Nel complesso<br />
è distinta in due parti dalle mura che in buona parte ancora sussistono su<br />
tre lati. La parte interna ha un volto antico, con diverse vie, spesso anguste e<br />
ombrose ancora sul tracciato romano, accompagnate da dimore vetuste; la parte<br />
esterna ha un aspetto moderno (salvo nel nucleo di antichi borghi) ed ospita notevoli<br />
industrie tessili disposte lungo il corso del Cosia (ormai in gran parte coperto).<br />
L ’attività vi si svolge vivacissima imperniata sul commercio, attivato dalla vicinanza<br />
del confine, sull’industria, tra cui celebre quella della seta naturale, e sul turismo,<br />
che annovera un movimento annuo di molte centinaia di migliaia di persone. La<br />
città è in rapido accrescimento: dall’inizio del secolo ha pressoché raddoppiata la<br />
sua popolazione; nel 1951 il solo aggregato urbano contava 57.000 abitanti.<br />
Bergamo.<br />
Bergamo sorge lungo il margine pedemontano delle Prealpi Orobie in posizione<br />
intermedia tra lo sbocco delle due grandi valli del Serio e del Brembo. La città si<br />
compone di due parti distinte: l’alta, più antica, posta sulla sommità di un colle<br />
(366 m.), e la bassa, distesa in ampio spazio alle falde sudorientali (247 m.) del colle<br />
stesso. La tradizione vuole che la città sia stata fondata dagli Orobi, ossia genti della<br />
montagna, del gruppo dei Galli Genomani, e che il primo insediamento si trovasse<br />
sul colle della Fara (dove oggi v’é Sant’Agostino) donde si sarebbe esteso a occu-<br />
496
pare il colle di Sant’Eufemia, da cui oggi, sul luogo forse del castrum romano,<br />
domina la Rocca. Con la conquista romana divenne municipium con il nome di Bergomum,<br />
ma delle mura e dei monumenti romani ivi edificati non restano che scarse<br />
vestigia; la sua importanza rimane comunque documentata dalle residue epigrafi.<br />
Il Cristianesimo fece presto il suo ingresso e forse già nel secolo IV sorgeva in Bergamo<br />
Bassa la chiesa che fu poi dedicata a Sant’Alessandro, patrono di Bergamo,<br />
martirizzato, secondo la tradizione, sul luogo della piazza antistante la chiesa attuale,<br />
ove trovasi una colonna romana che si vuole proveniente da un tempio di Venere.<br />
Durante le invasioni barbariche la città romana fu più volte devastata: Alarico I<br />
re dei Visigoti la mise a fuoco nel 408; appena risorta, venne nuovamente distrutta<br />
da Attila nel 452. Conquistata nel secolo appresso dai Longobardi venne da questi<br />
istituita sede di un ducato (575) e probabilmente munita di opere di difesa; via via<br />
essa andò sviluppandosi economicamente tanto che verso il secolo V ili la sua Fiera<br />
di Sant’Alessandro potè divenire una delle più importanti dell’Italia^ settentrionale.<br />
Sotto i Franchi fu sede comitale e venne poi governata dal vescovo. Intanto ai piedi<br />
della collina si era venuto formando, accanto alle chiese ivi edificate, il « Borgo »,<br />
da cui prese sviluppo la Bergamo Bassa.<br />
Nel secolo XII, la città, costituitasi in libero comune, fu dilaniata dalle lotte tra<br />
le famiglie dei Suardi di parte ghibellina e dei Colleoni di parte guelfa, ma ciò non<br />
Bergamo in una stampa del 1599<br />
(Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano).
Bergamo Alta da sud.<br />
Fot. Fotocielo<br />
le impedì di farsi promotrice, con Brescia e Cremona, della Lega Lombarda contro<br />
Federico Barbarossa. Durante quegli anni Bergamo Alta si arricchì di notevoli edifici<br />
quali il Palazzo della Ragione о Palazzo Vecchio, il più antico tra i palazzi comunali<br />
(in seguito più volte devastato e ricostruito), la chiesa di Santa Maria Maggiore,<br />
severa costruzione romanica, il Palazzo Suardi e altri ancora. Ma le discordie interne<br />
indebolirono la città e provocarono l’invadenza dei Torriani e dei Visconti, i quali<br />
nel 1329 l’assoggettarono. Due anni appresso vennero iniziati i lavori di costruzione<br />
della poderosa rocca che domina dall’alto sulla città alta e bassa e sulla piana<br />
circostante. I primi decenni del secolo XV furono travagliati da aspre contese per<br />
il possesso della città che, dominata da Pandolfo Malatesta (1408-19), era oggetto<br />
di contesa tra Milano e Venezia; fu assediata da Facino Cane al servizio dei Visconti<br />
nel 1412, assediata dal conte di Carmagnola, pure al servizio dei Visconti, nel 1419<br />
e ancora una volta conquistata dal Carmagnola, passato al servizio dei Veneziani,<br />
498
nel 1427. Si iniziava con il dominio veneziano un lungo periodo di prosperità,<br />
interrotto solo dalla calata di Napoleone nel 1797. La Serenissima fortificò la città<br />
con una cerchia di mura (di cui rimangono avanzi) che dalla cittadella scendeva<br />
a cingere il Borgo; concesse poi una larga autonomia amministrativa e favorì lo<br />
sviluppo delle industrie e dei commerci. Bergamo Alta si trasformò: all’austerità<br />
medioevale accostò lo splendore rinascimentale. Si abbatterono le vecchie casupole<br />
addossate al Palazzo della Ragione, facendo un ampio spazio da cui deriverà da un<br />
lato la Piazza del Duomo e dall’altro la suggestiva Piazza Vecchia, arricchita due secoli<br />
appresso del Palazzo Nuovo di stile palladiano. Con l’arte dei maestri campionesi<br />
si addolci l’austerità romanica di Santa Maria Maggiore e vi si eresse il Battistero<br />
(1340), che fu più tardi ricostruito di fronte al Duomo. Sul lato di Santa Maria si<br />
elevò la policroma Cappella ad onore del celebre capitano Bartolomeo Colleoni,<br />
che costituisce il primo capolavoro dell’arte rinascimentale lombarda (1470). Nel<br />
1459 fu iniziato con il concorso del Filarete il rifacimento del Duomo. Nè i lavori<br />
Fot. Enit<br />
Bergamo: il centro della città alta,<br />
dove si raggruppano i più insigni monumenti.<br />
499
Bergamo: la Basilica di Santa<br />
Maria Maggiore e la Cappella<br />
Colleoni.<br />
Fot. Ente Prov. Turismo, Bergamo<br />
di arricchimento cesseranno con il trascorrere del tempo. Anche Bergamo Bassa<br />
s’adornò di opere insigni, specialmente di chiese, come Sant’Alessandro, Santo Spirito,<br />
San Bernardino, ecc.<br />
Nel 1561 la città alta, ormai trasformata in un incomparabile gioiello, venne cinta<br />
dai Veneziani con maestose mura, che ancor oggi coronano torno torno la sommità<br />
del colle, in forma pressoché triangolare con i vertici a Punta Sant’Agostino, a<br />
Punta San Giacomo e a Punta Sant’Alessandro. Bergamo, centro artistico, cittadella<br />
fortificata, mercato attivissimo, forte, già nel secolo XVI, di 30.000 ab., divenne la<br />
città più importante del territorio lombardo soggetto alla Serenissima.<br />
Gli avvenimenti storici che seguirono alla calata di Napoleone arrestarono temporaneamente<br />
lo sviluppo economico cittadino; ma fu una breve pausa; l’ascesa<br />
poi riprese lenta e continua. Ma un notevole rivolgimento urbanistico doveva verificarsi<br />
con lo sviluppo delle comunicazioni e dell’industria. Allora pian piano la città<br />
alta perse il fervore di vita che l’aveva contraddistinta per tanti secoli; essa, troppo<br />
500
Bergamo Alta: il Palazzo Nuovo e la Torre del Gombito (52 m.) del see. XII.<br />
Fot. Stefani
fuori mano rispetto alle comunicazioni ferroviarie prima e stradali poi, si svuotò<br />
a poco a poco; l’industria, trovando sede adatta nella pianura attorno alla città bassa,<br />
accentuò la decadenza di Bergamo Alta. Contemporaneamente si verificò un grandioso<br />
sviluppo di Bergamo Bassa che si* dilatò, invero non molto ordinatamente,<br />
attorno al vecchio nucleo con i borghi di Santa Caterina, di Palazzo e di San Leonardo.<br />
Qui ferve oggi un’attività vivacissima, un traffico intenso e rumoroso proprio<br />
delle moderne città intensamente commerciali e industriali; là, nella città alta, domina<br />
la maestà dei monumenti in un raccoglimento austero, quasi rispettoso delle trascorse<br />
glorie. La popolazione, di 94.000 ab. nel 1951, vive per la maggior parte in<br />
Bergamo Bassa, protesa verso conquiste moderne, ma per nulla dimentica del suo<br />
passato.<br />
La città bassa attuale, superato il tracciato delle linee ferroviarie che si stendono<br />
a sudest dell’abitato con direzione da sudovest a nordest e che nel secolo scorso sembravano<br />
ancor lontane dall’aggregato urbano, tende a svilupparsi lungo le direttrici<br />
di comunicazioni, e soprattutto lungo quella meridionale verso Colognola (e l’auto-<br />
Bergamo Bassa e, sullo sfondo, Bergamo Alta.<br />
Fot. Stefani<br />
502
strada Milano-Brescia), verso Seriate e verso Redona. Lo sviluppo edilizio, residenziale<br />
e industriale, così protendendosi, ha già inglobato diversi sobborghi con<br />
tendenza a formare una conurbazione.<br />
Brescia.<br />
Brescia sorge nel piano là dove s’affondano, frazionandosi in amene colline, le<br />
ultime diramazioni delle Prealpi; tra le alture s’apre ampio e ridente il solco da cui<br />
discendono il Mella e il Garza, e la città con la sua espansione vi si insinua quasi<br />
a vigilare la soglia. Pare che il primo insediamento in così ameno e importante luogo<br />
risalga ai Liguri; è certo comunque che con i Galli Cenomani il centro (forse posto<br />
sul Colle Cidneo ove poi sorse il Castello) prese sviluppo divenendo uno dei maggiori<br />
della <strong>Lombardia</strong>. Quando esso, nel 225 a. C., fu conquistato e sottomesso dai<br />
Romani divenne, con il nome di Brixia (che si vuole derivato da Brich о Brig,<br />
radice celtica con significato di altura), la base più importante dell’espansione romana<br />
nella Gallia Transpadana. I Romani sostituirono al villaggio gallico il castrum, addossato<br />
al Colle Cidneo sul quale, forse, costruirono un’arce, in seguito sostituita da<br />
un castello. Il luogo crescendo d’importanza prese sviluppo; si ritiene che nel<br />
49 a. C. divenisse municipio romano; Augusto, poi, lo onorò del suo nome dichiarandolo<br />
colonia civica Augusta Brixia. Dalle vestigia rimaste si desume l’importanza<br />
e lo sviluppo della città imperiale, la cui struttura ha lasciato traccia evidente nella<br />
parte dell’odierna Brescia posta ai piedi del Castello. Il centro della città romana<br />
corrispondeva all’attuale piazza del Foro, che, non solo nel nome, conserva il ricordo<br />
della funzione di un tempo. Dalle notevoli vestigia sinora ritornate alla luce si può<br />
desumere che esso si estendesse in lunghezza circa 200 m. e in larghezza 40 e che<br />
fosse chiuso da un lato dal Capitolium, imponente tempio (di cui si conserva una<br />
parte) costruito nel 72 d. C. sotto l’imperatore Vespasiano. E in una delle celle del<br />
tempio, adibite a museo, che è custodita la Vittoria di Brescia, grande statua di<br />
bronzo dorato, modellata con perfezione, fusa con maestria, opera meravigliosa<br />
forse dominante dal fastigio del Capitolium, testimonianza della bellezza di Brescia<br />
romana. Alla luce son ritornati in parte anche il Teatro, la Curia, un porticato, e<br />
augurabile sarebbe una ricognizione completa del complesso urbanistico, certamente<br />
il più notevole della <strong>Lombardia</strong>. Attraverso l’abitato, forse sul tracciato dell’attuale<br />
via dei Musei, passava la via tra Milano e Verona, via di comunicazione troppo<br />
importante perchè lungo di essa non s’incanalasse l’orda dei barbari che più volte<br />
devastarono la città, saccheggiandola e spogliandola.<br />
Dalle distruzioni (terribile nel ricordo rimase quella di Attila nel 452) Brescia<br />
risorse lentamente sotto i Longobardi, che vi posero un duca. In quei secoli la città<br />
si arricchì di monumenti insigni quali la Basilica di Santa Maria Maggiore nel luogo<br />
del Duomo Vecchio e la Basilica di San Salvatore, che faceva parte del monastero<br />
S°3
Brescia in una stampa del 1599<br />
(Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano).<br />
fondato, secondo la tradizione, da Ansa, moglie di Desiderio, e dove fu ospite<br />
Ermengarda. Desiderio ebbe particolare benevolenza per la città; ma con lui il<br />
regno dei Longobardi era al tramonto e Brescia seguì la sorte comune alle altre<br />
città lombarde dal periodo dei re carolingi a quello degli imperatori germanici.<br />
Attraverso lotte civili e religiose consegui la libertà comunale che nel XII secolo,<br />
unita alle altre città lombarde della Lega, difese strenuamente contro il Barbarossa.<br />
Intanto la città medioevale si espandeva lentamente sul lato occidentale della città<br />
romana; sorgeva il Broletto dominato dalla Torre del Popolo, simbolo delle libertà<br />
comunali, e a fianco veniva edificata, sull’area dell’antica Basilica di Santa Maria<br />
Maggiore, la magnifica Rotonda (o Duomo Vecchio); si costituiva così il centro<br />
politico e religioso della nuova città, cinta ai suoi bordi da una cerchia fortificata,<br />
che sosterrà la memorabile difesa dei Bresciani contro Enrico VII. E probabilmente<br />
di questo periodo anche la costruzione о almeno la riattivazione del Naviglio Bresciano<br />
che, portando le acque del Chiese fin nei pressi dell’abitato, consentì la navigazione<br />
e la irrigazione. Fervida nelle arti e nei mestieri, attivissima nei commerci,<br />
la città era tuttavia dilaniata dalle discordie e dalle lotte di fazione, sicché cadde preda<br />
della tirannia di Ezzelino da Romano (1258), che segnò l’inizio degli interventi dei<br />
Torriani, degli Scaligeri e infine, nel 1339, dei Visconti, che rafforzarono le opere<br />
504
di difesa del castello e delle mura; essi, salvo una breve interruzione all’inizio del<br />
XV secolo, dominarono sino al 1427, allorché il Carmagnola conquistò Brescia alla<br />
Repubblica di Venezia.<br />
Entrata nell’orbita della Serenissima, per la politica protezionistica di questa,<br />
le attività manifatturiere bresciane, già tanto progredite, subirono una fase di depressione,<br />
ma la città, ottenuta una larga autonomia amministrativa, ebbe modo di<br />
riprendersi e di progredire. Lo sviluppo edilizio si manifestò vivacissimo: nel 1492<br />
ebbero inizio i lavori di costruzione della Loggia, il grandioso Palazzo del Comune,<br />
Fot. Sef<br />
Brescia : la parte orientale della città con i Ronchi,<br />
dal torrione di Piazza della Vittoria.<br />
505
«che sulle poderose arcate bramantesche eleva una florida leggiadria sansoviana,<br />
temperata dal Palladio in più chiara e calma misura ». Al fianco vennero poi edificati<br />
in bella armonia i Palazzi del Monte Vecchio, il Monte Nuovo improntato al<br />
rinascimento veneziano e il Palazzo con la Torre dell’Orologio, i quali formarono<br />
una pittoresca cornice alla Piazza della Loggia, che divenne il centro civile della<br />
città. Nuove costruzioni civili e religiose sorsero in altre parti dell’agglomerato<br />
urbano; tra esse la bella chiesa di Santa Maria dei Miracoli, la monumentale chiesa<br />
della Madonna del Càrmine, la chiesa di San Giovanni Evangelista. Nuovi lavori<br />
accrebbero anche la capacità di difesa del Castello e delle mura cittadine le quali,<br />
innestandosi al Castello stesso, cingevano la città a guisa di un quadrilatero, ed<br />
erano accompagnate all’esterno da un fossato. Ciò non impedì, durante il breve<br />
Brescia: Piazza della Vittoria, centro moderno<br />
e la parte occidentale della città.<br />
inaugurato nel 1932,<br />
Fot. Fotocielo<br />
S06
Brescia : Piazza della Loggia,<br />
antico centro cittadino con<br />
la Rotonda, il Duomo, il<br />
Broletto e la Torre del popolo,<br />
detta localmente Tor<br />
del pégol.<br />
Fot. Enit<br />
periodo di occupazione francese dopo la disfatta veneziana di Agnadello (1509),<br />
che Gastone da Foix, per punire la ribellione bresciana (1512), espugnasse il Castello<br />
da cui bombardò la città compiendo un orrendo massacro. Poco appresso Brescia<br />
fu ricuperata dai Veneziani e, pur così duramente provata, riprese la sua ascesa,<br />
che potè continuare in tranquillità per quasi due secoli, lasciando tracce imperiture<br />
nell’edilizia cittadina con il Duomo Nuovo (secolo XVII) dalla grandiosa architettura<br />
ancora nello stile tardo rinascimentale, il Palazzo della Biblioteca Queriniana,<br />
la chiesa di Sant’Eufemia, il Palazzo Martinengo e numerose altre chiese e palazzi.<br />
Nel 1797, con la conquista napoleonica, Brescia, che già contava 30.000 ab.,<br />
entrò a far parte della Repubblica Cisalpina, divenuta poi Regno d’Italia. Nel 1815<br />
passò con le altre città lombarde sotto il dominio austriaco, contro cui lottò con<br />
coraggio e tenacia, cospirando (1821 e 1833) ^ ribellandosi; memorabili le gesta di<br />
eroica resistenza guidata da Tito Speri nel 1849, che valsero alla città il nome di<br />
Leonessa d’Italia. Nel 1859, finalmente, l’aspirazione della città fu appagata e<br />
Brescia entrò a far parte del Regno d’Italia.<br />
Da allora lo sviluppo cittadino assunse un ritmo pari a quello delle maggiori<br />
città lombarde. La cerchia delle mura cedette a poco a poco alla forza espansiva<br />
S07
deir agglomerato urbano. La città si andò estendendo su tre lati: quello tra la<br />
vecchia cinta di mura e la ferrovia a sud, quello tra le vecchie mura e il corso<br />
del Mella a ovest e quello infine settentrionale verso il solco del Garza e del Mella.<br />
Lo sviluppo industriale accelerò, nel nostro secolo, il movimento di espansione;<br />
sorsero nei pressi dell’abitato imponenti opifici metallurgici, meccanici, tessili, alimentari,<br />
e il pulsare di nuova vita fece sentire l’angustia delle arterie dentro le<br />
vecchie mura. Sicché nel 1932 si inaugurava la nuova grande piazza della Vittoria<br />
aperta con l’abbattimento di dimore nel cuore della città vecchia; essa divenne<br />
nuovo centro della vita cittadina, sostituendo, almeno sotto l’aspetto economico,<br />
le vicine piazze del Duomo e della Loggia, già centri in età precedenti. La popolazione<br />
urbana, che all’inizio del secolo già superava i 50.000 ab., s’accresceva con<br />
ritmo notevole di anno in anno sicché nel 1951 già registrava 1 10.000 abitanti.<br />
Brescia: il Castello dal viale di accesso<br />
con il portale veneto sormontato dal Leone di San Marco.<br />
Fot. Stefani<br />
508
Pavia.<br />
La città di Pavia si stende su un ampio terrazzo affacciato alla sponda sinistra<br />
del Ticino a circa 6 km. a monte della confluenza di questo fiume nel Po. A quando<br />
risalga il più remoto insediamento nel luogo della città moderna non è dato di<br />
sapere con esattezza. Tito Livio e Plinio attribuiscono la fondazione del primo<br />
nucleo ai Liguri (precisamente ai Laevi о ai Laevi e Marici) e i reperti archeologici<br />
testimoniano della diffusione di quelle genti in tutta una vasta area circostante. Ma<br />
è comunque certo che lo sviluppo del nucleo, a partire dal IV secolo a. C., fu<br />
opera dei Galli; da allora, se non lo era già prima, divenne luogo di convergenza<br />
di piste padane notevolmente battute, che si trasformeranno poi in strade romane.<br />
Conquistato dai Romani e divenuto nodo delle vie per la Gallia e per la Germania,<br />
l’antico nucleo gallo si trasformò in castro il cui « impianto era ordinato secundum<br />
coelum, ma leggermente spostato verso est dall’adattamento del lato meridionale,<br />
in senso parallelo al corso del fiume. Era diviso in quattro quartieri rispettivamente<br />
dal cardo, ora Strà Nova, e dal decumanus, formato dagli attuali corsi Mazzini e<br />
Cavour. Con la campagna circostante la città comunicava mediante nove porte »<br />
(A. Pecora). La struttura determinata dall’antico castro romano non è stata cancellata<br />
dal tempo о dalle vicende. La città si è progressivamente espansa attorno al<br />
castro adattandosi ad esso, sicché oggi rimane come uno degli esempi più suggestivi<br />
della razionalità costruttiva dei Romani.<br />
Alla decadenza dell’Impero, essendo stata distrutta Milano, Pavia, per la sua<br />
posizione geografica, si impose facilmente. Teodorico la scelse come capitale e la<br />
arricchì di terme, di un anfiteatro, di un grande palazzo e di giardini. L ’espansione<br />
della città si sarebbe manifestata particolarmente verso la fascia prospiciente al fiume,<br />
ma non vi sono testimonianze per stabilirne i limiti. I Longobardi, dilaganti nella<br />
pianura del Po, trovarono in Pavia una resistenza che non avevano riscontrato altrove;<br />
cinsero la città d’assedio e solo dopo tre anni, nel 572, vi poterono porre piede.<br />
Alboino vi prese dimora e divenne la capitale longobarda. La dominazione longobarda<br />
lasciò alla città un’impronta indelebile nelle chiese, soprattutto con San Pietro<br />
in Ciel d’Oro e Santa Maria alle Pertiche a nord e San Giovanni in Borgo a est,<br />
destinate a formare i fulcri dei nuovi nuclei abitati, successivamente inglobati nella<br />
città. Risale a quei tempi anche l’erezione della chiesa di Santa Maria in Bethlem,<br />
attorno a cui si formerà Borgo Ticino sulla sponda opposta del fiume. Verso la metà<br />
del VII secolo la città, chiamata sino allora Ticinum, dal fiume che la lambiva, assume<br />
un nome nuovo Papia, di origine ignota, forse derivato da una radice romana о<br />
prelongobarda. Anche con i Franchi, Pavia conservò la sua dignità di sede centrale<br />
del Regnum Italicum e in essa presero la corona Berengario I ed Enrico IL Essa si<br />
509
arricchì di nuove chiese e di una scuola giuridica e, dopo le distruzioni operate<br />
dagli Ungari (924), fu cinta dal vescovo Giovanni di più ampie e solide mura, che,<br />
con una pianta approssimativamente quadrilatera, racchiudevano un’area di 97 ettari.<br />
L ’attività economica intanto si sviluppava notevolmente man mano che, liberandosi<br />
dalle imposizioni imperiali, la città si avviava verso il libero comune. Dalla lotta<br />
tra le città lombarde e il Barbarossa trasse vantaggio, poiché, sostenendo le parti<br />
di questo, ne ottenne favori e vantaggi; le immunità imperiali servirono ad affermare<br />
la preminenza sui tre settori, il Pavese p. d., la Lomellina e l’Oltrepò<br />
che costituiranno più tardi il suo ducato e ai giorni nostri la sua provincia. « Sotto<br />
l’impulso delle nuove forze comunali, le attività economiche progredirono ulteriormente,<br />
provocando una cospicua corrente immigratoria dal contado. Questa si andò<br />
costipando ai limiti della città, accanto alle porte, soprattutto a nord e a est. Riflesso<br />
e conseguenza fu la nuova espansione topografica della città, l’ultima dell’età di<br />
mezzo, che inglobò le nuove propaggini sorte all’intorno, includendo le antiche<br />
chiese fuori mura di Santa Maria alle Pertiche e di San Pietro in Ciel d’Oro, oltre<br />
Pavia: pianta della città in una incisione del 1704.<br />
Biblioteca Nazionale, Torino<br />
510
Pavia, il Ticino con il Ponte della Libertà e il Ponte Coperto, visti da nordovest.<br />
A destra Borgo Ticino.<br />
Fot. Fotocielo
f“avia; veduta aerea della città Al<br />
ЛІ centro, ¡1<br />
FotocieJo
la fascia depressa dei terreni dirimpetto al fiume » (A. Pecora). Il perimetro delle<br />
nuove mura era di circa 5 km. e racchiudeva una superficie di 150 ettari; nove<br />
erano le porte e altrettanti i quartieri (Palacense, Palazza, Pertusi, San Pietro al<br />
Muro, Ponte, Damiani, Marenca, San Giovanni, Laúdense). L ’ammontare della<br />
popolazione era di oltre 20.000 anime. Pavia era all’apice della sua grandezza<br />
comunale.<br />
Con l’espandersi della Milano viscontea Pavia venne annessa al Ducato (1359).<br />
L ’attività mercantile subì un lento declino; nè ad evitare la decadenza valse la corte<br />
sontuosa che nel Castello, da essi edificato, vi tennero i Visconti, nè lo Studium<br />
voluto da Galeazzo II (da cui ha origini l’Università), nè il rinnovamento edilizio;<br />
il numero degli abitanti andò decrescendo, per colpa anche delle pestilenze. Dagli<br />
atti di una visita pastorale infatti si deduce che nel 1460 essi erano 16.000 e si<br />
può presupporre che dopo la peste del 1485, che fece oltre 4000 vittime, scendes-<br />
Fot. Locati<br />
Pavia: lo sviluppo industriale al margine orientale della città.<br />
Al centro gli stabilimenti Snia Viscosa.<br />
33 — Le Regioni d'Italia ~ <strong>Lombardia</strong>.<br />
s e
Pianta di Pavia.<br />
Dai tipi dell’Istituto Geografico Militare, autorizzazione n. 902/ST/P del 17 dicembre 1959.<br />
sero ancora di numero. Ad aggravare la situazione sopravvenne l’invasione francese,<br />
il duro assedio di Francesco I nel 1525 e il sacco del Lautrec del 1527. La città<br />
stremata, spopolata, attraversò decenni oscuri. Vi giunsero gli Spagnoli, vi eressero<br />
nel 1531 un nuovo sistema difensivo sul medesimo sviluppo della cinta comunale<br />
del secolo XIII. Ancora nel 1555 la città contava 12.000 ab. e se accrescimento<br />
vi fu in seguito, la peste, con le gravi epidemie del 1576 e del 1630, portò gravi<br />
decimazioni. Nel secolo XVIII аѵл^еппе lo smembramento dell’antico principato:<br />
prima fu sottratta la Lomellina (1707), poi le terre prossime alla città. San Fedele,<br />
Torre dei Torti, Travedo, Campomaggiore (1738), poi l’Oltrepò e il Siccomario<br />
(1748). Il Po e il Ticino divennero un confine politico e Pavia una città di frontiera.<br />
5 4
priva di due terzi dell’area naturalmente gravitante verso di essa. Eppure, nonostante<br />
tale triste situazione, Pavia in questo frattempo andò acquistando fama mondiale<br />
per la sua Università, in cui tenevano cattedra maestri insigni quali Alessandro Volta,<br />
Lazzaro Spallanzani, Lorenzo Mascheroni, Antonio Scarpa.<br />
I prodromi di una ripresa, che si manifestarono nella seconda metà del secolo,<br />
testimoniati da un aumento della popolazione salita a 24.000 ab. e da una espansione<br />
cittadina verso il Borgo Calvenzano, vennero arrestati dall’invasione francese.<br />
Si può dire che l’inizio vero e proprio dello sviluppo di Pavia cominciò con la formazione<br />
dell’unità d’Italia, che ridiede alla provincia i confini dell’antico principato.<br />
La città rifiorì: si collegò con la ihrrovia alle città vicine, si liberò dalla stretta delle<br />
mura, si arricchì delle prime industrie, le propaggini urbane si espansero sia a nord<br />
che a est e a ovest catturando i borghi vicini (Torretta, San Pietro in Verzuolo,<br />
San Lazzaro). Soprattutto lo sviluppo delle comunicazioni e il progresso delle<br />
industrie possono considerarsi le molle propulsive della rinascita e dell’aumento<br />
di popolazione accresciutasi a 34.000 ab. all’inizio del secolo e a 57.000 nel 1951.<br />
Cifre certamente modeste se si confrontano con quelle di Milano, ma comunque<br />
non trascurabili. A tal proposito par necessario notare che la bilancia dei nati e<br />
dei morti da novant’anni a questa parte chiude in negativo, fatto non esclusivo<br />
della città, ma comune a vari centri del territorio della provincia (come è chiarito<br />
in un precedente capitolo); le ragioni dell’aumento di popolazione cittadina vanno<br />
dunque ricercate nel movimento di migrazione dal contado о comunque dall’esterno<br />
verso il centro urbano. In solo otto anni, dal 1946 al 1952 sono immigrate a Pavia<br />
13.460 persone contro una emigrazione di 8178 individui.<br />
Utet<br />
Sviluppo topografico di Pavia<br />
dall’antichità ad oggi (A. Pecora).<br />
I, città romana (see. I d. C.); 2, città del<br />
vescovo Giovanni (metà del see. X);<br />
3, città comunale (see. XII) più tardi bastionata<br />
(1530); 4, anno 1900; 5, anno<br />
19 31; 6, anno 1954; 7, casali e borgate<br />
« catturati I).
Nonostante la scomparsa delle mura (ne esistono soltanto pochi residui) si può<br />
dire che la divisione della città in due parti, quella interna e quella esterna, sia<br />
ancora viva e manifesta per molti aspetti architettonici e funzionali. La parte interna<br />
о medioevale costituisce un nucleo con attività prevalentemente commerciali e culturali;<br />
la parte esterna о moderna, è prevalentemente residenziale, ospitaliera e<br />
soprattutto industriale.<br />
« L ’attrezzatura industriale della città, gli uffici amministrativi e commerciali<br />
che incentra, la sua antica e famosa Lfniversità con il complesso degli ospedali di<br />
San Matteo, costituiscono oggi le principali risorse economiche di Pavia. Esse si<br />
sprigionano all’intorno con la loro forza di attrazione, e veramente, a seconda delle<br />
possibilità, vincolano il contado alla città. Si è così plasmata una regione urbana di<br />
Pavia, cioè un territorio che gravita per le più svariate necessità sul capoluogo<br />
provinciale » (A. Pecora).<br />
Cremona.<br />
Cremona si stende sulla sponda sinistra del Po a una decina di chilometri, in<br />
linea d’aria, dalla confluenza dell’Adda nel maggior fiume. Fu forse antichissima<br />
sede di un villaggio di Galli Genomani, ma la sua fondazione si fa risalire al 218 a. C.,<br />
allorché i Romani vi posero un caposaldo, a scolta del passaggio del Po, dal quale<br />
irradiavano strade verso il settentrione. La città, cinta di mura, ebbe soprattutto<br />
un’importanza militare (ne fa testimonianza l’assalto sferrato da Annibaie), ma si<br />
sviluppò presto anche come centro commerciale. Nel 90 a. G. divenne municipio<br />
romano e già era un centro floridissimo. Durante l’Impero fu coinvolta nelle lotte<br />
per il potere: nel 69 d. C. nella battaglia di Bedriaco (sulla strada per Mantova),<br />
combattuta tra Vitellio e Vespasiano, l’esercito di quest’ultimo saccheggiò e distrusse<br />
l’abitato. Poi Vespasiano volle che la città venisse nuovamente costruita, ma essa<br />
non riebbe l’antica prosperità. Le scorrerie dei barbari si susseguirono più tardi a<br />
tarpare ogni possibilità di ripresa; ai Longobardi la città oppose una tenace resistenza,<br />
protrattasi per 34 anni; solamente nel 603 Agilulfo riuscì a conquistarla e la rase<br />
completamente al suolo.<br />
Gremona risorse lentamente dalle rovine, rispettando in parte l’antico tracciato<br />
di vie romane che ancora oggi si può individuare nella struttura cittadina in prossimità<br />
del centro. Sede di una contea vescovile, rifiorì verso il secolo X, attuando<br />
una vasta bonifica del territorio circostante la città, facile a ricoprirsi di insalubri<br />
acquitrini. Ma, oltre che centro agricolo, a causa della sua posizione sul Po, agevole<br />
via di comunicazione con l’Adriatico, divenne mercato di attivi commerci.<br />
Verso il 1080, dopo lunga lotta del popolo contro il vescovo, si costituì in libero<br />
comune. La città che sino allora era stata presumibilmente, a causa delle distruzioni,<br />
S16
Fot. Fotocelere<br />
Cremona; panorama sulla città dal Torrazzo.<br />
A sinistra, sullo sfondo, il Po.<br />
priva di ogni monumentale bellezza e, nel complesso, di modestissimo aspetto, con<br />
il libero ordinamento comunale si adornò di opere di così imponente architettura<br />
e di così armoniose forme che oggi il centro, ov’esse si raccolgono, può considerarsi<br />
uno tra i luoghi d’arte più belli d’Italia. Fu iniziato prima d’ogni altra costruzione<br />
il Duomo (1107), ma a causa di danni recati dal terremoto del 1116 , pochi anni<br />
appresso si diè inizio a un edificio più grandioso. Nel 1167, di fianco al Duomo,<br />
fu eretto il Battistero. Nel 1206, di fronte al Duomo, si pose mano al rifacimento<br />
del Palazzo del Popolo, sull’area di un più antico palazzo comunale di cui rimane<br />
la torre. Tra il 1250 e il 1267 si eresse il Torrazzo, alta torre che serviva a chiamare<br />
i cittadini che facevan parte delle milizie, adibita in seguito a campanile della cattedrale.<br />
La torre, che costituisce il simbolo cittadino, costruita in laterizi con un coronamento<br />
marmoreo, raggiunge la straordinaria altezza di i n m. e risulta quindi<br />
il più alto campanile d’Italia. Collateralmente a tanto fervore di rinnovamento edilizio<br />
del centro cittadino, corrispondeva una espansione periferica: ai margini della<br />
città, che nel reticolo di vie denuncia l’impronta romana, la città si dilatava, tendendo,<br />
almeno nella parte orientale dove trovasi il Duomo, ad assumere un disegno<br />
radiale. Nel complesso la città assumeva una forma decisamente ovoidale, delineata<br />
517
Cremona: l’antico nucleo cittadino attorno al Duomo.<br />
Fot. Quirese<br />
nel SUO perimetro da imponenti bastioni di difesa, talché si comprende come potè poi<br />
essere scherzosamente chiamata magna phaselus, equivocando sul significato del termine<br />
che può significare tanto navicella quanto fagiolo.<br />
Ma, nonostante tanto fervore di sviluppo, la città era dilaniata da lotte interne<br />
ed esterne. AU’interno era divisa dalle fazioni dei ghibellini e dei guelfi, talché oltre<br />
al Palazzo del Comune, tenuto dai primi, nel 1256 fu edificato nella parte occidentale<br />
della città un diverso Palazzo del Popolo dei guelfi. A ll’esterno le lotte vivacissime<br />
s’appuntarono soprattutto contro Milano e Crema, procurando lutti e danni. Alleata<br />
dapprima degli imperiali, partecipò poi alla Lega lombarda. Nel secolo XIII, dal<br />
groviglio delle lotte tra guelfi e ghibellini emersero alcune figure di audaci quali Buoso<br />
da Dovara, che Dante colloca « là dove i peccatori stanno freschi », a piangere « l’argento<br />
dei francesi », e Uberto Pallavicini, di parte ghibellina. Dopo la disfatta di<br />
Benevento (1266) anche a Cremona prevalsero i guelfi con i Cavalcabò, il cui atteg-<br />
S18
giamento provocò le vendette di Enrico VII disceso in Italia per sollecitazione dei<br />
ghibellini; egli nel 13 11 assalì Cremona, la invase abbandonandola al saccheggio<br />
e le tolse il titolo di città. Ma fu una breve parentesi. Ritornati i guelfi, nel 1334<br />
la città si arrese ad Azzone Visconti, che proscrisse i Cavalcabò, cui tuttavia fu in<br />
sèguito concesso di ritornare e di prendere anche il governo cittadino. Ma la città,<br />
travagliata da tante lotte, era venuta decadendo anche economicamente.<br />
Venezia, nella sua espansione continentale, mirava a conquistare Cremona: un<br />
primo tentativo compiuto dal Carmagnola nel 1431 fu respinto dall’esercito del<br />
ducato milanese e costò alla Serenissima la flottiglia fluviale; la città entrò tuttavia<br />
in suo possesso nel 1499 per cessione dei Francesi (Trattato di Blois). Fu comunque<br />
un possesso solo decennale: nel 1509 Cremona fu ricuperata dal ducato di Milano<br />
che la tenne sino al 1525, allorché giunsero gli Spagnoli, che vi rimasero sino al 1702.<br />
Nel succedersi di così varie e spesso tristi vicende, non mancò tuttavia di farsi<br />
sentire il soffio vivificatore del Rinascimento, che lasciò tracce notevoli nell’edilizia<br />
cittadina, anzitutto con il bel Portico della Bertazzola (1499), che fu eretto dalla<br />
facciata del Duomo al Torrazzo, poi con<br />
la facciata marmorea del Duomo stesso<br />
(1498-1505), la loggia del Battistero, il Palazzo<br />
Fodri e altri palazzi e chiese, ornati<br />
prevalentemente in cotto per la presenza,<br />
nella zona, di utili argille. Fo sviluppo<br />
dell’agglomerato urbano, invece, fu modestissimo,<br />
essendosi il numero degli abitanti<br />
stabilizzato attorno alle 10.000 anime.<br />
Nel 1702 al dominio spagnolo successe<br />
l’austriaco e nel 1797 a questo subentrò<br />
il dominio francese. Con il Regno d’Italia<br />
la città divenne capoluogo del dipartimento<br />
dell’Alto Po.<br />
Durante il Regno Lombardo-Veneto il<br />
progresso agricolo favorì la città, procurandole<br />
un notevole sviluppo come mercato,<br />
che si consoliderà con l’unità d’Italia.<br />
Il fervore di sviluppo industriale, che ha<br />
caratterizzato la <strong>Lombardia</strong> nel nostro secolo,<br />
ha avuto sensibile riflesso anche in<br />
Cremona, che, pur conservando la sua preminenza<br />
nel campo agricolo, ha conseguito<br />
un notevole incremento soprattutto<br />
nel quadro delle produzioni alimentari (torroni,<br />
mostarde, farina, latticini, carni salate)<br />
e delle macchine agricole.<br />
Fot. E .P.T ., Cremona<br />
Cremona: il Torrazzo ( i n m.),<br />
simbolo della città, con il Duomo.<br />
519
Pianta di Cremona.<br />
Dai tipi dell’Istituto Geografico Militare, autorizzazione n. 902/ST/P del 17 dicembre 1959.
Fot. Stefani<br />
Cremona: la Piazza del Comune con il Battistero.<br />
L ’agglomerato urbano si è espanso fuori dalle mura, particolarmente lungo<br />
l’arco orientale e settentrionale tra Porta Venezia e Porta Milano, nel cui tratto<br />
intermedio trovasi la stazione ferroviaria. La popolazione, in parte immigrata dalla<br />
campagna, s’è accresciuta notevolmente nel nostro secolo, raggiungendo nel 1951 i<br />
56.000 abitanti.<br />
521
M a n to v a .<br />
Mantova sorge sulla riva destra del Mincio che, curvandosi a formare un’ampia<br />
ansa, s’apre nel contempo a guisa di lago. L ’espansione delle acque fu opera ardita<br />
di molti secoli or sono e lo specchio, recingendo la città, ne ha difeso la vita e le<br />
glorie, ma ha al tempo stesso condizionato la sua struttura e la sua espansione, sicché<br />
giustamente è stato detto che la storia e la vita di Mantova sono strettamente connesse<br />
con la storia e le vicende dei laghi.<br />
Quando sia stata fondata la città, più che storia, è leggenda. Certo la sua origine,<br />
forse etrusca, fu antichissima e per lunghi secoli nell’antichità aleggiò il mito di Ocno,<br />
eroe fondatore, cui più tardi si sovrappose quello dell’indovina Manto. Come ogni<br />
altra città lombarda, fu sede dei Galli sinché giunsero le legioni romane; allora l’abitato<br />
prese forma quadrilatera con centro, forse, nell’attuale piazza bordello, ossia<br />
nel luogo più elevato dell’attuale città. Tracce della romanità non ne esistono, non<br />
di mura, né di foro, né di terme, né di templi e solo qualche antica cronaca ne dà<br />
cenni vaghi. E probabile che Mantova romana fosse centro rurale, in mezzo a una<br />
campagna prospera (i laghi non esistevano ancora) sapientemente irrigata, taráis<br />
ingens ubi flexibus errat Mincius, il qual fiume correva allora pigramente al mare,<br />
non senza formare qualche ristagno. Questa visione ce la offrono gli scrittori latini<br />
e soprattutto Virgilio, nativo della campagna di Piétole, la quale, assieme a parte<br />
dell’Agro mantovano e cremonese, fu assegnata da Cesare Ottaviano ai suoi veterani<br />
(41 a. C.). La struttura della città romana si conservò probabilmente a lungo e incerte<br />
son le notizie dei più antichi mutamenti della cerchia.<br />
Forse nel 589, a causa delle abbondanti piogge autunnali di quell’anno, sarebbe<br />
avvenuto un fatto di notevoli conseguenze per Mantova: l’Adige in piena, rotti gli<br />
argini, avrebbe colmato con le sue alluvioni l’alveo per il quale Tacque del Mincio<br />
fluivano al mare e il Mincio avrebbe quindi deviato il suo basso corso verso il Po<br />
per sfociarvi presso Governolo. In seguito a ciò, rigurgitando le acque di piena del<br />
maggior fiume nell’alveo del minore e da questo dilagando nella campagna, i modesti<br />
acquitrini prossimi a Mantova divennero vasti stagni temporanei. Questa situazione,<br />
oltre che rendere la zona comprensibilmente insalubre, non serviva molto alla difesa<br />
della città, tanto è vero che Agilulfo, re dei Longobardi (volendo punire i Mantovani<br />
della loro opposizione) nel 602 poté conquistare la città. Egli ordinò di smantellarne<br />
le mura, che furono riedificate solo nel 661 dopo la morte del re e per<br />
concessione della madre di lui, Teodolinda. Le mura erano per un tratto segnate<br />
dal Fossatum Bovum о Porcorum (così chiamato perché lungh’esso i macellai scannavano<br />
gli animali) ; tale fossato, dall’Ancona paludosa di Sant’Agnese, oggi piazza Virgiliana,<br />
passava lungo la via oggi detta dell’Accademia e si gettava nel Mincio; questo<br />
522
Torino, Biblioteca Nazionale<br />
Pianta di Mantova in una incisione di M. Fiorimi del 1600 circa.<br />
poi lambiva gli altri lati della cerchia. La città era divisa in rioni che prendevano<br />
il nome delle chiese (San Pietro, San Paolo, Sant’Agata, Santa Croce, Santa Maria<br />
di Capo di Bove, Santa Maria Mater Domini, Sant’Alessandro, San Damiano,<br />
Santa Trinità). Così la città si presentava verso il Mille allorché entrò a far parte<br />
dei domini feudali della famiglia di cui fu ultima e famosa rappresentante Matilde<br />
di Canossa. Fu appunto con Matilde che Mantova si preparò a resistere a Enrico IV,<br />
il quale assediò invano la città (1090-91); questa, accordatasi poi con l’imperatore,<br />
fece resistenza a Matilde, che la assediò (1114 ) e la vinse solo per fame. Forse da<br />
questi fatti d’arme, oltre che dalla necessità di bonificare l’aria e dal desiderio di<br />
conferire alla città un aspetto ridente, nacque e maturò l’aspirazione di dare a Mantova<br />
una difesa di prim’ordine; ciò che il libero Comune attuò affidandone al Pitentino<br />
la realizzazione. Con le dighe di Mulina e Belfiore e gli argini di Governolo<br />
e di Cerese il geniale architetto disciplinò le acque in modo che la città fu avvolta,<br />
quasi un’isola, tra quattro laghi: il lago Superiore, il lago di Mezzo, il lago Inferiore<br />
e il lago di Paiolo. Per comunicare con il territorio circostante vi erano dei<br />
ponti (quali il ponte dei Molini e il ponte San Giorgio, tuttora esistenti) e la<br />
523
Mantova: suggestiva veduta della città dal lago Inferiore.<br />
Fot. Calzolari<br />
città poteva ritenersi facilmente difendibile. Ma, non contenti, «... finiti i laghi per<br />
ampliare maggiormente il riparo che essi apportavano alla città, si misero i cittadini<br />
a pensare di circondarsi anco le case in riva al lago di bonissime mura, sì<br />
come fecero l’anno 1240 incominciando dal Cepetto fino alla Pradella, et l’anno 1242<br />
dalla Pradella fino al Santo Nicolò » (G. Bertazzolo). Solo nel 1352 doveva completarsi<br />
la cerchia con il tratto di mura da San Nicolò al Cepetto (Porta dei Molini),<br />
ma ormai Mantova poteva ritenersi una valida fortezza. Ne fece la prima esperienza<br />
nel 1252 Ezzelino da Romano, che sferrò, senza risultati, un assalto violentissimo<br />
alla città.<br />
Intanto Mantova si andava arricchendo di opere insigni, quali, in epoca comunale,<br />
il Palazzo della Ragione e il Broletto, e in sèguito, durante il predominio dei<br />
Bonacolsi, il Palazzo Bonacolsi, il Palazzo del Capitano, l’Arengario, la « Magna<br />
Domus» e diverse chiese.<br />
Nel 1328, in sèguito alla cacciata e alla morte del Passerino (Rinaldo Bonacolsi),<br />
Luigi Gonzaga, capitano del popolo, assunse il potere e instaurò la signoria che<br />
524
si reggerà sino al 1627. Furono tre secoli di grande splendore. La città acquistò<br />
importanza politica, divenne un centro d’arte e di cultura, si arricchì di opere<br />
d’arte. Vi accorsero in tempi diversi uomini insigni nelle arti e nelle lettere, quali<br />
Vittorino da Feltre che nella Cà Giocosa fondò la scuola umanistica, Leon Battista<br />
Alberti che progettò le chiese di San Sebastiano e di Sant’Andrea, Andrea Mantegna<br />
che affrescò mirabilmente nel Castello la « Camera degli Sposi », il Poliziano<br />
che ebbe l’ispirazione per la sua favola d’Orfeo, Giulio Romano che sbizzarrì la sua<br />
fantasia nella costruzione del Palazzo del Tè, e molti altri ancora.<br />
La città, che già contava circa 70.000 ab., si abbellì, venne dotata di edifici di<br />
pubblica utilità, furono, con opere diverse, rafforzate le mura, furono rammodernati<br />
più volte i ponti e furono tentati espedienti per porre riparo agli imprevisti dell’opera<br />
del Pitentino. Ma nel 1536, divenuti i Gonzaga anche signori del Monferrato,<br />
si profilò il declino politico ed economico di Mantova, che sfocerà nell’infruttuoso<br />
assedio del 1529 ad opera delle truppe imperiali e, in sèguito a tradimento,<br />
al vandalico e crudele saccheggio dell’anno successivo.<br />
La città decadde; la grave inondazione del 1654, che devastò la campagna, e le<br />
gravi pestilenze, che decimarono la popolazione, contribuirono a rendere precaria<br />
Fot. Fotocelere<br />
Mantova: Piazza Sordello.<br />
Sullo sfondo il lago di Mezzo e la campagna a nordest della città.<br />
525
Fot. Stefani<br />
Mantova: la rotonda di S. Lorenzo, il Palazzo della Ragione, la Torre dell’Orologio e la cupola di Sant’Andrea.
la sua situazione. I Gonzaga del ramo cadetto dei Nevers non ebbero qualità per<br />
rialzarne le sorti e nel 1707 Mantova passava sotto il diretto potere del governo<br />
austriaco.<br />
Intanto era andata peggiorando la situazione idrologica per il graduale interrimento<br />
dei laghi che, in periodi di magra, si trasformavano in limacciosi e mefitici<br />
pantani; scaduto almeno in parte, per gli sviluppi della tecnica militare, il loro scopo<br />
difensivo, sorse quindi il problema di far scomparire gli specchi d’acqua. Verso<br />
il 1780, per volere di Maria Teresa, fu tentato il prosciugamento del lago Paiolo<br />
forse con esito modesto, ma tuttavia tale da eliminare il carattere quasi insulare<br />
della città. Il problema rimase tuttavia per gli altri laghi e fu sentito sempre più acutamente.<br />
Conquistata e riconquistata da Napoleone, Mantova fu da questi fortificata;<br />
tornata sotto l’Austria conservò il suo carattere di fortezza, caposaldo del « quadrilatero<br />
», teatro di memorabili vicende risorgimentali. Ma il problema dei laghi si<br />
faceva, con il trascorrere del tempo, sempre più urgente. « La loro funzione era terminata,<br />
ora erano di danno: impedivano l’espansione della città in quanto bloccata<br />
dalle acque per troppo ampio giro, intrinstivano la vita dei cittadini con un clima<br />
nebbioso e umido nei mesi invernali, maleodorante nei mesi estivi » (E. Azzi). I<br />
progetti si susseguirono nel tempo, ma l’ingente costo ne ha impedito la realizzazione<br />
e ancora attualmente la città sta quasi come una penisola per tre lati avvolta dalle<br />
Fct. Fotocelere<br />
Mantova : pittoresca veduta sul<br />
Rio, che attraversa la città,<br />
sboccando a Porto Catena.<br />
527
acque. Anche per questa ragione, Mantova, non ha avuto, nel nostro tempo, uno<br />
sviluppo pari a quello delle altre città lombarde e la sua popolazione è rimasta<br />
numericamente assai al di sotto di quella che vi risiedeva nel più splendido periodo<br />
dei Gonzaga, contando ancora nel 1951 poco più di 47.000 abitanti. Lo sviluppo<br />
urbanistico si va manifestando tuttavia lentamente nell’unica direzione possibile, ossia<br />
sul lato meridionale; qui la città va espandendosi con un aspetto moderno, in<br />
contrasto con il volto grandioso e severo della parte rinascimentale.<br />
528
N(<br />
CONCLUSIONE<br />
Così come una tessera avulsa da un mosaico, pur brillando di un suo vivido<br />
colore e di una sua splendente lucentezza, risulterebbe alla fine insignificante se<br />
trattenuta fuori dal quadro d’assieme della composizione, altrettanto il nostro territorio,<br />
per quanto dotato di smaglianti e invidiabili caratteristiche, risulterebbe<br />
svuotato di vitalità se si mancasse di ricollocarlo nel grembo della madre comune;<br />
e se l’esigenza di porre in luce le precipue caratteristiche lombarde ha giustificato<br />
la momentanea enucleazione della parte dal tutto, giunti a questo punto è necessario<br />
riannodare sulla trama comune gli stami del tessuto particolare. Tanto più<br />
ciò s’impone in quanto la <strong>Lombardia</strong> non rappresenta una vera e propria regione<br />
geografica e tanto meno una regione a sè, distinta dalle altre, ma soltanto un<br />
lembo del vasto bacino padano. La sua individualità ha radici storiche, originandosi<br />
soprattutto dalla forza d’attrazione, crescente nei secoli, esercitata da Milano in un<br />
raggio di ampiezza progressivamente maggiore. Territorio marginale al primo affermarsi<br />
di Roma e poi di transito per più lontane conquiste, indifeso teatro di barbare<br />
escursioni e di efferate distruzioni al declinare della protezione di Roma, la<br />
<strong>Lombardia</strong> uscì dalla penombra all’affermarsi delle libertà comunali, prodromo<br />
della vitalità della popolazione locale. La storia della <strong>Lombardia</strong> divenne allora<br />
storia di città che la posizione geografica favorevole (già intuita dai condottieri<br />
romani che vi avevano costituito le loro basi) aveva fatto preminenti. Nella lotta<br />
scatenatasi tra le città stesse fu ancora la posizione geografica che favorì Milano,<br />
posta su un tenue rilievo proteso, a guisa di penisola, al margine tra l’alta pianura<br />
ancora densa di selve e la bassa pianura ancora intrisa di acquitrini, all’incrocio di<br />
grandi vie di comunicazioni padane e alpine, in posizione mediana del vasto bacino<br />
del Po. Milano estese il suo dominio, s’affermò via via sulle altre città lombarde<br />
ad eccezione di Mantova, più remota e soprattutto ben difesa dallo specchio dei<br />
suoi laghi. Ed ecco, dopo la lotta contro Como, Lodi, Cremona e le altre città<br />
vicine, la lotta di Milano contro potenze lontane, contro i Veneziani, i Grigionesi,<br />
3 4 — Le Regioni d ’Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
529
i Francesi; non conta che sopravvenga poi la dominazione straniera. Milano ha<br />
imposto la sua supremazia regionale, ha affermato la sua vitalità; il ruolo di Milano<br />
è ormai quello delle grandi città europee.<br />
Se questi cenni, pure insufficienti, possono lasciare intravvedere per rapidi lampeggiamenti<br />
le situazioni geografiche e storiche che, attraverso la supremazia di<br />
Milano e l’orbita di tale supremazia, si trovano a fondamento del delinearsi territoriale<br />
della <strong>Lombardia</strong>, ben più ampio discorso sarebbe necessario per seguire il<br />
manifestarsi della supremazia economica milanese, condivisa dalle altre città lombarde,<br />
la cui orbita attualmente ha ben altri confini che quelli regionali. Essa trae<br />
sì origine dal favore dei luoghi e della posizione geografica, ma in misura non<br />
secondaria dall’ammirevole fervore, dalla grande intraprendenza, dalla meravigliosa<br />
tenacia degli uomini, che si espresse dapprima nell’opera di trasformazione agraria<br />
del suolo, in cui il Milanese primeggiò stimolando pari intensità di opere in più<br />
ampio raggio, e susseguentemente nell’artigianato e nell’industria quantitativamente<br />
e qualitativamente apprezzabile. Sin dal Medioevo entrambi i settori di attività<br />
determinarono con i loro prodotti un vivacissimo mercato e relazioni commerciali<br />
non solo con le città italiane ma anche con le città d’Oltralpe. La posizione già<br />
eminente assunta dalla <strong>Lombardia</strong> del Quattrocento ben si rileva, ad esempio, dalle<br />
attestazioni del doge Tomaso Mocenigo, per quanto forse un poco esagerate; è<br />
comunque certo che a Venezia le città lombarde acquistavano quantità ingenti per<br />
quei tempi di materie prime, soprattutto cotoni greggi e filati, lane « francesche »<br />
e spagnole, e compensavano le importazioni con quasi 50.000 pezze di lana e di<br />
fustagno provenienti dalle manifatture di Como, di Bergamo, di Monza, di Brescia,<br />
di Milano, di Pavia. Anche i mercanti stranieri si sentivano attratti dal mercato<br />
lombardo, in gran numero affluivano i Tedeschi, che nel loro commercio erano agevolati<br />
dai facili passi del Gottardo, del San Bernardino, del Lucomagno, dello Spinga,<br />
di Sèttimo, e non solo i piccoli mercanti facevan traffico, ma anche i rappresentanti<br />
delle maggiori case di Augusta, di Ulma e di Basilea; pertanto, notevoli quantità<br />
di metalli grezzi, di argento, di rame, panni di lana, fustagni e anche grosse partite<br />
di cereali e di vini prendevano le vie delle Alpi. I Lombardi non si limitavano però<br />
ad attendere i mercanti stranieri, ma si recavano essi stessi ai più ricchi mercati<br />
europei. Così già nel secolo XIII la Camera dei mercanti di Milano figurava come<br />
la principale interessata all’apertura e al mantenimento della strada del Sempione<br />
che i Milanesi frequentavano numerosi per recarsi alle fiere di Champagne e più<br />
tardi a quelle di Ginevra e di Lione; all’inizio del Trecento furono ancora i mercanti<br />
milanesi i primi a valersi della nuova strada del Gottardo attraverso la quale,<br />
passando per la Lorena, essi si avviavano a Bruges. La Camera stessa trattava direttamente<br />
coi rappresentanti delle organizzazioni mercantili per assicurare condizioni<br />
favorevoli ai mercanti lombardi che trafficavano a Genova, a Napoli, in Francia,<br />
in Fiandra, in Inghilterra. La via di Genova assunse per essi particolare importanza<br />
sia per il transito terrestre verso la riviera francese sia per l’imbarco verso la Spagna<br />
e il Napoletano. La <strong>Lombardia</strong> (e in modo particolare Milano) assumeva così fin<br />
530
dall’età viscontea e sforzesca quella funzione (che si conserverà parzialmente nei<br />
secoli seguenti, anche sotto il dominio spagnolo) « di concentrazione e di smistamento<br />
del commercio della valle padana con l’Europa centro-occidentale, che ancor<br />
oggi, in misura ben maggiore per l’enorme aumento della potenzialità dei trasporti,<br />
costituisce tanta parte della sua grande fortuna economica » (G. Luzzatto).<br />
Tali precedenti chiariscono il ruolo che la <strong>Lombardia</strong>, già preminente nell’agricoltura<br />
e nei commerci, doveva assumere nel quadro nazionale con lo sviluppo dell’industria<br />
moderna. Essa ha conseguito un primato produttivo che si riversa beneficamente<br />
su tutto il territorio nazionale, un primato finanziario in grado di concorrere<br />
allo sviluppo delle altre regioni, un primato di progresso che si riflette come esempio<br />
e stimolo. Naturalmente, per questo intenso fervore di attività la <strong>Lombardia</strong> è divenuta<br />
un’area di attrazione e di afflusso delle forze del lavoro di ogni parte d’Italia.<br />
Ci si spiega in tal modo come numericamente la popolazione sia più che raddoppiata<br />
dai giorni dell’unità nazionale; e com’essa vada di anno in anno aumentando<br />
senza soste, anzi con ritmo crescente; poderosa concentrazione che si mantiene<br />
oscillante attorno a un settimo del totale della popolazione italiana. Questo afflusso<br />
nazionale, addensatosi nelle maggiori città e nella zona industrializzata, del tutto<br />
assorbito in un primo momento dall’ambiente lombardo, con l’andar del tempo<br />
e con il suo accrescersi ha determinato sensibili riflessi sulle tradizioni, i costumi,<br />
le parlate locali; male davvero modesto tuttavia e comunque minore del vantaggio,<br />
poiché l’amalgama non può che giovare a meglio rafforzare la solidarietà nazionale<br />
e ad attenuare le tendenze più deleterie del regionalismo, sopravvissute sin troppo<br />
a lungo nel tempo. In tal senso si può dire che Milano e le città industriali della<br />
<strong>Lombardia</strong> abbiano agito e agiscano come preziosi crogiuoli.<br />
Milano, già considerata nei suoi aspetti fondamentali in un quadro regionale<br />
dove emerge nettamente sotto ogni riguardo, anche nel quadro nazionale rappresenta<br />
un pilastro fondamentale. Essa costituisce il centro nevralgico dell’economia<br />
nazionale con forza attrattiva e propulsiva in campo bancario, finanziario, commerciale,<br />
industriale. I dati dimostrativi sono molti e vari: alcuni accennati nella precedente<br />
esposizione; basta aggiungere, come esempio significativo della potenza<br />
attrattiva, che il volume degli scambi della Borsa di Milano è, come media di anni<br />
recenti, quattro volte superiore a quello della Borsa di Roma, seconda in Italia, ed<br />
enormemente superiore a quello delle Borse di Napoli, di Genova, di Eirenze, di<br />
Venezia, di Bologna, di Trieste e di Palermo. La potenza propulsiva si manifesta<br />
con l’intervento diretto di capitale e di iniziativa, e non v’è forse regione italiana che<br />
non ne abbia testimonianza; si manifesta anche come emulazione e imitazione a tutto<br />
vantaggio dell’economia nazionale.<br />
Infine, in un quadro nazionale, non si può trascurare la funzione lombarda,<br />
derivata dalla posizione geografica, di nodo di raccordo tra l’economia italiana e<br />
quella continentale. Da ciò nasce quella partecipazione fattiva e concreta all’attività<br />
economica europea che permette a Milano di aspirare a un ruolo primario nel quadro<br />
del Mercato Comune Europeo.<br />
531
In conclusione e senza esagerazione si può considerare la <strong>Lombardia</strong> come antesignana<br />
del progresso economico dell’Italia. Per più aspetti, nella precedente esposizione,<br />
c’è stato motivo per confermare questa sua posizione, che si è venuta<br />
accentuando in confronto con il passato. Ma è altresì confortante rilevare come le<br />
distanze con le altre regioni siano notevolmente diminuite con il trascorrere del<br />
tempo, non per un regresso lombardo, ma per un progresso che si diffonde in più<br />
ampio spazio della Nazione e ben venga il giorno in cui la <strong>Lombardia</strong> possa conservare<br />
soltanto il vanto di aver trascinato tutto il territorio nazionale verso le più<br />
avanzate forme di progresso.<br />
532
N O T A DI A G G IO R N A M EN T O A L L A SECO N D A ED IZIO N E<br />
Il ritmo di accrescimento della popolazione lombarda considerata nella sua totalità<br />
è continuato ininterrotto nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale.<br />
I rilevamenti statistici ne danno evidente dimostrazione: al censimento del 1951<br />
la popolazione residente risultava di 6.518.421 unità; essa, al censimento successivo<br />
del 1961, risultava di 7.371.640 unità, con un aumento di 853.219 unità. Secondo<br />
poi una valutazione compiuta nel dicembre del 1967 si calcolava un totale<br />
di 8.231.665 residenti, con un accrescimento medio di 143.000 unità, ed è quindi<br />
da presumere che al censimento del <strong>1971</strong> la popolazione totale della <strong>Lombardia</strong> supererà<br />
gli 8 milioni e mezzo di residenti, con un aumento, rispetto al 1951, di più<br />
di 2 milioni di abitanti.<br />
L ’aumento della popolazione non si è manifestato in egual misura nelle diverse<br />
parti del territorio e, anzi, in alcune non vi è stato aumento, ma diminuzione. Il massimo<br />
aumento si è verificato nelle città, nelle conurbazioni e, in genere, nelle aree<br />
industriali, ossia nell’alta pianura e nella collina del Milanese, del Varesotto, del<br />
Comasco, del Bergamasco e del Bresciano. Nella montagna alpina e prealpina l’andamento<br />
demografico ha manifestato notevoli differenze da luogo a luogo: in contrapposizione<br />
all’aumento numerico della popolazione in alcuni centri più favoriti<br />
per posizione (come quelli dei grandi fondovalle e quelli in condizione di dare sviluppo<br />
al turismo estivo e invernale), vi è stata diminuzione in altri poco о nulla<br />
favoriti, che sono la maggior parte. Più forte e generale è stato poi il calo del numero<br />
degli abitanti nei centri e nei nuclei della montagna appenninica dell’Oltrepò<br />
Pavese. La pianura irrigua, infine, ha presentato in tutta la sua estensione una sensibile<br />
riduzione della sua popolazione rurale, soprattutto giovane, soggetta al richiamo<br />
della città e del lavoro industriale. Pur riferiti a larghi spazi come quelli delle province,<br />
i rilevamenti statistici confermano con evidenza la delineata situazione. Così,<br />
mentre la provincia di Milano dopo il censimento del 1951, ossia nel volgere di nep-<br />
533
pure un ventennio, s’è accresciuta, essa sola, di più di un milione di abitanti, le<br />
province di Cremona e di Mantova, nello stesso periodo, sono diminuite rispettivamente<br />
di circa 50 e 40.000 abitanti.<br />
Il richiamo della popolazione verso i centri abitati (soprattutto verso le città)<br />
risulta chiaramente dalla comparazione dei rilevamenti censuari del 1951 con quelli<br />
del 1961. In totale la popolazione accentrata tra le due date è aumentata dall’82,6%<br />
aU’87,7%, mentre la popolazione dei nuclei è diminuita dal 10,8% al 7,5% e la<br />
popolazione sparsa è passata dal 6,6% al 4,8%. Per il 1961 la percentuale massima<br />
di accentramento si registra in provincia di Milano, dove il 95,5% dei suoi abitanti<br />
erano addensati nei centri e soltanto il 3,9% e lo 0,9% distribuiti rispettivamente<br />
nei nuclei e nelle case sparse; per contro, il valore minimo di accentramento si registra<br />
in provincia di Mantova, dove il 64,7% degli abitanti viveva nei centri (ma<br />
57,7% nel 1951), mentre il 13,4% e il 21,9% erano distribuiti rispettivamente nei<br />
nuclei e nelle case sparse.<br />
Non v’è dunque alcun dubbio che anche in anni recenti è continuato, in qualche<br />
caso accentuandosi, l’esodo della popolazione dalla montagna, il trasferimento degli<br />
abitanti della campagna verso i centri e la convergenza verso le maggiori città.<br />
Riguardo all’aumento numerico della popolazione lombarda il contributo, come<br />
per il passato, è derivato in parte dall’incremento naturale e in parte dall’immigrazione.<br />
Il tasso di natalità, già inferiore in <strong>Lombardia</strong> alla media nazionale, ha avuto<br />
oscillazioni positive, elevandosi anche al di sopra della media stessa e ciò in conseguenza<br />
probabilmente dell’afflusso di giovani immigrati meridionali che, sistematisi,<br />
hanno costituita о ricostituita la famiglia. Lo si deduce dalla constatazione che<br />
le aree di maggior afflusso di immigrati sono quelle che denunciano i valori più alti<br />
di natalità. Questa, come media generale per la <strong>Lombardia</strong> nel quinquennio 1964-<br />
1968, è stata del i7,8°/oo, ma per diversi anni ha superato il i8°/oo e soltanto nel<br />
1967 e nel 1968 ha manifestato una contrazione, forse soltanto temporanea, scendendo<br />
al i7,i°/oo e al i6,y'^joo. Nel 1968 i rilevamenti statistici assegnavano alla<br />
provincia di Varese il tasso di natalità più elevato (i9,4°/oo), mentre assegnavano<br />
alla provincia di Pavia il tasso più basso (ii,9°/oo), inferiore al tasso della mortalità<br />
e quindi con saldo negativo. Non però molto differente è la situazione nelle province<br />
di Cremona e di Mantova, dove si sono registrati tassi di natalità piuttosto<br />
bassi, appena superiori a quelli della mortalità. Riguardo a questa si può notare che<br />
le province della « bassa » hanno tutte un tasso sensibilmente più elevato della media<br />
regionale e nazionale (Pavia із,8°/оо, Cremona i3 ,3 % o , Mantova ii,8°/oo nel 1968),<br />
il che denuncia l’invecchiamento della popolazione delle aree agricole per l’abbandono<br />
della campagna da parte dei giovani, richiamati dalle città e dalle industrie.<br />
Parallelamente all’aumento numerico della popolazione assoluta si è verificato,<br />
com’è ovvio, l’aumento dei valori della popolazione relativa, il cui valore medio,<br />
calcolato sulla popolazione presente nella regione, è passato da 273 ab. per kmq.<br />
nel 1951 a 3 11 ab. per kmq. nel 1961 e, secondo una valutazione al 31 dicembre 1967,<br />
534
si sarebbero raggiunti i 345 ab. per kmq. Le differenze tra i valori provinciali, a<br />
causa dei movimenti in atto della popolazione, si sono accentuate e, mentre in alcune<br />
aree la densità è in forte progressione e già ha aggiunto livelli altissimi, in altre<br />
aree è manifesta una continua e lenta diminuzione. A dimostrazione bastano pochi<br />
dati più significativi. Nel territorio della provincia di Milano si sono raggiunti i<br />
ІГ45 nel Г961 e i 1334 ab. per kmq. nel 1967. Ugualmente, nei territori delle province<br />
di Varese, Como, Bergamo e Brescia i valori di densità, sebbene distanti dal<br />
massimo milanese, sono in forte progressione e lo denunciano le rispettive medie<br />
che però risultano attenuate dal fatto che ciascuna circoscrizione include vaste zone<br />
di montagna in fase di spopolamento. Situazione contraria si riscontra per i territori<br />
delle province di Mantova e di Cremona; ivi i valori di densità sono in diminuzione:<br />
nella prima si è passati da 217 nel 1951 a 200 nel 1961 e a 191 ab. per kmq.<br />
nel 1967; nella seconda, alle stesse date, si è passati da 179 a 166 e a 162 ab. per kmq.<br />
In condizioni leggermente diverse è il territorio di Pavia, dove, in relazione a un<br />
sia pur limitato sviluppo industriale, la densità denuncia un lieve aumento (da 170<br />
nel 1951 a 179 ab. per kmq. nel 1967). Anche il territorio di Sondrio, mercè l’insediarsi<br />
di industrie nell’ampio fondovalle valtellinese, conserva un andamento crescente<br />
del valore di densità (da 46 ab. per kmq. nel 1951 a 53 ab. per kmq.<br />
nel 1967).<br />
Come s’è accennato, all’aumento della popolazione lombarda ha dato un forte<br />
contributo l’immigrazione. Il movimento di afflusso da altre regioni d’Italia è continuato<br />
senza interruzione, sebbene con consistenza variabile da un anno all’altro;<br />
comunque si tratta sempre di diverse decine di migliaia per anno. Le regioni di provenienza<br />
sono state in prevalenza quelle meridionali : la Sicilia, la Puglia, la Campania,<br />
la Calabria, alle quali si affianca il Veneto. In genere l’immigrato non ha dimostrato<br />
di preferire come sua sede Milano e le grandi città pedemontane, ma piuttosto i<br />
centri minori dell’alta pianura e della collina (soprattutto quelli della conurbazione<br />
milanese), che comportano minori spese. In ciò l’immigrato è agevolato dall’intensa<br />
rete di trasporti che permettono di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro.<br />
Com’è comprensibile, l’inserimento di un flusso immigratorio così consistente ha<br />
posto e pone alle amministrazioni dei luoghi di accoglimento problemi non lievi<br />
di diverso ordine, tra i quali preminente quello della casa.<br />
Il richiamo della regione lombarda sulla popolazione di altre regioni italiane è<br />
determinato dallo sviluppo economico che nel decennio 1961-70 ha presentato un<br />
andamento in complesso favorevole.<br />
La popolazione attiva al censimento del 1961 risultava di 3.220.159 unità, con<br />
un notevole aumento rispetto al precedente censimento (3.145.931 nel 1951)- A l<br />
l’ultima data censuaria Г 11% della popolazione attiva risultava dedita all’agricoltura,<br />
con una diminuzione sensibile rispetto al passato: di fatto, dai 558.000 addetti<br />
a questo settore nel 1951 si è scesi a 355.000 nel 1961 e per diverse indicazioni si<br />
è portati a presumere che il calo sia proseguito nel tempo. Notevole invece è stato<br />
l’aumento del numero degli addetti nel settore industriale (comprendendo anche i<br />
535
settori minerario ed edile): nel 1951 si calcolavano in 1.550.768, che rappresentavano<br />
il 49,3% del totale della popolazione attiva, mentre nel 1961 si valutavano in<br />
1.871.441, corrispondenti al 58,1% , e anche in questo caso vi è stato un continuo<br />
aumento. Sensibile è stata anche la variazione positiva nei settori trasporti, commercio<br />
e servizi (accresciutisi di oltre 200.000 unità) e per contro la variazione negativa<br />
nel settore della pubblica amministrazione (che ha avuto un calo di oltre<br />
70.000 unità).<br />
La situazione nelle varie province riguardo alla proporzione degli addetti ai vari<br />
settori di attività varia notevolmente in relazione alla diversità di ambiente e quindi<br />
di attività economica. Nelle province di Cremona e di Mantova il settore agricolo<br />
conserva una preminenza, per numero di addetti, sugli altri settori; nelle rimanenti<br />
province invece ha la preminenza il settore delle industrie; ma sebbene eccella per<br />
numero assoluto di unità la provincia di Milano, in ordine alla percentuale il primo<br />
posto è occupato dalla provincia di Varese (73% di addetti alle industrie sul totale),<br />
seguita dalle province di Como (66%), di Bergamo (62%), di Milano (61%), di<br />
Brescia (51% ), di Sondrio (47%), di Pavia (46%).<br />
La contrazione del numero dei lavoratori rurali non ha determinato la riduzione<br />
della produzione agricola, che conserva altissimi livelli, e deH’allevamento,<br />
che, anzi, ha avuto un sensibile incremento. Ciò si deve all’adozione di nuove<br />
tecniche e alla generale diffusione dei mezzi meccanici. Si può ricordare, come<br />
esempio, l’uso ormai stabilizzato dell’elicottero per cospargere il solfato di calce<br />
nei vigneti dell’Oltrepò Pavese о i diserbanti sulle risaie della Lomellina e del Pavese<br />
p. d.; in queste l’adozione di macchine anche per il trapianto ha fatto scomparire<br />
rapidamente e quasi totalmente la figura della mondina.<br />
In seguito all’evoluzione sociale ed economica molti aspetti tradizionali nei settori<br />
dell’agricoltura e dell’allevamento sono mutati e vanno mutando; nella montagna<br />
i livelli altimetrici delle colture si abbassano, i terreni meno produttivi sono<br />
lasciati incolti, i castagneti vengono trascurati; nella collina subalpina e nell’alta<br />
pianura asciutta lo sviluppo edilizio e gli impianti industriali sottraggono spazio<br />
sempre maggiore ai coltivi e le dimore rurali perdono la loro tradizionale funzione,<br />
adattate a case per operai.<br />
Per tali fatti la estensione della superficie agraria e particolarmente la superficie<br />
dedicata ai seminativi ha subito sensibile riduzione e se ne trova conferma<br />
nelle statistiche, anche se non del tutto recenti. Così, mentre nel 1951 la superficie<br />
agraria era valutata in 1.517.688 ha., nel 1961 la medesima superficie era calcolata<br />
in 1.415.326 ha., con un calo di oltre 100.000 ha. sottratti quasi per intero ai seminativi,<br />
mentre quasi invariate risultavano le aree dedicate alle colture legnose e ai<br />
foraggi. Dal confronto dei dati per i medesimi anni si deduce una sensibile espansione<br />
dell’area a bosco ed è da ritenere che ciò derivi dalle piantagioni di pioppi,<br />
incrementate nella pianura irrigua. Naturalmente, le superfici coperte dall’espansione<br />
edilizia, dalle industrie e dalle strade hanno denunciato una notevole progressione.<br />
536
Non ostante ciò, il livello produttivo, come s’è accennato, non ha manifestato<br />
flessioni. V ’è però una grave minaccia per l’agricoltura della pianura irrigua, la minaccia<br />
costituita dall’inquinamento delle acque. I fiumi e i canali da essi derivati,<br />
che da secoli contribuiscono alla fecondità delle terre, per gli scarichi delle industrie<br />
lungo il loro corso portano ai campi acque dense di contenuti chimici nocivi alle<br />
colture. Il problema diventa tanto più grave in relazione al progredire dello sviluppo<br />
industriale e soltanto un’opportuna e tempestiva legislazione che imponga l’installazione<br />
di appropriati depuratori potrà impedire l’insterilimento della florida pianura<br />
della « bassa ».<br />
La consistenza dell’industria lombarda al censimento industriale del 1961 era<br />
rappresentata da 128.281 unità locali (di cui 1 13.239 del ramo manifatturiero,<br />
14.100 del ramo edile e 942 del ramo minerario) corrispondenti al 18% del totale<br />
nazionale. Il territorio milanese deteneva la preminenza su quello delle altre province<br />
con quasi la metà delle unità locali; a distanza seguivano Como, Brescia, Varese,<br />
Bergamo e Pavia.<br />
Negli anni successivi al rilevamento censuario la progressione dell’industria nel<br />
suo complesso non ha avuto soste: si sono espansi i complessi già esistenti e sono<br />
sorti nuovi impianti, prendendo sede in prevalenza nella sezione occidentale dell’alta<br />
pianura e, in misura di poco minore, della collina. Nella « bassa » nuovi impianti<br />
sono sorti lungo le direttrici di maggior traffico irradiantesi da Milano, come<br />
quella tra Milano e Piacenza e tra Milano e Pavia. Milano conserva la prerogativa<br />
di attrazione e di propulsione dell’economia lombarda (e non soltanto lombarda)<br />
e anche le industrie tendono a non distanziarsi troppo dal grande centro. Un po’<br />
ai margini di quest’area di grande concentrazione industriale si trovano Cremona<br />
e Mantova, che aspirano ad una partecipazione sulla via dello sviluppo industriale,<br />
maggiore di quella sin qui avuta.<br />
Molte speranze fonda la città di Cremona sul grande canale navigabile, in parte<br />
già compiuto, che, distaccandosi dal Po nei pressi dell’agglomerato urbano, traverserà<br />
la pianura per giungere alle porte di Milano. Il canale dovrebbe determinare<br />
la valorizzazione del maggior fiume come arteria navigabile e creare così un collegamento<br />
diretto per via d’acqua tra l’Adriatico e Milano, il che darebbe impulso<br />
a Cremona, nodo principale dell’arteria. Meno sicure le prospettive per la città di<br />
Mantova, chiusa tra gli specchi dei laghi del Pitentino. Anche Sondrio soffre di isolamento<br />
a causa dell’insuflìcienza delle strade di collegamento tra le sue grandi valli<br />
e la pianura.<br />
Dei vari settori dell’industria manifatturiera, non tutti hanno avuto un pari<br />
sviluppo; accanto a quelli in grande progresso, ve ne sono stati alcuni stazionari e<br />
altri addirittura in sia pur lieve e temporaneo regresso. Tra i primi si possono citare,<br />
come esempio, il chimico, l’elettrotecnico, l’elettromeccanico, tra i secondi il<br />
tessile soprattutto cotoniero.<br />
Un’indicazione dello sviluppo complessivo può dedursi dal progresso compiuto<br />
nella produzione e nel consumo della forza motrice. La potenza installata con moil<br />
I<br />
537
tori primari che nel 1951 era di 2.625.000 kW, nel 1968 aveva raggiunto i<br />
5.232.331 kW, il 61% dei quali idroelettrici e il resto termoelettrici. La produzione<br />
nel medesimo anno raggiungeva i 18 miliardi e mezzo di kWh. Il consumo tuttavia<br />
è stato superiore di oltre 2 miliardi di kWh (20,8 miliardi, pari al 24% del totale<br />
nazionale) per la maggior parte (14 miliardi) assorbito dall’industria manifatturiera<br />
e soprattutto dalle industrie chimiche, elettrochimiche, meccaniche.<br />
Al grande sviluppo industriale corrisponde un pari sviluppo delle attività commerciali<br />
e dei trasporti. Per i primi, al censimento del 1961 si annoveravano<br />
176.183 unità locali, addensate soprattutto a Milano. Un indice deU’intensità commerciale<br />
può derivarsi dal crescente successo della Fiera Internazionale di Milano<br />
e altresì dall’intensificarsi dei trasporti. La rete delle comunicazioni si è arricchita<br />
di alcune nuove arterie (ad esempio, il prolungamento dell’autostrada da Brescia a<br />
Venezia), ma soprattutto si sono migliorate le condizioni di viabilità stradale. Il movimento<br />
è aumentato notevolmente e già in alcuni tratti e in alcuni periodi particolarmente<br />
sulle autostrade si avvertono sintomi di congestione. Ciò è del resto<br />
comprensibile a causa del numero di veicoli a motore circolanti: 2.345.683 nel 1968,<br />
corrispondenti a circa un sesto del totale nazionale.<br />
Nel quadro delle prospettive di sviluppo della <strong>Lombardia</strong> assume particolare<br />
significato l’attuazione dell’istituto regionale contemplato dalla Costituzione repubblicana;<br />
esso infatti potrà consentire una maggiore efficienza nella vita amministrativa<br />
ed economica ed agire quindi di stimolo al progresso generale della Regione.<br />
Tale funzione è affermata dallo Statuto regionale deliberato dal Consiglio regionale,<br />
là dove si dichiara che « obbiettivi preminenti dell’attività della Regione sono lo sviluppo<br />
economico e sociale finalizzato alla affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento<br />
dei bisogni collettivi, la promozione delle libere attività delle collettività<br />
e degli Enti locali, il superamento degli squilibri nell’àmbito della Regione e dell’intero<br />
territorio nazionale ». In particolare si precisa che la Regione, nei limiti concessi<br />
dalla Costituzione, « promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo<br />
studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione e la tutela dei diritti<br />
dei lavoratori; assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo<br />
a quelli inerenti all’abitazione, all’istrazione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti,<br />
alle attività sportive e al turismo; adotta le iniziative necessarie per assicurare<br />
la funzione sociale della proprietà e acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali<br />
d’interesse generale; attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali<br />
nelle campagne; assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane;<br />
promuove lo sviluppo della cooperazione e dell’artigianato; promuove e attua un<br />
organico assetto nel territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti<br />
umani e delle infrastrutture sociali; garantisce la tutela dell’ambiente; predispone<br />
ed attua piani per la difesa del suolo per la prevenzione ed eliminazione delle<br />
cause d’inquinamento; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico,<br />
artistico e culturale; promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;<br />
assume iniziative per assicurare un’ampia e democratica informazione.<br />
538
intervenendo nell’organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi;<br />
contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali<br />
e locali ».<br />
Nella particolareggiata formulazione vi è in definitiva un articolato e complesso<br />
impegno che non può evidentemente essere realizzato in breve volgere di tempo.<br />
L ’attuazione inoltre presuppone una coordinazione, che, dallo Statuto, risulterebbe<br />
doversi inquadrare in una « politica di piano, come metodo di intervento, in concorso<br />
con lo Stato e con gli Enti locali ».<br />
ti<br />
ì<br />
539
Alt.<br />
m.<br />
Tabella I.<br />
T emperature medie mensili e annue in °C.<br />
(Le medie delle Stazioni indicate con asterisco sono calcolate sul periodo 1930-50; le altre medie sono calcolate per periodi<br />
con inizio dall’anno indicato tra parentesi e sino al 1958).<br />
Stazione G F м A M G L A s 0 N D<br />
M ed ia<br />
annua<br />
P ian u ra (bassa):<br />
20 Mantova * ........................................... 0,8 3,2 8,5 13,4 17-7 22,5 24,8 24,0 20,1 13-9 7-6 2,3 1 3 А<br />
45 Cremona * ........................................... 0,7 3-3 8,6 1З-І 17-2 22,1 24,5 23,7 19-9 13,6 7,4 2,2 13 ,0<br />
77 Pavia * ............................................... 0,1 2,8 8,0 12,6 16,9 21,2 23,2 22,2 18,4 12,6 6,5 1,5 12,2<br />
P ian u ra (alta) :<br />
148 Chiari * ............................................... 2,5 5,6 10,2 14-1 18,1 22,1 24-9 24,6 21,5 16,0 9-3 3-8 1 4 ,3<br />
122 Milano (18 3 8 )................................... 1,2 3-7 8,3 13-І 17-7 21,9 24-3 23-3 20,0 13-3 6,9 2,7 13 ,0<br />
C ollina e pedem onte:<br />
366 Bergamo * ........................................... 2,2 4-1 8,2 12,5 16,2 20,8 23-0 22,2 19,0 13-4 7-6 3-3 1 2 ,7<br />
427 Asso (18 9 8 )....................................... 2,3 3-9 7-3 іі-З 15-0 19-4 21,1 20,3 17-3 12,2 6,9 3,9 1 1 , 7<br />
L agh i p realpini:<br />
70 Desenzano * ....................................... 3,5 4-9 8,9 іЗ-З 17-4 22,0 24,0 23,6 20,1 14,8 9-3 4,6 13 .9<br />
100 S a l ò ................................................... 4.0 4,6 8,9 13-2 17-3 21,8 24-5 23,7 20,4 14-7 10,0 5-3 14 ,0<br />
206 Bedano * ........................................... 4,3 6,3 10,0 13-5 16,2 20,3 22,2 22,3 19-3 14-3 9-5 5-2 1 3 ,7<br />
241 Pallanza (1924)................................... 2,8 4-3 8,2 12,5 16,8 20,4 22,9 22,2 18,9 13,2 7-8 4-0 13 ,0<br />
P rea lp i :<br />
312 Breno ( 1 9 2 4 ) ................................... —0,5 —0,9 5,4 9-7 13-3 17,6 20,2 20,0 16,5 I I , I 5,6 0,8 1 1 , 3<br />
648 elusone (1896)................................... 2,0 2,8 6,4 9-7 13-6 17,8 20,3 19,6 16,5 1 1 ,3 6,3 2,6 10 ,7<br />
355 San Pellegrino (1908)........................ 1,2 2,6 6,6 10,9 14,6 18,8 2 1,0 20,3 17,2 12 ,0 6,7 2,2 II,I<br />
1820<br />
A lp i:<br />
Lago d’Arno ( 1 9 1 3 ) ........................ —4,3 --- 2,8 -- 0,1 2,9 6,2 10 ,0 12,1 11,6 9,0 5,0 0,6 —3-1 5 ,7<br />
1520 Fòppolo ( 1 8 9 3 ) ............................... —3,6 —2,9 —0,3 2-7 6,1 9-8 12,3 12 ,0 9-3 4-9 3-9 2,4 7 f i<br />
333 Chiavenna (1891)............................... 3,3 5-4 9-3 13-2 16,3 20,1 22,7 22,5 18,8 13,1 8,1 4,0 13 ,0<br />
298 Sondrio * ........................................... 0,2 3-2 7-9 12,3 15-8 20,2 21,9 21,3 17,6 12,2 6,1 0,6 1 1 , 6<br />
I22S Bormio * ........................................... — 1-4 0,7 3-9 7-7 11-5 15,5 17-3 16,5 13-8 8,7 3-3 —0,7 8 ,1<br />
L a<br />
93<br />
O ltrepò pavese:<br />
Voghera (1914)................................... — 0,2 2,3 7-8 12 ,4 16,7 21,1 23,6 22,6 18,8 12,7 6,4 1,5<br />
—<br />
(Dati elaborati dalla sezione di Milano dell'Ufficio Idrografico del Po)
La<br />
Ю<br />
Tabella IL — Precipitazioni medie mensili e annue in mm.<br />
(Le medie sono calcolate per il periodo 1921-50, salvo che per Milano la cui media riguarda il periodo 1805-1955).<br />
Stazione G F M A M G L A s 0 N D<br />
Media<br />
annua<br />
Giorni<br />
piovosi<br />
P ian u ra (bassa):<br />
M a n to v a ............................................................. 49 41 54 54 83 71 40 40 68 68 71 46 68s 76<br />
C re m o n a ............................................................. 48 49 46 56 69 48 32 46 SI 75 69 52 641 77<br />
P avia...................................................................... 58 48 63 71 82 55 51 S3 68 82 88 65 784 80<br />
P ian u ra (alta):<br />
C h i a r i .................................................................. 60 SI 57 76 113 77 66 83 8S 8S 8S 58 876 81<br />
M ila n o .................................................................. 60 59 73 89 102 83 72 81 87 12 1 IOS 76 1007 102<br />
C ollina e pedem onte:<br />
B re sc ia .................................................................. SI 52 63 78 117 81 64 80 76 77 80 63 882 86<br />
B e rg a m o ............................................................. 60 S8 91 117 172 122 93 104 I I 2 113 120 81 1243 100<br />
A s s o ...................................................................... S2 64 HO 189 227 149 149 156 149 I6I 157 90 1653 91<br />
V a r e s e ................................................................. 59 SS 102 145 198 126 IOS 122 132 139 138 87 1408 92<br />
L agh i p realpini:<br />
D e se n z a n o ......................................................... SO 48 63 70 99 75 67 66 78 67 71 . 61 81S 76<br />
I s e o ...................................................................... S4 56 87 IOS 147 II6 93 II4 119 II6 104 67 1178 92<br />
C o m o .................................................................. 56 60 88 118 172 109 107 I IO IIO 129 138 78 1275 91<br />
Bellan o.................................................................. S2 57 82 126 197 152 153 170 143 141 128 67 1468 92<br />
P a lla n z a ............................................................. S2 50 100 178 258 183 133 147 188 179 192 80 1740 88<br />
P rea lpi :<br />
Breno .................................................................. 47 43 62 81 IIS 127 lOI 107 92 102 84 58 1019 93<br />
e l u s o n e ............................................................. 65 66 104 146 192 155 I3I 132 13s 146 148 87 1507 104<br />
San Pellegrino.................................................... 54 63 96 148 192 145 I 2 I 14s 140 14s 144 75 1468 IOS<br />
A lp i:<br />
È d o l o ................................................................. 32 41 54 75 lio 106 I18 106 I16 106 98 42 1004 93<br />
Lago d’A r n o .................................................... SS SO 9 4 IOS 15 1 149 138 134 133 14s 123 71 1348 117<br />
F ò p p o lo ............................................................. 74 76 137 168 250 216 215 219 204 212 191 III 2073 95<br />
C h ia v e n n a ......................................................... 37 57 82 108 ISO 140 149 168 133 160 128 64 1376 81<br />
Sondrio................................................................. 40 49 72 96 129 99 98 107 102 III 119 61 1083 92<br />
B o rm io ................................................................. 19 23 39 47 75 79 90 100 80 74 69 33 728 86<br />
O ltrepò pavese:<br />
V o g h e r a ............................................................. 52 46 55 54 67 47 35 41 48 76 87 62 670 76<br />
(Dati ricavati da «Precipitazioni medie, ecc. », 1st. Idr. del Po. Per Milano: L. S a n t o m a u r o , L in e a m e n ti c lim a tic i, ecc., Milano, 1957).<br />
L a<br />
LO<br />
><br />
P<br />
Pc<br />
H<br />
0<br />
vO Оp<br />
N)<br />
О<br />
< 02 0 n n CÖ Cö<br />
¡3 0<br />
< . р 0) i-í<br />
a<br />
w Cb р 3<br />
!3 3 0 oc 0<br />
P<br />
0“ о о J І-Ц LO to to to Ы to Ф to Н-. Cß<br />
CO w to Ò •b do -J h -b dj тз<br />
0 0 H Оч La 00 La 04 Ф La Q<br />
L>J 00 УН Ф СОчО 04 04 чО 00 3 th<br />
00 чО УН Ф 0 00 УН b<br />
00 w ü о La 1-1 чО Ф 04 to<br />
b-1<br />
Ь-1 1—( м l-ч 0 La LL» ы »H чО _( to )_( Ьч 1-1 do 04<br />
On чО La La чО La 0 <br />
н<br />
d<br />
><br />
о к<br />
d<br />
о<br />
W >VÖ
Л .<br />
P<br />
Ш: Я<br />
ы<br />
U~l<br />
ф .<br />
г -<br />
о<br />
со<br />
><br />
я<br />
Ö<br />
К)<br />
OJ<br />
оо<br />
ф Ln<br />
<<br />
сл<br />
о<br />
D<br />
СЬ<br />
D<br />
о*<br />
p<br />
<<br />
p ’<br />
1 S<br />
p<br />
0<br />
pT<br />
3<br />
0<br />
3Г+<br />
0<br />
<<br />
f3<br />
3<br />
0<br />
3<br />
0<br />
0<br />
3<br />
0<br />
w<br />
СЛ<br />
0<br />
p ‘<br />
w fO i-i<br />
OQ<br />
P3<br />
p p 0<br />
LO M 0 hM Ы W N)<br />
чО Ф 0 M • v j Ф<br />
0 4 0 4 0 vO Ы Ф<br />
ф<br />
00<br />
Ln<br />
<br />
3<br />
О<br />
О<br />
п<br />
3<br />
со<br />
3<br />
то '<br />
3(“f<br />
о<br />
<<br />
£і.<br />
с"<br />
н<br />
сг<br />
П)<br />
<<br />
Ü<br />
н<br />
ся<br />
Н<br />
О<br />
><br />
f<br />
П<br />
О<br />
Г<br />
><br />
н<br />
><br />
w<br />
С|<br />
f<br />
><br />
о<br />
►ti<br />
О<br />
г<br />
><br />
N<br />
О<br />
г ;<br />
и<br />
►ti<br />
>Ö<br />
и<br />
ся<br />
И<br />
И<br />
м<br />
w w M »-H ><br />
00 00 <br />
о N<br />
О ' о<br />
:z:<br />
%<br />
о<br />
^ г<br />
г ь<br />
о 3 2Ö<br />
2 - ^<br />
3 О<br />
р ><br />
г*<br />
•<br />
{-<<br />
0 0 0 L 00<br />
n<br />
3<br />
то 'vj<br />
W ю ю to<br />
LO ьн HH Ò<br />
0<br />
M T3<br />
0 00 0 0<br />
Ò ò ò Ò —<br />
0<br />
0 0 0 0 3<br />
то<br />
M HH ><br />
00 00 00<br />
1 U t Ф LO<br />
00 CO о<br />
W IO Ы<br />
óo<br />
Ф<br />
Ф ÍO чО<br />
L O<br />
1<br />
Ò ò Ò »<br />
0 0 0 0<br />
, т .<br />
.Je ’M !<br />
.iWÄ'i“ '<br />
I<br />
ЙЗ<br />
Tabella VII. — P o p o l a z i o n e ( p r e s e n t e ) d e l l a R e g i o n e e d e l l e P r o v i n c e d a l i 8 6 i a l 1951.<br />
Province<br />
Censimento<br />
1861<br />
Popolaz.<br />
presente<br />
Indice<br />
Censimento<br />
1911<br />
Popolaz.<br />
presente<br />
Indice<br />
Censimento<br />
1921<br />
Popolaz.<br />
presente<br />
Indice<br />
Censimento<br />
1931<br />
Popolaz.<br />
presente<br />
Indice<br />
Censimento<br />
1951<br />
Popolaz.<br />
presente<br />
Indice<br />
Censimento<br />
1961<br />
Popolaz.<br />
presente<br />
Indice<br />
C“’ о<br />
3<br />
B e r g a m o ............................................. 347-235 100 S lI - 2 3 7 14 7 555-686 16 0 584.881 168 673-524 19 3 7 19 .4 2 0 207<br />
B r e s c ia .................................................. 4 3 4 .2 19 100 5 9 6 .4 11 13 7 6 52.225 ISO 710 .6 4 2 16 3 8 4 4 .4 17 19 4 8 6 3 .5 17 198<br />
457-434<br />
—<br />
6 16 .2 12<br />
—<br />
630.977 —<br />
C om o ( * ) ............................................. 487.277 1 4 1 562.035 1 6 2 6 23.377 1 8 0<br />
3 4 5 . 0 0 0 100 4 4 8 . 0 0 0 1 3 0 4 5 7 . 0 0 0 13 2<br />
C r e m o n a ............................................. 2 8 5 .14 8 100 348.749 1 2 2 357-605 12 5 356 .728 12 5 38 0 .557 13 3 346.028 12 1<br />
. ш .<br />
іШ :<br />
M a n t o v a ............................................. 2 6 2 .8 19 10 0 349-048 13 2 376 .9 0 1 14 3 397-686 1 5 1 4 19 .56 8 159 382.667 145<br />
948.320 —<br />
1.726.54 8<br />
—<br />
1.9 0 6 .2 3 1<br />
—<br />
M ilan o { * ) ........................................ 2 .0 0 1.8 5 7 232 2.505.638 292 3 .18 1.2 4 3 3 7 1<br />
8 5 6 . 0 0 0 100 1.56 3.0 0 0 1 8 2 1 . 7 3 3 - 0 0 0 2 0 2<br />
P a v ia ....................................................... 419-785 100 5 12 .3 4 0 1 2 2 492.520 1 1 7 4 8 1.8З4 1 1 4 506.276 12 0 5 15 .2 8 7 1 2 2<br />
S o n d rio .................................................. 106.040 zoo 129.928 12 2 13 1- 18 4 12 3 133-758 12 6 15 0 .16 8 14 1 153-59 2 14 4<br />
V arese ( * ) ........................................ ■<br />
■ — —<br />
204.000 100 3 3 2 . 0 0 0 16 2 347-000 17 0<br />
382.462 1 8 7 476.238 2 3 8 586.509 2 8 6<br />
L o m ba rd ia / 3.2 6 1.0 0 0 , 100 4-790.473 14 7 5 .10 3 .3 2 9 15 6 5-537-193 17 0 6 .5 18 .4 2 1 199 7 .3 7 1.6 4 0 225<br />
S3-<br />
-t-<br />
Oa<br />
(*) La Provincia di Varese venne istituita nel 1927 cdn territorio e popolazione precedentemente inclusi nelle Province di Milano e di Como. Perciò, in tondo sono segnati<br />
i valori di popolazione effettiva delle P ro vin > « .^ M ilai^ e Como, in corsivo i valori calcolati nel territorio delle Province di Milano, di Como e di Varese secondo la divisione<br />
adottata nel 1927.
Ln<br />
Ф* ON<br />
Tabella V ili. — P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e d e i c e n t r i , d e i n u c l e i e d e l l e c a s e s p a r s e i n L o m b a r d i a .<br />
Censimento 1951.<br />
P r o v i n c e e R e g i o n e<br />
Popolazione dei centri Popolazione dei nuclei Popolazione delle case sparse Totale popolazione residente<br />
n. % n. % n. % n. %<br />
Bergamo................................................... 519-761 74.6 102.325 1 4 . 7 74-540 10,7 696.626 100<br />
B r e s c ia ..................................................<br />
6 4 7 - 5 6 5 75.5 104.037 1 2 , 1 106.641 12,4 858-243 1 0 0<br />
C om o....................................................... 473-052 84,1 62.849 11,2 26.603 4.7 562.504 100<br />
C re m o n a .............................................. 297-654 78,0 68.787 18,0 15-375 4.0 381.816 100<br />
Mantova.................................................. 245.263 57.7 73-878 1 7 . 4 105.612 24,9 424-753 100<br />
M ila n o .................................................. 2.310.036 92,2 160.021 6,4 35-096 1,4 2 - 5 0 S - 1 5 3 1 0 0<br />
P a v ia ...................................................... 401.231 79.2 73-850 14,6 31-430 6 , 2 506.511 1 0 0<br />
S o n d rio .................................................. 1 14.403 74.5 32.190 21,0 6.900 4.5 153-493 1 0 0<br />
V a r e s e ..................................................<br />
4 1 8 - 4 3 3 87^7 2 9 - 3 6 7 6 , 2 29-255 6,1 477-055 100<br />
L ombardia 5-427-398 82,6 707-304 10,8 431-452 6 ,6 6-566.154 100<br />
Tabella IX. — P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e d e i c e n t r i , d e i n u c l e i e d e l l e c a s e s p a r s e i n L o m b a r d i a .<br />
Censimento 1961.<br />
P r o v i n c e e R e g i o n e<br />
Popolazione dei centri<br />
Popolazione dei nuclei<br />
Popolazione<br />
delle case sparse<br />
Totale<br />
popolazione residente<br />
n. % n. % n. % n. %<br />
B e r g a m o .............................................. 599-773 8o,S 87-378 11,8 57-519 7,7 744.640 100<br />
B r e s c ia .................................................. 718.662 81,4 79-555 9,0 84-732 9,6 882.949 100<br />
C om o...................................................... 539-444 86,7 57-624 9,3 25.064 4,0 622.132 100<br />
C re m o n a .............................................. 292.387 83.3 43-798 12,5 14-975 4,3 351.160 100<br />
Mantova.................................................. 250.693 64.7 51.889 13,4 84-673 21,9 387-255 100<br />
M ila n o .................................................. 3.006.251 95,2 123.483 3,9 27.081 0,9 3-156.815 100<br />
P a v ia ...................................................... 436.493 84,2 53-025 1 0 , 2 28.675 5,6 518.193 100<br />
S o n d rio .................................................. 128.024 79,4 27.749 7,9 5-677 3,6 161.450 1 0 0<br />
Varese...................................................... 521.867 89,7 33-489 5,8 26.172 4,5 581.528 100<br />
L ombardia 6-493-594 87,7 557-990 7,5 354-568 4,8 7.406.152 100<br />
Ln<br />
Ф
Ol<br />
0 0<br />
Tabella X. ■— L ’ e m i g r a z i o n e l o m b a r d a d a l 1876 a l 1956.<br />
A n n o<br />
Emigr. europea<br />
e mediterranea<br />
Transoceanica<br />
Totale<br />
Anno<br />
Emigr. europea<br />
e mediterranea Т ransoceanica Т Otale Anno Emigr. europea<br />
e mediterranea Transoceanica<br />
Т Otale<br />
1876<br />
1877<br />
1878<br />
1879<br />
1880<br />
1881<br />
1882<br />
1883<br />
1884<br />
1885<br />
1886<br />
1887<br />
1888<br />
1889<br />
1890<br />
1891<br />
1892<br />
1893<br />
1894<br />
189s<br />
1896<br />
1897<br />
1898<br />
1899<br />
1900<br />
1901<br />
1902<br />
* Esclusa<br />
13-658<br />
15-837<br />
12.802<br />
12.200<br />
13.677<br />
15.421<br />
13.988<br />
13-645<br />
11.830<br />
8.492<br />
8-713<br />
7- 793<br />
7.114<br />
8.020<br />
7.660<br />
8.592<br />
8.938<br />
5-532<br />
4.817<br />
5.786<br />
8- 255<br />
9.904<br />
10.952<br />
12.245<br />
16.028<br />
27.836<br />
37.087<br />
remigrazione<br />
7- 43621.094<br />
3- 39719.234<br />
2.792 15-594<br />
4- 49916.699<br />
3.900 17-577<br />
5- 804 21.225<br />
8.620 22.608<br />
8- 655 22.300<br />
11.124 22.954<br />
10.152 19.644<br />
9.205 17.918<br />
14-319 22.112<br />
18.488 25.602<br />
16.824 24.844<br />
15.261 22.921<br />
20.046 28.638<br />
12.964 21.902<br />
10.238 15-770<br />
10.780 15-597<br />
14.682 20.468<br />
14.064 22.319<br />
14.802 24.706<br />
6- 75517.707<br />
7.021 19.266<br />
5-373 16.401<br />
7.668 35-504<br />
7- 41544.502<br />
europea e la temporanea.<br />
1903 28.558 8.321 36.879 1930 40.725 3-065 43-790<br />
1904 32.278 12.481 44.769 1931 25.804 1.762 26.566<br />
1905 45-845 16 .2 11 62.056 1932 I I .194 938 12.132<br />
1906 43-586 15-506 59.092 1933 9-582 999 10.581<br />
1907 45-449 20.046 65-495 1934 7-970 1.005 8-975<br />
1908 42.536 10.600 63.136 1935 6.466 904 7-370<br />
1909 37-452 12.738 50.190 1936 3-485 692 4-177<br />
1910 45-301 17.028 62.329 1937 5-513 1.034 6.547<br />
I9II 52-672 12.397 65.069 1938 — — —<br />
1912 59-059 16.377 75-436 1939 — — —<br />
1913 64.384 22.749 87-133 1940 — — —<br />
1914 47-586 12.620 60.206 1941 — — —<br />
1915 ig.084 2.765 21.849 1942 — — —<br />
1916 13-319 i.i86 14-505 1943 — — —<br />
1917 5-674 290 5-964 1944 — — —<br />
1918 3-931 226 4-157 1945 — — —<br />
1919 23-725 4-063 27.788 1946 ? ? ?<br />
1920 39.189 3-647 42.836 1947 14.687 3-894 18.583<br />
1921 17.050 4.900 21.950 1948 ? ? ?<br />
1922 31.968 5-998 37.966 1949 209* 6-475 6.684<br />
1923 33-768 6-350 40.118 1950 265* 4.842 5.107<br />
1924 36.484 4-933 41.417 1951 356* 4-433 4-789<br />
1925 26.899 3-722 30.621 1952 362* 3-294 3-656<br />
1926 21.991 4-252 26.243 1953 329* 2.296 2.625<br />
1927 21.073 6-259 21.332 1954 1.886* 2.813 4-699<br />
1928 17.464 2.651 20.115 1955 314* 2.642 2-956<br />
1929 21.222 1-835 23-057 1956 195* 2.418 2.613<br />
■ l’I ' i Av’r<br />
ІІІШ ■<br />
^‘ЛГ;Г4<br />
bÄj<br />
Tabella XI. — L a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a t t i v a l o m b a r d a p e r s e t t o r e d i a t t i v i t à e c o n o m i c a .<br />
44<br />
P r o v in c e e R e g io n e<br />
Agricoltura,<br />
caccia e pesca<br />
I n c o n d iz io n e p r o f e s s io n a l e<br />
Industrie<br />
Trasporti, commercio<br />
e servizi<br />
1 1<br />
Credito<br />
e assicurazioni<br />
Pubblica<br />
amministrazione<br />
In attesa<br />
di prima<br />
occupazione<br />
Totale<br />
Censimento 1951.<br />
JH^№î.<br />
r\ik Ä<br />
I l l r ^<br />
Bergamo • ......................... 64.117 161.748 39-043 2.048 19.824 39-185 325-965<br />
B rescia.................................. 107.990 143-532 49-445 2.118 23.619 36.316 363.020<br />
C o m o ................................. 35-448 164.332 41.665 2.397 16.458 21.348 281.648<br />
C rem ona.............................. 64.118 47-985 24.087 1.452 12.329 14.917 161.888<br />
M an to va.............................. 98.194 44.769 26.337 1.156 11.487 8.319 190.262<br />
M ilano.................................. 82.828 708.001 283.658 25.236 83-944 69.970 1.253.637<br />
Pavia ................................. 95-032 88.395 37-067 1.976 15-439 12.833 250.742<br />
Sondrio ............................. 26.366 23-386 8.584 325 6.420 4.286 69.367<br />
V a re se ................................. 13-977 168.620 32.513 2.232 14.071 14.989 246.402<br />
L o m b a r d ia ............................ 588.070 1.550.768 542.399 38.940 203.591 222.163 3.145.931<br />
(% sul totale della attiva) (25,7%) {49.3 %) (27,J% ) (2,2%) (6,5%) (7.0%) ( l O O )<br />
Censimento 961.<br />
B ergam o............................. 35.205 195.096 61.823 2.726 11.376 6.668 312.894<br />
Brescia.................................. 66.623 181.995 78.032 2.870 15-457 6-277 351-254<br />
C o m o ................................. 20.107 182.593 53-865 2.967 10.502 3.795 273-829<br />
C rem ona............................. 42.026 57.025 33-443 1.608 7.317 3.129 144.548<br />
M an to va............................. 59-881 55-536 33-001 1.387 7.878 2.953 160.636<br />
M ilano................................. 49.718 870.600 390.208 32.135 60.358 15.984 1.419.003<br />
Pavia..................................... 60.194 107.134 48.505 2.661 10.055 3.466 232.015<br />
Sondrio................................. 13-358 30.843 14-695 447 3-951 1.669 64.963<br />
V a re se .................................. 8.830 190.619 46-563 2-754 9.227 3.024 261.017<br />
Ln<br />
O<br />
L ombardia 355.942 1.871.441 760.135 49-555<br />
136.121 46.965 3.220,159<br />
(% sul totale della attiva) (55,1%) (23,6%) (1,5% ) (4.2%) (l s %) (100%)
Ln<br />
Ln<br />
О<br />
Tabella XII. — P opolazione pr esen te n e l comune di M ilano n e i cen sim en t i 1861-1951.<br />
Zone 1861 1871 1881 1901 I9I I 1921 1931 1936 1951<br />
Entro cerchia N a v ig li.....................<br />
Da cerchia Navigli a mura spagnole .<br />
196.109 199,009 214.004<br />
1 13.029<br />
132-539<br />
96.795<br />
137-933<br />
102.858<br />
152.509<br />
93.228<br />
132.225<br />
91.742<br />
129.490<br />
68.676<br />
125.227<br />
T o ta le 196.109 199.009 214.004 245.568 234.728 255-360 257-453 221.232 193-903<br />
Da mura spagnole ai limiti del Comune 46.348 62.976 107-835 245.892 364.472 463.440 766.583 892.879 1.082.618<br />
T o ta le com plessivo 242.457 261.585 321.839 491.460 599.000 798.800 992.036 I.II4.III 1.276.521<br />
Superficie del Comune in ettari ■ . . 7-189,43 |^-iÇ9.4 3 7-189,43 7-395,86 7.404,00 7.585,16 18.832,80 18.174,13 ^ .^ 6 ,0 0<br />
Media della popolazione per ettaro . 3 4 36 45 68 81 95 53 61 70<br />
Ln<br />
Ln<br />
r<br />
о<br />
Cd<br />
><br />
Ö<br />
<<br />
co<br />
О<br />
c n<br />
n n Cd<br />
0 A3 S S »-{ Q<br />
0 -<br />
2<br />
0 *<br />
r-t ПЗ<br />
< ^ T A3 i-t 0 >-{<br />
A3 P<br />
P J*<br />
P CO CfQ<br />
P r■^ 3 0<br />
0 P<br />
0<br />
0 0 A3*<br />
< p 3<br />
A3 A3 0<br />
00 H M N3 hH<br />
sO U3 N3 Ut 00<br />
Ъ C^ ¿3 Ln hH Ln<br />
00 00 00 1-1 0 vO 1—(<br />
M 0 0 фн ф. LO vO 00<br />
и<br />
73<br />
О<br />
<<br />
Z<br />
n<br />
00 to CO CO to CO hH HHW<br />
0 CO 4 - hH 0 •vj 0 4 ^ 4 h<br />
00 CO to Ln 00 0 vp NO<br />
vb cb bo cb cn Ò nO cb Ln cb<br />
Ln 0 0 CO 00 O' hH hH ON<br />
LO<br />
—1 NO 00 CO<br />
to CO 00 LO NO 4 ^ Ln 4 - •-H to 0 c<br />
ó cb io •b ON ON Ln b io cb ►0 -•<br />
4^ ON 0 0 to Ln Ln CO 00 hH<br />
to to nO CO to Ln On 4 h 4 ^<br />
w<br />
ON ф. to 00 00 CO 00 nO ON to 0 43<br />
bo b to NÛ hH to nO b b NO *0 W-.<br />
LO <br />
p ►n<br />
0<br />
0<br />
CO<br />
s<br />
0 N C<br />
0" 0 z<br />
<<br />
p<br />
3<br />
p<br />
*<br />
to to to to to to CO CO 4 4 CO Ln<br />
Ü ON Ln CO ON 4 Ln ON nO CO nO to<br />
-b bo hH Ln b to b bo On hH b hH b b 0<br />
4 - to NO ON 4 NO 4 0 hH NO hH hH to CO hH<br />
to hH 0 nO hH CJN Ln hH hH 4 'O O' CO<br />
to to CO to CO to CO 4 Ln Ln 4 (O' 00<br />
CO 0 CO hH nO nO CO Ln to 'O CO<br />
ON<br />
NO<br />
b b b 4 cb cb nO N3 4 io Nb bo to<br />
CO Ln to 4 Ln Ln hH to to 00 0 00 hH hH<br />
00 0 On to 00 On to to Ln CO 4 CO 0<br />
to to CO CO hH CO CO 4 4 Ln Ln Ln 0<br />
Cn hH 0 CO to 4 4 00 CO 4 hH CO<br />
-b b b b b Ln to bo 4 b O' ON ON Ñ)<br />
00 NO 4^ to to 4 00 nO ON Ln ON )—( CO 1<br />
0 0 4 ^ nO CO to CO nO 0 O' O'<br />
CO to CO CO to CO CO 4 Ln ON O' O' hH<br />
и nO CO to 0 nO CXD ■
(iî<br />
T ab e lla X V . — R i p a r t i z i o n e d e l t e r r it o r io d e l l e p r o v in c e e d e l l a r e g i o n e s e c o n d o l ’ u t i l i z z a z i o n e (e t t a r i).<br />
S и p E R F I C I E<br />
A G R A R I A<br />
i<br />
P rovince e R egioni<br />
Coltivazioni erbacee<br />
Avvicendate<br />
(escluse foraggere)<br />
Foraggere<br />
Coltivazioni<br />
legnose<br />
T Otale<br />
Boschi<br />
(compresi<br />
i castagneti)<br />
Incolti<br />
produttivi<br />
Superficie<br />
agraria<br />
forestale<br />
Altre<br />
utilizzazioni<br />
Superficie<br />
totale<br />
19 5 6<br />
Bergam o.............................. 53-246 103.669 7.310 164.225 69.145 8.756 242.126 33-766 275.892<br />
Brescia.................................. 104.962 142.299 12.843 260.104 122.086 18.256 400.446 74.470 474.916<br />
C o m o ......................... .... . 32.449 54.007 440 86.896 71-343 9.785 168.024 38.660 206.684<br />
Crem ona............................. 78.911 73-755 1-381 154.047 6.134 — 160.181 15.428 175.609<br />
M antova.............................. 112.852 88.375 8.165 209.392 3-833 1-837 215.062 18.879 233-941<br />
Milano • ............................. 117.528 1 16.265 923 234.716 7.176 575 242.467 33-348 275.815<br />
P a v i a .................................. 147-917 75-305 16.168 239.390 31-759 7.617 278.766 17.704 296.470<br />
S o n d r io ............................. 4-779 1 12.766 4.283 121.828 89.065 21-585 232.478 88.742 321.220<br />
V arese.................................. 23.568 22.080 1.442 47.090 47-798 2.216 97.104 22.767 119.871<br />
L ombardia 676.212 788.521 52-955 1.517.688 4 4 8 -3 3 9 70.627 2 .0 3 6 . 6 5 4 343-764<br />
2 . 3 8 0 . 4 1 8<br />
19 6 6<br />
Bergamo............................. 4 6 .2 4 9 1 0 8 .8 7 9 5 .6 0 2 160.730 70.492 3.610 2 3 4 . 8 3 2 4 1 . 0 6 0 2 7 5 .8 9 2<br />
B r e s c ia ............................. 9 1 . 9 2 9 4 3-2 34 10 .8 5 8 246.021 123.680 24.179 3 9 3 .8 8 0 8 1 . 0 3 6 2 7 4 . 9 1 6<br />
C o m o ................................. 3 0 . 2 8 3 18 . 4 9 5<br />
4 17 49-195 70.234 7-893 1 6 3 . 0 1 9 43-665 2 0 6 .6 8 4<br />
Cremona............................. 6 3-147 9 0 .5 0 1 1. 4 8 6 15 5 -ІЗ 4 8.134 — 1 6 3 . 2 6 8 13-7 9 1<br />
1 7 7 . 0 5 9<br />
M antova............................. 8 8 .9 5 6 1 0 3 . 1 5 1 9-744 201.851 10.853 7 5 0 213.454 2 0 .4 2 7 2 3 3 . 8 8 1<br />
M ila n o ............................. 1 10 .2 6 5 96.341 669 207.275 13 - 2 6 5 2.800 2 2 3 . 3 4 0 5 2 .8 8 3 2 7 6 . 2 2 3<br />
P a v i a ................................. 1 2 0 . 4 1 8 5 9 - 5 1 6 1 6 .9 8 2 196.916 65.422 7.617 269.955 2 6 . 5 1 5 2 9 6 .4 7 0<br />
S o n d rio ............................. 4 . 3 0 0 I I I . 7 6 6 4 .4 7 6 120.542 89.486 18.490 2 2 8 . 5 1 8 9 2 . 6 7 2 321.190<br />
Varese ............................. 2 1 . 8 7 7 18 .4 9 5 1-493 41.865 46-325 5.868 9 4 .0 5 8 25-8 13<br />
1 1 9 . 8 7 1<br />
L ombardia 577-424 786.175 51-727 I.415.326 497.891 71.207 1 . 9 8 4 . 3 2 4 3 9 7 . 8 6 2 2 . 3 8 2 . 1 8 6<br />
(I.S.T.A.T.)<br />
Tabella XVI. — E s t e n s i o n e e p r o d u z i o n e d e l l e p r i n c i p a l i c o l t u r e e r b a c e e e l e g n o s e .<br />
C o l t u r e e r b a c e e ha. q- q. per ha. C o ltu r e l e g n o s e ha. q- q. per ha.<br />
Il<br />
19 5 6<br />
F ru m en to .......................................... 200.768 9.994.600 3 3 .2 Vite (c. specializzata)..................... 43-367 3.012.300 69.5<br />
G ra n o tu rc o ...................................... 213-393 9.784.500 4 5 .9 Vite (c. promiscua)......................... 1 13.102 1.426.700 —<br />
R iso ...................................................... 49.184 2.360.000 48,0 Olivo (c. specializzata)................. 2.807 23.100 8,3<br />
Segale.................................................. 10.328 178.600 17.3 Olivo (c. prom iscu a)..................... 3-851 3.840 —<br />
Avena .................................................. 9-726 211.300 21,7 Limone (c. specializzata)................ 5 300 60,0<br />
O r z o .................................................. 465 9.900 21.3 Albicocco (c. promiscua) . . . . 9.638 2.250 —<br />
Patata.................................................. 15.669 2.653.500 169.3 Pesco (c. specializzata)................. 1.075 46.400 43,2<br />
Barbabietola da zucchero . . . . 11.413 3.733.000 327.1 Pesco (c. prom iscu a)..................... 24.121 25.150 —<br />
Tabacco.............................................. 1.016 24.698 24.3 Melo (c. specializzata).................... 1-531 244.400 159.6<br />
Foraggi (fieno norm ale)................. 788.521 67.506.300 85.6 Melo (c. p ro m iscu a)..................... 27.699 235.900 —<br />
Pom odoro.......................................... 625 238.900 382,3 Pero (c. specializzata)..................... 522 52.200 100,0<br />
L i n o .................................................. 610 (tiglio) 3.050 5 .0 Pero (c. promiscua)......................... 32.210 121.800<br />
19 6 6<br />
La<br />
La<br />
U)<br />
F ru m en to .......................................... 268.381 10.476.100 3 9 .0 Vite (c. specializzata)..................... 40.516 2.811.900 70,0<br />
Granoturco......................................... 159.825 8.517.600 5 3 .4 Vite (c. promiscua)......................... 69.952 993.800 —<br />
R iso ...................................................... 41.877 1.915.100 4 5 .7 Olivo (c. specializzata)................. 1-983 15.800 8,1<br />
Segale.................................................. 6.163 154.000 25.0 Olivo (c. prom iscu a)..................... 3.669 23.400<br />
A ven a.................................................. 9-517 246.300 2 5 .9 L im o n e .............................................. — — —<br />
O r z o .................................................. 450 12.600 28,0 Albicocco (c. promiscua) . . . . 2 5 9 6.900 —<br />
Patata.................................................. 14.625 2.419.000 165.4 Pesco (c. specializzata)................. 1-347 156.100 118,7<br />
Barbabietola da zucchero . . . . 13.421 6.154.000 458.5 Pesco (c. prom iscua)..................... 1.586 13.600 —<br />
T abacco.............................................. 462 10.555 22,9 Melo (c. specializzata)..................... 2.648 608.900 247.9<br />
Foraggi (fieno n o rm ale)................. 786.175 79.480.200 101,0 Melo (c. p ro m iscu a)..................... 7-552 69.700 —<br />
Pom odoro.......................................... — — — Pero (c. specializzata)..................... 1.207 174.200 179.5<br />
L i n o .................................................. — — — Pero (c. promiscua)......................... 6-7 3 7 54.100 —
Гь»?' '"■Жа'<br />
ѵ-ГІ<br />
Ul Tabella XVII. — N u m e r o d e l l e i m p r e s e i n d u s t r i a l i s e c o n d o i l n u m e r o d e g l i a d d e t t i (Censimento 1961).<br />
P r o v in c e e R e g io n e<br />
con<br />
I addetto<br />
con<br />
2 addetti<br />
da 3 a<br />
5 addetti<br />
N umero d e l l e IMPRESE<br />
da 6 a<br />
IO addetti<br />
da II a<br />
50 addetti<br />
da 5 1 a<br />
10 0 addetti<br />
da l o i a<br />
500 addetti<br />
da 5 0 1 a<br />
10 0 0 addetti<br />
O ltre<br />
1000 addetti<br />
T Otale<br />
im prese<br />
B e r g a m o ...................................... 10.419 8-394 4-933 1.602 1-338 201 II6 IO 8 27.021<br />
B re s c ia .......................................... 16.679 11.032 6.509 2 .O H I-S75 212 152 9 6 38.185<br />
C om o.............................................. 10.702 8.444 5-645 1.823 1.720 312 195 16 4 28.861<br />
C re m o n a ...................................... 6.676 4-857 2.885 670 502 62 39 6 — 15-697<br />
M a n to v a ...................................... 7.970 5-557 3-507 934 640 76 30 2 — 18.716<br />
M ila n o .......................................... 46.998 38.801 29-905 10.009 9.762 1.666 1.436 17 1 166 138.914<br />
P a v ia .............................................. 10.783 8.198 4-213 I.2 II I.II9 149 90 5 I 25.769<br />
Sondrio.......................................... 2.292 1.860 1.089 306 257 27 13 I — 5-845<br />
V a r e s e .......................................... 9-591 7.070 4.821 1-738 1.786 292 209 21 5 25-533<br />
L ombardia 1 2 2 .1 IO 94-213 63-507 20.304 18.699 2.997 2.280 241 190 324-541<br />
Tabella XVIII. — A d d e t t i a l l e i m p r e s e i n d u s t r i a l i (d i s t i n t e p e r n u m e r o d i a d d e t t i ) (Censimento 1 9 6 1 ) .<br />
P r o v in c e e R e g io n e<br />
con<br />
I addetto<br />
con<br />
2 addetti<br />
da 3 a<br />
5 ad detti<br />
N umero di ADDETTI IN IMPRESE<br />
da 6 a<br />
IO addetti<br />
da 1 1 a<br />
50 addetti<br />
da 5 1 a<br />
10 0 addetti<br />
d a l o i a<br />
500 addetti<br />
d a 5 0 1 a<br />
10 0 0 addetti<br />
O ltre<br />
1000 addetti<br />
T o tale<br />
addetti<br />
B e r g a m o ...................................... 10.419 16.788 17.829 II.9 71 28.268 14.027 24.918 6.585 15-510 146.315<br />
B r e s c ia .......................................... 16.679 22.064 23.428 14.912 33-432 14.958 29.904 6.241 9-893 17 1.5 11<br />
C om o.............................................. 10.702 16.888 20.402 13-545 37.826 21.304 37-570 10.732 6.725 175.694<br />
C re m o n a ...................................... 6.676 9.714 10.242 4-929 10.475 4.189 7.710 3-465 — 57-400<br />
M a n to v a ...................................... 7.970 H .II4 12.576 6.858 12.452 S-283 S-I93 1-497 — 62.943<br />
M ila n o .......................................... 46.998 77.602 108.693 74.427 214.366 117-З63 300.378 119.362 561-716 1.620.905<br />
P a v ia .............................................. 10.783 16.396 15-103 8-967 23.824 10.489 17.086 3-431 5-501 111.5 8 0<br />
Sondrio.......................................... 2.292 3-720 3.841 2.286 5.161 1.848 1.867 527 — 21.542<br />
V a r e s e .......................................... 9-591 14.140 17.562 12.885 39-983 20.733 42.092 14-853 9.207 181.046<br />
L ombardia 1 2 2 . H O 188.426 229.676 150.780 405-787 210.194 466.718 166.693 608.552 2.548.936<br />
Tabella XIX. — U n i t à l o c a l i p e r r a m o d i a t t i v i t à e c o n o m i c a (Censimento 1961).<br />
P r o v in c e e R e g io n e<br />
Agricoltura,<br />
foreste,<br />
caccia<br />
e pesca<br />
Industrie<br />
estrattive<br />
Industrie<br />
manifatturiere<br />
Costruzioni<br />
e<br />
installazioni<br />
impianti<br />
Elettricità,<br />
gas<br />
e acqua<br />
Commercio<br />
T rasporti<br />
e comunicazioni<br />
Credito<br />
e<br />
assicurazioni<br />
Servizi<br />
Totale<br />
i l i<br />
B e r g a m o ...................................... 245 172 8.054 1-565 198 15-550 1.276 444 1.679 29.183<br />
B re s c ia .......................................... 395 221 10.938 1-539 3 11 22.535 1-675 569 2.228 40.411<br />
C om o.............................................. 188 80 II.3 8 1 1.460 204 14.564 1.227 351 1.502 30-957<br />
C re m o n a ...................................... 273 34 4-975 565 72 8.856 655 322 I .I 22 16.874<br />
M a n to v a ...................................... 779 38 6.524 639 53 9-297 969 295 1.292 19.886<br />
M ila n o .......................................... 255 146 52.230 5-383 348 74-974 4-13S 1.766 10.127 149.364<br />
P a v ia .............................................. 441 33 8.135 1.056 161 14.026 1.241 482 1.699 27-274<br />
Sondrio.......................................... 154 166 1.519 391 112 3.226 480 89 272 6.409<br />
V a r e s e .......................................... 321 52 9.483 1.502 132 13-155 950 353 1.535 27-483<br />
L ombardia 3-051 942 113.239 14.100 1-591 176.183 12.608 4.671 21.456 347.841<br />
Tabella XX — A d d e t t i a l l e u n i t à l o c a l i p e r r a m o d i a t t i v i t à e c o n o m i c a (Censimento 1 9 6 1 ) .<br />
P rovince e R egione<br />
Agricoltura,<br />
foreste,<br />
caccia<br />
e pesca<br />
Industrie<br />
estrattive<br />
Industrie<br />
manifatturiere<br />
Costruzioni<br />
e<br />
installazioni<br />
impianti<br />
Elettricità,<br />
gas<br />
e acqua<br />
Commercio<br />
Trasporti<br />
e comunicazioni<br />
Credito<br />
e<br />
assicurazioni<br />
Servizi<br />
Totale<br />
La La<br />
La<br />
B e r g a m o ...................................... 8 5 4 2 .2 2 7 1 2 0 . 2 0 3 16 . 5 7 9 1.9 4 9 3 4 -2 6 6 6 .0 2 5 2-552 3 - 3 0 1 1 8 7 . 9 6 1<br />
B re s c ia .......................................... 1 - 1 5 7 2 .7 2 2 I I 2 . 6 2 1 2 0 . 3 2 0 2 .9 6 1 4 5 .6 4 2 7 . 8 2 1 2 .7 9 9 4 . 4 1 6 2 0 0 .4 5 9<br />
C om o.............................................. 50 9 5 1 0 1 3 8 . 0 7 7 17 - 4 9 7 1 . 4 1 9 3 2 . 2 7 5 7 -4 7 0 2 .5 0 5 2 .9 5 0 2 0 3 . 2 1 2<br />
C re m o n a ...................................... 2 . 2 3 7 1 4 3 3 2 . 1 5 5 7 -0 4 3 9 7 3 1 8 . 8 2 2 3-4 9 5 1. 4 6 8 2 . 1 3 7 6 8 .4 7 3<br />
M a n t o v a ...................................... 3 -5 0 7 2 5 7 3 3 - 4 8 7 9 -5 9 2 50 8 19 . 0 2 7 3 .8 4 0 1 . 2 3 4 2 .3 7 9 7 3 - 8 3 1<br />
M ila n o .......................................... 1 . 1 1 7 2 .6 2 0 7 6 5 . 1 0 7 7 8 .5 8 4 1 3 . 6 0 0 2 3 2 . 9 5 7 5 9 . 4 7 0 35-025 3 0 . 1 1 9 1 . 2 1 8 . 5 9 9<br />
P a v ia .............................................. 1 . 6 3 2 3 4 0 7 5 - 8 0 4 1 1 . 4 4 9 1- 2 5 3 2 9 .0 0 3 6 .7 5 7 2 . 1 8 2 3 - 3 6 7 1 3 1 . 7 8 7<br />
Sondrio.......................................... 4 3 8 1. 0 6 0 9 . 7 1 2 7 .8 4 7 1.6 8 3 6 .6 8 8 1 . 7 0 0 397 533 3 0 .0 5 8<br />
V a r e s e .......................................... 6 29 3 7 4 15 8 . 0 2 8 1 8 . 6 3 0 1 . 6 3 8 2 9 . 1 3 9 6 .2 5 7 2 . 3 2 0 3 . 2 1 7 2 2 0 . 2 3 2<br />
L ombardia 1 2 . 0 8 0 1 0 . 2 5 3 1 . 4 4 5 . 1 9 9 1 8 7 . 5 4 1 2 5 .9 8 4 4 4 7 . 8 1 9 1 0 2 . 8 3 5 5 0 .4 8 2 5 2 . 4 1 9 2 . 3 3 4 . 6 1 2<br />
l l l l
ч'<br />
Ç..<br />
-'Ife<br />
Ж<br />
Щ<br />
liSîi<br />
■vWíg<br />
S^si¿ütu.v: i
N O T A B IB L IO G R A FIC A<br />
Gli scritti riguardanti la regione lombarda sotto i vari aspetti sono innumerevoli; se ne indicano<br />
qui soltando pochi, scegliendo particolarmente quelli di maggiore risonanza о di più ampio respiro<br />
о di più recente data.<br />
Opere generali. — Le descrizioni d’assieme о corografie sono poche e di vecchia data. Dopo<br />
le opere di C. C attan eo, N o tizie naturali e civili su la Lom bardia (Milano, Bernardoni, 1844)<br />
e di C. C antù e L. G u a lt ieri B r en n a, G rande illustrazione del Lom bardo-V eneto (Ronchi, Milano,<br />
1857-61) che rispecchiano la situazione della <strong>Lombardia</strong> austriaca, è utile ricordare la breve sintesi<br />
di G . M a r in e l l i, contenuta nella grande opera L a T erra (voi. IV, parte 2^, Vallardi, Milano, 1893-<br />
1901), e i volumi dedicati da G . Straffo rello alle città e province lombarde (nella collezione L a<br />
P a tria , U. T. E. T., Torino, 1894-99) ricchi di interessanti notizie e curiosità. Di epoca più recente<br />
è il volume di G . G razian i e S. G rand e, L a Lom bardia col Canton Ticino (U. T. E. T., Torino,<br />
1927), parte della successiva collezione L a P a tria . Una brillante sintesi geografica sulla regione<br />
è quella di G. G aragi alla voce Lom bardia contenuta nella Enciclopedia Treccani; ugualmente interessanti<br />
sono i capitoletti introduttivi contenuti nelle guide turistiche Lom bardia e M ilan o e L agh i<br />
(T. C. I., Milano, 1954).<br />
Il nome e il territorio. — Riguardo alla designazione relativa al nome, frequenti cenni frammentari<br />
si trovano in svariate pubblicazioni; qualche interesse presentano gli articoli di E. D e T o n i,<br />
L a parola Lom bardia (Riv. Geografica Italiana, 1903), di G. L. B e r t o lin i, S u lla perm anenza del<br />
significato estensivo del nome di Lom bardia (Boll. Soc. Geogr. Ita!., Roma, 1903) e di L. N e g r i, Il<br />
nome Lom bardia nel M edio E v o (Archivio Storico Lombardo, 1929). Relativamente ai confini politici<br />
risulta sempre utile l’opera di V. A dam i, Sto ria documentata dei confini del Regno d ’Ita lia (Libreria<br />
dello Stato, Roma, 1920), una cui parte riguarda la <strong>Lombardia</strong>; su Campione d’Italia vi è un<br />
articolo di L. P ed r esc h i, L ’« exclave » italiano in terra svizz era di Cam pione d 'Ita lia (Riv. Geogr.<br />
Ita!., LXIV, Firenze, 1957); su recenti variazioni del confine, l’articolo di A. N o rcen, S u alcune<br />
rettifiche del confine italo-svizzero (Boll. Soc. Geogr. Ital., Roma, 1958), e le annotazioni di A. M arc<br />
h esi, D efinizione del confine italo-svizzero... (L’Universo, i960 e 1961).<br />
Le vicende storiche. — Riguardo alle ricerche storiche vi è una bibliografia vastissima; hanno<br />
particolare interesse anche geografico alcuni scritti contenuti in <strong>Lombardia</strong> romana (Istituto di Studi<br />
557
R om ani, M ilan o, 1938) e le opere già citate del C attaneo e del C antò. Fondam entale è la grande<br />
pubblicazione della Sto ria di M ilan o (Fondazione T reccan i, M ilan o, 1953 e sg.).<br />
I l r ilie v o : m o n ta g n e e p ia n u r e . — Innumerevoli ricerche sono state condotte sulla geologia<br />
della regione; un indice ottimo è quello di A. D esio, B ibliografia geologica lom barda (Comune di<br />
Lecco, 1943), aggiornata successivamente dallo stesso A. e pubblicata dal Consiglio Nazionale<br />
delle Ricerche (Roma, 1957). D ’interesse geologico e morfologico, di sintesi ancora suggestiva è lo<br />
scritto di T. T a r a m elli, Il paesaggio lombardo e la geologia (Pavia, 1909). Per la zona alpina lombarda<br />
sono utili le opere di G. N a n g ero n i, L a struttura geologica del territorio della P rovin cia di<br />
Sondrio (Amm. Prov. di Sondrio, 1958), M orfologia del Gruppo del S ella e della regione del B a rb e l<br />
lino (Vita e Pensiero, Milano, 1938), che prospetta interessanti problemi di un angolo delle Orobie.<br />
Interesse morfologico hanno gli scritti di A. Saragat, L a geografia fisica della V altellina (Boll. Soc.<br />
Geografica Italiana, 1914), di G. R overeto, L a V alle San Giacomo (Studi di geomorfologia, Genova,<br />
1908), di L. R ic c i, O sservazioni geografiche sulla catena orobica (L’Universo, 1922) di G. N a n<br />
g ero n i, sui monti della vai Malenco (Boll. Soc. Geografica Italiana, 1931), sulla regione del Màsino<br />
(Riv. del C. A. I., Milano, 1928), sulla valle del Bràulio (Natura, 1932), sulla valle di Livigno<br />
(Natura, 1942 e 1954).<br />
Per le Prealpi tra i numerosi scritti si segnalano quelli di C. Sa ib e n e, Il gruppo delle G rigne (Atti<br />
Soc. Ital. Se. Nat., Milano, 1955) che sintetizza le numerose ricerche geomorfologiche della suggestiva<br />
montagna, di R . P racch i, Contributo alla conoscenza del fenom eno carsico in Lom bardia (Vita<br />
e Pensiero, Milano, 1943) primo tentativo di sintesi sull’argomento, cui hanno fatto seguito gli<br />
studi di A. L igasacchi e G. R òndina, Il fenomeno carsico nel territorio varesino (1st. di Geogr.,<br />
Università di Bologna, 1955) e una bibliografia di M. e M. P avan, Speleologia lom barda (Soc. Spel.<br />
Ital., Pavia, 1955). Sull’origine dei laghi prealpini notevole interesse presenta il breve scritto di<br />
G. N an gero n i, A ppunti suU’ origine di alcuni laghi prealpini lombardi (Atti Soc. Ital. Se. Nat., M i<br />
lano, 1956); il problema riaffiora nelle ricerche di G. N an gero n i, R . P racch i, O. V ecch ia, A. R iva,<br />
Studi sul glaciale quaternario della Lom bardia (Atti Soc. Ital. Se. Nat., Milano, 1954)1 opera fondamentale<br />
per ampiezza e profondità di indagine che si estende ai depositi morenici della montagna<br />
e della collina delle regioni del Verbano, del Lario e del Sebino. In aggiunta a questi vanno<br />
ricordati i lavori di A. R iva, G li anfiteatri morenici a sud del L a rio e le pianure allu vionali tra A d d a<br />
e O lona (Atti 1st. Geo!., Università di Pavia, 1957), di F . M auro e G. N a n g ero n i, I « trovanti »<br />
nella regione dei tre laghi (C. A. I., Milano, 1949) e di G. N an gero n i, C a rta geognostica e geologica<br />
della provincia di Varese (Istituto Tecnico Daverio, Varese, 1932) che oltre agli aspetti del Quaternario<br />
esamina problemi geomorfologici della complessa regione varesina. Per la pianura rimane<br />
come particolarmente utile il lavoro di A. D esio, C aratteri fisici e geologici della provincia di M i<br />
lano (Ann. Sperim. Agraria, Roma, 1938).<br />
L e a c q u e . — Sul glacialism o attuale della m ontagna lom barda, oltre alla indagine valtellinese<br />
di G . N angero ni (Boll. C om it. G lacio l. I t a l, T o rin o , 1928, 1929, 1932, 1933) a quella di S. Pi-<br />
GNANELLI Sulla valle San G iacom o (Boll. C om it. G laciol. Ital., 1932, i 95S) o э, quella della zona<br />
del C evedale di A . D esio (A tti Soc. Ital. Se. N at., 1927-28), risultano di notevole interesse lo<br />
scritto di G . N a n g er o n i, A ppunti per una revisione del catalogo dei ghiacciai lom bardi (A tti Soc.<br />
Ital. Se. N at., M ilano, 1954) e, dello stesso A ., il Catasto dei ghiacciai italiani (C. N . R ., C om it.<br />
G laciol. Ital., T o rin o , 1959).<br />
Riguardo all’idrografia, oltre alle opere generali per l’Italia, utili per le indicazioni statistiche,<br />
si segnalano le vecchie ricerche di E. L om bardini, come i C enni idrografici sulla Lom bardia (Bernardoni,<br />
Milano, 1844) e D ell’ origine e del progresso della scienza idrau lica in Lom bardia (Memoria<br />
1st. Lomb. Se. e Lett., Milano, i860), in cui si esaminano anche le opere di canalizzazione e di irrigazione.<br />
Su questo argomento la bibliografia è assai vasta e utile risulta l’opera di G. C odara,<br />
558
I N a v ig li di M ila n o : passato, presente e fu tu ro (Fam iglia M enegh ina, M ilan o, 1927). R ig u ard o ai fo n <br />
tanili, tra la vastissim a bibliografia si segnalano, per la loro im postazione geografica, oltre al già citato<br />
studio di A . D esio sulla provincia di M ilan o, gli articoli di M . M oro, L a zona dei fo n tan ili in L o m <br />
bardia e le m arcite (L a G eografia, 1924), e di A . R . T oniolo, L a zona delle resorgive nella P ianura<br />
P a d a n a ( « L e vie d ’Italia», T . C . I., M ilano, 1933). R ig u ard o ai laghi u n ’am pia raccolta di dati<br />
m orfom etrici, di osservazioni fisiche e di indicazioni bibliografiche si trova in R . R icca rd i, I laghi<br />
d ’Ita lia (Boll. Soc. G eografica Italiana, 1925).<br />
Il clima e la vegetazione. — Per il clima, oltre alle opere generali per l’Italia, del-<br />
I’E r ed ia, conservano il loro valore la ricerca di G. A n fo ssi, L e piogge nella regione lombarda<br />
(« Memorie Geogr. », di G. D a in e l l i, n. 25, Firenze, 1914) e le osservazioni di G. V. S ch iap<br />
a r e l l i; numerose le indagini più recenti quali quelle del G abba sulle nebbie a Milano (Boll.<br />
Meteorol. Ital., 1924), dell’OMODEO sul clima dei laghi («Meteor, pratica», 1940), del G h erar-<br />
DELLi, sulle piogge («L ’acqua», 1943); fondamentale l’opera del M agistrato d e l le A cque, P re <br />
cipitazioni medie m ensili..., 1921-50 (Roma, 1959). Per Milano preziosi dati e notevoli osservazioni<br />
si trovano in L. Santomauro, Lineam enti clim atici di M ilan o (Quaderni della « Città di<br />
Milano », 1957).<br />
Rispetto al mantello vegetale, dal vecchio lavoro di V. C e sa t i, Saggio sulla geografia botanica<br />
della Lom bardia (Milano, 1844) al recente studio su L e brughiere lombarde (Ass. For. Lomb., Milano,<br />
1958) gli scritti si annoverano a cento a cento e i principali son segnalati nel bel volume L a flo ra<br />
(T. C. I., Milano, 1958); notevole in particolare è lo studio del bosco, contenuto in un numero speciale<br />
della rivista « L ’Alpe» (1938) e interessante l’esposizione di L. M oser, C aratteri e problem i della<br />
montagna lom barda (« Atti Conv. di Studi su problemi di agricoltura lombarda », 1st. Lomb. di<br />
Se. e Lett., Milano, 1954).<br />
La popolazione e l’insediamento umano. — L ’insediam ento um ano è problem a che ha richiam<br />
ato l’attenzione di m olti studiosi. Sulla popolazione dei tem pi passati prezioso contributo ha<br />
portato K . J. B eloch, L a popolazione d ’ Ita lia nei secoli X V I , X V I I e X V I I I (Bull, de l’Inst. internat,<br />
de Statistique, 1888). G ran d e interesse presenta l ’indagine di C . C attaneo, S u lla densità di popolazione<br />
in L om bardia... (« Il Politecnico », M ilan o, 1839). N otevoli sono poi le ricerche di M . R omani,<br />
U n secolo di vita economica lom barda, 1748-1848 (V ita e Pensiero, M ilan o, 1950) e II movimento demografico<br />
in L om bardia dal 1750 al 1850 («Eco n o m ia e Sto ria», 1955). Sulla distribuzione della p opolazione<br />
in generale hanno trattato T . B ertossi e A . C h iesa, L a densità della popolazione in L o m <br />
bardia ( « L ’U n iverso » , F iren ze, 1951); interessanti indagini particolari di A . P iras sulle valli Se-<br />
riana e Brem bana, di C . V erga sulla provincia di Sondrio, di A . P astormerlo sulla provin cia di<br />
P avia sono contenute in Contributi agli studi di G eografia (V ita e Pensiero, M ilan o , 1939); altri<br />
particolari sono q u elli; di A . R . T oniolo, Ricerche di antropogeografia nell’alta Valcam ònica (in<br />
« M em o rie G e o g r.» , di G . D a in e l l i, n. 23, Firenze, 1913); di G . N a n g ero n i, / centri abitati<br />
della p rovincia di Varese (V ita e Pensiero, M ilan o, 1935), C enni della distribuzione della popolazione<br />
nella regione benacense (Boll. Soc. G eogr. Ital., R om a, 1936) e N ote geografiche sulla v a i Taleggio<br />
(M ilan o, 1939); di R . P racch i, L a distribuzione della popolazione nel triangolo lariano (R iv . G eogr. Ital.,<br />
F iren ze, 1941), L a V a lfu r v a : note antropogeografiche (R iv. G eogr. Ital., F iren ze, 1953), L a B ria n z a<br />
(S. A . G . S. A ., C om o, 1954); di A . P ecora, L a p rovincia di P a v ia (M em . di G eogr. antr., R om a, 1954);<br />
di C . D ella V a l l e, L a Valassina (Boll. Soc. G eogr. Ital., R om a, 1952); di P. L a n d in i, L a Lom ellina<br />
(Signorelli, R om a, 1950); di C . Sa ib e n e, Problem i e ricerche sull’insediamento umano nelle aree lacustri<br />
prealpine in Ita lia (« Studi geografici in onore di R . B iasu tti », Firenze, 1958) e II versante oròbico<br />
valtellinese. Ricerche antropogeografiche (C . N . R ., R om a, 1959); di G . D e S im o n i, L a valle dello<br />
Splu ga (U nione T ip . M ilan o, 1935); di M . R iccardi, O sservazioni di geografia antropica sulla<br />
V a l S an Giacom o (Boll. Soc. G eogr. Ital., R om a, i960); ecc.<br />
559
Sullo spopolamento della montagna vi è la poderosa indagine promossa dall’Istituto nazionale<br />
di economia agraria (voi. II, Roma, 1934); qualche interesse presenta l’articolo di R. F racch i, L o<br />
spopolamento montano è in regresso? (Boll. Soc. Geogr. Ital., Roma, 1953), sondaggio eseguito per<br />
la montagna lombarda sui dati censuari del 1951.<br />
Lo studio delle dimore rurali per il territorio lombardo, dopo lo scritto di G. G aragi, Le « corti »<br />
lombarde e l’origine della « corte » (Mem. Società Geogr. Ital., Roma, 1932), è stato affrontato da<br />
G. N angeroni e R. F racch i, La casa rurale nella montagna lombarda (2 voli., C. N. R., Firenze,<br />
1958), da C. Sa ib e n e, La casa rurale nella pianura e nella collina lombarda (C. N. R., Firenze, 1955)<br />
e, per l’Oltrepò pavese, da E. B o ria n i, in La casa rurale nell’Appennino emiliano e nell’Oltrepò pavese<br />
(C. N. R., Firenze, 1953).<br />
Tradizioni e dialetti. — Sulle tradizioni e i costumi del passato vi sono scritti locali come<br />
quelli di A. G iacosa, Tradizioni e costumi del Lario (Como, 1938), di G . R osa, Dialetti, costumi e<br />
tradizioni nelle province di Bergamo e di Brescia (Brescia, 1872).<br />
Fer i dialetti giova tener presente lo scritto di G. I. A sco li, L ’Italia dialettale (Arch. Glott.<br />
Ital., V ili, 1882) e l’atlante di K. J aberg e J. J ud, Sprach- und Sachadas Italiens und der Südschweiz<br />
(Zofingen, 1928-40). Recente e interessante la ricerca di A. M a r in o n i, I dialetti da Saranno al Ticino,<br />
(in « Fanorama storico dell’alto Milanese », Rotary C. Busto-Legnano, 1957).<br />
Toponomastica. — Fer la toponomastica si dispone di un’opera generale di grande interesse,<br />
quella di D. O l iv ie r i, Dizionario di toponomastica lombarda (« La Famiglia Meneghina », Milano,<br />
1931) ripubblicato in seconda edizione riveduta e ampliata nel 1961 (Ed. Geschina, Milano). Tra<br />
i vari studi si segnalano quelli di N. B ottazzi, Liguri, Celti, Germani nei nomi di luogo in <strong>Lombardia</strong><br />
(Brescia, Ed. Vanini, 1961), di G. D e S im o n i, Alcuni nomi di luogo nell’alta Val Grosina<br />
(Sondrio, i960) e Toponimia dell’alta Valle Spinga con riscontri valtellinesi e chiavennaschi (Camera<br />
di Commercio, Sondrio, s. d.).<br />
L ’agricoltura, l’ industria e il commercio. — Nel campo economico, sia riguardo agli sviluppi<br />
nel tempo, come riguardo alle situazioni recenti, sono ottimi compendi i volumi; La Cassa<br />
di Risparmio delle Province Lombarde nella evoluzione economica della regione 1823-1923 (Milano,<br />
1923), con scritti di R. C iasca, S. F u g l ie s e, G. L uzzatto e altri, e L ’economia della regione lombarda<br />
(Cassa di Risparmio delle Frovince Lombarde, Milano, 1954), con scritti di A. Sa po ri, C. B onato,<br />
A. F a g a n i, F . a . J elm oni e altri. Utile pure la sintesi di F. M ilo n e nell’opera L ’Italia nell’economia<br />
delle sue regioni (Einaudi, Torino, 1955).<br />
Interesse storico hanno le opere: C. A. V ia n e ll o , Relazioni sull’industria, il commercio e l’agricoltura<br />
lombardi del ’700 (Giuffrè, Milano, 1941); S. F u g l ie se, Le condizioni economiche e finanziarie<br />
della <strong>Lombardia</strong> nella prima metà del see. X V III (Bocca, Torino, 1924); M. R om ani, Un<br />
secolo di vita economica lombarda, 1748-1848 (Vita e Fensiero, Milano, 1950).<br />
Fer l’agricoltura presentano una efficace indagine storica M. R omani, L ’agricoltura in <strong>Lombardia</strong><br />
dal periodo delle riforme al 1859 (Vita e pensiero, Milano, 1945) e una sintesi dello stato recente,<br />
C. B onato, L ’economia agraria della <strong>Lombardia</strong> (1st. Naz. Ec. Agr., Milano, 1952). Di interesse<br />
più particolare, ma miniera di utili informazioni sono le opere di S. J a c in i, La proprietà fondiaria<br />
e le popolazioni agricole in <strong>Lombardia</strong> (Milano, 1854) e dell’I. N. E. A., La distribuzione della proprietàfondiaria<br />
in Italia. <strong>Lombardia</strong> (Roma, 1947); sull’argomento è notevole lo scritto di C. B onato,<br />
La dinamica della proprietà fondiaria in <strong>Lombardia</strong> (Milano, 1951). Sulle bonifiche si segnalano<br />
l’opera deiri. N. E. A., I comprensori di bonifica, Italia Settentrionale (Roma, 1942) e lo studio di<br />
F. F rancesch i, Le bonifiche e il progresso economico agrario in <strong>Lombardia</strong> (Milano, 1838).<br />
Sulla vita pastorale si possono trovare notizie generali in R. F racch i, Il fenomeno della transumanza<br />
sul versante italiano delle Alpi (Marzorati, Como, 1943). Situazioni particolari presen-<br />
560
taño; G. N an gero n i, S tu d i sulla vita pastorale in V al M alenco (Boll. Soc. Geografica Italiana, 1930),<br />
T ip i di alpeggio nelle A lp i Orobie occidentali (Riv. Geografica Italiana, 1940); R. A l b e r t in i, L e<br />
bàite della V a lfu rva (Atti XV Congresso Geografico Italiano, Torino, 1952); G. A g o stin i, L a vita<br />
pastorale nel gruppo deH’A dam ello (Memorie del Museo di Storia Naturale, Trento, 1950).<br />
Sul turismo presenta interesse geografico la ricerca di C. D e l la V a l l e, I laghi lombardi e la<br />
geografia del turismo (Boll. Soc. Geogr. Ital., Roma, 1957).<br />
Gli studi sulle industrie dispongono di pubblicazioni periodiche delle Camere di commercio<br />
provinciali e di una notevole mole di opere e di articoli delle Società industriali, delle Amministrazioni<br />
provinciali, ecc. Dal punto di vista geografico vi è un tentativo di sintesi di L. F. De M a g ist r is,<br />
Sulla localizzazione delle industrie in <strong>Lombardia</strong> (in: «La localizzazione delle industrie in Italia»,<br />
C. N. R., Roma, 1937) e interessanti pubblicazioni di G. N a n g ero n i, La localizzazione delle industrie<br />
nella Provincia di Varese (in: «La localizzazione delle industrie in Italia», C. N. R., Roma,<br />
1937), di F. M auro, Teratismi dell’industria (Hoepli, Milano, 1938). Una sintesi storica presenta<br />
A. Sa po ri, Attività manifatturiere in <strong>Lombardia</strong> dal 1600 al 1914 (Stucchi, Milano, 1959). Per informazioni<br />
sul secolo scorso sono buona fonte Milano tecnica (Hoepli, Milano, 1855) e Mediolanum<br />
(Vallardi, Milano, 1881) oltre a ricerche particolari, tra le quali si segnalano; G. F r a t t in i, Storia<br />
e statistica delle industrie manifatturiere (Milano, 1856); L. G addi, Per la storia della legislazione<br />
e delle industrie mercantili lombarde (Milano, 1893); E. V erga, Storia della vita milanese (Milano,<br />
1909). Per le singole industrie vi sono: un tentativo di studio geografico di P. S co tti, Le industrie<br />
idroelettriche nelle Oròbie (Atti XVI Congresso Geogr. Ital., Padova-Venezia, 1954) e interessanti<br />
appunti di C. D ella V a l l e, Aspetti geografici dell’industria del cemento nella Brianza (Boll. Soc.<br />
Geogr. Ital., Roma, 1955) e di R. B racch i, Notizie sull’industria del ricamo a macchina in Italia<br />
(Atti XVII Congresso Geogr. Ital., Bari, 1957).<br />
Per le comunicazioni particolare interesse rivestono gli studi di F. A. J e l m o n i; vi è quello di<br />
sintesi contenuto nel già citato volume della Cassa di Risparmio delle PP. LL. del 1954 e quelli<br />
sui progetti di opere ferroviarie stradali, quale, ad esempio, sui Progetti delle ferro v ie di valico dello<br />
Stelvio e dello Spinga (Cam. di Comm., Bergamo, 1955). Per le strade riveste interesse storico e<br />
geografico lo scritto M. Z e c c h in e lli B e l l o n i, L a S tra d a R egina nella storia e nel paesaggio (Nani,<br />
Como, i960). Per la navigazione interna P. P io la-D averio, Fiu m i, canali e laghi navigabili di L o m <br />
bardia (Ministero LL. PP., Roma, 1903) riflette una situazione d’inizio .secolo; una situazione meno<br />
lontana presenta E. M a lesa n i, L a navigazione interna nell’Ita lia settentrionale (Boll. Soc. Geografica<br />
Italiana, 1922).<br />
M ila n o e i m a g g io r i c e n tri. — Sugli aggregati urbani hanno particolare interesse le ricerche<br />
di A . P ecora, P a v ia : saggio di geografia urbana (R iv. G eogr. Ital., F iren ze, 1954) e Contributi allo<br />
studio geografico della città di M ilan o (Boll. Soc. G eogr. Ital., R om a, 1953); di E . A zzi, M an tova<br />
e il problem a dei suoi laghi (M antova, 1958); di C . V o lpa ti, S vilu p p i e aspetti di Como attraverso i<br />
secoli (N ani, C om o, 1934); di G . M . R u l f i, M o n z a : appunti p er uno studio di geografia urbana (A tti<br />
X V II C ongr. G eogr. Ital., B ari, 1957) e Un centro industriale lom bardo: Sesto S an G iovanni (R ivista<br />
G eogr. Ital., 1955); di A . T izzo n i, D istribuzione topografica delle grandi industrie in M ilan o (A tti<br />
X V II C ongr. G eogr. Ital., B ari, 1957); di C . D ella V a l l e , Lecco e il suo territorio (M em . Società<br />
G eogr. Ital., R om a, 1954); di P. L a n d in i, L o sviluppo industriale di Vigevano (Boll. Soc. G eogr. Ital.,<br />
R om a, 1938); di A ss. M ori, U na città doganale: Chiasso e il suo sobborgo italiano di Ponte Chiasso<br />
(in « S critti geografici», Pisa, i960). Particolare interesse attuale presenta l’articolo di A . S e s t in i,<br />
Qualche osservazione geografico-statistica sulle conurbazioni italiane (« Studi geografici in onore di<br />
R . B iasutti », Eirenze, 1958).<br />
C a rto g ra fia . — Il materiale cartografico per la <strong>Lombardia</strong> si basa sulle carte topografiche<br />
dell’Istituto Geografico militare di Firenze alla scala i ; 100.000 (fogli 6-9, 16-20, 31-3S, 44-48,<br />
36 — Le Regioni d'Italia - <strong>Lombardia</strong>.<br />
561
58-63, 7i) ; per lo stesso territorio l’Istituto disp one di belle tavolette alla scala 1:25.000. V i sono<br />
poi le carte edite dal T. C. I. e per diversi usi possono tornare utili quelle alla scala i ; 250.000<br />
(fogli 3, 4, 5, IO, II, 12), quelle autom obilistiche alla scala 1:200.000 (fogli 2, 4, 5, 7, 8) e alla scala<br />
1:650.000 (foglio i ) ; di ottim a esecuzione le carte speciali delle zone turistiche all’ 1:50.000 per<br />
l ’A dam ello e per l’ O rtles-C eved ale; per quest’ultim a zona v i è anche una carta di itinerari sciistici<br />
all’ i : 50.000.<br />
APPEN D ICE BIBLIO G R A FIC A A L L A SECONDA ED IZIO NE<br />
Negli anni successivi alla prima edizione della presente opera sono apparsi numerosi scritti<br />
riguardanti la regione lombarda. La maggior parte di essi sono citati nella B ibliografia geografica<br />
della Lom bardia, a cura di R. P racchi e P. L. P eretta (voi. XIII della « Collana di Bibliografie<br />
geografiche delle Regioni Italiane », C. N. R., Comitato per le Scienze Storiche, Filologiche e Filosofiche,<br />
1969).<br />
Notevoli sono i contributi alla conoscenza della morfologia lombarda; tra essi si segnala:<br />
P. G a bert, Les plaines occidentales du P o et leur piedm ont {Piémont, Lom bardie occidentale et centrale,<br />
Gap, Louis-Jean, 1962). Nuovi studi ha dato G. N angeroni e in particolare: L a m orfologia della<br />
conca del Verbano in base a una nuova carta batim etrica (Boll. Soc. Geogr. Ital., 1963); A ppunti sull'origine<br />
del L ago d'Iseo («L ’Universo», 1964); L a geomorfologia della regione del Sebino (Atti del<br />
XIX Congresso Geogr. Ital., Como, 1965); A ppunti sulla geomorfologia della regione lariana (Atti<br />
del XIX Congresso Geogr. Ital., Como, 1965); A p p u n ti sulla struttura e sulla m orfologia del territorio<br />
varesino (Atti del XIX Congresso Geogr. Ital., Como, 1965); N ote geomorfologiche sui monti a occidente<br />
del L a rio comasco (Atti d. Soc. Ital. di Scienze Naturali, 1969); I monti d ell’A lto L a rio occidentale<br />
(«L ’Universo», 1969); N ote sulla geom orfologia del gruppo montuoso C ornizzolo-M oregallo-<br />
C orni di Ganzo {P realp i Comasche) (in « Scritti sul Quaternario in onore di A. Pasa », Museo di<br />
Storia Naturale, Verona, 1969); A ppunti sulla geomorfologia dei P ian i di Bòbbio e di A rtavàggio<br />
{P realp i Lecchesi («L ’Universo», 1970). A spazi più limitati si riferiscono gli studi di: E. F u rrer,<br />
D er Bergstu rz von Borm io (Vierteliahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1962);<br />
G. Mussio, L a degradazione del suolo nel bacino dell’E n na {P realpi Bergam asche): form e e stadi<br />
(C. N. R., 1962); A. PiETRACAPRiNA, I fenom eni crionivali nell'alta va lle del B ra u lio («L ’Universo»,<br />
1963)-<br />
Sul glacialismo attuale l’opera più importante è quella di A. D esio , I ghiacciai del gruppo O rtles-<br />
C evedale, A lp i C entrali (C. N. R., Comit. Glaciologico Ital., 1967).<br />
Sul fenomeno carsico si annoverano vari contributi: A. C igna e G. R ondina, Sull'idrologia<br />
carsica epigea nel territorio della provincia di Como (Atti d. Soc. Ital. di Scienze Naturali, 1959);<br />
A . F o carile, a . C ig n a, G . C a ppa, Ricerche sugli aspetti del fenom eno carsico profondo nel gruppo<br />
delle G rigne (Atti d. Soc. Ital. di Scienze Naturali, i960); E. D e M ic h e l e, O sservazioni e misure<br />
sulle sorgenti nel gruppo delle G rigne {Como) (Atti d. Soc. Ital. di Scienze Naturali, 1961); G. N a n<br />
g ero n i, Il fenomeno carsico nel territorio del L ago d ’Iseo (in « Scritti in onore di C. Colamonico »,<br />
Napoli, Loffredo, 1963); G. C a ppa, Considerazioni generali sul fenom eno carsico nel gruppo delle<br />
G rigne con particolare riguardo alle form e sotterranee (« L ’Universo », 1964).<br />
Tra le numerose pubblicazioni riguardanti il paesaggio vegetale si segnala per caratteri generali<br />
quella di G. G iacom ini riguardante il territorio della provincia di Sondrio contenuta nell’opera:<br />
Am biente fisico e paesaggio vegetale nella provincia di Sondrio (Camera di Commercio, I. e A.,<br />
Sondrio, i960), nella quale vi è una premessa di carattere fisico di G. N a n g er o n i.<br />
Sul Parco Nazionale dello Stelvio, a cura dell’Azienda di Stato Foreste Demaniali e dell’Ufficio<br />
Amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio è stato pubblicato un volume (Rovereto, Man-<br />
562
frinì, 1968) contenente articoli di R. Pozzi sulla geologia, V. De M ic h e le sulla mineralogia, C. S a i-<br />
b e n e sulla geomorfologia, Л. P iróla sulla vegetazione, L. C agnolaro sulla fauna.<br />
Molto ricca è la bibliografia riguardante la preistoria della <strong>Lombardia</strong>; si segnalano qui alcuni<br />
scritti attinenti alla trattazione svolta nel presente volume: A . R a d m illi, La preistoria della <strong>Lombardia</strong><br />
e del Piemonte («L ’Universo», i960); C. C orrain e O. C ornaggia C a st ig l io n i, Resti fossili<br />
di presumibile età pleistocenica rinvenuti in territorio lombardo (« Natura », Riv. di Scienze Naturali,<br />
1963); E. A m a ti, La civilisation du Val Camònica (Grenoble, Arthaud, i960), in traduzione<br />
italiana (Milano, ed. « Il Saggiatore », 1964).<br />
Riguardo alla storia locale sono apparse opere di notevole importanza, quali la Storia di Bergamo<br />
di B. B elo tti (a cura della Banca Popolare di Bergamo, Bergamo, 1959, 7 voli.), la Storia di<br />
Brescia, diretta da G. T reccan i d eg li A l f ie r i (Milano, E. Milli, 1963-64, 5 voli.) e Mantova. La<br />
storia (Mantova, Istituto Carlo d’Arco, 1958-63, 3 voli.). Accanto a queste opere maggiori si segnalano<br />
alcuni scritti riguardanti alcuni capoluoghi, che rivestono anche un interesse geografico:<br />
Lo sviluppo urbanistico [di Brescia] dal 1956 al i960 (a cura del comune di Brescia, Brescia, i960);<br />
E. Azzi, Mantova e il problema dei suoi laghi (Mantova, Stab. Tip. Citem, 1958); P. V accari, La<br />
posizione e la funzione storica della città di Pavia (Archivio Storico Lombardo, 1966). Sull’exclave<br />
di Campione merita segnalazione lo studio di M. Z ec c h in e ll i B e l l o n i, Campione, terra italiana<br />
(Archivio Storico Lombardo, 1966).<br />
Sulla popolazione della regione lombarda si leggono con interesse le pagine dello scritto: Prime<br />
conclusioni dell’indagine sui problemi e prospettive di andamento dello sviluppo della popolazione in<br />
<strong>Lombardia</strong> (Istituto Lombardo per gli Studi Economici e Sociali, Milano, 1966). Particolare interesse<br />
hanno suscitato negli studiosi gli aspetti e i movimenti della popolazione di Milano e del suo<br />
territorio; se ne sono occupati: G. P ranzo, Aspetti dell’immigrazione a Milano (Comune di Milano,<br />
Ufficio Studi, 1961); R. C atalisan o, Distribuzione territoriale e differenziazione strutturale dei vari<br />
sistemi sociali che compongono l’ambiente urbano (Comune di Milano, Studi e documenti dei servizi<br />
statistici, 1961); G. Mussio, Fenomeni migratori interessanti Milano nel periodo 1952-1959 (Atti d.<br />
XVIII Congresso Geogr. Ital., Trieste, 1962); C. L acca, I movimenti migratori nell’alto Milanese<br />
e i loro riflessi urbanistici (Istituto di Urbanistica del Politecnico di Milano, 1964); Contributo allo<br />
studio del movimento pendolare delle forze del lavoro in provincia di Milano (a cura della Associazione<br />
Industriale Lombarda, Milano, 1963). Sugli aspetti demografici della provincia milanese presenta<br />
una sintesi M. Z egna in un articolo contenuto nel volume: La provincia di Milano (Milano,<br />
Giuffré, 1969).<br />
Anche per le altre città e per gli altri territori della regione si dispone di studi, tra i quali:<br />
G. S covenna, Movimenti pendolari in Provincia di Pavia (Camera di Commercio, I. e A. di Pavia,<br />
1964) e L ’invecchiamento della popolazione in provincia di Pavia (Camera di Commercio, I. e A. di<br />
Pavia, 1966); E. M assi, Momenti dello sviluppo dell’Oltrepò Pavese (Milano, Giuffré, 1967) e L ’Oltrepò<br />
Pavese (1st. di Geogr. ec. dell’Università di Roma, 1967); P. D agradi, L ’Appennino lombardo:<br />
il bacino della Stafferà (Riv. Geogr. Ital., 1962); G. C orna P e l l e g r in i e L. F errario, Cremona:<br />
elementi di una politica di sviluppo (Amministrazione provinciale di Cremona, 1965); G. C orna<br />
P e l l e g r in i, L. T errario e G. L. Sa la, Il Cremasco (Milano, Giuffré, 1967); G. C orna P e l l e <br />
g r in i e L. F errario, Varese: premesse alla programmazione (Amministrazione Provinciale di Varese,<br />
1963); R. P racch i, La Brianza e la collina comasca (Atti del XIX Congresso Geogr. Ital., Como,<br />
1965) ; E. B 0N G 10V A N N I, Il fenomeno delle migrazioni giornaliere in provincia di Bergamo (Bergamo,<br />
Bolis, 1963).<br />
Gli aspetti e i problemi economici della <strong>Lombardia</strong> hanno offerto grande possibilità di ricerche<br />
e la produzione bibliografica è ricchissima; si dà qui appresso un elenco di alcuni degli scritti di<br />
carattere più generale e di altri più attinenti ai temi trattati nel volume: A. D e V it a, L ’evoluzione<br />
economica della <strong>Lombardia</strong> dalla prima guerra mondiale a oggi (Associazione Industriale Lombarda,<br />
Milano, 1959); M. R omani, Un secolo di vita agricola in <strong>Lombardia</strong> {1861-1961) (Giuffré, Milano,
1963); L. C afagna, La rivoluzione agraria» in <strong>Lombardia</strong> (Annali dell’Istituto G. Feltrinelli, M i<br />
lano, i960); Relazione sullo stato dell’agricoltura in <strong>Lombardia</strong> e sulle prospettive di sviluppo (Ministero<br />
dell’Agricoltura e Foreste, 1967); E. C alcaterra e P. N e r v i, La situazione dell’agricoltura<br />
nella regione lombarda (ILSES, Milano, 1962); A. P ecora, L ’azienda agricola lomellina (in «Scritti<br />
geografici in onore di C. Colamonico », Loffredo, Napoli, 1963); P. C. M o n ti, Lambro e Olona<br />
nella storia e nell’economia lombarda (Camera di Commercio, I. e A. di Como, 1966); V. C olumbo,<br />
Gli insediamenti rurali in <strong>Lombardia</strong> (Centro Studi del Piano Territoriale in <strong>Lombardia</strong>, Milano,<br />
1961); M. O r to la n i, <strong>Lombardia</strong> e Lancashire. Saggio di geografia industriale comparata (Istituto<br />
di Geografia dell’Università, Napoli, 1963); P. D agradi, L ’area industriale milanese (Ed. Ponzio,<br />
Pavia, 1964) e Un complesso industriale: Legnano-Busto Arsizio (Atti del XVIII Congresso Geogr.<br />
Ital., Trieste, 1962); C. D ella V a l l e, La popolazione industriale in provincia di Como (Camera di<br />
Commercio, I. e A. di Como, 1961) e La nascita di una к città nuova» della pianura lombarda nordoccidentale<br />
(Atti del XX Congresso Geogr. Ital., Roma, 1970); F. I ndovina e A. P izzorno, Tendenze<br />
e fattori della localizzazione industriale in <strong>Lombardia</strong> (ILSES, Milano, 1967); F . F er o ld i,<br />
L. Santambrogio e D . P o l it i, Indagini sull’industria lombarda (Centro Lombardo di Studi e iniziative<br />
per lo sviluppo economico, Milano, 1968); P. D agradi, Pavia come centro industriale (Atti<br />
del XVIII Congresso Geogr. Ital., Trieste, 1962); M. L. Pajola B a g n i, Aspetti e fattori della localizzazione<br />
industriale in provincia di Mantova (Ufficio Studi e programmazione della Provincia di<br />
Mantova, 1967); A m. R iva, Lecco, centro di un’area industriale a crescita spontanea (Atti del<br />
XIX Congresso Geogr. Ital., Como, 1964); G. Mussio, Il centro industriale di Cantù (Atti del<br />
XIX Congresso Geogr., Como, 1964).<br />
Riguardo alle comunicazioni e ai trasporti si segnalano i seguenti scritti: E. D almasso, Problèmes<br />
de trasport dans la région milanaise («Méditerranée», 1963); Stato di consistenza delle strade<br />
statali e provinciali della regione lombarda al 1 ° gennaio iç66 (Unione regionale delle PP. LL., M i<br />
lano, 1967); M. M a t ern in i e S. C araco glia, La viabilità lombarda e le sue prospettive future (Centro<br />
lombardo di studi e iniziative per lo sviluppo economico, Milano, 1967). Sulla navigazione interna<br />
si distingue l’opera di G. C. Z imolo, La navigazione nel Comasco dalle origini ai giorni nostri (Camera<br />
di Commercio, I. e A. di Como, 1962); alla navigazione nel passato sono altresì dedicati diversi<br />
studi contenuti nei fascicoli dell’annata 1964 dell’« Archivio Storico Lombardo».<br />
5 6 4
IN D IC E A N A L IT IC O A L F A B E T IC O<br />
I n u m e ri in neretto in d ic a n o le p a g in e p iù p a rtic o la rm e n te d e d ic a te а ІГ а гд о т еп іо ,<br />
i n u m eri con a sterisco in d ic a n o le p a g in e con illu s tr a z io n i.<br />
Abbazia<br />
Bacino<br />
Canale<br />
Cascata<br />
Castello<br />
Cattedrale<br />
Colline<br />
Ferrovia<br />
= abbaz.<br />
= bac.<br />
= can.<br />
= case.<br />
= cast.<br />
= cattedr.<br />
— coll.<br />
= ferr.<br />
ABBREVIAZIONI<br />
Fiume<br />
Ghiacciaio<br />
Golfo<br />
Isola<br />
Lago<br />
Mare<br />
Monte<br />
Passo<br />
= f.<br />
= ghiacc,<br />
= g-<br />
= is.<br />
= 1.<br />
= m.<br />
= mt.<br />
= p.<br />
Penisola = pen.<br />
Pianura = pian.<br />
Popolazione = pop.<br />
Provincia = prov.<br />
Regione = reg.<br />
Torrente = torr.<br />
Valle = V.<br />
A b b ad ia, io 6.<br />
A b b a z i e , v. C h ie s e .<br />
A bbiategrasso, 408.<br />
Acqua Mutia, fosso, 289.<br />
A cquate, 444.<br />
A d am ello, m t., 14 , 56, 67-68,<br />
69*, 7 3 , 9 7 , 9 9 , 126, 12 7 ,<br />
169. 4 3 3 .<br />
Adda, £ , 7 8 , 1 0 5 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7 ,<br />
1 2 0 * , 1 2 2 * , 1 2 1 -1 2 5 , 1 2 6 , 1 3 1 ,<br />
1 3 2 , 1 7 8 , 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 6 , 2 9 9 ,<br />
3 0 4 , 3 6 4 , 4 0 6 , 4 1 5 , 4 3 4 , 4 4 9 .<br />
Adda, V. dell’, v. Valtellina, V.<br />
Addetta, can., 1 2 1, 2 9 9 .<br />
A d ige, f ., 1 2 9 , S 2 2 .<br />
A d riatico, m ., 17 , 18.<br />
A d u la, ghiacc. d ell’ , 59.<br />
A d u la, m t. (Rheinw aldhorn), 59.<br />
Aemilia, ant. prov., 23.<br />
A go gn a, f., 1 1 4 , 1 1 5 * , 1 1 7 , 4 17 .<br />
A g r i c o l t u r a , 287, 3 0 5-335,<br />
329<br />
A irolo, 59, 76.<br />
Alba, 459.<br />
A lban o, coll, di, 88.<br />
A lban o, f., 10 7.<br />
A lb an o , V . di, 2 10 .<br />
A lb en , m t., 85, 170 , 439.<br />
A l b e r t i L e o n B a t t i s t a , a r c h i<br />
tetto, 525.<br />
A lb in o , 80, 35 5 , 436, 437.<br />
A l i o n e G i a n G i o r g i o , scrittore,<br />
282.<br />
A l l u v i o n i , p ie n e , 73, 107,<br />
109, 1 1 7 , 118 , 1 2 1 , 12 8 -13 0 ,<br />
14 9 * , 494, 522.<br />
A lm è, 355.<br />
A lm enno S. Salvatore, 434.<br />
A l p e , a l p e g g i o , 2 6 1* , 262,<br />
263, 3 3 7 -<br />
A lp i Lepontin e, 4, 57, 58-60.<br />
A lp i Lom bard e, 49-70, 95, 1 1 3 ,<br />
1 1 4 , 138 , 14 3 , 14 8 -15 0 , 15 7 ,<br />
200, 2 1 3 ’*, 2 16 * , 240 -243, 258-<br />
263, 265-266, 3 2 3 * , 32 7-330 .<br />
A lp i O robiche (O robie), 54, 58,<br />
68-70, 7 1 * , 83, 85, 97, 99,<br />
12 4 , 16 5, 16 9 -17 0 , 263, 449.<br />
A lp i O robie, V. A lp i O robiche.<br />
A lp i R etiche, 4, 57, 60-68, 7 1 * ,<br />
16 5, 449.<br />
A lp isella, p. di, 77, 1 2 1.<br />
A lserio, 1. di, 90, I I I , 1 1 3 , 440.<br />
A lzan o L om bardo, 355, 387, 436.<br />
Andes, V. Bietole V irgilio.<br />
A n g e l i n i G i a n B a t t i s t a , poeta<br />
dialettale, 284.<br />
A ngeloga, p ., i i , 6 1.<br />
A n gera {Vicus Sebuinus), 354,<br />
4 5 5 *. 458.<br />
A n g u i s s o l a , c o n t e , g o v e r n a t o r e<br />
di Com o, 400.<br />
A nnone, 1. di (O ggiono, 1. di),<br />
20, 90, I I I , 1 1 3 , 34 4 *, 440.<br />
Antegnana, roggia, 297.<br />
A nzasca, V ., 272.<br />
A osta, prov., 200.<br />
A ppennino, 1 1 4 .<br />
A p rica, 404.<br />
A p rica, p. d ell’, 57, 72, 73, 7 3 * ,<br />
126, 169, 434.<br />
A q u i s g r a n a , p a c e d i , 2.<br />
A rbed o, 76.<br />
A r c h i , V. P o r t e .<br />
A rcore, 3 8 1.<br />
A rdenno, 353.<br />
A rd esie, 437.<br />
A rerà, m t., 79, 85, 170 .<br />
A rgegno, 106 , 446.<br />
A r i b e r t o d i A n t i m i a n o , arcivescovo,<br />
29, 442.<br />
A rm isa, torr., 12 1 .<br />
A rn o , f., 1 1 5 .<br />
A rn o , 1. d ’, 1 1 3 .<br />
A r t i g i a n a t o , 2 16 , 378.<br />
A s b u r g o , c a s a d ’ :<br />
M a r i a T e r e s a , 4 6 ; G i u <br />
s e p p e II, 46; R a n i e r i , 46.<br />
A s c o l i G r a z ia d io I., scritt., 2 7 1.<br />
À spide, torr., 124.<br />
Augusta Brixia, v. B rescia.<br />
A u s o n i o D e c i m o M a g n o , poeta,<br />
24, 460.<br />
A varo , pian d ell’, 262*<br />
A vio f., 126.<br />
A vio , V . d ’ , 78.<br />
A z zi E ., 527.
B a c i n i i d r o e l e t t r i c i , 77,<br />
118 , 12 0 * , 1 2 1 , 12 2 , 124, 126,<br />
360-365, з6 о *-з б 5 *.<br />
Baciolago, poggio di, 442.<br />
B adile, pizzo, i i , 55, 62, 6 2*,<br />
63, 9 9 -<br />
Bagnolo M ella, 377.<br />
Baiona, roggia, 297.<br />
Baitone, corno, 68, 70 *.<br />
Baitene, 1., 1 1 3 .<br />
Balbianello, 400, 447.<br />
Baldiscio, p. di, 60.<br />
Balestrieri D omenico, scrittore,<br />
283.<br />
Balisio, 445.<br />
Baradello, colle, 4.92.<br />
Barano, 244.<br />
Bardello, torr., 1 1 3 .<br />
Baretti G iuseppe, scrittore, 4 4 1.<br />
Barro, m t., 1 1 3 , 442.<br />
Barzio, 80, 445.<br />
B a s i l i c h e , v. C h ie s e .<br />
Battagio G iovanni, architetto,<br />
4 16 .<br />
Beccaria C esare, scrittore, 345.<br />
Bedretto, V ., 59, 76, 118 .<br />
Beigioioso, 4 17 .<br />
Bellagio, 10 5, 14 2 , 14 3 , 2 3 7 * ,<br />
400, 403, 443, 446.<br />
Bollano, 243, 448.<br />
Bellati F rancesco, scrittore,<br />
283.<br />
Bellerio C arlo, 345.<br />
B ellini V incenzo, musicista,<br />
400, 446.<br />
Bellinzona, 5*.<br />
B elviso, torr., 1 2 1 .<br />
Benaco, 1. (G ard a, 1. di), 15 , 20,<br />
80, 8 6 ,9 9 ,10 8 * , 108-109,14 2 * ,<br />
15 7 , 16 0 * , 1 6 1, 17 2 * , 2 12 ,<br />
243. 330, 331, 344*, 387. 399,<br />
400, 403, 428.<br />
Benacum, v. T oscolano.<br />
B erchet G iovanni, scrittore,<br />
400.<br />
Bergam asca, pian., 325, 434.<br />
Bergam asca, v. Bergam asco.<br />
Bergam asco, 3, 88, 1 7 4 , 176, 2 12 ,<br />
Bergam o, prov., 1 8 1 , 1 9 2 , 1 9 5 ,<br />
2 0 0 , 2 1 S , 2 3 8 , 3 5 2 , 3 7 5 , 3 7 6 ,<br />
5 3 5 - 5 3 7 -<br />
Bergogum, v. Bergam o.<br />
Bernina, f., 62.<br />
Bernina, pizzo, 12 , 56, 63-64,<br />
64*, 99, 14 8 *, 148.<br />
B ernina, p ., 13 , 64, 6 5*.<br />
B e r t a c c h i G i o v a n n i, s c r i t t o r e ,<br />
4 5 1 -<br />
B e r t a z z o l o G a b r i e l e , s c r i t t o r e ,<br />
1 2 9 , 5 2 4 .<br />
B esana Brianza, 376.<br />
B evera, V . della, 8 1.<br />
B e y l e M a r i e - H e n r i ,<br />
d e t t o<br />
S t e n d h a l , s c r i t t o r e , 4 0 0 .<br />
Bezzo, 385.<br />
Bianco, corno, 68.<br />
Bianco, 1., 1 1 2 * , 1 1 3 .<br />
Biandronno, 1., 90, i i i , 1 1 3 .<br />
Biasca, 59, 76.<br />
B i b l i o t e c a ; m u s e o : 28, 4 5*,<br />
223-224, 507.<br />
B i f f i G i o v a n n i A m b r o g i o , s c r i t <br />
t o r e , 2 8 3 .<br />
Bione, torr., 106 , 12 4 , 243, 444.<br />
BiRAGO G i r o l a m o , p o e t a d i a l e t <br />
t a le , 283.<br />
Bitte, torr., 121.<br />
B itte, V . del, 69.<br />
Bizantini, pop., 26.<br />
B las, pizzo, 58.<br />
B ienio, f., 118 .<br />
B ienio, V ., 76.<br />
B levio, 446.<br />
B oario T erm e, 4 3 2 * , 433.<br />
B obbio, 28.<br />
B o c c o n i F e r d i n a n d o , i n d u <br />
s tr ia le , 2 2 2 .<br />
Boesio, V . del, 8 1.<br />
B offalora, m t., 16.<br />
Bogliaco, 400.<br />
Boi, pop., 459,<br />
Bollate, 383.<br />
Boltiere, 375.<br />
Bolzano, prov., 200.<br />
BoNATO C o r r a d o , 2 9 9 , 3 0 4 , 3 1 7 ,<br />
3 2 2 , 3 3 7 .<br />
Bondasca, V ., g*.<br />
Bondione, V ., 124.<br />
233, 247, 299, 346, 354, B355,<br />
ondo, 9 *.<br />
372, 374, 434-440. S33. BoNVESiN DA la R iva, Scrittore,<br />
Bergam asco, coll., 331.<br />
Bergam o (Bergomum), 24, 33,<br />
279.<br />
Bordolano, 356.<br />
3 5 *, 3 9 , 140, 1 4 1 , 180, 18 3,<br />
18 6 *, 200, 228, 236, 238, 272,<br />
B o r d o n i A n t o n i o , m a t e m a t i c o ,<br />
2 2 1.<br />
279, 283, 348, 366, 369, Borlezza, 376, V., 85, 86, 211.<br />
377, 3 8 1, 389, 404, 496-503, Borm io, 77, 14 3, 16 3, 204*, 242,<br />
4 9 7 *-S 0 2 *, 5 3 0 .<br />
404, 450.<br />
B o r m i o , c o n t e a , 3 , 4 8 , 1 6 8 .<br />
Borrom ee, is., 100.<br />
Borrom eo, g., 100.<br />
B orromeo :<br />
Carlo, 45, 4 1 2 ; F ederico, 45.<br />
B osisio Parini, 442.<br />
B o ssi G iuseppe, scrittore, 284.<br />
Botticino, 353.<br />
Bovegno, 356.<br />
Bozzolo, 179 , 423.<br />
B o z z o l o , p r i n c i p a t o d i , 2.<br />
B rabbia, can., 1 1 3 .<br />
Bracca, fonte, 440.<br />
Braulio, f., 1 2 1 .<br />
Braulio, V . del, 77, 1 2 1.<br />
Bregaglia, V ., 9 *, i i , 13 , 55,<br />
6 1, 62, 78, 16 8 , 454-<br />
B regagno, m t., 2 6 1* .<br />
B rem bana, V . (V. del Brem bo),<br />
79, 83, 170 , 1 7 1 * , 209, 2 10 ,<br />
2 4 1, 242, 356, 364, 437-438-<br />
Brem bate, 354.<br />
Bram billa, torr., 124.<br />
B ram billa, V ., 80, 124, 439.<br />
B rem bo, f., 84, 114 , 12 3 * , 12 4 ,<br />
299.<br />
B rem bo, V . del, v. Brem bana, V .<br />
B rano, 7 7 * , 377, 433.<br />
B rescia (Brixia), 2 2 * , 23, 30 *,<br />
39, 14 0 , 1 4 1 , 18 3 , 200, 228,<br />
236, 284, 350, 366, 369, 377,<br />
3 8 1. 38 3. 389. 404. 503-508,<br />
5 0 4 * - 5 o 8 * , 5 3 0 , 5 3 8 .<br />
B rescia, p rov., 1 8 1 , 19 2, 19 5,<br />
200, 2 15 , 327, 352. 375. 376,<br />
5 3 5 -5 3 7 -<br />
Bresciana, pian., 159 , 325, 428.<br />
B resciano, 3, 20, 2 1, 158 , 16 3,<br />
17 4 . 17 6 . 209, 2 12 , 2 33, 246,<br />
299. 30 3. 3 5 3 . 3 5 4 . 3 7 3 . 3 7 4 .<br />
428-434, 533.<br />
B resciano, coll., 3 19 , 3 2 1, 3 3 1,<br />
Briantiae, 178.<br />
Brianza, i i i , 178, 244, 2 7 1, 3 7 1,<br />
372, 374. 400. 440-442, 441*.<br />
Brianza, colle di, 442.<br />
Brianzola, 178.<br />
Brinzio, V . di, 8 1.<br />
Brixia, v. B rescia.<br />
Broni, 368, 38 3, 4 2 1.<br />
B rugh erio, 230, 376.<br />
B rúñate, 489.<br />
Buciaga, m t., 68.<br />
B u o so DA D ovara, signore di<br />
C rem ona, 5 18 .<br />
Bura, p. di, 79, 84, 439.<br />
B usto A rsizio , 236, 238, 349,<br />
366, 372 , 387, 412-413, 458.<br />
B usto G aro lfo , 376.<br />
S 6 6
C adenabbia, 10 5, 403, 447.<br />
C alab ria, 535.<br />
C a l d e r ik ' i A ., 22.<br />
C aldone, to rr., 106, 12 4 , 243,<br />
4 4 4 .<br />
Calolziocorte, 378.<br />
C alusco d ’A d d a, 355, 377.<br />
C a ’ M addalena, 118 .<br />
C am erlata, 496.<br />
C am erlata, insellatura, 489.<br />
C am ino, pizzo, 86, 86*.<br />
C am orta, 22.<br />
Cam pania, 199, 366, 535.<br />
C am pelio, m t., 68.<br />
Cam pione, 6 *, 7, 7 * , 8-10 .<br />
C am po, m t., 65, 66.<br />
C am po dei F io ri, m t., 8 1, i n ,<br />
13 6 , 456, 487.<br />
C a M PO F O R M ID O , TRA TTATO D I, IO .<br />
Camunni, p op., 23.<br />
C a n a l i , 1 1 3 , 118 - 1 2 0 , 12 4 ,<br />
12 7 , 289-304, 290*, 298*,<br />
30 0 *, 3 0 2 *, 537.<br />
C ancano, 1. di, 1 2 1 , 364.<br />
C andoglia, 2 9 1.<br />
C anegrate, 376.<br />
C annerò R iviera, 100.<br />
Canneto, 387.<br />
C a n o s s a , B o n i f a c c i o d i , 2 8 ;<br />
M a t i l d e d i , 5 2 3 .<br />
Canossi a ., scrittore, 284.<br />
Canova A ntonio, scultore, 400.<br />
C anto A lto , pizzo del, 85.<br />
C antù, 2 7 1, 2 8 1* , 387, 38 8 *,<br />
442.<br />
Cantò C esare, storico, 19.<br />
Capis G iovanni, scrittore d ialettale,<br />
283.<br />
C aplone, m t., 87.<br />
C ap o di Ponte, 2 1 * , 433.<br />
Capolago, 102.<br />
C apriate, 372.<br />
C a r a c i G i u s e p p e , g e o g r a f o ,<br />
250.<br />
C aravaggio, 434.<br />
C ardinello, m t., 60.<br />
Carducci G iosuè, poeta, 465.<br />
C arenno, 106, 446.<br />
Cariàdeghe, altopiano, v. Serie,<br />
altopiano di.<br />
C arona, roggia, 120.<br />
Caronella, to rr., 1 2 1.<br />
C a r s is m o , 87, 88*, 89*, 13 5 ,<br />
13 6 , 429, 438, 439.<br />
C arugate, 383.<br />
C arugo, 376.<br />
C arzano, 432.<br />
Casalbuttano, 423.<br />
Casalm aggiore, 228, 423.<br />
C asalpusterlengo, 4 17 .<br />
C a ’ San M arco, p ., 69, ijo.<br />
Casatenuovo, 3 7 1.<br />
Casatevecchio, 244.<br />
Casati, 442.<br />
C ascina L u p o , 17.<br />
C asiino, 372.<br />
C asiin o d ’E rb a, 1 2 1.<br />
C aspoggio, 2 16 , 353.<br />
Cassandra, pizzo, 63.<br />
C assago, 355.<br />
C assano, 12 4 , 349.<br />
Cassolnovo, 373.<br />
Casteggio, 368, 4 2 1.<br />
Castelletto, 108.<br />
C a s t e l l i ; r o c c h e d i :<br />
A b b ia te g ra s s o , 4 0 8 ; A n fo ,<br />
4 30 ; A n gera (dei Visconti),<br />
4 8 5; Beigioioso, 4 1 7 ; Borm io,<br />
4 34 ; B rescia, 506*, 508; B rignano<br />
d ’A d d a, 4 3 4 ; C osta di<br />
M o z z a te , 4 3 4 ; G o v e rn a g o ,<br />
4 3 4 ; M alpaga, 4 3 4 ; M antova,<br />
525 (del T e ), 4 1 * (S. G io rgio);<br />
M ilano, 3 9 * , 470, 485 (Sfo r<br />
z e s c o ); M o n ig a , 4 2 8 ; P a -<br />
denghe, 428 ; Pavia, 3 7 * (V i<br />
sconteo); Piattam ola, 12 , 3 7 * ;<br />
R evere, 426 ; R om ano, 4 34 ;<br />
S. A n gelo Lod igian o, 4 1 5 * ;<br />
Sartirana L om ellina, 4 20 * ; Sir-<br />
m ione, 4 2 9 * ; Solferino, 4 2 5 * ;<br />
Soncino, 4 2 * ; V igevano, 4 19 * ;<br />
V illipenta, 426.<br />
Castellanza, 366.<br />
C astello, cim a di, i i , sS . 63-<br />
Castelm arte, 243.<br />
C astel Seprio, 458.<br />
Castenèdolo, coll, di, 88.<br />
C astiglione delle Stiviere, 427.<br />
C astro, 243, 3S4, 38 0 *, 432.<br />
C attaneo Carlo, scrittore, 200,<br />
2 19 , 228, 229, 285, 289, 3 10 .<br />
Cavalcabò, casa dei, 5 18 , 519 .<br />
C avallina, V ., 80, 86, n o , 170 ,<br />
2 1 1, 354, 436.<br />
C avargna, V ., 109.<br />
C a v e , V. M i n i e r e .<br />
C aviaga, 356.<br />
C avo u r, can., 297, 4 17 .<br />
Celto-Galli, pop., 23, 18 3 , 509.<br />
C engalo, pizzo, 55, 6 2 *, 63.<br />
Centovalli, V ., 72.<br />
C entrale, pizzo, 58.<br />
C e n t r i, distribuzione dei, 248*.<br />
C eresio, 1. (Lugan o , 1. di), $,<br />
80-82, 89, 99, l o i * , l o i , 10 2 ,<br />
10 2 * , 15 7 , 16 4, 169, 399, 440,<br />
4 4 7 -<br />
C enano, 375.<br />
Cermenati M ario, naturalista,<br />
4 4 3 -<br />
Cernobbio, 446, 4 4 7*.<br />
C esano Boscone, 238.<br />
Cesano M adern o, 372, 375, 385.<br />
Cevedale, m t., 14 , 5 1 * , 54, 66,<br />
9 7 . 9 9 -<br />
Cherio, f., 1 1 4 , 12 7 , 436.<br />
C hiari, 373, 378, 428.<br />
Chiasso, 4 *.<br />
Chiavenna, 6 1, 369, 4 51-4 52.<br />
C hIAVENNA, contea, 3, 48, 168.<br />
Chiavenna, piano d i; V ., 60, 62,<br />
16 6, 304, 451-<br />
Chiavenna, V a lli di, 78, 166,<br />
168, 169, 207, 364, 4 5 1, 452,<br />
Chiesa Valm alenco, 353.<br />
C h ie s e :<br />
A bbiategrasso, 408 (basilica<br />
S. M aria N uova).<br />
A gliate Brianza, 2 7 * (basilica<br />
S. Pietro).<br />
Bergam o, 490, 500 (S. M aria<br />
M aggiore, cappella C o l-<br />
leoni); 497 (S. A lessandro).<br />
Bobbio, 28 (m onastero).<br />
B rescia, 36 (S. Stefano in<br />
A r c e ) ; 50 3 (Capitolium);<br />
504 (duom o vecchio) 506<br />
(S. M aria dei M iraco li ; M a <br />
donna del C arm in e ; S. G io <br />
v a n n i E v a n g e lis t a ) ; 507<br />
(duom o N u o vo S. Eufem ia).<br />
Busto, 4 13 (duom o; S. M aria<br />
di Piazza).<br />
Cam pione, 8 (basilica S. Z e <br />
none).<br />
C aravaggio, 4 4 *, 434 (santuario<br />
della M adonna).<br />
C astel Seprio, 458 (S. M aria<br />
F o ris Porta).<br />
C hiaravalle, 32, 406, 407*<br />
(abbaz.).<br />
Com o, io 7 ,4 9 3*,4 9 4 (d u o m o );<br />
^ 4 9 0 (S. C arp oforo); 490,<br />
495 (S. A bbondio).<br />
Com o, p rov., 535.<br />
Crem a, 422 (duom o ; santuario<br />
S. M aria della Croce).<br />
C rem ona, 359, 5 17 , 5 19 * , 5 2 1<br />
(duom o; battistero); 537.<br />
Crem ona, p rov., 535, 536.<br />
Fontanella, 434 (abbaz.).<br />
G allarate, 4 14 (S. Pietro).<br />
Im b ersago, 4 4 1 (santuario).<br />
Im bèvera, 441 (santuario).<br />
567
C h ie s e :<br />
Legnano, 4 13 (duom o ; S. M aria<br />
di Piazza).<br />
L o d i, 4 16 (santuario d ell’In <br />
coronata).<br />
M aguzzano, 248 (abbaz.).<br />
M antova 525 (S. Sebastiano;<br />
S. A ndrea).<br />
M ilano, 8, 28, 462, 4 6 3*, 485<br />
(m onastero S. A m brogio) ;<br />
32 (m onastero di B rera);<br />
462, 485 (S. E usto rgio); 467,<br />
470, 482, 483 (duom o); 485<br />
(S. G ottardo) ; 485 (S. M aria<br />
delle G razie); 24, 485*<br />
(S. Lorenzo M aggiore) ; 462<br />
(S. N azaro); 462 (S. Sem <br />
pliciano).<br />
M irasole, 408 (abbaz.).<br />
M onza, 26 (basilica S. G io <br />
vanni Battista); 4 10 (duom o;<br />
cappella E sp iatoria; cappella<br />
di Teodolinda).<br />
M orim ondo, 407 (abbaz.).<br />
Pavia, 40*, 4 17 , 4 18 * (C e r<br />
tosa); 62 (S. G io van n i B a t<br />
tista); 509 (S. Pietro in<br />
C iel d ’O ro ; S. M aria alle<br />
Pertiche, S. G io vanni in<br />
B orgo); 5 1 2 ’* (duomo).<br />
Piona, 448 (abbaz.).<br />
Pontida, 434 (abbaz.).<br />
R ho, 4 12 (santuario).<br />
Saronno, 4 14 (santuario M a <br />
donna dei M iracoli).<br />
S. Benedetto al Po, 426, 4 27*<br />
(basilica).<br />
S. G enesio, 440 (santuario).<br />
T ir a n o , 12 , 450 (sa n tu a rio<br />
della M adonna).<br />
Varese 486 (santuario Sacro<br />
M onte); 488 (basilica S. V ittore).<br />
Viboldone, 408 (abbaz.).<br />
Vigevano, 4 18 (duomo).<br />
Chiese, f., 1 1 4 , 12 7 , 299, 304,<br />
430.<br />
Chiese, V . del, 109, 17 2 , 364.<br />
C hiudono, 376.<br />
Chiuso, 444.<br />
CiASCA R a f f a e l e , storico, 347,<br />
3 4 9 -<br />
Cidneo, colle, 503.<br />
C ipressi, is. dei, 20.<br />
C i s a l p i n a , r e p u b b l i c a , 3 , i o ,<br />
4 7 , 179 . 4 5 0 , 487.<br />
Cisano, 355.<br />
C ivid ate C am uno (Civitas Camunnorum),<br />
433.<br />
Civitas Camunnorum, v. C iv i<br />
date Cam uno.<br />
C lerici A ., industriale, 345.<br />
e lu so n e , 2 0 1* , 4 0 3*.<br />
C oca, pizzo, 69, 7 2 *.<br />
C odogna, roggia, 295.<br />
Codogno, 237.<br />
C oira, 13 .<br />
C o l e t t i F . , 2 3 4 .<br />
C olico, 387 448.<br />
Colico, 1. di, 104, 10 4 * , 10 5.<br />
C 0 L L E O N I, c a s a d e i, 4 9 7 .<br />
C ollio, 14 3 , 432.<br />
Colognola, 502.<br />
C olom bana, roggia, 120.<br />
C olom bine, m t., 86.<br />
C o l o m b o G i u s e p p e , in g e g n e r e ,<br />
360.<br />
G oloniola, 489.<br />
Golzate, 80.<br />
Gom abbio, 1. di (Varano, 1. di),<br />
20, 90, l o i . III, 1 1 3 , 458.<br />
Com asco, 73, 158 , 17 4 , 17 6 ,<br />
258, 262, 2 7 1, 3 10 , 3 2 1, 324,<br />
346, 374, 387, 4 4 ° - 4 4 3 > 5 3 3 -<br />
Com asco, coll., 3 19 , 3 3 1 , 442.<br />
C o m m e r c io , 389-390.<br />
Com m essaggio, can., 299.<br />
C om o (Novum Comum), 2 4 , 2 8 ,<br />
3 1 , 3 1 * , 1 0 4 , 1 0 7 , 1 4 7 , 1 5 2 ,<br />
1 6 9 , 1 7 9 , 1 8 0 , 1 8 3 , 2 0 0 , 2 3 6 ,<br />
3 4 8 , 3 6 6 , 3 7 4 , 3 8 1 , 3 8 9 , 4 0 4 ,<br />
489-496, 4 9 0 * - 4 9 S * . 5 2 9 , 5 3 0 .<br />
C om o, prov., 179 , 1 8 1 , 199, 2 15 ,<br />
238, 344, 352, 376, 383, 440-<br />
448, 536, 537-<br />
Com o, 1. di, V. L ario , 1.<br />
Comum, V. Com o.<br />
C o m u n ic a z io n i, 58, 59, 62,<br />
76, 77, 16 5, 390-399, 3 9 1* ,<br />
39 2 *, 3 9 4 * - 3 9 8 *, 4 0 2 ’*, 428,<br />
456, 471-<br />
C o n fin e it a lo - s v iz z e r o , 3 * ,<br />
4 *, 5 - 13 , 8*, IO * , 60.<br />
C o n f i n i i n t e r r e g i o n a l i ,<br />
14 * , 1 4 - 1 5 , 60.<br />
CONSOLINI L ., 4 2 5 .<br />
C onvenduna, roggia, 296.<br />
Coppa, torr., 129.<br />
C orbetta, 246.<br />
CoRio Bernardino, storico, 468.<br />
CoRio F . G i r o l a m o , s c r i t t o r e<br />
d i a l e t t a l e , 2 8 3 .<br />
Corm ano, 378.<br />
C orna B iacca, m t., 87.<br />
C orna G rande, m t., 84.<br />
C orna R ossa, m t., 63.<br />
Cornacela, m t., 65.<br />
C ornegliano Laúdense, 356.<br />
C ornelio, 438.<br />
C o rn i B ruciati, m t., 63.<br />
C o rn i di Canzo, m t., 82, 8 3*.<br />
Cortem aggiore, 358.<br />
Còrteno, V ., 57, 72, 78, 126,<br />
4 3 4 .<br />
Cortenuova, 244.<br />
C o r t i, zona di, 2 4 7 *, 2 5 2 * .<br />
Cosia, torr., 489, 493, 494, 496.<br />
C o s t a n z a , p a c e d i , 3 3 .<br />
Crem a, 3 1 , 32 , 39, 200, 228,<br />
237, 284, 4 22, 4 22*, 4 2 3 * .<br />
C rem asco, 3, 17 4 , 2 33, 253, 254,<br />
264, 325, 369, 4 2 1, 422.<br />
C rem ona (Cremona), 24, 33, 140,<br />
179 , 228, 237, 278, 284, 366,<br />
368, 3 7 1 , 376, 3 8 1, 383, 387.<br />
389. 5 16 - 5 2 1, 5 i 7 * - 5 2 i * , 529.<br />
Crem ona, prov., 18 1, 200, 2 15 ,<br />
352, 366, 375.<br />
Crem onese, 20, 2 1, 174 , 17 8 ,<br />
18 2, 2 12 , 246, 264, 299, 303,<br />
3 10 , 334 , 3 3 5 , 369, 373, 374,<br />
4 2 1. 423. 5 3 4 -<br />
Crem onese, pian., 306*.<br />
Crescenzago, 3 7 1.<br />
C resm ero, can., 299.<br />
C ristallo, m t., 66.<br />
C roce D om ini, p ., 68, 86, 4 3 1.<br />
Curtatone, 2 33, 425.<br />
C usano M ilanino, 375, 385.<br />
D<br />
D agò, 244.<br />
D alm ine, 377, 379 *.<br />
Dandolo V incenzo, scienziato<br />
e patriota, 308.<br />
D arfo, 377, 433.<br />
D e i B e n e d e t t o , s c r i t t o r e , 2 8 2 .<br />
D e l l a T o r r e , c a s a d e i :<br />
P a g a n o , 3 4 ; N a p o , 3 4 ; 4 4 5 ,<br />
498, 504-<br />
D ella Valle Carlo, geografo,<br />
444.<br />
D elm ona, can., 29g.<br />
D entro, V . di, 18 2, 260, 4 5 3 *.<br />
D ervio, 106, 19 3 * , 243, 448.<br />
D esenzano, 109, 2 3 4 * , 428.<br />
D esio, 236, 376, 4 14 .<br />
Desio A rdito, geologo, 290.<br />
D ezzo, 377.<br />
D ezzo, f., 126, 433, 436.<br />
D ezzo, V . del, v. Scalve, V .<br />
D i a l e t t i : 2 71-278 .<br />
D iavolo, 1. del, 360.<br />
D iavolo, pizzo, 70.<br />
D iavolo di T en d a, pizzo, 70.<br />
D im o r e : 247-266, 2 5 0 *-2 5 8 *,<br />
265*.<br />
S6 8
D isgrazia, m t., 56, 5 7 * , 6 1* ,<br />
62-64, 99> 148-<br />
D isgrazia, ghiacc. del, 64.<br />
D om aso, 243.<br />
D ongo, 14 7, 448.<br />
D osdè, pizzo, 65, 66*, 99.<br />
D uana, pizzo, 6 1.<br />
Dunant E nrico, letterato, filantropo,<br />
427.<br />
Dungal, religioso, 28.<br />
D u o m o , V. C h ie s a .<br />
Edolo, 78, 4 3 3 * , 434.<br />
Elena, can., 119 .<br />
E llo , 442.<br />
Em et, pizzo d ’, 6 1.<br />
E m ilia-R om agn a, 17 , 286, 337.<br />
Èndine, 354.<br />
Èndine, 1. d ’ (Spinone, 1. di), 86,<br />
99, ІЮ ,* ІЮ , 12 7 , 4 35*. 436.<br />
Enna, gola d ell’ , 438, 439.<br />
Enna, torr., 124.<br />
E rb a, 244, 269*, 376, 377, 442.<br />
E ridio, 1. (Idro, 1. d ’), 15 , 80.<br />
99, 10 9 * , 10 9 , n o , 2 12 , 4 3 1.<br />
Eruli, pop., 26.<br />
E ste, Isabella d’, 44.<br />
Etruria, 22.<br />
Etruschi, pop., 19 , 22, 18 3.<br />
E u p ili, 1. (Pusiano, 1. di), 20, 90,<br />
III, III* , 1 1 3 , 440.<br />
F ara, colle della, 496.<br />
Fasano, 19 2 * , 243.<br />
F a u n a , 16 3 -16 4 , 3 3 7 , 339,<br />
34 0 *, 3 4 1, 3 4 1 * , 34 2 * , 34 3-<br />
344. 417-<br />
Fellaria, ghiacc. di, 64, 9 6 *, 99.<br />
F errari G audenzio, pittore,<br />
413. 414-<br />
F ilarete, A ntonio A verlino<br />
detto il, architetto, 499.<br />
F ilelfo F rancesco, umanista,<br />
4 1.<br />
Finsteraarhorn, m t., 58.<br />
Fium elatte, 344.<br />
Fium elatte, sorgente, 136 .<br />
F i u m i , 1 1 4 - 1 3 3 .<br />
Fium icello, f., 73, 126.<br />
F ogazzaro A ntonio, scrittore,<br />
448.<br />
F o lla d ’ Induno, 88.<br />
F o n t a n i l i , 93, 1 1 7 , 13 2 * ,<br />
1 3 3 - 13 6 , 13 4 * , 204, 290, 299,<br />
333. 406, 4 17 .<br />
Fòppolo, 148, 404, 438, 439 *.<br />
Fórcola, p. della, 60.<br />
F orlanini Carlo, medico, 221.<br />
Formico, pizzo, 86.<br />
Forno, ghiacc. del, 67, 9 7*, 99.<br />
Foscagno, m t., 65.<br />
Foscagno, p., 65, 77.<br />
F oscolo U go, poeta, 48, 221,<br />
400, 417.<br />
Fraele, 1. di, 1 2 1 .<br />
F raele, p., 65.<br />
F raele, V . di, 77, 1 2 1 .<br />
Franchi, pop., 26, 28, 497, 509.<br />
Franciacorta, 89.<br />
F ranconia, casa di:<br />
Corrado II, 29; E nrico III,<br />
29; F ederico Barbarossa, 32-<br />
33; E nrico V I, 33.<br />
F rattini S., 349.<br />
Frod olfo, f., 1 2 1 .<br />
Fu m o, m t., 67.<br />
Fu sia, roggia, 297.<br />
Fusio , 356.<br />
G aggiano, 283.<br />
Galavesa, torr., 124.<br />
G aldino, arcivescovo, 33.<br />
Gallarate, 179, 227*, 236, 348*,<br />
349. 372. 381. 383. 412. 413.<br />
458. ^<br />
G alleggione, pizzo, i i , 6 1.<br />
Galli Cenomani, pop., 23, 496,<br />
S03. S°9 . 516, 522.<br />
Galli Insubri, pop., 19, 23, 408,<br />
409, 459.<br />
G allina, pizzo, 58.<br />
G allio T olomeo, cardinale,<br />
400, 446.<br />
G am bara, rio, 297.<br />
G andino, 354, 3 7 5 * , 376, 437.<br />
G anna, 1. di, loi.<br />
Garda, 1. di, v. Benaco, 1.<br />
Garda, coll, del 1. di, 89.<br />
Garda, is. di, 109.<br />
G ardesana, strada, 4 0 2*, 428.<br />
G ardone, 19 8 *, 403, 429.<br />
G ard one V al T ro m p ia, 432.<br />
G argn an o, 403, 429.<br />
Garlate, 1. di, 106, 124, 440-<br />
Garza, f., 431.<br />
G arza, V . del, 4 3 1.<br />
G arzirola, m t., 60.<br />
G avard o, 376, 430.<br />
G avia, p., 65, 67, 77, 169.<br />
G avirate, 376.<br />
G azzada, 456.<br />
G em elli, 1., 1 1 3 .<br />
G emelli A gostino, religioso,<br />
psicologo, 223.<br />
G eneroso, m t., 82.<br />
G enova, 18 , 530.<br />
G enova, V . di, 67.<br />
G eolitologico, schem a, 56 *.<br />
G era, 106.<br />
G erenzone, torr., 106 , 12 4 , 243,<br />
4 4 4 ;<br />
G erm ignaga, 100.<br />
G erundo, L, 4 2 1, 422.<br />
G h ia c c ia i, i i * , 58, 64, 67,<br />
68, 9 6 *, 97-99.<br />
G h irla, 1. di, loi.<br />
G ino, pizzo di, 60.<br />
G i o c h i , d a n z e , 269*, 2 7 1.<br />
G ioia M elchiorre, scrittore,<br />
307. 3 10 , 345.<br />
G io vi, p., 18.<br />
G iulini G iorgio, storico, 33.<br />
G iu lino, 447.<br />
G iulio R omano, pittore e architetto,<br />
525.<br />
G iussano, 238, 376.<br />
G leno, m t., 70.<br />
G leno, torr., 436.<br />
G liischaint, m t., 64.<br />
G odiasco, 4 2 1.<br />
G oito, 425.<br />
G olasecca, 2 1, 22, 118 .<br />
G onzaga, 228.<br />
G onzaga, casa dei 423, 426,<br />
427. 525, 527:<br />
L uigi I, 3 9 , G uido, 3 9 ;<br />
L uigi II, 3 9 ; F rancesco I,<br />
39 ; G ian F rancesco, 39 ;<br />
426, 4 2 7 ; L uigi III, 40: F e<br />
derico II, 44; F rancesco III,<br />
4 4 ; G uglielm o, 4 4 ; V in <br />
cenzo I, 44, 45 ; L uigi, santo,<br />
524-<br />
G orgonzola, 3 7 1, 409.<br />
G orlago, 376.<br />
G orno, 356.<br />
Goti, pop., 26, 462.<br />
G ottardo, ferr., l o i , 209, 350,<br />
4 5 2 .<br />
G ra n Z eb rù , m t., 14 , 68*.<br />
G ravedona, 243, 387, 448.<br />
Greenfield K . R ., econom ista,<br />
288.<br />
G rign a, f., 126.<br />
G rign e, m t., 79, 82, 84*, 89*,<br />
4 4 3 . 4 4 5 -<br />
G rom o, 2 0 5*, 437.<br />
G rosina, V ., s s , 1 2 1 .<br />
G rosio, 2 7 1, 3 S3 -<br />
G rossi T ommaso, scrittore, 284.<br />
G uglielm o, m t., 86.<br />
G uidana, roggia, 296.<br />
G üzza, cresta, S5 *.<br />
569
H<br />
Hostilia, V. O stiglia.<br />
Idro, 1. d ’, V. E ridio, 1.<br />
Im agna, torr., 124.<br />
Im agna, V ., 80, 84, 12 4 , 4 38 , 439.<br />
Incino, 244.<br />
I n d u s t r i a :<br />
286-288, 345-387. 347*. 349*.<br />
351*. 355*, 358*, зб7*-372*.<br />
3 7 4 * -3 8 s *. 388*, 4 11*, 412,<br />
431. 434, 439, 478*, 479*,<br />
513*<br />
Inferiore, 1., 12 8 , 12 9 , 523.<br />
Inn, f., 62.<br />
Inn, V . d ell’ , 62.<br />
Insubria (Is-Ombria), 19.<br />
Intelvi, V ., 82, 446.<br />
Introbio, 445.<br />
Introbio, V . di, 445.<br />
Inverigo, 442.<br />
I r r i g a z i o n i , 30 0 *.<br />
Isella, pen. d ’ , 1 1 3 .<br />
Iseo, 432.<br />
Iseo, 1. d ’ , V. Sebino, 1.<br />
Iseran, p., 65.<br />
Isolacela, 2 6 1.<br />
Isola b iro , 6 1.<br />
Isolino, 19.<br />
Isolino, is., 1 1 3 .<br />
Is-Ombria, v. Insubria.<br />
I s t i t u t i c u l t u r a l i , 2 18 , 2 19 -<br />
224, 2 2 0 * -2 2 3 * .<br />
Italia, regno d ’ , io , 28, 468, 5 19 .<br />
Italiae, regnum, 26, 17 9 * , 509.<br />
J acini Stefano, uom o politico,<br />
308, 3 12 , 3 2 1.<br />
J elmoni F . A imone, ingegnere,<br />
3 9 3 -<br />
Jerago, 378.<br />
К<br />
K ennedi, punta, 63.<br />
Laevi, pop., 509.<br />
L a g h i , 5, 19 , 20, 20*, 72, 80,<br />
86, 90, gì*, 9 9 -114 , 14 2 , 243.<br />
L ago, pizzo del, i i .<br />
Lagoscuro, punta del, 67.<br />
Lainate, 32 0 *.<br />
L aiulfo, vescovo, 28.<br />
Lam bro, f., 1 1 4 , 1 1 9 * , 1 2 1 ,<br />
1 3 1 . 13 5 . 372, 408, 4 10 , 4 17 .<br />
Lam brone, £ , 1 1 3 , 1 2 1 .<br />
L andini Piero, geografo, 17 3 .<br />
Langobardi (Longobardi), pop.,<br />
I, 26, 28, 409, 463, 497, 503,<br />
509. 5 16 , 522.<br />
Langobardia (Pannonia), i, 2.<br />
Lanzada, 353.<br />
Lanzo, 446.<br />
Laorca, V . di, 445.<br />
L a Polada, 428.<br />
L a R asa, 119 .<br />
L arghi Pietro C ., poeta d ialettale,<br />
283.<br />
L ario , 1. (Com o, 1. di), 53, 60,<br />
76, 78, 82, 89, 9 1 * , 99, 10 3 * ,<br />
10 5 * , 10 4 -10 7 , 12 2 , 12 4 , 15 5 * ,<br />
15 7 . 1 6 1 , 164, 16 6 * , 243, 3 3 1,<br />
3 4 4 . 387. 3 9 9 . 4 °o . 403. 440.<br />
445*-448*. 489.<br />
Lario , 1., bac. del, 169.<br />
L ascaris Costantino, um anista,<br />
4 1.<br />
Laus Pompeia, v. L o d i Vecchio.<br />
L aven o, 19 5 * , 456 *, 458.<br />
Lecch ese, 268*, 346.<br />
Lecco, 104, 124, 169, 234*, 236,<br />
243. 350, 376, 377, 383, 443*,<br />
4 4 3 - 4 4 4 -<br />
L ecco , 1. di, 82, 89, 10 5 , 1 1 3 ,<br />
4 4 3 *-<br />
L e ffe, 436.<br />
Legnano, 3 2 * , 236, 238, 272,<br />
372 , 3 7 2 * , 377, 38 3, 387, 4 12 .<br />
Legnon e, m t., 70, 169, 443.<br />
L e i, p. di. I I .<br />
L e i, V ., I I .<br />
Lenate, 372.<br />
L enna, 12 4 , 2 4 5 *.<br />
Lerm o, 447.<br />
L e Prese, 78.<br />
L èsim a, m t., 15 , 16 , 94.<br />
L e t t e r a t u r a d ia le t t a le , 278-<br />
284.<br />
Leven tin a, V ., 59, 76, 118 .<br />
Lèzzeno, 243.<br />
L igòncio, pizzo, 62.<br />
L igu re, m ., 18.<br />
Liguri, pop., 19 , 18 3, 459, 503,<br />
509-<br />
L igu ria, 199, 376.<br />
Liguria, ant. prov., 23.<br />
L im o n e sul G ard a, 14 2 ’*, 429.<br />
L inate, aeroporto di, 399.<br />
L inati Carlo, scrittore, 4 41.<br />
L iro , f., 10 7, 12 2 .<br />
L iro , V . del, 72, 2 10 , 448.<br />
Lisson e, 2 2 8 *, 236, 387, 4 14 .<br />
LiSTZ F ranz, m usicista, 400.<br />
Livign asco, 99.<br />
L ivign o , 18 2 , 240, 2 5 5 * , 265,<br />
328.<br />
L ivign o , V . di, 12 , 1 3 * , 260.<br />
L iv o , V . del, 2 10 .<br />
L ivrio , torr., 1 2 1.<br />
L o d i, 179 , 228, 2 3 2 * , 376, 4 14 * ,<br />
4 15 , 4 16 , 530.<br />
L o d i, prov., 200.<br />
L o d i V ecchio (Laus Pompeia),<br />
415-<br />
L od igiano, 17 4 , 17 8 , 2 33, 246,<br />
2 4 7 *. 253. 254, 264, 299, 303.<br />
3 17 . 369. 3 7 3 . 4 15 - 4 17 . 3 1 3 * .<br />
4 16 * .<br />
L omazzo G iovanni Paolo, 282.<br />
Lom b ard a, coll., 5 0 * , 5 1 , 87-89,<br />
15 7 , 200-204, 243, 244, 255-<br />
258, 264.<br />
L om bard a, pian., 16 , 17 , 50 *,<br />
90-94, 9 2 *, 13 0 , 13 7 , 13 8 -14 2 ,<br />
14 5 -14 6 , 150, 15 7 , 17 5 * , 200-<br />
204, 244-247, 255-258 , 263-<br />
264, 2 8 7 *, 3 0 7 * , 3 1 1 * , 3 1 5 * ,<br />
3 1 8 * , 3 2 2 * , 3 2 4 * , 3 3 2 -3 3 5 .<br />
366.<br />
L ombarda, lega, 33, 434, 498,<br />
504, 518.<br />
L ombardo-Veneto, regno, 3,<br />
IO, 48, 5 19 .<br />
Lom ellina, 46, 1 7 3 , 17 4 * , 178,<br />
1 8 1 , 19 4, 2 12 , 2 33, 246, 253,<br />
258, 264, 334 , 3 7 3 , 4 17 , 4 18 ,<br />
536.<br />
Lom ello, 17 3 , 4 18.<br />
Lon ato, 240 *, 428.<br />
Longobardi, v. Langobardi.<br />
Longobardorum, regnum, 26.<br />
L o ra , 496.<br />
L oreto, is., 108.<br />
L oven o , 14 7.<br />
L ò vere, 432.<br />
Lucen dro, pizzo, 58.<br />
Lucom agno, p., 58, 59, 530.<br />
Lugan o , 10 2.<br />
Lugan o , 1., V. C eresio, 1.<br />
Luin ese, 60.<br />
L uini Bernardino, pittore, 413,<br />
414.<br />
L u in o , 458.<br />
Lum ezzano, 377 , 378.<br />
L u ra , torr., 1 1 5 , 289, 4 13 , 462.<br />
L uzzatto G ino, storico d ell’econom<br />
ia, 350, 5 3 1.<br />
M<br />
M acherio, 376.<br />
M adern o, 243.<br />
M adéslm o, 404.<br />
M agadino, pian, di, 118 .<br />
M agasa, 244*.<br />
M agenta, 18 7 * , 385, 408.<br />
5 7 0
M aggi C arlo M aria, scrittore,<br />
283.<br />
M aggia, f., 100.<br />
M aggia, V ., 59.<br />
M aggiore, 1., V. Verbano, 1.<br />
M agreglio , 243.<br />
M alenco, V ., 56, 63, 75, 78,<br />
1 2 1 , 3 5 3 , 356, 363, 4 4 9 -<br />
M algin a, torr., 1 2 1 .<br />
M aliern, f., 1 2 1.<br />
M alnate, 88, 458.<br />
M aloggia, p. (M aloià), 13 , 59*,<br />
6 1, 6 2, 12 2 .<br />
M aloia, p ., V. M aloggia, p.<br />
M alpensa, aeroporto di, 399.<br />
M andello del L ario , 106 , 243,<br />
378, 3 8 1, 4 4 4 .<br />
M androne, ghiacc. del, 67, 68, 99.<br />
M androne, m t., 67.<br />
M anerbio, 376.<br />
M an g ia ga lli L u ig i, ostetrico,<br />
223.<br />
M an iva, p. di, 4 3 1.<br />
M a n t e g n a A n d r e a , p itto re,<br />
525-<br />
M an to va (Mantua), 24, 28, 39,<br />
46, 140, 14 2 , 146, 179 , 228,<br />
237, 3 1 3 . 3 5 9 , 3 8 1, 38 3, 389,<br />
404, 522-528 , S 2 3 * -5 2 7 * , 529,<br />
5 3 7 -<br />
M antova, ducato d i, 2, 39, 40.<br />
M antova, prov., 179 , 1 8 1 , 194,<br />
200, 2 15 , 2 19 , 303, 336, 352,<br />
366, 375, 425, 534-536 .<br />
M antovano, 20, 2 1, 17 4 , 17 8 ,<br />
18 2 , 2 12 , 2 33, 246, 254, 258,<br />
264, 303, 3 10 , 32 5, 334 , 3 5 4 ,<br />
373, 3 7 4 , 4 24 *, 424-427.<br />
M anzoni A lessandro, scrittore,<br />
4 5 , 442, 4 4 4 , 4 4 5 -<br />
M archirolo, V ., 8 1, 458.<br />
M argh era, 359.<br />
M argu a, pizzo, 62.<br />
M arian o Góm ense, 3 8 5 ,3 8 7 , 443.<br />
Mariai, p op., 509.<br />
M aridati A lessandro, 124.<br />
Mariguana, v. M elegnano.<br />
M arobbia, V ., 72.<br />
M artesana, can. della, 124, 178.<br />
M artinengo, 434.<br />
M arzano, 353.<br />
M arzano, can., 296.<br />
M arzio, 18 2.<br />
M a s c h e r e , 283.<br />
M ascheroni L orenzo, matematico,<br />
2 2 1, 5 15 .<br />
M àsino, f., 12 1 .<br />
M àsino, V ., 55, 62, 72, 75, 78,<br />
I 2 I , 2 5 3 * , 353.<br />
M aslianico, 18 2, 387.<br />
M atteo da C am pio ne, arch i<br />
tetto, 4 10 .<br />
M ed a, 238, 387, 4 15 .<br />
M ed el, piz, 58.<br />
Mediolanum, v. M ilano.<br />
M elegnano (Mariguana), 349,<br />
408.<br />
M elid e, lo i .<br />
M ella, f., 1 1 4 , 12 7 , 297, 299,<br />
304, 4 3 1, 503, 508.<br />
Melpum, 459.<br />
M elzo, 3 7 1, 409.<br />
M enaggio, 10 5 , 19 9 *, 243, 403,<br />
447.<br />
M enaggio, V . (M enaggina), 60,<br />
447.<br />
M enaresta, sorgente, 1 2 1 , 13 5 .<br />
M engoni G iu se p p e, architetto,<br />
471.<br />
M era, f., 78, 10 5, 12 2 , 445, 4 5 1,<br />
452.<br />
M era, V , della, 75, 16 6 *.<br />
M erate, 400, 442.<br />
M eraviglie, grotta delle, 438.<br />
M ercurago, 19.<br />
M erla, f., 445.<br />
M erlata, torr., 462.<br />
M e r l in i G iovanni, geografo,<br />
333.<br />
M erone, 88, 355.<br />
M esolcina, V ., 76.<br />
M e t a n o d o t t i, 358 *.<br />
M etanopoli, 1 9 1 * , 358, 359 *.<br />
M ezzo, 1. di, 12 8 , 523.<br />
M ezzola, 1. di, 60, 78, 10 5,<br />
449.<br />
M ilanese, 2 1, 174, 176 -177,<br />
2 12 , 253, 264, 305, 3 10 , 3 14 ,<br />
346, 368, 369, 372, 378, 380,<br />
384. 387. 4 0 5-4 15. 533.<br />
M ilanese, pian., 30 8 *, 3 14 * ,<br />
3 16 * , 406.<br />
M ilan o (Mediolanum), 2, 17 , 24,<br />
2 4 *, 26-33, 47, 4 7 * , 13 8 * ,<br />
140, 14 1 , 14 4 * , 14 5. 147.<br />
15 2 , 15 4 , 179 . 18 3 . 18 5 * . 199.<br />
220, 2 2 1* , 228, 267, 269, 270,<br />
272, 278, 234-236, 283, 345,<br />
348, 350. 366, 369, 374, 376,<br />
378, 3 8 1, 38 3-387. 389. 39 0 *,<br />
392, 404, 459-486, 460*, 484,<br />
529. 531. 535-538.<br />
M ilano, prov., 1 8 1 , 189, 19 2-<br />
19 4, 199, 200, 2 15 , 2 17 , 233,<br />
238, 3 14 . 336, 352, 366, 380,<br />
383, 387. 389. 534 -536 .<br />
M ilan o, ducato d i, 6, 34-46,<br />
184, 196, 4 15 , 5 19 .<br />
M ilano, stato d i, 2, 38, 4 1,<br />
184, 227, 305.<br />
M iller, corno, 68.<br />
MiLONE F erdinando, geografo,<br />
352, 362, 378.<br />
M incio, f , 4, 15 , 17 , 1 1 4 , 12 7 * ,<br />
12 7-129 , 1 3 1 , 13 2 , 178 , 289,<br />
425. 522.<br />
M i n i e r e , c a v e , 2 9 1, 353-<br />
355. 354*. 355*. 356. 377.<br />
429. 431. 432.<br />
M iorina, 118 .<br />
M iradolo, 4 17 .<br />
M issaglia, 35 5 , 383.<br />
Madida, v. M onza.<br />
M oesa, f., 118 .<br />
M oggio, 80.<br />
M oglia, 233.<br />
M òlgora, torr., 1 1 5 , 1 2 1 , 296.<br />
M oltrasio, 400, 446.<br />
M o n a s t e r o , v. Chiese.<br />
M onastero, V ., 76.<br />
M onate, 1. di, 20, 90, l o i , i n ,<br />
1 1 3 , 164, 458.<br />
M ontaldo Pavese, 4 2 1.<br />
M ontanaro Lom bard o, 3 19 * .<br />
M ontechiari, brughiera, v. B re <br />
sciana, pian.<br />
M onte Lon ato, 2 1, 240*.<br />
M ontesiro, 244.<br />
M ontespluga, 207.<br />
M ontevecchia, 400, 4 4 1.<br />
M onticello, 244.<br />
M ontichiari, 428.<br />
M ontisola, is., 8 0 ,1 0 7 ,10 7*, 432.<br />
M onti V incenzo, poeta, 2 2 1.<br />
M ontòrfano, coll, del, 88.<br />
M ontòrfano, 1. di, 90, i n ,<br />
1 1 3 , 440.<br />
M onza (Madida), 26, 228, 236,<br />
349. 371. 372. 376. 383. 408*,<br />
409*. 409-410. 53°.<br />
M o ra, V ., 69.<br />
M orbegno, 2 16 , 242, 246*, 368,<br />
450.<br />
M orgorabbia, V . della, 8 1.<br />
M origallo, m t., 443.<br />
M ortara, 237, 376, 420.<br />
M orterone, 439.<br />
M otta A n g elo, industriale,<br />
367.<br />
M ottarone, m t., 1 1 7 .<br />
M uggiasca, V ., 445, 448.<br />
M u ggiò, 238.<br />
M uratori L udovico, storico, 48.<br />
M uretto, p., 12 , 62.<br />
M u s e i , V. B i b l i o t e c h e .<br />
M usso , 354.<br />
M usso lini B en ito , 447.<br />
571
M uzza, can., 1 2 1 , 12 4 , 289,<br />
293-296, 2 9 3*.<br />
N<br />
N angeroni G iu seppe, geografo,<br />
98, 2 4 1.<br />
N ave, 387.<br />
N avigliaccio, can., v. N aviglietto,<br />
can.<br />
N aviglietto, can. (N avigliaccio),<br />
292, 299.<br />
N aviglio di Bereguardo, can.,<br />
293. 407. 417-<br />
N aviglio di G aggiano, can. (G a <br />
zano), 2 9 1.<br />
N aviglio di G azano, can., v. N a <br />
viglio di G aggiano, can.<br />
N aviglio di G o ito , can., 297.<br />
N aviglio G rande, can., 118 , 289,<br />
290, 2 9 1* , 399, 466.<br />
N aviglio G ran d e bresciano, can.,<br />
12 7 , 297, 504.<br />
N aviglio della M artesana, can.<br />
(N aviglio Piccolo), 294*, 295*,<br />
296, 409.<br />
N aviglio di Pavia, can., 289,<br />
292-293, 292*, 4 17 .<br />
N aviglio Piccolo, can., v. N a <br />
viglio della M artesana, can.<br />
N em bro, 378, 436.<br />
N ero, 1., 1 1 3 .<br />
N esso, 387, 446.<br />
N irone, torr., 462, 468.<br />
N oce, f., 126.<br />
N ossa, 436, 437.<br />
N ovara, 3 1 .<br />
N ovarese, 46, 1 1 7 .<br />
N ovarolo, can., 299.<br />
N ovena, p. di, 58, 59, 75,<br />
118 .<br />
Novum Comum, v. Como.<br />
N ozza, 430.<br />
N u d o, m t., 8 1.<br />
N uoro, p rov., 200.<br />
N uvolento, 354.<br />
N u volera, 353.<br />
N uvolone, m t., 15 4 * .<br />
О<br />
O ggiono, 1. di, V. A nnone, 1. di.<br />
O gionno, 1. di, V. A nnone, 1. di.<br />
O glio, f., 73, 79, 10 7, 108, 114 ,<br />
i i S , 1 1 7 , 12 5 - 12 7 , 12 6 * , 1 3 1 ,<br />
13 2 , 169, 178 , 297, 299, 304,<br />
364, 432, 4 3 4 -<br />
Oglio, V. dell’, V.<br />
nica, V.<br />
Oíate, 444.<br />
Valcamò-<br />
O lginate, 1. di, 106 , 12 4 .<br />
O lm o al Brem bo, 355.<br />
O lona, f., 1 1 4 , 119 - 1 2 0 , 1 3 1,<br />
289, 462.<br />
O lona, V . d ell’ , 387.<br />
O ltre il C olle, 440.<br />
O ltrem incio m antovano, 178.<br />
O ltrepò m antovano, 15 , 17 , 23,<br />
46, 17 3 , 178.<br />
O ltrepò pavese, 15 , 17 , 23, 46,<br />
94. 94*. 129, 146, 17 3 , 178,<br />
18 1 , 2 33, 2SS, 263, 325, 32 6 *,<br />
3 S4 . 3 5 5 . 36 8 *, 373, 4 17 . 4 2 1,<br />
536.<br />
O ltrepò pavese, coll., 3 3 1.<br />
O neta, 356.<br />
O ria, 448.<br />
Orobi, pop., 489, 496.<br />
O rties, m t., 66, 148.<br />
O rselina, 16 3.<br />
O rzinuovi, 246.<br />
O spitaletto, 378.<br />
O ssi, 356.<br />
O stiano, 20.<br />
O stiglia (Hostilia), 18 3, 426.<br />
Padania, 196.<br />
Paderno, 12 4 , 352, 378.<br />
Pagherà, f., 126.<br />
Paiolo, 1. prosciugato, 129, 523.<br />
P a la z z i ;<br />
Bergam o (N uovo, 499, 501 ;<br />
Suardi, 498; Vecchio, 501).<br />
B orm io (Collegiata, 450).<br />
B rescia (Broletto, 504, 5 0 7 * ;<br />
del C om une, 505 ; M artinengo,<br />
507; M onte N uovo,<br />
506; M onte V ecchio, 506).<br />
Com o (Broletto, 493 * ; tem pio<br />
Voltiano, 492).<br />
C rem ona (Fodri, 5 19 ; del<br />
Popolo, 5 17 , 518 ).<br />
M aggiore, 1. (Borrom eo, 400).<br />
M an to va (A rengario, 5 2 4 ; B o-<br />
nacolsi, 524; Broletto, 524;<br />
C apitano, 524 ; M agn a D o-<br />
m us, 524; della Ragione,<br />
524).<br />
M ilano (B roletto, 466; C à<br />
G rande, 485 ; dei G iu reco n <br />
sulti, 466; L a Scala, 468,<br />
4 7 1* , 484: M arino, 4 7 3*,<br />
484; O sii, loggia degli, 484;<br />
della Ragione, 466, 484;<br />
Reale, 470, 485 ; U niversità<br />
Cattolica, 223 * ; U niversità<br />
degli Studi, 2 2 1* ) ;<br />
P a l a z z i :<br />
Pavia (U n iversità degli Studi,<br />
2 18 * , 2 2 0 ’*').<br />
Sabbioneta (D ucale, 426 ; del<br />
G iardino, 426).<br />
Palazzolo, 376.<br />
P a lla v ic in i U berto, 518.<br />
Pallavicino, roggia, 297.<br />
Palòn della M are, m t., 66.<br />
Paiosco, 373.<br />
Palù, 1., 1 1 3 .<br />
Palò, pizzo, 12 , 64.<br />
Pannonia, v. Langobardia.<br />
Pan Perducto, fosso, 289.<br />
Papia, v. Pavia.<br />
Parabiago, 387.<br />
Parina, torr., 12 4 , 439.<br />
Parina, V ., 85, 124.<br />
P arin i G iu seppe, poeta, 417,442.<br />
Parre, 356.<br />
P a s s i , 8 , 10 -14 , 15 * . i6 *.<br />
18, 57-60, 65, 67-69, 72, 73*,<br />
75-78, 84, 86, 118 , 12 1, 122,<br />
126, 129, 169, 170, 17 1, 3 5 1,<br />
451. 433. 436. 439-<br />
Pasturo, 445.<br />
P atecchio G irardo, scritt., 278.<br />
Pavese, 174, 17 8 , 18 1, 182, 194,<br />
2 12 , 233, 246, 253, 264, 2 71,<br />
309*. 346, 369. 417. 536.<br />
Pavia (Ticinum, Papia), i, 24,<br />
2 5 ’*', 26, 29, 3 1, 140, 179, 183,<br />
220, 220*, 228, 237, 284, 366,<br />
376, 380, 38 1, 383, 385, 387,<br />
50 9 -516 , 5 io ’* -5 i5 * , 530, 537.<br />
Pavia, p rov., 18 1, 182, 19 2-195,<br />
200, 2 14 , 2 15 , 334, 336, 352,<br />
366, 375, 4 17. 535-537-<br />
P ecora A ldo, geografo, 509,<br />
513. 516.<br />
Pedem osso, 2 6 1.<br />
P edreschi L u ig i, geografo, io.<br />
P e l l e g r in i G ., 345.<br />
P e l l e g r in i, T ibald i P e l l e g r i<br />
no, detto, architetto, 410, 412.<br />
P ellico S ilv io, patriota, scrittore,<br />
400, 447.<br />
Pénice, m t., 94.<br />
Pero, 238, 4 12 .<br />
Perrucchetti, m t., 12 , 16.<br />
P e s c a , 287, 3 4 3- 3 4 4 . 3 4 3 * . 432.<br />
Pescarenico, 444.<br />
Pescaù, 243.<br />
Peschiera, 432.<br />
Pezzate, 356.<br />
Piacenza, 33, 223, 255, 5 3 7 -<br />
Piadena Sergnano, 356, 423.<br />
Piazza Brem bana, 437, 438.<br />
Piazzi, cim a d e’, 65, 99.<br />
572
Piazzo, m t., 84.<br />
Piem onte, 15 , 49, 9 5 . 286, 352,<br />
364. 376-<br />
P ie n e , V. A l l u v i o n i .<br />
PiERMARiNi G iu se p p e, arch i<br />
tetto, 4 10 .<br />
Pietole V irgilio (Andes), 21, 425.<br />
P ietro, arcivescovo, 28.<br />
P ietro da B arsegapè, scrittore,<br />
2 7 9 -<br />
Pigra, 446.<br />
P io X I, papa, 414.<br />
Piom bo, buco del, 19, 442.<br />
Pioverna, f., 107.<br />
P iras A ugusto, 241.<br />
P ir e l l i G iovanni B attista,<br />
industriale, 385.<br />
Pirola, 1., 1 1 3 .<br />
Pisgana, punta, 67.<br />
Pisogne, 377 , 432.<br />
P iten tin o A lberto, architetto,<br />
179 .<br />
Piuro, 6 1.<br />
Pizzighettone, 23 6 * ,2 4 7 ,3 8 5 ,4 2 3 .<br />
Pliniana, sorgente, 13 5 , 446.<br />
P lin io , il G iovane, scrittore<br />
latino, 13 5 , 446, 447.<br />
P l in io , il V ecchio, scrittore<br />
latino, 13 s , 446.<br />
Po, f., 4, 15 , 18 , 1 1 4 , 1 1 7 , 118 ,<br />
1 2 1 , 12 7 , 12 8 , 12 9 - 13 0 , 13 0 * ,<br />
17 8 , 4 17 , 4 2 1, 5 16 , 537.<br />
Po, V . del, 17 .<br />
Poglia, f., 126.<br />
Polacchi, tom ba dei, 439.<br />
P oliziano A n g elo, poeta, 525.<br />
P o llar L eopoldo, architetto,<br />
4 12 .<br />
Pontechiasso, 4 *.<br />
Ponte L am b ro, 387.<br />
Ponte di L egn o, 2 0 3 *, 404, 434.<br />
Ponte San Pietro, 434.<br />
Ponte Selva, 436.<br />
Ponte T re sa , 10 2, 458.<br />
Ponte Visconteo, 424*.<br />
Pontirolo, 372.<br />
Pontoglio, 3 7 3 , 376.<br />
P o p o la z io n e , 18 3-2 6 6 , 18 4 *,<br />
19 7 * , 2 26 *, 2 3 3 * , 248*, 2 6 5*,<br />
286*.<br />
Pora, m t., 86.<br />
Porlezza, 447.<br />
P orro L am bertenghi L u ig i,<br />
patriota, 348.<br />
P o r t e ; a r c h i :<br />
Brescia, 504*.<br />
Com o, 3 1 * (di Porta V ittore),<br />
489, 492.<br />
Crem a, 4 2 3 * (del T orrazzo).<br />
P o r t e ; a r c h i :<br />
Crem ona, 5 2 1 (Venezia, M i<br />
lano).<br />
M antova, 524 (dei M olini).<br />
M ilano, 4 7 * (T icin ese); 460<br />
(Rom ana, T icin ese, V ercellina.<br />
N uova) ; 462 (Rom ana,<br />
T icin ese, Vercellina, N uova,<br />
Com acina, A rgentea) ; 464*,<br />
465 (Vercellina, T icin ese,<br />
Rom ana, O rientale, N uova,<br />
Com asina) ; 466 (G iovia) ;<br />
468, 4 7 1, 472 (V ittoria);<br />
474 (V enezia); 479 (T ic i<br />
nese, T en aglia); 481 (V e<br />
nezia); 484 (T icin ese); 485<br />
(Vercellina).<br />
Pavia, 509, 5 13 .<br />
P orta C arlo, scrittore, 284.<br />
Porto Ceresio, 10 2, 458.<br />
Porto della T o rre , 119 .<br />
Poschiavina, V ., 13 .<br />
Poschiavo, V ., 1 2 , 1 2 * , 13 , 62, 78.<br />
Pozzolo, fossa di, 297, 30 3, 304.<br />
Prata, pizzo di, 4 5 1.<br />
Pravello, m t., 8 1.<br />
Prealpi bergam asche, 8 1, 83-86,<br />
8 5*, 148, 207, 262, 356.<br />
P realpi bresciane, 8 1, 86-87,<br />
8 7*, 262, 3 3 6 * , 3 5 5 * . 356 . 429.<br />
Prealpi com asche, 8 1-8 3 , 8 3*,<br />
88*, 148, 503.<br />
Prealpi lom barde, 50 * , 5 1, 52,<br />
69. 78-85, 1 1 3 - 1 1 5 , 13 0 , 14 3,<br />
14 6 -15 0 , 15 7 , 16 3 , 263, 329,<br />
330 , 3 3 1 * . 3 5 5 -<br />
Prealpi varesine, 80-81, 8 2*, 148.<br />
P r e c i p i t a z i o n i , 1 1 4 , 138 ,<br />
14 6 -15 3 , 14 7 * , 15 2 * , 15 3 * .<br />
Predarossa, ghiacc., 64.<br />
Prem eno, 2 16 .<br />
Prèm olo, 356.<br />
Presanella, m t., 67.<br />
Preseglie, 80.<br />
Presolana, m t., 79, 85, 8 5*.<br />
Presolana, p. della, 79, 86, 1 7 1 ,<br />
436.<br />
Prevalle G avard o , 354.<br />
Prim aluna, 445.<br />
P rocopio di C esarea, storiografo,<br />
26.<br />
Puglia, 535.<br />
P ulci L u ig i, poeta, 282.<br />
Pusiano, 1. di, v. E u p ili, 1.<br />
Q uadro, pizzo, 60.<br />
Q uatrelle, 16 , 17 , 12 9 , 1 3 1.<br />
Q uinzana, fossa, 297.<br />
R<br />
R ai, m t., 1 1 3 .<br />
Ram eròn, abisso, 136 .<br />
R ancio, pian, 13 5 .<br />
R àsica, punta, 63.<br />
R e di C astello, m t., 68.<br />
R eale, can., 299.<br />
R eam òl, 109.<br />
R ebbio, 2 1.<br />
R edefossi, can., 299.<br />
R edona, 503.<br />
R edorta, pizzo di, 70, 7 2 *.<br />
Reggiano, agro, 303.<br />
R eggio ri F erdinando, arch i<br />
tetto, 467, 4 7 1.<br />
R em edello Sotto, 2 1.<br />
R em ulo, f., 126.<br />
R eno, f., 58, 6 1.<br />
R eno di L e i, V ., 6 1.<br />
Resegone, m t., 79, 83, 84, 169,<br />
170 , 438, 443.<br />
R évere, 303, 426.<br />
Rezzato, 353, 430.<br />
Rezzonico, 2 5 7 * .<br />
Rheinw aldhorn, m t., v. A d u la,<br />
mt.<br />
R h o, 18 9 * , 236, 238, 375, 3 8 5 * ,<br />
4 12 .<br />
R ho, fratelli, industriali, 345.<br />
R ip alta C rem asca, 356.<br />
R iso, V . del, 85.<br />
R iviera, V ., 60, 76, 118 .<br />
Rizzolo, 356.<br />
Roasco, torr., 1 2 1.<br />
R ebbiate, 124.<br />
R eb b io , 3 7 1.<br />
R o c c h e , V. C a s t e l l i .<br />
Rodano, f., 58.<br />
Roggione, pizzo, 60.<br />
R ogne, 242.<br />
Romani, pop., 23, 26, 18 3, 459,<br />
503. 509. 5 16 , 522.<br />
R omani M ario, storico d ell’econom<br />
ia, 17 9 , 200, 305, 306,<br />
3 10 .<br />
Romania, 2.<br />
Rom ano, 434.<br />
R oncocorrente, 303.<br />
R oseg, pizzo, 12 , 64.<br />
R ossini G ioacchino, musicista,<br />
400.<br />
R ota G iu se p p e, scrittore, 284.<br />
Rotondo, 1., 113 .<br />
Rotondo, pizzo, 58.<br />
Rovato, 88, 428.<br />
Rozzano, 375.<br />
Rozzo, 243.<br />
R udiana, roggia, 297.<br />
573
R ugger: P ietro, scrittore, 284.<br />
R ule: G ian M ario, 410, 412.<br />
Sabbia, V ., 80, 86, 16 3, 17 2 , 430.<br />
Sabbioneta, 423, 425-426.<br />
S a b b i o n e t a , d u c a t o d i , 2.<br />
Sacro M onte, 456.<br />
Saiben e C esare, geografo, 2 51-<br />
Sale, roggia, 297.<br />
Salice T erm e, 4 2 1.<br />
Salò, 14 2 , 14 3, 14 5, 239, 428,<br />
430*.<br />
Salò, g. di, 109.<br />
Saltrio, 354-<br />
Sam òlaco {Summo Lacu), 78.<br />
Sanagra, torr., 10 7, 447.<br />
Sapori A rmando, storico dell’economia,<br />
310 , 345.<br />
Sarca, f., 4, 108, 114 .<br />
Sardegna, i s .<br />
Sàrnico, 17 , 432.<br />
Saronno, 236, 3 5 1 * , 366, 383,<br />
4 13 - 4 14 , 458.<br />
Sassalbo, m t., 12 , 66.<br />
Sasso di S. M artin o, m t., 447.<br />
Saviore, V ., 126.<br />
Savoia, V ittorio A medeo II d i,<br />
1 7 3 ; E ugenio d i, 46.<br />
Scandalora R avara, 247.<br />
Scais, punta, 70, 72*.<br />
Scalino, pizzo, 12 , S 3*.<br />
Scalve, V . di (V. del Dezzo),<br />
79, 85, 86, 126, 169, 1 7 1 , 356,<br />
3 7 7 . 436, 4 3 7 *.<br />
Scarpa A ntonio, chirurgo, 2 21,<br />
SIS-<br />
Scerscen, ghiacc. di, i i * , 64,<br />
98*, 99.<br />
Scerscen, m t., 64.<br />
Scharboden, pizzo, 59.<br />
Schilpario, 2 4 1* , 436.<br />
Sciora, ago di, 63.<br />
Scopi, m t., 58.<br />
ScopoLi A ntonio, medico e naturalista,<br />
2 21.<br />
Scuropasso, torr., 129.<br />
Sebino, 1. (Iseo, 1. di), 20, 86,<br />
89, 99, 10 7 * , 10 7 -10 8 , 15 7 ,<br />
169, 170 , 2 12 , 243, 344, 3S4,<br />
3 7 3 . 3 9 9 . 4 3 1 * . 432.<br />
Sedrina, 438.<br />
Segrino, 1., 140, 440.<br />
Selva, m orena, 436.<br />
Selvino, 2 4 2 *, 243.<br />
Seniga, 20.<br />
Senoni, 4 S9 -<br />
Seregno, 236, 378, 38 3, 4 15 .<br />
Soriana, V. (V. del Serio), 69,<br />
83. Ss, 170. 1 7 1 . 2 1 1 , 2 4 1!<br />
242, 346, 3S6, 364, 372, 277,<br />
436-437.<br />
Seriate, S °3 '<br />
Serina, 440.<br />
Serina, torr., 124.<br />
Serina, V ., 79, 8s, 124, 439-<br />
440.<br />
Serio, f., 84, 1 1 4 , 12 4 , I2 S * ,<br />
296, 299.<br />
Serio G rande, can., 296.<br />
Serio m orto, can., 299.<br />
Serio, V. del, v. Soriana, V.<br />
Serie, 3 S3 -<br />
Serie, altopiano di (Cariàdeghe,<br />
altopiano), 87, 429.<br />
Sèrm ide, 426.<br />
Serradino, 336.<br />
Serriola Donata, roggia, 297.<br />
Serriola V etra, roggia, 297.<br />
Sertori, punta, S4 *-<br />
Sesia, f., 4 17 .<br />
Sestin i A ldo, geografo, 238.<br />
Sesto C alende, 438.<br />
Sesto San G iovanni, 236, 238,<br />
3 7 7 . 38 3. 409. 4 10 -4 12 , 4 1 1 * .<br />
Settim o, p ., S30-<br />
Seveso, 38 3, 4 13 .<br />
Seveso, f., x 2 i, 289, 296, 372.<br />
S f o r z a , c a s a d e g l i :<br />
F rancesco I, 38, 40, 17 3 ,<br />
2 9 2; G aleazzo M aria, 4 1 ;<br />
G ian G aleazzo, 42, 4 1 7 ; L u<br />
dovico IL M oro, 6, 43, 468;<br />
M assim iliano, 43 ; F rancesco<br />
II, 44.<br />
S f o r z a , d u c a t o d e g l i , 2, 422,<br />
468, 487.<br />
Sh e l l e y P ercy B y ssh e, poeta,<br />
400.<br />
Sicilia, 13 , 366, 333.<br />
Siculi, pop., 19.<br />
Sighignola, m t., 8.<br />
Sillero, can., 299.<br />
Sirm ione, 109, 403, 428, 429*.<br />
Sirone, 88.<br />
Siviano Porto, 432.<br />
Sogno, grotta del, 438.<br />
Solbiate A rn o , 378.<br />
Sole, V . di, 67, 72.<br />
Solferino, 423.<br />
Som m a Lom bard o, 2 1.<br />
Sondalo, 78, 333.<br />
Sondrio, 14 3 , 14 3, 180, 208, 239,<br />
3 1 3 , 3 8 1, 389, 4 4 9 -4 5 °> 4 S I* ,<br />
5 3 7 ;<br />
Sondrio, prov., 18 1, 189, 192,<br />
194, 19 3, 200, 2 13 , 2 19 , 2 4 1,<br />
327, 344, 3S2, 366, 449-454,<br />
535. 536.<br />
Soresina, 336, 423.<br />
S o r g e n t i t e r m a li, 4 17 , 4 2 1,<br />
433. 439, 440.<br />
Sòrico, 448.<br />
Sossana, 243.<br />
Spagna, pian di, 76 *, 78, 10 5,<br />
12 2 , 304, 449.<br />
Spa llan zan i L azzaro, biologo,<br />
2 2 1, 3 13 .<br />
Spe r i T ito, patriota, 307.<br />
Spinone, 1. di, v. Endine, 1. d ’ .<br />
Spinga, m t., 8*, 99, 148.<br />
Spinga, p ., 8, IO , 37, 38, 60, 6 1,<br />
12 2 , 330.<br />
Spinga, V ., V. San G iacom o, V .<br />
Spoi, torr., 12 .<br />
Stàffora, torr., 13 , 94, 114 , 1 1 3 ,<br />
129, 4 2 1.<br />
Stàffora, V . della, 94*, 1 3 1 * .<br />
Stella, corno, 6 1, 70.<br />
Stelvio, m t., 63.<br />
Stelvio, p ., 1 3 * , 60, 63, 77.<br />
Sten d h al, scrittore, v. B e y l e<br />
M a r ie-H e n r i, scrittore.<br />
Stoppani A ntonio, geologo, 19,<br />
83, 443.<br />
S trabone P ompeo, storico, 23,<br />
415.<br />
Stradella, 333, 368, 4 2 1.<br />
SuARDi, casa dei, 497.<br />
Summo Lacu, v. Sam òlaco.<br />
Superiore, 1., 12 8 , 12 8 * , 129,<br />
304. 523-<br />
Suretta, m t., 6 1.<br />
S. A gostino, 24.<br />
S. A mbrogio, 24, 483.<br />
S. A n gelo L od igiano, 4 1 3 * , 4 17 .<br />
S. A ntonio, 2 6 1.<br />
S. Benedetto Po, 426.<br />
S. Bernardino, p ., 39, 76, 330.<br />
S. B ernardo, abate di C lairvau x,<br />
407.<br />
S. C aterina del Sasso, 436, 4 37*.<br />
S. C olombano, 28.<br />
S. C olom bano al L am b ro, 4 17 .<br />
S. C olom bano al L am b ro , coll,<br />
di, 93. 93*.<br />
S. E m idio, vescovo di Pavia,<br />
490.<br />
S. E ufem ia, colle di, 497.<br />
S. E usebio, p ., 4 3 1.<br />
S. F ed ele, p., 446.<br />
S. Fed ele Intelvi, 303.<br />
S. G enesio, m t., 442.<br />
S. G erolam o, rupe di, 444.<br />
S. G iacom o, V . (Spinga, V .), 33,<br />
60, 6 1, 78, 16 8, 454.<br />
574
s. G io vanni Bianco, 35 5 , 438.<br />
4 38 *.<br />
S. G io van n i Bianco, V ., 80.<br />
S. G io vanni del D osso, 233.<br />
S. G iu liano M ilanese, 19 1.<br />
S. G ottardo, m t., 58, 58 *, ф,<br />
148.<br />
S. G ottardo, p., 58, 3 5 1, 530-<br />
S. lorio, p., 60, 72.<br />
S. Lorenzo, 436.<br />
S. M aria, 254 *.<br />
S. M aria, p. 5 2 *, 77.<br />
S, M aria di Lugan o , 109.<br />
S. M artino (Val M asino), 253*-<br />
S. M artino, m t., 443.<br />
S. M artin o della Battaglia, 428.<br />
S. M atteo, m t., 67.<br />
S. Paolo, is., 10 7.<br />
S. Pellegrino, 376, 438.<br />
S. Pellegrino, V ., 80.<br />
S. Pellegrino V etta, 438.<br />
S. Prim o, m t., 82.<br />
S. V igilio , coll., 88.<br />
T agliata, can., 299.<br />
T agliu n o, 376.<br />
T aleggio , V ., 79, 80, 84, 124,<br />
2 5 8 *, 3 7 1 . 4 3 9 -<br />
T am b ó , pizzo, 59, 60.<br />
T aram elli T orquato, geologo,<br />
78, 7 9 -<br />
T ártan o, torr., 1 2 1 , 128.<br />
T ártan o, V ., 206*, 449.<br />
Taurini, pop., 459.<br />
Tavèrnola Bergamasca, 355.<br />
T azzi C . a ., scrittore, 283.<br />
T e lo d ’Intelvi, f., 10 7 , 446.<br />
T e lo di O steno, f., 446.<br />
T e lo di O steno, V . del, 169,<br />
446.<br />
T e m p e r a t u r a , 13 8 -14 6 , 1 4 1 * ,<br />
14 6 *.<br />
T em ù , 148.<br />
T erd o p p io , f., 1 1 5 , 1 1 7 - 1 1 8 , 4 1 7 .<br />
T ern ate, coll, di, 88.<br />
T e rri, pizzo, 59.<br />
T erzan a A lta, 356.<br />
T esin ello , can., v. N aviglio<br />
G rande, can.<br />
T h u rw ieser, m t., 66.<br />
T icin ello , can., v. N aviglio<br />
G rande, can.<br />
T icin o , cantone, 27, 55, 16 3.<br />
T icin o , f., 4, 14 * , 17 , 58, 76,<br />
100, 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 6 * , 1 1 7 ,<br />
1 1 7 * , 1 3 1 , 13 2 , 290, 299, 387,<br />
406, 4 17 , 509.<br />
T icin o , V . del, 59, 72, 7 5 * , 75-<br />
76 , 129, 16 5.<br />
Ticinum, V. Pavia.<br />
TiEFFEN F ., industriale, 345.<br />
T iran o , 78, 148, 3S 3, 450.<br />
T o ce , f., 100.<br />
T ommaso, arcivescovo, 2 7 .<br />
T o n ale, p., 14 , 16 * , 67, 72, 78,<br />
169, 4 3 3 -<br />
T orena, m t., 70, 124.<br />
T o rn a vento, 118 .<br />
T o rn o , punta di, 400.<br />
T o r r i ;<br />
Bergam o (del G om bito, 5 0 1* ).<br />
B rescia (M irabella, 3 6 * ; del<br />
Popolo, 30 * , 504).<br />
B orm io (del G om une, 4 5 1).<br />
C om o (Com unale, 4 9 3 * ; di<br />
Porta V ittoria, 3 1 * ) .<br />
C rem ona (T orrazzo, 5 17 ).<br />
M ilano (Filarete, 485).<br />
Pavia, 2 5 *.<br />
S. M artino della Battaglia, 425.<br />
V igevano, 4 18 , 4 19 * .<br />
T o rre Santa M aria, 353.<br />
T o rrevilla, 244.<br />
T orrezzo, m t., 86.<br />
T o rricella, 244.<br />
T o rriggia, 106.<br />
T o rro n e, pizzi, 63.<br />
T o rto , rio, 1 1 3 .<br />
T oscolan o (Benacum), 387, 429.<br />
T r a b a t t o n i M o r la n a , ro g g ia ,<br />
296.<br />
T rad ate, 387, 458.<br />
T ra fo i, m t., 66.<br />
Transpadana, ant. prov., 2, 23.<br />
T rem ezzina, riviera della, 447.<br />
T rem ezzo, 10 5 , 400, 403, 447.<br />
T rem osine, V alli di, 87.<br />
T ren tin o -A lto A d ige, 17 , 2 19 .<br />
T renzana, roggia, 297.<br />
T rep alle, 207, 2 0 7*.<br />
T resa, f., l o i , 10 2.<br />
T re sa , V . della, 8 1.<br />
T resco re B alneario, 20, 354,<br />
436.<br />
T resenda, 76.<br />
T resero, pizzo, 67.<br />
T r e Signori, m t., 14 , 67, 84,<br />
12 4 , 12 5 , 169.<br />
T revasco, V ., 85.<br />
T revigliese, 325.<br />
T reviglio , 247, 434.<br />
T rezzo, 124.<br />
T r izzin i e ., scrittore, 284.<br />
T ro b io lo , V ., 356.<br />
T ro m p ia, V ., 86, 12 7 , 17 2 , 356,<br />
3 7 7 . 4 3 1-4 3 2 .<br />
T u rb igo , 118 , 387.<br />
T u r i s m o , 399-404, 429, 432,<br />
4 3 4 . 436-438.<br />
T u rriglian a, fonte, 439.<br />
U<br />
U ga, sorgente, 136 .<br />
U go da P ersico, scrittore, 278.<br />
U guccione da L odi, scrittore,<br />
278.<br />
U m brail, pizzo, 65.<br />
Unni, pop., 26.<br />
Vailata, roggia, 296.<br />
V albondione, V ., 437.<br />
V alcam ònica, V . (V. d ell’O glio),<br />
S3 . SS. S7 . 67. 72, 7 4 . 7 S. 7 7 *.<br />
78, 86, 12 7 , 148, 1 5 1 * , 169-<br />
17 0 , 17 0 * , 207, 2 1 1 , 2 1 1 * ,<br />
2 S I * . 2 59 *, 260, 262, 270*,<br />
280*, 3 3 2 * , 3 5 4 * , 364, 377,<br />
4 3 3 - 4 3 4 -<br />
V alcuvia, V ., 2 10 , 458.<br />
V alduce, to rr., 493.<br />
V alfu rva, V ., 65, 67, 77, 12 1,<br />
18 1 , 19 3, 254 *.<br />
Valganna, V ., 8 1, 2 10 , 458.<br />
Vallassina, coll, della, 89.<br />
V allassina, V ., 82, 243.<br />
V alm adrera, V ., 1 1 3 .<br />
Valsàssina, V ., 80, 82, 356 , 445.<br />
V alsolda, V ., 2 10 .<br />
V altellina, V . (V. d ell’A d d a), 3,<br />
47. S3 . SS. 5 7 . 62, 72. 7 4 *.<br />
7 S. 76 -77. 9 7 . 148, 1 6 1 * , 16 3,<br />
16 5 -16 9 , 207, 242, 258, 260-<br />
263, 267, 2 7 4 *, 2 7 5 * , 3 2 1,<br />
324, 3 2 8 * , 330 , 336 , 3 5 3 . 364.<br />
3 6 5 *. 368, 377, 4 4 9 -4 51. 4SO*.<br />
4 S2 *.<br />
Valtravaglia, V ., 8 1, 458.<br />
V aprio d ’A d d a, 350.<br />
Varano, 1. di, v. C om abbio, 1. di.<br />
V aredo, 3 7 3 * , 375, 385.<br />
V arenna, 10 5 , 354, 446.<br />
Varese, 140, 1 4 1 , 200, 236, 366,<br />
369. 3 7 4 . 376, 3 8 1, 38 3. 387.<br />
389, 486-489, 4 8 7*, 488*.<br />
V arese, 1., 19 , 20, 20*, 90, lo i.<br />
1 1 1 - 1 1 3 . 458.<br />
V arese, p rov., 60, 1 8 1 , 199, 238,<br />
3 14 . 352, 366, 376, 383, 387,<br />
S3 4 . S36.<br />
Varesotto, 20, 73, m , 158,<br />
17 2 , 17 4 - 17 6 , 209, 258, 262,<br />
3 1 5 . 3 19 , 324, 372 , 378, 455-<br />
458. S3 3 -<br />
575
V arrone, f., 107.<br />
V arrone, V ., 2 14 * , 260, 448.<br />
V arzi, 3 7 1.<br />
Vecchia, roggia, 120.<br />
Vecchiabbia, can,, v. V ettabbia,<br />
can.<br />
Vedano, 119 .<br />
Veddasca, V ., 60, 209*, 2 10 ,<br />
2 16 , 458.<br />
V edeseta, 439.<br />
V e g e t a z i o n e , 88, 89, 92,<br />
15 6 * , 15 7 - 16 3 , 1 6 1 * , 16 2 * ,<br />
335-336.<br />
V éleso, 446.<br />
V elleio P atercolo, storico, I.<br />
V e n e t a , rep., 3, 422, 449, SoS-<br />
Veneti, pop., 19.<br />
Venetia, ant. prov., 2, 23.<br />
Veneto, 17 , 49, 2 12 , 366, 376,<br />
5 3 5 -<br />
Venina, torr., 1 2 1 .<br />
V e n t i, 149, 15 4 - 15 7 .<br />
Ventina, ghiacc. del, 64.<br />
Ventina, pizzo, 63.<br />
V entura G iovanni, scrittore,<br />
284.<br />
V erbano, 1. (M aggiore, 1.), 20,<br />
S 3 . 5 9 . 72. 7 S. 80, 88, 9 9 -10 1,<br />
10 0 * , 156 , IS 7 . 1 6 1 , 164, 399,<br />
400, 4 0 1* , 458.<br />
V erde, 1., 1 1 3 .<br />
V erga C arlo, 241.<br />
Vergiate, 2 1.<br />
V e r r i, 442.<br />
V ersa, torr., 129.<br />
V értova, V ., 85.<br />
Verzasca, f., 100.<br />
Verzasca, V ., 59.<br />
Vescovata, roggia, 297.<br />
Vestono, 80, 430.<br />
Vettabbia, can. (Vecchiabbia),<br />
1 2 1 , 288*, 289, 299, 462.<br />
Vezza d ’O glio, 242, 3 S4 '<br />
Viadana, 228, 423.<br />
V ial, piz, 58.<br />
Vicus Mae, v. Voghera.<br />
Viens Sebuinus, v. A ngera.<br />
V igevano, 2 12 , 2 3 1 * , 237, 3 7 3 .<br />
375. 386, 387, 4 18 -4 2 0 , 4 19 * .<br />
Vigezzo, V ., 72.<br />
V iggiù , 458.<br />
V i l l e :<br />
B rianza (A lbertoni, 400; B e i<br />
gioioso, 400).<br />
C om o, 1. di (A rconati, 400,<br />
447; C apuana, 13 6 ; C a r<br />
lotta, 1 6 1 , 400, 447; C respi,<br />
400; E ste, d ’ , 16 1, 400, 446,<br />
4 4 7; G eno, 496; M elzi,<br />
400, 4 4 7: M onastero, 446;<br />
O lm o, 496 ; Passalacqua,<br />
446; Pliniana, 13 5 , 400,<br />
446; Salterio, 400; Serbelloni,<br />
16 1, 400, 4 4 7; T a <br />
verna, 16 1, 17 7 * ).<br />
G ard a, 1. di (Bottoni, 400;<br />
D esenzano, 428 ; V ittoriale,<br />
429) ;<br />
Lugano, 1. di (Ciani, 16 1).<br />
M onza (Reale, 410).<br />
V illa (Lecco), 243.<br />
V illa d ’A lm è, 34g.<br />
V illa C alcin a, 378.<br />
V illafran ca, arm istizio d i, 3.<br />
V illanova, sul Olisi, 244, 373.<br />
V illasanta, 376, 383.<br />
V illa di Serio, 355.<br />
V ill’Incino, 244.<br />
V iim inore, 437.<br />
V illoresi, can., 118 , 12 0 , 13 2 ,<br />
289, 296, 297*, 300.<br />
Vim ercate, 383, 4 15 .<br />
V in c i, L eonardo da, 133, 418,<br />
468, 486.<br />
Viola, f., 1 2 1.<br />
V iola, mt., 65, 66.<br />
Viola, p ., 77.<br />
V iola, V ., 77, 1 2 1 .<br />
V ioz, m t., 67.<br />
V irgilio, 233.<br />
V irgilio, can., 3 0 1.<br />
V ille T rep on ti, 353, 354.<br />
V isconti A lessandro, 47.<br />
V isco n ti, casa d e i:<br />
O tto ne, arcivescovo M a t<br />
teo I, 34, 444; G aleazzo, 3 5 ;<br />
M arco, 35 ; G iovanni, 35 ; L u <br />
chino, 35 ; G aleazzo II, 37,<br />
292, 5 13 , 4 1 7 ; B ernabò, 3 7 ;<br />
G ian G aleazzo, 6, 37-38 , 467 ;<br />
G iovanni M aria, 3 8 ; F ilippo<br />
M aria, 3 8 ; A zzo ne, 444, 519 .<br />
V isco n ti, ducato d e i, 2, 4 10 ,<br />
422, 450, 466, 487, 493, 498,<br />
S04. 513-<br />
V ittorino da F e l t r e, 525.<br />
Vizzola, 118 .<br />
V obarno, 430.<br />
V ogh era (Vicus Mae), 237, 355,<br />
368, 3 7 3 , 376, 4 2 1.<br />
V o lpati C arlo, storico, scrittore,<br />
489, 492.<br />
V olpe, buco della, 88*.<br />
V olta A lessandro, fisico, 2 2 1,<br />
SIS-<br />
Y<br />
Y oung A rturo, scrittore, 305.<br />
Z eb rù , m t., 66, 6 7*.<br />
Zem brasca, m t., 65.<br />
Zogno, 438, 440.<br />
Zogno, V . di, 80.<br />
Zuccone di C am pelli, m t., 84,<br />
169, 170 .<br />
Z u p ò , pizzo, 64.<br />
576