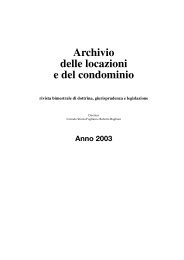Archivio civile - La Tribuna
Archivio civile - La Tribuna
Archivio civile - La Tribuna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
giate in cui è insita o delle caratteristiche dei mezzi adoperati.<br />
Il criterio suindicato trova per il DI MARTINO (Responsabilità<br />
<strong>civile</strong> per l’esercizio di attività pericolosa, Giuffrè<br />
1979, p. 94) piena e sufficiente giustificazione dal momento<br />
che «ove il giudice valuti adeguatamente una attività per la<br />
sua natura e le sue componenti modali, la qualificazione<br />
stessa, ai fini dell’art. 2050 c.c., non potrà che risultare corretta<br />
indipendentemente dall’utilizzo di schemi fissi di riferimento<br />
quali quelli stabiliti da normative particolari».<br />
Il GERACI (Premessa allo studio per un inquadramento<br />
della responsabilità <strong>civile</strong> per esercizio di attività pericolosa,<br />
in Arch. resp. civ. 1972, p. 31), invece, è alquanto scettico<br />
circa l’importanza dei due parametri cui frequentemente<br />
si fa riferimento – pericolosità intrinseca o relativa ai<br />
mezzi di lavoro impiegati – poiché ritiene che la casistica<br />
non possa fare a meno di offrire spunti per considerazioni<br />
frammentarie e per cogliere dissonanze a volte interessanti<br />
fra decisioni su situazioni analoghe, di talché non possono<br />
trarsi al definitivo principi fissi validi per ogni tempo.<br />
Né si può guardare all’evento dannoso per dedurne la pericolosità<br />
della attività in occasione della quale si è verificato<br />
il sinistro, atteso che esso non può essere indice di per<br />
sé di pericolosità della attività poiché ci troveremmo di<br />
fronte ad un giudizio a posteriori: la pericolosità deve cioè<br />
essere insita nella attività e non essere desunta dal risultato<br />
dannoso, poiché la «potenzialità di danno» – e cioè la notevole<br />
possibilità del verificarsi di un evento dannoso – non<br />
è certamente un giudizio a posteriori desumbile dai risultati,<br />
ma una valutazione del tutto preventiva, oltre la quale,<br />
comunque, riteniamo di poter andare, come in appresso vedremo.<br />
D’altronde è la stessa Corte di cassazione ad affermare<br />
che «ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui<br />
all’art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità della attività<br />
– ossia su quella attività che, per sua natura o per i mezzi<br />
impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile,<br />
il verificarsi dell’evento dannoso, distinguendosi, così,<br />
dall’attività normalmente innocua, che diventi pericolosa<br />
per la condotta di chi la eserciti, comportando la responsabilità<br />
secondo la regola generale di cui all’art. 2043 c.c. –<br />
va espresso non sulla base dell’evento dannoso effettivamente<br />
verificatosi, bensì, attraverso una prognosi postuma,<br />
sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al<br />
momento stesso dell’esercizio dell’attività ed erano riconoscibili<br />
dall’uomo medio o, comunque, dovevano essere conosciute<br />
dall’agente in considerazione del tipo di attività<br />
esercitata; tale valutazione, nel caso in cui non sia stata<br />
compiuta direttamente dal legislatore, è rimessa all’apprezzamento<br />
del giudice del merito ed è insindacabile in sede di<br />
legittimità se adeguatamente e logicamente motivata»<br />
(Cass. civ., sez. III, 30 agosto 1995, n. 9205).<br />
E ad una valutazione preventiva guardava pure a suo<br />
tempo il DI MARTINO (Responsabilità per danno da attività<br />
pericolosa e responsabilità per danni nell’esercizio di attività<br />
pericolose, Giuffrè 1979, p. 973), ma da una diversa angolatura.<br />
Invero, questo Autore, sia per giungere ad una precisa<br />
definizione di attività pericolosa sia per motivare l’impostazione<br />
data dal nostro legislatore con l’art. 2050 c.c. ai criteri<br />
che debbono presiedere al risarcimento dei danni prodotti<br />
dall’esercizio di una attività pericolosa, finiva col<br />
sostenere che l’attività, in quanto pericolosa sembra possedere<br />
per sé stessa una intrinseca energia, un’autonoma po-<br />
DOTTRINA 5<br />
tenzialità dannosa, preventivamente ineliminabile da parte<br />
del soggetto che esercita l’attività stessa, al pari delle entità<br />
autonomamente agenti in senso materiale. Ma per questo<br />
percorso il danno derivante in via diretta dalla pericolosità<br />
dell’attività svolta – ineliminabile da parte del soggetto che<br />
la esercita – non sarebbe necessariamente mai legato in<br />
qualsiasi caso ad una negligenza del medesimo soggetto, e<br />
sarebbe normalmente una conseguenza materiale oggettiva<br />
della stessa pericolosità: con il che si dovrebbe concludere<br />
che la pericolosità di una attività sia l’attitudine della attività<br />
stessa a produrre danni.<br />
Viene spontanea allora una domanda: se la pericolosità<br />
di una certa attività è ineliminabile che senso pratico ha la<br />
previsione normativa di una possibile prova «di avere adottato<br />
tutte le misure idonee ad evitare il danno» (art. 2050<br />
c.c.).<br />
Dato interessante, però, in questa impostazione, l’implicito<br />
ritorno ad un concetto di potenzialità di danno dal quale<br />
partiremo per arrivare a quello di probabilità di danno, e<br />
cioè di alea.<br />
Ma, al di là di questo, non vediamo come si possa affermare<br />
che la pericolosità sta ad indicare la impossibilità di<br />
adottare misure preventive tali da escludere del tutto l’evenienza<br />
di danno o in buona misura la possibilità di danno:<br />
le misure cautelative potrebbero riuscire soltanto, secondo<br />
questa teoria, ad attenuare la pericolosità, ma non ad escludere<br />
del tutto il rischio.<br />
Il che ci lascia perplessi.<br />
Che una misura preventiva non sia tale da escludere matematicamente<br />
sempre al cento per cento in determinate situazioni<br />
la possibilità del verificarsi di un evento dannoso<br />
appare pure a noi concretamente una affermazione fondata<br />
poiché anche le tecniche più collaudate e sofisticate lasciano<br />
pur sempre un margine modesto all’imponderabilità;<br />
ma da qui ad affermare che la pericolosità di una attività<br />
corrisponde solo e sempre alla impossibilità di adottare misure<br />
preventive tali da escludere del tutto – o almeno in<br />
buona misura di probabilità – l’evenienza di un evento dannoso<br />
il passo ci appare notevole.<br />
Arriveremmo infatti allora ad un risultato aberrante riconoscendo<br />
che mai si può avere la certezza matematica<br />
dell’efficacia integrale delle misure preventive: saremmo di<br />
fronte sempre e soltanto ad attività pericolose senza possibilità<br />
alcuna di rimedio o cautela preventiva. Se poi per converso<br />
uno volesse sostenere – guardando solo all’affidabilità<br />
di queste misure preventive – che ve ne sono di quelle<br />
capaci di escludere del tutto (arrivando cioè all’estremo opposto<br />
del ragionamento) un evento dannoso – ma non siamo<br />
convinti, per parte nostra, comunque della possibile esistenza<br />
di questa certezza assoluta – finiremmo col restringere<br />
il campo di applicazione dell’art. 2050 c.c.<br />
Quindi, tutto ben considerato, più appagante appare limitarsi<br />
a sostenere soltanto, come fa il GERACI (ibid., p. 40),<br />
in questa fase di approccio al nocciolo del problema, che la<br />
pericolosità deve essere insita nell’attività e non nel risultato.<br />
E su questa linea si è ritrovata anche la giurisprudenza<br />
della Cassazione per affermare – in un ulteriore passaggio<br />
– che la caratteristica della pericolosità – da apprezzarsi<br />
come particolare – deve essere intrinseca alla attività presa<br />
in esame e non può quindi dipendere neppure dall’intervento<br />
di cause esterne quali errori, colpe, iniziative anomale<br />
o avventate dell’utente del servizio prestato o del bene fornito:<br />
non può cioè una anomala, imprudente modalità su-