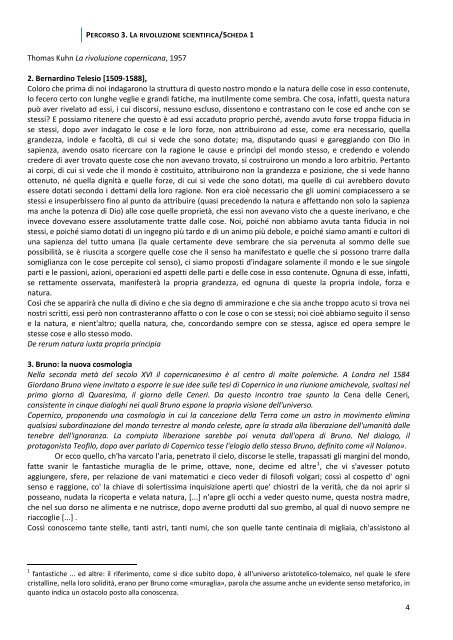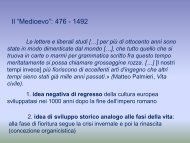La Rivoluzione scientifica (testi introduttivi/Scheda 1)
La Rivoluzione scientifica (testi introduttivi/Scheda 1)
La Rivoluzione scientifica (testi introduttivi/Scheda 1)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PERCORSO 3. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA/SCHEDA 1<br />
Thomas Kuhn <strong>La</strong> rivoluzione copernicana, 1957<br />
2. Bernardino Telesio [1509-1588],<br />
Coloro che prima di noi indagarono la struttura di questo nostro mondo e la natura delle cose in esso contenute,<br />
lo fecero certo con lunghe veglie e grandi fatiche, ma inutilmente come sembra. Che cosa, infatti, questa natura<br />
può aver rivelato ad essi, i cui discorsi, nessuno escluso, dissentono e contrastano con le cose ed anche con se<br />
stessi? E possiamo ritenere che questo è ad essi accaduto proprio perché, avendo avuto forse troppa fiducia in<br />
se stessi, dopo aver indagato le cose e le loro forze, non attribuirono ad esse, come era necessario, quella<br />
grandezza, indole e facoltà, di cui si vede che sono dotate; ma, disputando quasi e gareggiando con Dio in<br />
sapienza, avendo osato ricercare con la ragione le cause e princìpi del mondo stesso, e credendo e volendo<br />
credere di aver trovato queste cose che non avevano trovato, si costruirono un mondo a loro arbitrio. Pertanto<br />
ai corpi, di cui si vede che il mondo è costituito, attribuirono non la grandezza e posizione, che si vede hanno<br />
ottenuto, né quella dignità e quelle forze, di cui si vede che sono dotati, ma quelle di cui avrebbero dovuto<br />
essere dotati secondo i dettami della loro ragione. Non era cioè necessario che gli uomini compiacessero a se<br />
stessi e insuperbissero fino al punto da attribuire (quasi precedendo la natura e affettando non solo la sapienza<br />
ma anche la potenza di Dio) alle cose quelle proprietà, che essi non avevano visto che a queste inerivano, e che<br />
invece dovevano essere assolutamente tratte dalle cose. Noi, poiché non abbiamo avuta tanta fiducia in noi<br />
stessi, e poiché siamo dotati di un ingegno più tardo e di un animo più debole, e poiché siamo amanti e cultori di<br />
una sapienza del tutto umana (la quale certamente deve sembrare che sia pervenuta al sommo delle sue<br />
possibilità, se è riuscita a scorgere quelle cose che il senso ha manifestato e quelle che si possono trarre dalla<br />
somiglianza con le cose percepite col senso), ci siamo proposti d'indagare solamente il mondo e le sue singole<br />
parti e le passioni, azioni, operazioni ed aspetti delle parti e delle cose in esso contenute. Ognuna di esse, infatti,<br />
se rettamente osservata, manifesterà la propria grandezza, ed ognuna di queste la propria indole, forza e<br />
natura.<br />
Così che se apparirà che nulla di divino e che sia degno di ammirazione e che sia anche troppo acuto si trova nei<br />
nostri scritti, essi però non contrasteranno affatto o con le cose o con se stessi; noi cioè abbiamo seguito il senso<br />
e la natura, e nient'altro; quella natura, che, concordando sempre con se stessa, agisce ed opera sempre le<br />
stesse cose e allo stesso modo.<br />
De rerum natura iuxta propria principia<br />
3. Bruno: la nuova cosmologia<br />
Nella seconda metà del secolo XVI il copernicanesimo è al centro di molte polemiche. A Londra nel 1584<br />
Giordano Bruno viene invitato a esporre le sue idee sulle tesi di Copernico in una riunione amichevole, svoltasi nel<br />
primo giorno di Quaresima, il giorno delle Ceneri. Da questo incontro trae spunto la Cena delle Ceneri,<br />
consistente in cinque dialoghi nei quali Bruno espone la propria visione dell'universo.<br />
Copernico, proponendo una cosmologia in cui la concezione della Terra come un astro in movimento elimina<br />
qualsiasi subordinazione del mondo terrestre al mondo celeste, apre la strada alla liberazione dell'umanità dalle<br />
tenebre dell'ignoranza. <strong>La</strong> compiuta liberazione sarebbe poi venuta dall'opera di Bruno. Nel dialogo, il<br />
protagonista Teofilo, dopo aver parlato di Copernico tesse l'elogio dello stesso Bruno, definito come «il Nolano».<br />
Or ecco quello, ch'ha varcato l'aria, penetrato il cielo, discorse le stelle, trapassati gli margini del mondo,<br />
fatte svanir le fantastiche muraglia de le prime, ottave, none, decime ed altre 1 , che vi s'avesser potuto<br />
aggiungere, sfere, per relazione de vani matematici e cieco veder di filosofi volgari; cossì al cospetto d' ogni<br />
senso e raggione, co' la chiave di solertissima inquisizione aperti que' chiostri de la verità, che da noi aprir si<br />
posseano, nudata la ricoperta e velata natura, [...] n'apre gli occhi a veder questo nume, questa nostra madre,<br />
che nel suo dorso ne alimenta e ne nutrisce, dopo averne produtti dal suo grembo, al qual di nuovo sempre ne<br />
riaccoglie [...] .<br />
Cossì conoscemo tante stelle, tanti astri, tanti numi, che son quelle tante centinaia di migliaia, ch'assistono al<br />
1 fantastiche ... ed altre: il riferimento, come si dice subito dopo, è all'universo aristotelico-tolemaico, nel quale le sfere<br />
cristalline, nella loro solidità, erano per Bruno come «muraglia», parola che assume anche un evidente senso metaforico, in<br />
quanto indica un ostacolo posto alla conoscenza.<br />
4