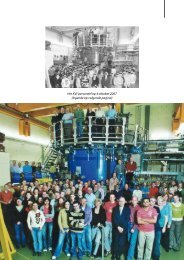LA DOMUS PUBLICA DI PIETRABBONDANTE
LA DOMUS PUBLICA DI PIETRABBONDANTE
LA DOMUS PUBLICA DI PIETRABBONDANTE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
nell’affermazione che essi furono insediati<br />
nelle località in questione nel corso della prima<br />
metà del XVI secolo e parlano di loro proprio<br />
come di gente che era venuta dalla Dalmazia in<br />
Italia non molto tempo prima […]” (“Le colonie<br />
serbocroate nell’Italia meridionale”, 1911).<br />
In questo paese ha avuto luogo una importante<br />
attività di ricerca sulla lingua “slavisana”, secondo<br />
il neologismo proposto da Walter Breu<br />
e Giovanni Piccoli, autori del locale dizionario<br />
croato molisano. La valorizzazione della lingua,<br />
che prevede anche scambi culturali con<br />
la Croazia, si accompagna alla rivitalizzazione<br />
delle tradizioni. Oltre la Smercka natalizia<br />
(la notte della vigilia di Natale viene accesa,<br />
sul sagrato della chiesa, una grande torcia,<br />
costituita da pezzi di legno e collocata su un<br />
tronco di albero rovesciato), la festa del primo<br />
maggio ripresa - come ci ricorda Matteo Patavino<br />
nel capitolo “Archetipi e trasformazioni”<br />
del volume “Passaggi Sonori” - dalla metà del<br />
1980, rappresenta un’occasione di condivisione<br />
collettiva di una tradizione particolarmente<br />
sentita. Il corteo del Mája rientra nelle feste<br />
A sinistra:<br />
Colle d’Anchise, 6-5-2007: il Pagliaro in chiesa<br />
(foto: D. D’Alessandro)<br />
Nell’altra pagina:<br />
Acquaviva Collecroce: particolare della targa<br />
commemorativa di Nicola Neri posta sulla facciata<br />
del Municipio<br />
primaverili propiziatorie e ha un intento di<br />
rafforzamento della fraternità tra la popolazione,<br />
che mantiene ancora vivo il ricordo delle<br />
proprie origini. Come avviene in manifestazioni<br />
analoghe che hanno alla base la figura del<br />
pagliaio, per realizzare il Mája si riveste un telaio<br />
conico con elementi vegetali. La struttura,<br />
alta più di tre metri, è composta da rami flessibili,<br />
canne e paglia e si differenzia dalle altre<br />
composizioni per il suo aspetto antropomorfo<br />
(presenta infatti anche la testa e le braccia). La<br />
preparazione inizia il giorno precedente la festa,<br />
con la raccolta di fiori e primizie, protratta<br />
fin quando è possibile per evitarne l’appassimento.<br />
L’addobbo viene eseguito da un gruppo<br />
di giovani e da alcuni adulti: via via che il Mája<br />
prende forma, ognuno contribuisce al miglioramento<br />
della composizione con proposte e<br />
suggerimenti. La mattina del giorno successivo<br />
si compiono gli ultimi ritocchi; quando la figura<br />
è completata, nel rivestimento e nelle fattezze<br />
quasi umane accentuate nei grandi occhi<br />
del volto, il Mája è pronto per essere animato.<br />
Questa personificazione presenta un aspetto<br />
piuttosto femminile: ha una corona sulla testa,<br />
una lunga capigliatura e la parte sottostante<br />
appare come un’ampia gonna.<br />
Nella rappresentazione osservata nel 2007, il<br />
Mája non porta sul capo una croce ma un ciuffo<br />
vistoso, a differenza delle analoghe figure di<br />
Fossalto (2005, 2006) e Colle d’Anchise (2007),<br />
dove inoltre il Pagliaro entra in chiesa. Ricordiamo<br />
che nella descrizione di Milan Rešetar<br />
del 1911 il Mája viene benedetto e, come la Pagliara<br />
di Fossalto, è innaffiato con getti d’acqua<br />
augurali, elemento che Rešetar ricollega al<br />
corteo delle dòdole presso i serbocroati, effet-<br />
tuato per propiziare la pioggia e la fertilità della<br />
terra. Sulla base delle informazioni raccolte,<br />
che attestano la vitalità della festa fino al 1940<br />
e la sua interruzione causata dalla guerra, Alberto<br />
M. Cirese cita la presenza di una croce di<br />
spighe di grano, posta sulla sommità del cono,<br />
la benedizione religiosa e la distruzione finale<br />
del Mája, presso i ruderi di una chiesa, eseguita<br />
da ragazzi (“La pagliara del primo maggio nei<br />
paesi slavo-molisani”). La festa del Mája è documentata<br />
fotograficamente, dal 2001 al 2007,<br />
in un sito internet dedicato ad Acquaviva Collecroce.<br />
Dalle immagini si nota come il ciuffo<br />
sia differente, di anno in anno, cosa che indica<br />
come le feste possano, nel tempo, presentare<br />
alcune diversità, pur mantenendo tratti distintivi<br />
di base sui quali i protagonisti procedono<br />
con andamenti variabili e in base alla propria<br />
creatività. Al termine della composizione, la<br />
veste vegetale viene indossata da un giovane e<br />
inizia il corteo, dapprima verso piazza Nicola<br />
Neri, poi lungo le vie del paese. Lo “spirito della<br />
vegetazione” continua la sua processione,<br />
tra esibizioni coreutiche e musicali di gruppi<br />
in costume provenienti anche da altre località<br />
del Molise. Il primo maggio è un giorno particolare<br />
ad Acquaviva Collecroce, un giorno di<br />
festa ma soprattutto di memoria: vi è un sentimento<br />
di intensa partecipazione, specialmente<br />
nei bambini, che si impegnano a cantare con<br />
l’aiuto di testi scritti nella loro “bella lingua”,<br />
come sollecitava Nicola Neri. Tutto ciò testimonia<br />
quanto sia importante l’apprendimento<br />
della tradizione attraverso le feste, non soltanto<br />
con il coinvolgimento e l’osservazione, ma<br />
anche secondo a modalità “guidate” da associazioni<br />
locali, culturali o scolastiche. Mentre<br />
il corteo prosegue il suo percorso nel paese,<br />
le danze e la distribuzione del cibo sciolgono<br />
l’iniziale compostezza e sollecitano i partecipanti<br />
a esprimersi più gioiosamente, cantando<br />
e ballando attorno al Mája.<br />
Questo articolo costituisce, in alcune sue parti, una rielaborazione<br />
del testo “Mája, Acquaviva Collecroce”, pubblicato<br />
in Feste e Riti d’Italia. Sud 1, a cura di S. Massari, De<br />
Luca, Roma, 2009: pp. 326-337.<br />
bibliografia<br />
Cirese A. M. (1955): La “pagliara maie maie”. La<br />
Lapa, a. III, n. 1-2: 33-36.<br />
Cirese A. M. (1955): La “pagliara” del primo<br />
maggio nei paesi slavo-molisani. Slovenski Etnograf,<br />
8: 207-224.<br />
Cirese A. M. (1995-1996): Milovan Gavazzi e la<br />
“pagliara” slavo-molisana. Studia Ethnologica<br />
Croatica, 7-8: 47-52.<br />
De Simoni E. (2009): Patrimonio immateriale<br />
del Molise. Conoscenze, numero monografico,<br />
IV (1), Betagamma, Viterbo.<br />
Eliade M. (1949), Traité d’histoire des religions.<br />
Payot, Paris.<br />
Frazer J. G. (1922): The Golden Bough. A study in<br />
Magic and Religion. Macmillan, New York.<br />
Mascia G. (2006): Maggio nella tradizione<br />
popolare molisana. Utriculus, X (38), Associazione<br />
Culturale Circolo della Zampogna, Scapoli:<br />
32-33.<br />
Moffa S. (1938): Calendimaggio Molisano. Luci<br />
Sannite, fascicolo 3-4 (IV), maggio-luglio.<br />
Patavino M. (a cura di) (2006): Passaggi Sonori.<br />
I canti, le musiche e gli strumenti della tradizione<br />
orale del Medio Molise Fortore. Finis Terrae,<br />
Santa Croce di Magliano.<br />
Rešetar M. (1911): Die Serbokroatischen Kolonien<br />
Süditaliens, Wien (traduzione italiana a<br />
cura di W. Breu e M. Gardenghi (1997): Le colonie<br />
serbocroate nell’Italia meridionale ,Amministrazione<br />
Provinciale di Campobasso).<br />
60 61