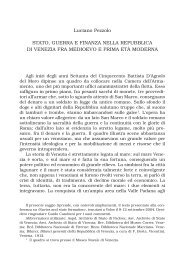Alla ricerca di Focerò - Mediterranea
Alla ricerca di Focerò - Mediterranea
Alla ricerca di Focerò - Mediterranea
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Focero' DEF:Focero' DEF 17-11-2008 21:52 Pagina 12<br />
12 | <strong>Alla</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>di</strong> <strong>Focerò</strong> | Michele Fasolo<br />
originale, tradotti ed illustrati da<br />
Salvatore Cusa, 1 v. in 2 tomi,<br />
Palermo, 1868-1882 (e<strong>di</strong>z. A cura <strong>di</strong><br />
A. Noth, Köln- Wien, 1982), p. 471,<br />
703-704; E. Pontieri, “La madre <strong>di</strong> Re<br />
Ruggero: Adelaide del Vasto contessa<br />
<strong>di</strong> Sicilia Regina <strong>di</strong> Gerusalemme (?-<br />
1118)”, in Atti del Convegno<br />
Internazionale <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Ruggeriani,<br />
Palermo, 1955, p. 368-369.<br />
10 E’ significativo però che il<br />
personaggio non venga qualificato né<br />
categumeno né tantomeno electus.<br />
11 S. Cusa, I <strong>di</strong>plomi greci ed arabi <strong>di</strong><br />
Sicilia pubblicati nel testo originale,<br />
tradotti ed illustrati da Salvatore Cusa,<br />
1 v. in 2 tomi, Palermo, 1868-1882<br />
(e<strong>di</strong>z. A cura <strong>di</strong> A. Noth, Köln- Wien,<br />
1982), p. 532-535, 705-706.<br />
12 Annales Cassinensis, ed. MG.SS, III,<br />
all’anno 1141: “Ad monasterium venit<br />
IV non. Novembris”.<br />
13 Si trattava evidentemente <strong>di</strong> terre<br />
incolte.<br />
14 E. Caspar, Roger II. (1101-1154)<br />
und <strong>di</strong>e Gründung der normannischsicilischen<br />
Monarchie, Innsbruck, 1904<br />
(trad. it. E. Caspar, Ruggero II (1101-<br />
1154) e la fondazione della<br />
monarchia normanna <strong>di</strong> Sicilia,<br />
Roma-Bari, 1999, p. 27).<br />
15 E. Pontieri, “La madre <strong>di</strong> Re<br />
Ruggero: Adelaide del Vasto contessa<br />
<strong>di</strong> Sicilia Regina <strong>di</strong> Gerusalemme (?-<br />
1118)”, in Atti del convegno<br />
internazionale <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> ruggeriani,<br />
Palermo, 1955, p. 368-369.<br />
16 Adelasia fu reggente ra il 1101 ed il<br />
1105 a nome <strong>di</strong> Simone, dal 1105 al<br />
1112 a nome <strong>di</strong> Ruggero. Orderico<br />
Vitale ricorda come Roberto figlio del<br />
Duca <strong>di</strong> Borgogna fosse chiamato da<br />
Adelasia proprio a causa dei torbi<strong>di</strong><br />
con i baroni ribelli. Adoperato per<br />
reprimere i baroni e maritato ad una<br />
sua figlia, sarebbe stato fatto infine<br />
scelleratamente uccidere dalla regina<br />
con il veleno. Hodorici Vitalis, Hist.,<br />
lib. XIII.<br />
17 Sino alla metà del XIV sec., ad<br />
esempio nel Codex Messanensis<br />
Graecus 105, risulta usato il toponimo<br />
Bloro in luogo del successivo Brolo<br />
che ritroviamo in Fazello e Maurolico<br />
cfr. R. Cantarella (a cura <strong>di</strong>), Codex<br />
Messanensis Graecus 105, Palermo,<br />
1937, loca varia; T. Fazelli, De rebus<br />
siculis decades duae, Panormi, 1558, p.<br />
34. La denominazione, piuttosto che<br />
<strong>di</strong> origine gallo-italica < gall.<br />
Bro(g)ilos ‘giar<strong>di</strong>no’ ‘frutteto’ ‘luogo<br />
recintato’ come proposto dal<br />
Pellegrini cfr. G. Gasca Queirazza – C.<br />
Marcato – G.B. Pellegrini- G.<br />
Petracco Sicar<strong>di</strong> –A Rossebastiano,<br />
Dizionario <strong>di</strong> Toponomastica, Storia<br />
dei nomi geografici italiani, Torino,<br />
1990, s.v., p. 102, è forse esito da<br />
'Aulèn ‘canale’ come per Vlora in<br />
Albania.<br />
struttura religiosa lesa dai comportamenti appropriativi <strong>di</strong> Algeri.<br />
Nell’incontro i convenuti ricordano ancora una volta al sovrano le usurpazioni <strong>di</strong><br />
Algeri e il sequestro da lui compiuto <strong>di</strong> familiari dell’arconte 38 Mulè del villaggio <strong>di</strong><br />
Mauro 39 tra cui due figli, i cui nomi, Cartulario e Filippo, ci sono noti da altri due<br />
documenti 40 . Non sappiamo se nell’occasione si svolse un contrad<strong>di</strong>ttorio tra le parti in<br />
causa ma dal testo emergono anche le ragioni <strong>di</strong> Algeri che riven<strong>di</strong>cava la legittimità dei<br />
suoi possessi in base e secondo un titolo <strong>di</strong> proprietà concessogli dallo stesso re. La<br />
fonte, giunta sino a noi in maniera incompleta, non contiene notizie circa la decisione<br />
assunta in merito dal sovrano. L’esito comunque si rinviene nel documento n. 4:<br />
l’assegnazione, in adempimento alle precise volontà della defunta regina Adelasia, del<br />
territorio <strong>di</strong> <strong>Focerò</strong> alla chiesa beati Bartholomei.<br />
I confini <strong>di</strong> <strong>Focerò</strong> nell’attribuzione fatta alla chiesa <strong>di</strong> S. Bartolomeo a Lipari da<br />
Filippo «preceptor et stratigotus» <strong>di</strong> tutta la Val Demone nel 1142. (Doc. n. 4)<br />
Il documento, il terzo in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tempo riguardante <strong>Focerò</strong>, è un atto in lingua latina<br />
in cui Filippo 41 preceptor et stratigotus <strong>di</strong> tutta la Val Demone, totius vallis Demii, assegna<br />
per l’appunto, descrivendone i confini, la terra Fucherotis alla chiesa <strong>di</strong> S. Bartolomeo <strong>di</strong><br />
Lipari. Fu erroneamente scambiato dal Collura 42 per il documento n. 7 ovvero per la<br />
versione latina del <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> concessione da parte <strong>di</strong> Ruggero II del territorio <strong>di</strong> <strong>Focerò</strong><br />
a Giovanni categumeno <strong>di</strong> Patti. Probabilmente lo stu<strong>di</strong>oso fu portato fuori strada da una<br />
svista del Garufi che aveva datato quest’ultimo atto e la sua versione in lingua greca<br />
anziché al 1143 al 1142, anno invece dell’attribuzione dello stratigotus che egli tuttavia<br />
trascrive correttamente, 1142, nell’appen<strong>di</strong>ce al suo articolo dove ne è riportato il testo. 43<br />
A Filippo, figlio del logoteta Leone, si era presentato Iohannes abbas Liparitanus, che gli<br />
aveva esibito una carta recante l’or<strong>di</strong>ne urgente <strong>di</strong> re Ruggero <strong>di</strong> consegnare alla chiesa<br />
beati Bartholomei il territorio adempiendo così le volontà della defunta madre Adelasia<br />
che lo aveva legittimamente a suo tempo posseduto. L’alto funzionario aveva quin<strong>di</strong><br />
proceduto nei luoghi interessati alla in<strong>di</strong>viduazione dei confini avvalendosi dell’opera e<br />
della testimonianza ex bonis ac probis hominibus Demii. 44 Della commissione incaricata <strong>di</strong><br />
rifare la delimitazione del territorio <strong>di</strong> <strong>Focerò</strong> facevano parte il categumeno del<br />
monastero <strong>di</strong> S. Angelo <strong>di</strong> Lizicò, Orestis, ed il suo priore <strong>di</strong> cui non viene fatto il nome, un<br />
notaio <strong>di</strong> Naso <strong>di</strong> nome Nicholaus, il notaio Nichitor con Nicholao notaio <strong>di</strong> Fitalia ed il<br />
notaio Petrus figlio <strong>di</strong> Nichite Policarpi, ed una serie <strong>di</strong> personaggi che potrebbero essere<br />
stati dei possidenti locali come Robertus brihennis, 45 Mule unglofaua e l’anziano 46 Iohannes<br />
Gaitanus. Ad essi vennero aggiunti dei conoscitori dei luoghi, definiti testes <strong>di</strong>visores, ex<br />
hominibus pactensibus che vengono nominati ed alii quam plures ex illis pertinentiis i cui<br />
nomi non vengono fatti.<br />
Il documento, conservato nell’archivio capitolare <strong>di</strong> Patti e pubblicato dal Garufi<br />
nel 1928, fornisce una versione dei confini <strong>di</strong> <strong>Focerò</strong> in lingua latina forse <strong>di</strong> poco<br />
successiva a quella delineata nel documento n. 2. Rispetto alla precedente la<br />
descrizione che viene fatta ci appare molto meno chiara quanto ai punti <strong>di</strong> riferimenti<br />
che vengono in<strong>di</strong>viduati per definire i confini della regione. È indubbio però l’avvenuto<br />
restringimento del territorio <strong>di</strong> <strong>Focerò</strong>, perlomeno a settentrione, rispetto all’originale<br />
configurazione datagli dal conte Ruggero e riven<strong>di</strong>cata nel documento n. 2, con<br />
l’esclusione <strong>di</strong> una porzione oggi rientrante nei limiti amministrativi del comune <strong>di</strong><br />
Piraino e forse, a meri<strong>di</strong>one, <strong>di</strong> porzioni <strong>di</strong> territorio oggi facenti parte dei comuni <strong>di</strong><br />
Raccuja e <strong>di</strong> San Piero Patti.<br />
L’andamento della descrizione sembra essere ora in senso orario con partenza dal<br />
vallone <strong>di</strong> San Silvestro ad oriente. «Dal vallone <strong>di</strong> San Silvestro e per lo stesso vallone<br />
<strong>di</strong>scende la <strong>di</strong>visione in giù verso il fiume e <strong>di</strong> là sale in alto per la via <strong>di</strong> minoto nella valle <strong>di</strong><br />
Spathari sino alla via pubblica». Probabilmente la linea <strong>di</strong>visoria giunta nel punto <strong>di</strong>