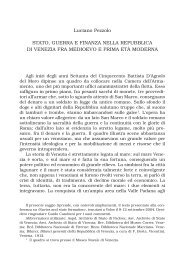Alla ricerca di Focerò - Mediterranea
Alla ricerca di Focerò - Mediterranea
Alla ricerca di Focerò - Mediterranea
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Focero' DEF:Focero' DEF 17-11-2008 21:52 Pagina 30<br />
30 | <strong>Alla</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>di</strong> <strong>Focerò</strong> | Michele Fasolo<br />
203 R. Pirro, Sicilia sacra<br />
<strong>di</strong>squisitionibus et notitiis illustrata, I-<br />
II, Panormi, 1733, (ed. anast. con<br />
introduzione <strong>di</strong> F. Giunta, Bologna,<br />
1987), I, p. 495. Ve<strong>di</strong> sopra n. 69.<br />
204 C. Grass, Sizilische Reise, Stuttgart-<br />
Tübingen, 1815 (trad. it. Sant’Angelo<br />
<strong>di</strong> Brolo 1804, Marina <strong>di</strong> Patti, 1992,<br />
p. 51-52)<br />
205 G. Gaetani, Giojosa nella sua origine<br />
e nella sua evoluzione storica, Catania,<br />
1929, p. 61.<br />
206 Acqua = “Sorgente”. D. Trischitta,<br />
Toponimi e paesaggio nella Sicilia<br />
orientale, Napoli, 1983, p. 129.<br />
207 Drago = Forse terreno sassoso e<br />
ripido.<br />
208 Chianu = “Terreno pianeggiante <strong>di</strong><br />
non grande estensione”. D. Trischitta,<br />
Toponimi e paesaggio nella Sicilia<br />
orientale, Napoli, 1983, p. 142.<br />
209 Diminutivo <strong>di</strong> Ciappe (lastroni <strong>di</strong><br />
pietre ve<strong>di</strong> D. Trischitta, Toponimi e<br />
paesaggio nella Sicilia orientale, Napoli,<br />
1983, p. 144).<br />
210 Fossa <strong>di</strong> la nivi = “Neviera, grotta<br />
naturale nella quale si raccoglie la<br />
neve che, poi, con opportuni<br />
proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> copertura viene<br />
conservata oltre il periodo dello<br />
scioglimento”. D. Trischitta,<br />
Toponimi e paesaggio nella Sicilia<br />
orientale, Napoli, 1983, p. 152.<br />
Sinagra<br />
La località risulta menzoniata come Senagra nella lista lista <strong>di</strong> 34 nomina autem civitatum<br />
et castellorum assegnati alla <strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Troina. 203 <strong>Alla</strong> metà del XIII sec. viene qualificata in più<br />
documenti relativi ad uno scambio <strong>di</strong> posse<strong>di</strong>menti come casalis.<br />
Tindari<br />
La città antica fu sede vescovile alla fine del VI sec. e lo rimase sino alla metà del IX allorché<br />
sarebbe stata espugnata dai conquistatori arabi che ne riportano forse il toponimo nei loro resoconti<br />
nelle forme <strong>di</strong> M.d.nar o D.ndarah. Da allora non risulta più attestato alcun inse<strong>di</strong>amento<br />
significativo nel territorio. Nel 1100 a ridosso della strada <strong>di</strong> scavalcamento del crinale su cui<br />
sorgeva la città greca (Scala) sarebbe stato fondato il monastero <strong>di</strong> S. Elia de Scala Oliveti.<br />
Dinamiche del ripopolamento me<strong>di</strong>evale<br />
Nel quadro delineato il ruolo propulsivo nel ripopolamento dell’intero territorio (370<br />
kmq) sembra essere appannaggio del monastero benedettino <strong>di</strong> Patti che in circa mezzo<br />
secolo tra 1094 e 1143 raddoppia i propri tenimenti sino ad interessare quasi metà del<br />
comprensorio. Il tentativo “demaniale” (1/5 dell’area), condotto in prima persona dal<br />
conte Ruggero e poi da Adelasia fallisce per l’impossibilità <strong>di</strong> contenere la rapacità dei<br />
terrieri. I due monasteri basiliani presenti appaiono come delle enclaves (appena un decimo<br />
del territorio) dove probabilmente è rimasta concentrata durante il periodo arabo la<br />
popolazione grecofona ma sembrano svolgere un ruolo privo <strong>di</strong> evidente <strong>di</strong>namicità e<br />
meramente sussi<strong>di</strong>ario nel nuovo scenario apertosi con la conquista normanna. Il vecchio<br />
ceto <strong>di</strong> possidenti greci con il loro inse<strong>di</strong>amento pare soccombere <strong>di</strong> fronte all’emergere dei<br />
nuovi signori sopraggiunti con la conquista normanna.<br />
La <strong>ricerca</strong> sul terreno<br />
Il sito <strong>di</strong> Fossa della Neve<br />
L’incrocio delle in<strong>di</strong>cazioni fornite dai documenti me<strong>di</strong>evali con i dati provenienti dal<br />
terreno hanno orientato le ricerche dell’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> <strong>Focerò</strong> verso un settore <strong>di</strong> versante<br />
collinare, esposto ad O, compreso tra il bacino idrografico del torrente Zangaria a settentrione<br />
e quello del torrente Marcurella a meri<strong>di</strong>one. Il versante presenta una pianta tronco-conica<br />
allungata, in <strong>di</strong>rezione ovest ed un profilo convesso-concavo-convesso <strong>di</strong>gradante per circa 2,5<br />
km da quota 992 m s.l.m. <strong>di</strong> Monte Fossa della Neve, picco lungo la cresta che dal crinale dei<br />
Nebro<strong>di</strong> si <strong>di</strong>stacca correndo in <strong>di</strong>rezione N verso la costa, sino alla quota 380 m s.l.m<br />
dell’alveo del torrente S. Angelo tra le contrade S. Venera e Mannara. La pendenza in <strong>di</strong>rezione<br />
O è moderatamente acclive non superando attualmente nella porzione me<strong>di</strong>o alta del versante<br />
il 35%. Precedentemente ai lavori agricoli meccanizzati effettuati alla fine degli anni ’80 del XX<br />
secolo tale parte, denominata Ciappitelli, doveva essere subpianeggiante tanto da configurarsi<br />
in un pianoro intorno a quota 930 m s.l.m. <strong>di</strong> 290 x 290 m, parzialmente protetto dai venti del I<br />
e II quadrante. Nel sito non si evidenziano frane e smottamenti significativi in <strong>di</strong>rezione O. Il<br />
principale bacino idrografico <strong>di</strong> riferimento è quello del torrente S. Angelo.<br />
La località Ciappitelli è al <strong>di</strong> sotto dell’altura <strong>di</strong> Fossa della Neve, la cui area sommitale<br />
presenta una forma ovoidale (misure max 300 m x 90 m) allungata in <strong>di</strong>rezione NNO-SSE.<br />
L’altura raggiunge i 992 m s.l.m. ed occupa un’area <strong>di</strong> 0,026 kmq. I pen<strong>di</strong>i non superano il 35%<br />
in <strong>di</strong>rezione O, N e NE mentre le pendenze arrivano al 75% ed oltre in <strong>di</strong>rezione E, SE e SO.<br />
Dalla cima <strong>di</strong> Fossa della Neve è possibile spaziare con la vista in con<strong>di</strong>zioni normali <strong>di</strong><br />
visibilità atmosferica da Capo Zafferano a Capo Rasocolmo, abbracciando tutte le isole Eolie<br />
ed in particolare il tratto <strong>di</strong> mare tra Lipari e Milazzo, con esclusione solamente <strong>di</strong> quello<br />
imme<strong>di</strong>atamente antistante la costa tirrenica a causa dell’interposizione del Monte <strong>di</strong> Gioiosa<br />
Guar<strong>di</strong>a. E’ ben visibile lo sbocco a mare della fiumara <strong>di</strong> S. Angelo <strong>di</strong> Brolo. Verso l’interno