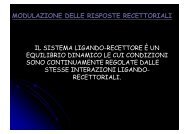Appunti di Storia della medicina - Medicina e Chirurgia
Appunti di Storia della medicina - Medicina e Chirurgia
Appunti di Storia della medicina - Medicina e Chirurgia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gli ospedali me<strong>di</strong>evali (ma questo andò avanti fino all'età moderna, e vale anche per l'ospedale<br />
civile vecchio San Giovanni <strong>di</strong> Dio) hanno la porta rivolta verso il Vaticano, perché lo Spirito Santo<br />
possa entrare meglio. Erano costituiti con una cappella che potesse essere vista da tutti i reparti<br />
ospedalieri. Il primo ospedale vero e proprio fu quello <strong>di</strong> Santo Spirito fondato a Roma da<br />
Innocenzo III, il secondo fu quello <strong>di</strong> santa Maria Novella, a Firenze.<br />
Nasce anche l’or<strong>di</strong>ne religioso dei cavalieri <strong>di</strong> San Giovanni o Ospitalieri.<br />
A partire dal X secolo l’educazione me<strong>di</strong>ca comincia ad essere istituzionalizzata. Il curriculum dei<br />
me<strong>di</strong>ci che intendessero esercitare la professione è abbastanza flessibile e consta principalmente<br />
<strong>di</strong> letture e <strong>di</strong>scussioni sotto la guida <strong>di</strong> me<strong>di</strong>ci più esperti; ancora non è previsto l’addestramento<br />
negli ospedali.<br />
Per la cosiddetta “Morte nera” del 1347 si costruirono i lebbrosari o lazzaretti, per l’isolamento dei<br />
malati contagiosi, in primis i lebbrosi, ai quali era impe<strong>di</strong>ta la frequentazione dei luoghi pubblici e i<br />
quali erano obbligati ad indossare abiti particolari ed ad annunciarsi con un campanaccio.<br />
Nel rinascimento inizia il vero e proprio processo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>calizzaizone degli ospedali, inoltre questi<br />
ultimi si dotano <strong>di</strong> spezierie ed infermerie. Tuttavia le strutture non sono ancora luogo <strong>di</strong> cura, ma<br />
solo <strong>di</strong> ricovero, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sperazione e <strong>di</strong> abusi (manicomi).<br />
Dopo il concilio <strong>di</strong> Trento (1542-1563) si assiste ad un calo delle vocazioni per le regole più<br />
severe imposte ai religiosi; il personale <strong>di</strong> assistenza si laicizza e viene reclutato fra le classi meno<br />
abbienti <strong>della</strong> popolazione, rimanendo comunque senza una preparazione specifica.<br />
Sempre nel ‘500 nasce l’or<strong>di</strong>ne Fatebenefratelli, de<strong>di</strong>to all’assistenza degli infermi.<br />
Nell’illuminismo, secondo i principi <strong>della</strong> rivoluzione francese povertà, malattia e men<strong>di</strong>cità devono<br />
essere prevenuti.<br />
Nel XIX secolo mutuano l’architettura e le funzioni degli ospedali (pa<strong>di</strong>glioni separati). Accanto alle<br />
corsie nascono i gabinetti <strong>di</strong> analisi. Si <strong>di</strong>ffondono i raggi X, proliferano i laboratori <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnostica e<br />
le corsie <strong>di</strong>ventano meno affollate, più spaziose e pulite.<br />
Vengono introdotti etere ed antisettici, gli infermieri <strong>di</strong>vengono qualificati e l’ospedale perde<br />
parzialmente l’immagine <strong>di</strong> luogo <strong>di</strong> orrori per acquisire quella <strong>di</strong> luogo <strong>di</strong> cura, dove anche i<br />
facoltosi si recano per essere curati.<br />
L’ospedale <strong>di</strong>venta anche un luogo <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong>dattica.<br />
Deontologia, etica e bioetica<br />
Il concetto <strong>di</strong> deontologia me<strong>di</strong>ca si rifà al famoso testo del “giuramento <strong>di</strong> Ippocrate”, che<br />
stabilisce una serie <strong>di</strong> norme etico-comportamentali in<strong>di</strong>rizzate alla regolarizzazione del<br />
comportamento degli appartenenti ad una comunità professionale.<br />
I comportamenti ai quali il me<strong>di</strong>co si deve attenere sono rivolti al raggiungimento del benessere<br />
del paziente, fine ultimo <strong>della</strong> me<strong>di</strong>cina; il me<strong>di</strong>co dovrà pertanto compiere solamente atti <strong>di</strong> cui è<br />
capace, rispettare la vita (<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> provocare la morte e l’eutanasia), avere un corretto rapporto<br />
con il paziente che ha <strong>di</strong>ritto ad essere informato <strong>della</strong> sua con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> salute ed ha il <strong>di</strong>ritto al<br />
segreto su tutto ciò che lo riguarda.<br />
L’osservanza <strong>di</strong> questi principi, che delineano il trattamento me<strong>di</strong>co moralmente accettabile e la<br />
condotta da tenere nell’esercizio professionale, costituisce la norma in base alla quale il me<strong>di</strong>co<br />
può essere accolto all’interno del gruppo, poiché è legato da vincoli che egli stesso sceglie <strong>di</strong><br />
mantenere. L’esigenza <strong>di</strong> regolamentare i comportamenti pratici del me<strong>di</strong>co è propria <strong>di</strong> ogni<br />
tempo: nel XIII secolo a Venezia si stende un “capitolare per i me<strong>di</strong>ci”, ma è nel XVI secolo, in<br />
Inghilterra che si arriva ad una normativa etica professionale.<br />
L’illuminismo porta a ridefinire i confini dei comportamenti sociali e professionali all’interno <strong>di</strong> una<br />
comunità (autorevolezza del me<strong>di</strong>co e la sua dolcezza nel rapporto con il paziente).<br />
La rivoluzione dell’etica me<strong>di</strong>ca prende avvio dopo la seconda guerra mon<strong>di</strong>ale, quando il<br />
processo <strong>di</strong> Norimberga svelò i crimini compiuti nella Germania nazista anche in nome <strong>della</strong><br />
ricerca scientifica. Si affermano quin<strong>di</strong> questi principi:<br />
• Libertà del soggetto (il malato deve dare il consenso alle cure)<br />
• Responsabilità dello sperimentatore<br />
• Necessità <strong>della</strong> ricerca<br />
• Adeguata proporzionalità rischio/beneficio<br />
21