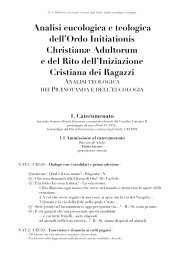introduzione alla profezia e all'apocalittica - Home Page FTTR
introduzione alla profezia e all'apocalittica - Home Page FTTR
introduzione alla profezia e all'apocalittica - Home Page FTTR
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
feta (cf Dt 18,13-20). In Nm 24,3-4 «lo spirito di Dio fu su di lui» (condizione estatica,<br />
animazione divina tipica del profeta); è «l’uomo dall’occhio penetrante» (Cei) o dallo<br />
sguardo misterioso (visionario?) 8 , vede la visione dell’Onnipotente, cade (o riceve<br />
l’oracolo) e i suoi occhi si aprono» (rivelazione; in estasi?), «ascolta parole di Dio, conosce<br />
la scienza dell’Altissimo (partecipa dei suoi piani, cf Am 3,7). La sua <strong>profezia</strong> mostra<br />
la profonda esperienza e comunicazione con Dio, non collegata all’olocausto, ma<br />
all’incontro con il Signore (Jhwh) che «venne a lui di notte» (come nella iscrizione di<br />
Deir ‘Alla), «in luogo deserto» (come Mosè). Egli potrà dare «la parola che mi mostrerà»<br />
(23,1-3).<br />
Ingaggiato come «divinatore» da Balak re di Moab per maledire Israele «nel nome del<br />
Signore», contro la volontà del re potrà solo benedirlo, perché dominato d<strong>alla</strong> parola del<br />
Signore (23,7-10 e 18-24; 24,3-9 e 15-24). Egli si giustifica di fronte al re affermando<br />
che il profeta non può trasgredire l’ordine di Dio (24,13), anche perché Giacobbe è<br />
«senza iniquità e il Signore è con lui», perciò rimane invincibile (23,8-24).<br />
«Posso io dire qualcosa? Dirò quello che Dio mi metterà in bocca» (Nm 22,38, cf<br />
23,12.26);<br />
«devo conservare e dire solo quello che il Signore ha messo nella mia bocca» (23,13).<br />
«E il Signore mise la parola nella bocca di Balaam» (23,5.6).<br />
Egli dunque è bocca di Dio con una missione destinata <strong>alla</strong> Parola (cf Ger 1,9; Es<br />
4,12-16). In tutto ciò non compie magia né divinazione.<br />
Il fenomeno del profeta, inteso come «persona che tramite una esperienza cognitiva<br />
riceve la rivelazione di un messaggio divino e lo trasmette coscientemente [non in trance]<br />
a un destinatario» (cf M. Weippert), è ben attestato nell’Antico Vicino Oriente. È<br />
perciò distinto dall'arte divinatoria, che trae auspici deduttivamente da alcuni fenomeni<br />
(cf 2Sam 28,6). Si pongono all’attenzione le lettere profetiche del regno paleobabilonese<br />
di Mari, una lettera divina del regno paleobabilonese di Esnunna; acceni da Emar e Ugarit<br />
(RS 25.460) con l’ordine di scrivere al re con un diretto messaggio da parte del dio, la<br />
stele di Zukkur re arameo di Hamat e collezioni profetiche neoassire riferite al re Asharaddon.<br />
Tali testi contengono la legittimazione dell’ascesa al trono del re, danno responsi<br />
su conflitti militari e alleanze politiche, esprimono esigenze religiose e morali di giustizia<br />
9 .<br />
Alcuni esempi. A Biblos un ragazzo invasato da una frenesia esaltatrice favorisce mediante<br />
un oracolo le trattative commerciali tra il re di Biblos Zakir e un ambasciatore egiziano.<br />
Ad Hamat il re riceve un messaggio, interessante per lo stile, il cui testo è su una stele.<br />
È dato tramite «veggenti» e «indovini», messaggeri del Dio del Dio Baal Shamin: «Non<br />
temere, perché io t’ho fatto re e io ti sosterrò e ti libererò da tutti i re che hanno posto<br />
l’assedio contro di te» (cf. Is 7,3-9).<br />
In Mesopotamia, Mari soprattutto ci ha tramandato testi profetici, il cui nucleo principale<br />
va dal 1830 al 1759 a.C. 10 Nella modalità della comunicazione divina sembrano avere le<br />
caratteristiche fondamentali dei profeti biblici. Sono pragmatici e danno responsi ex eventu,<br />
dal fatto. I loro messaggi contengono ordini o proibizioni, minacce o promesse di benedizione,<br />
assicurazione di liberazione dal pericolo, come nei profeti biblici. Il fenomeno appa-<br />
8<br />
Il TM ha «uomo šetūm di occhio», cioè dall’occhio «sigillato» - cieco? Perciò vede oltre le apparenze, in<br />
profondità? LXX traduce «occhio aperto», Targum intende tam, «perfetto», così i suoi occhi sono aperti, svelati<br />
(v.4).<br />
9<br />
Cf P. MERLO, «Il profetismo nel Vicino Oriente antico: panorama di un fenomeno e difficoltà comparative»,<br />
RSB 21 (1/2009) 55-83.<br />
10<br />
Cf. L. CAGNI, Le profezie di Mari (Testi del Vicino Oriente antico), Paideia, Brescia 1995 (raccoglie 52 testi<br />
profetici: 50 relazioni e 2 resoconti di sogni); i tipi di profetismo sono a p. 18s.<br />
8