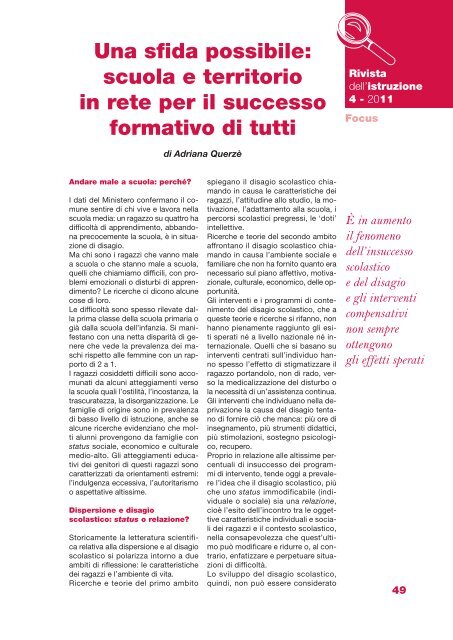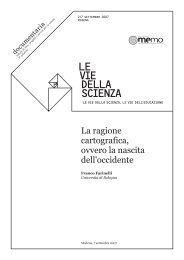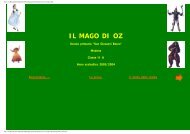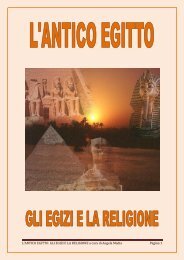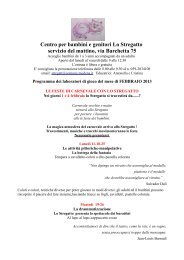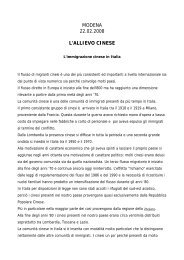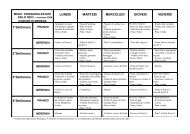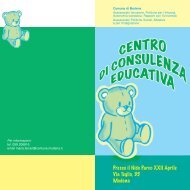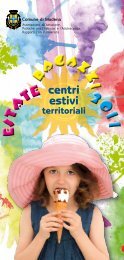Rivista dell'istruzione. N. 4/11 Focus - Comune di Modena
Rivista dell'istruzione. N. 4/11 Focus - Comune di Modena
Rivista dell'istruzione. N. 4/11 Focus - Comune di Modena
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Una sfida possibile:<br />
scuola e territorio<br />
in rete per il successo<br />
formativo <strong>di</strong> tutti<br />
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
<strong>di</strong> Adriana Querzè<br />
Andare male a scuola: perché?<br />
I dati del Ministero confermano il comune<br />
sentire <strong>di</strong> chi vive e lavora nella<br />
scuola me<strong>di</strong>a: un ragazzo su quattro ha<br />
<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento, abbandona<br />
precocemente la scuola, è in situazione<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio.<br />
Ma chi sono i ragazzi che vanno male<br />
a scuola o che stanno male a scuola,<br />
quelli che chiamiamo <strong>di</strong>fficili, con problemi<br />
emozionali o <strong>di</strong>sturbi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento?<br />
Le ricerche ci <strong>di</strong>cono alcune<br />
cose <strong>di</strong> loro.<br />
Le <strong>di</strong>fficoltà sono spesso rilevate dalla<br />
prima classe della scuola primaria o<br />
già dalla scuola dell’infanzia. Si manifestano<br />
con una netta <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> genere<br />
che vede la prevalenza dei maschi<br />
rispetto alle femmine con un rapporto<br />
<strong>di</strong> 2 a 1.<br />
I ragazzi cosiddetti <strong>di</strong>fficili sono accomunati<br />
da alcuni atteggiamenti verso<br />
la scuola quali l’ostilità, l’incostanza, la<br />
trascuratezza, la <strong>di</strong>sorganizzazione. Le<br />
famiglie <strong>di</strong> origine sono in prevalenza<br />
<strong>di</strong> basso livello <strong>di</strong> istruzione, anche se<br />
alcune ricerche evidenziano che molti<br />
alunni provengono da famiglie con<br />
status sociale, economico e culturale<br />
me<strong>di</strong>o-alto. Gli atteggiamenti educativi<br />
dei genitori <strong>di</strong> questi ragazzi sono<br />
caratterizzati da orientamenti estremi:<br />
l’indulgenza eccessiva, l’autoritarismo<br />
o aspettative altissime.<br />
Dispersione e <strong>di</strong>sagio<br />
scolastico: status o relazione?<br />
Storicamente la letteratura scientifica<br />
relativa alla <strong>di</strong>spersione e al <strong>di</strong>sagio<br />
scolastico si polarizza intorno a due<br />
ambiti <strong>di</strong> riflessione: le caratteristiche<br />
dei ragazzi e l’ambiente <strong>di</strong> vita.<br />
Ricerche e teorie del primo ambito<br />
spiegano il <strong>di</strong>sagio scolastico chiamando<br />
in causa le caratteristiche dei<br />
ragazzi, l’attitu<strong>di</strong>ne allo stu<strong>di</strong>o, la motivazione,<br />
l’adattamento alla scuola, i<br />
percorsi scolastici pregressi, le ‘doti’<br />
intellettive.<br />
Ricerche e teorie del secondo ambito<br />
affrontano il <strong>di</strong>sagio scolastico chiamando<br />
in causa l’ambiente sociale e<br />
familiare che non ha fornito quanto era<br />
necessario sul piano affettivo, motivazionale,<br />
culturale, economico, delle opportunità.<br />
Gli interventi e i programmi <strong>di</strong> contenimento<br />
del <strong>di</strong>sagio scolastico, che a<br />
queste teorie e ricerche si rifanno, non<br />
hanno pienamente raggiunto gli esiti<br />
sperati né a livello nazionale né internazionale.<br />
Quelli che si basano su<br />
interventi centrati sull’in<strong>di</strong>viduo hanno<br />
spesso l’effetto <strong>di</strong> stigmatizzare il<br />
ragazzo portandolo, non <strong>di</strong> rado, verso<br />
la me<strong>di</strong>calizzazione del <strong>di</strong>sturbo o<br />
la necessità <strong>di</strong> un’assistenza continua.<br />
Gli interventi che in<strong>di</strong>viduano nella deprivazione<br />
la causa del <strong>di</strong>sagio tentano<br />
<strong>di</strong> fornire ciò che manca: più ore <strong>di</strong><br />
insegnamento, più strumenti <strong>di</strong>dattici,<br />
più stimolazioni, sostegno psicologico,<br />
recupero.<br />
Proprio in relazione alle altissime percentuali<br />
<strong>di</strong> insuccesso dei programmi<br />
<strong>di</strong> intervento, tende oggi a prevalere<br />
l’idea che il <strong>di</strong>sagio scolastico, più<br />
che uno status immo<strong>di</strong>ficabile (in<strong>di</strong>viduale<br />
o sociale) sia una relazione,<br />
cioè l’esito dell’incontro tra le oggettive<br />
caratteristiche in<strong>di</strong>viduali e sociali<br />
dei ragazzi e il contesto scolastico,<br />
nella consapevolezza che quest’ultimo<br />
può mo<strong>di</strong>ficare e ridurre o, al contrario,<br />
enfatizzare e perpetuare situazioni<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà.<br />
Lo sviluppo del <strong>di</strong>sagio scolastico,<br />
quin<strong>di</strong>, non può essere considerato<br />
È in aumento<br />
il fenomeno<br />
dell’insuccesso<br />
scolastico<br />
e del <strong>di</strong>sagio<br />
e gli interventi<br />
compensativi<br />
non sempre<br />
ottengono<br />
gli effetti sperati<br />
49
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
50<br />
<strong>Focus</strong><br />
Quando il <strong>di</strong>sagio<br />
scaturisce<br />
da un cattivo<br />
rapporto<br />
tra un ragazzo<br />
e i contesti<br />
<strong>di</strong> vita,<br />
la scuola<br />
può svolgere<br />
un ruolo decisivo<br />
per una buona<br />
crescita<br />
soltanto effetto <strong>di</strong> un certo ambiente<br />
familiare o sociale né univoco risultato<br />
<strong>di</strong> caratteristiche del ragazzo. L’insieme<br />
dei comportamenti sintomatici<br />
del <strong>di</strong>sagio scolastico va considerato<br />
all’interno del contesto scolastico che<br />
lo contiene.<br />
La scuola non può autoassolversi<br />
Dunque, è opportuno accettare il fatto<br />
che il <strong>di</strong>sagio non trae origine da qualcosa,<br />
ma è componente dell’insieme<br />
dei sistemi relazionali <strong>di</strong> cui il ragazzo<br />
fa parte.<br />
Così impostato il problema chiama fortemente<br />
in causa la scuola come contesto<br />
nel quale la relazione viene agita.<br />
Più precisamente chiama in causa i<br />
docenti con le loro competenze <strong>di</strong>sciplinari<br />
e metodologiche; il clima <strong>di</strong> classe<br />
e <strong>di</strong> scuola; le relazioni fra docenti e<br />
fra docenti e genitori; l’immagine mentale<br />
che gli adulti hanno degli studenti;<br />
l’idea <strong>di</strong> efficacia professionale, cioè<br />
il convincimento degli adulti <strong>di</strong> ‘potercela<br />
fare’. Questo approccio può meglio<br />
contenere il proliferare <strong>di</strong> situazioni<br />
nelle quali il <strong>di</strong>sagio annunciato si<br />
materializza come profezia che si auto-adempie.<br />
Le tecniche, gli interventi specialistici,<br />
i programmi settoriali possono essere<br />
importanti ma è la capacità della scuola<br />
<strong>di</strong> non auto-assolversi, <strong>di</strong> non chiamarsi<br />
fuori (è colpa del ragazzo o della<br />
famiglia o è colpa della società…) e<br />
<strong>di</strong> riflettere sulle concrete modalità <strong>di</strong><br />
relazione messe in campo negli altrettanto<br />
concreti contesti <strong>di</strong> lavoro. Solo<br />
questo approccio può dare ai ragazzi<br />
la garanzia <strong>di</strong> non essere considerati<br />
perduti dalla scuola e <strong>di</strong> usufruire <strong>di</strong><br />
altre opportunità.<br />
Questo non significa scuola facile, sarebbe<br />
un doppio tra<strong>di</strong>mento per chi<br />
ha bisogno, forse più <strong>di</strong> altri, <strong>di</strong> uscire<br />
dalla scuola culturalmente attrezzato;<br />
significa scuola responsabile e<br />
capace <strong>di</strong> porsi come luogo <strong>di</strong> buona<br />
crescita.<br />
L’esperienza delle scuole<br />
secondarie <strong>di</strong> primo grado<br />
<strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />
Da nove anni le scuole secondarie <strong>di</strong><br />
primo grado <strong>di</strong> <strong>Modena</strong> lavorano in rete<br />
sui temi del <strong>di</strong>sagio scolastico cercando<br />
<strong>di</strong> concretizzare un approccio che parta<br />
dall’accettazione del fatto che esso non<br />
trae origine da qualcosa ma è componente<br />
dell’insieme dei sistemi relazionali<br />
<strong>di</strong> cui il ragazzo fa parte; insieme che<br />
include, in primo luogo, la scuola stessa,<br />
inelu<strong>di</strong>bile agente <strong>di</strong> cambiamento.<br />
Il convegno “Una sfida possibile: scuola<br />
e territorio in rete, per il successo formativo<br />
<strong>di</strong> tutti”, svoltosi a <strong>Modena</strong> il 13<br />
maggio 20<strong>11</strong>, ha tentato <strong>di</strong> dar conto<br />
<strong>di</strong> questa esperienza inquadrandola in<br />
riflessioni più generali e mettendola in<br />
relazione con altre, attuate da altri soggetti<br />
sul territorio nazionale.<br />
Il convegno, organizzato dal <strong>Comune</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Modena</strong>, Rete delle scuole secondarie<br />
<strong>di</strong> primo grado, Associazione<br />
Città&Scuola, è stato patrocinato<br />
da Regione Emilia-Romagna, Provincia<br />
<strong>di</strong> <strong>Modena</strong>, Ufficio scolastico regionale<br />
e Ufficio scolastico provinciale<br />
ed ha avuto il sostegno <strong>di</strong> Fondazione<br />
Cassa <strong>di</strong> Risparmio <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>, Fondazione<br />
San Filippo Neri e Associazione<br />
Servizi per il volontariato <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>.<br />
La pluralità <strong>di</strong> soggetti a vario titolo<br />
coinvolti, due dei quali – Fondazione<br />
Cassa <strong>di</strong> Risparmio <strong>di</strong> <strong>Modena</strong> e Associazione<br />
Città &Scuola – sostengono<br />
<strong>di</strong>rettamente il progetto, dà conto<br />
dell’articolazione del lavoro delle scuole<br />
secondarie <strong>di</strong> primo grado della città<br />
e della sua positiva azione sul tessuto<br />
sociale oltre che scolastico.
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
Le ipotesi del convegno <strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />
Proponiamo in questo inserto alcune delle relazioni ed esperienze presentate al convegno<br />
sottolineando che si è trattato <strong>di</strong> una giornata in cui i cosiddetti ‘saperi esperti’<br />
sono stati obbligati a mettersi in relazione con le esperienze e le conoscenze maturate<br />
da insegnanti, educatori, <strong>di</strong>rigenti scolastici. Questa scelta, culturale più che<br />
organizzativa, è nata dalla volontà <strong>di</strong> non applicare alla prassi scolastica modelli e<br />
teorie elaborati altrove ma, al contrario, <strong>di</strong> contribuire a fare interagire <strong>di</strong>fferenti luoghi<br />
<strong>di</strong> elaborazione del sapere nella consapevolezza che il ‘luogo-scuola’ consente<br />
a professionisti riflessivi e colti <strong>di</strong> elaborare conoscenze e saperi autentici che assumono<br />
tanto più valore quanto più si interfacciano con la ricerca educativa e ne vengono<br />
riconosciuti come parte qualificata.<br />
I contributi qui proposti consistono in quattro relazioni ed altrettante esperienze ed<br />
intendono fornire spunti <strong>di</strong> riflessione sul progetto modenese.<br />
Le ragioni del progetto<br />
Mario Menziani nell’intervento su Il progetto “Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta. Scuola e territorio<br />
insieme per prevenire il <strong>di</strong>sagio e la <strong>di</strong>spersione scolastica”, ripercorre le fasi <strong>di</strong><br />
crescita del progetto stesso, la sua sistematizzazione e assunzione consapevole da<br />
parte delle scuole definendone gli aspetti centrali:<br />
- l’arricchimento dell’offerta formativa con l’apertura delle scuole oltre l’orario curricolare<br />
per realizzare attività, laboratori e iniziative basate sul lavoro <strong>di</strong> docenti,<br />
<strong>di</strong> genitori in qualità <strong>di</strong> esperti, <strong>di</strong> volontari, <strong>di</strong> associazioni e <strong>di</strong> istituzioni del territorio;<br />
- il supporto all’appren<strong>di</strong>mento con l’organizzazione <strong>di</strong> sportelli <strong>di</strong>dattici e attività<br />
<strong>di</strong> ‘compiti insieme’ svolti in sinergia con doposcuola già attivi sul territorio, centri<br />
<strong>di</strong>urni e associazioni con il miglioramento e l’incremento del rapporto fra scuola<br />
e territorio;<br />
- il reperimento <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> necessari alla realizzazione degli interventi col coinvolgimento<br />
<strong>di</strong> enti e istituzioni del territorio: fondazioni bancarie, regione, comune.<br />
Questi interventi, sottolinea Menziani, sono stati resi possibili grazie alla creazione<br />
ed alla manutenzione <strong>di</strong> reti: quella delle scuole, quella territoriale e quella del volontariato,<br />
delle quali vengono esaminati gli effettivi punti <strong>di</strong> forza e le potenzialità.<br />
Il ruolo dei soggetti in gioco<br />
Francesco Pisanu, nel saggio Attività extracurricolari, sostegno all’impegno scolastico<br />
e prevenzione del <strong>di</strong>sagio: il caso del progetto “Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta”, esamina<br />
alcune caratteristiche strutturali del progetto che coinvolge significativamente enti,<br />
istituzioni e collettività. Un dato quantitativo esprime questo coinvolgimento: se, su<br />
base annua, Fondazione Cassa <strong>di</strong> Risparmio e <strong>Comune</strong> arrivano a finanziare 3.144<br />
ore <strong>di</strong> attività nelle scuole considerate, il volontariato ne realizza 3.150. In questo<br />
contesto i punti <strong>di</strong> rilievo sono:<br />
- attivazione <strong>di</strong> azioni su aspetti cognitivi e psico-sociali (ren<strong>di</strong>mento e comportamento),<br />
in cui sono sempre meno le possibilità <strong>di</strong> supporto per studenti in <strong>di</strong>fficoltà;<br />
attribuzione agli attori istituzionali della rete <strong>di</strong> maggiori responsabilità sul versante<br />
‘accademico’ e cognitivo, per assegnare a genitori e volontariato azioni che<br />
solo in parte sono centrate sul successo formativo;<br />
- attenzione alla con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> ‘assunti <strong>di</strong> base’ che possano consentire ai <strong>di</strong>versi<br />
attori in gioco <strong>di</strong> avere un approccio comune nella realizzazione delle attività.<br />
In questo quadro le percezioni degli studenti, in particolare su “compiti assieme”,<br />
sono molto positive, risultando inclusive e positivamente slegate da ciò che avviene<br />
in classe rispetto alle <strong>di</strong>namiche relazionali a volte etichettanti ed emarginanti rispetto<br />
ad alunni che presentano <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento.<br />
<strong>Focus</strong><br />
Il convegno<br />
<strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />
della primavera<br />
20<strong>11</strong><br />
ha messo a fuoco<br />
idee fondamentali<br />
in materia<br />
<strong>di</strong> contrasto<br />
della <strong>di</strong>spersione,<br />
come il lavoro<br />
<strong>di</strong> rete, l’apporto<br />
<strong>di</strong> genitori<br />
e il ruolo del<br />
volontariato<br />
51
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Concetti<br />
fondamentali<br />
per prevenire<br />
il <strong>di</strong>sagio sono<br />
il coinvolgimento<br />
attivo<br />
dei soggetti<br />
(capability),<br />
la partecipazione<br />
sociale,<br />
la ricerca-azione<br />
Un nuovo approccio<br />
Ciro Ruggerini e Sumire Manzotti in Capability e Developmental Approach: possibili<br />
implicazioni nell’esperienza scolastica presentano la capability come concetto capace<br />
<strong>di</strong> orientare le azioni <strong>di</strong> tutte le agenzie (politiche, sociali e sanitarie) <strong>di</strong> una comunità<br />
verso una maggiore sinergia ed efficacia. Evidente è l’attinenza <strong>di</strong> questo contributo<br />
con le caratteristiche strutturali del progetto modenese per alcuni aspetti salienti:<br />
la persona alla quale sono <strong>di</strong>retti atti <strong>di</strong> assistenza o aiuti allo sviluppo non va<br />
considerata un recettore passivo ma un agente in grado <strong>di</strong> identificare obiettivi<br />
prioritari;<br />
- la persona e le agenzie della comunità possono funzionare al meglio in un terreno<br />
culturale esplicitamente con<strong>di</strong>viso.<br />
Le Capabilities rappresentano le libertà o le opportunità che le persone hanno <strong>di</strong> essere<br />
e <strong>di</strong> fare quello che in realtà vogliono essere e fare; l’approccio è dunque in grado<br />
<strong>di</strong> tener conto delle <strong>di</strong>versità in<strong>di</strong>viduali e del ruolo fondante della libertà umana.<br />
Anche la cultura alla base dell’organizzazione scolastica può esserne profondamente<br />
influenzata.<br />
La metafora della rete<br />
Vando Borghi nell’intervento La metafora della rete: aprire la scatola nera, prendendo<br />
le mosse dall’alta ricorrenza del concetto <strong>di</strong> rete nei ragionamenti relativi all’istruzione,<br />
afferma che tale termine è <strong>di</strong>ventato una metafora che occorrerà esplorare e,<br />
in un certo senso, <strong>di</strong>sambiguare.<br />
La rete non è virtuosa in sé e occorre esaminare le proprietà che rendono virtuosa<br />
tale modalità <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento partendo dalla con<strong>di</strong>visibile affermazione che una<br />
rete è virtuosa se persegue l’interesse generale. Centrale <strong>di</strong>viene allora l’identificazione<br />
dei ‘sintomi’ che ci segnalano la presenza <strong>di</strong> questa caratteristica:<br />
- la visibilità dei criteri sulla base dei quali viene perseguito un obiettivo <strong>di</strong> interesse<br />
generale. Il fatto che si riconosca che le materie, i problemi, le questioni <strong>di</strong> cui<br />
si sta trattando sono attinenti al bene pubblico;<br />
- la pratica della partecipazione che non è un dato <strong>di</strong> partenza ma, laddove si produce,<br />
è un esito, qualcosa che richiede un investimento <strong>di</strong> risorse materiali e immateriali,<br />
un sostegno, una manutenzione nel corso del tempo;<br />
- il fatto che le relazioni promosse dalla rete siano orientate alla creazione <strong>di</strong> terre<br />
<strong>di</strong> confine, che mettano in contatto soggetti <strong>di</strong>versi per natura, estrazione sociale,<br />
appartenenza culturale per poter almeno tentare <strong>di</strong> contrastare il fatto che<br />
l’esperienza sociale urbana contemporanea è sempre più fortemente caratterizzata<br />
dall’incontro tra simili.<br />
Le esperienze-pilota<br />
A questi contributi sono state affiancate quattro esperienze particolarmente significative:<br />
La gestione dei casi <strong>di</strong>fficili nella scuola me<strong>di</strong>a del Canton Ticino <strong>di</strong> Flavia Cereghetti-Bion<strong>di</strong>;<br />
I laboratori del fare e del sapere nell’esperienza trentina <strong>di</strong> Silvia Tabarelli;<br />
Provaci ancora, Sam! <strong>di</strong> Marina Busso e Barbara Rivoira;<br />
Scuola per prevenire, scuola per recuperare <strong>di</strong> Daniele Giar<strong>di</strong>na e Edda Odorici dell’Istituto<br />
comprensivo “Trilussa” <strong>di</strong> Quarto Oggiaro (Mi).<br />
Si tratta <strong>di</strong> esperienze <strong>di</strong>verse che però <strong>di</strong>mostrano che intervenire sul <strong>di</strong>sagio è possibile<br />
se la scuola, le famiglie, il volontariato, la ricerca accademica, gli enti e le istituzioni<br />
prendono sul serio l’affermazione che il bene più prezioso del presente e del<br />
futuro sono i ragazzi e le loro potenzialità.<br />
Non possiamo permetterci <strong>di</strong> perdere né gli uni né le altre, perché ciò non è giusto<br />
e nemmeno conveniente per le persone e per il Paese.<br />
52<br />
Adriana Querzè<br />
Assessore all’Istruzione, politiche per l’infanzia<br />
e l’adolescenza, rapporti con l’università<br />
del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>
Il progetto<br />
“Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta”<br />
Scuola e territorio insieme per prevenire<br />
il <strong>di</strong>sagio e la <strong>di</strong>spersione scolastica<br />
<strong>di</strong> Mario Menziani<br />
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Le ragioni che hanno ispirato<br />
il progetto<br />
Più che <strong>di</strong> un singolo progetto dobbiamo<br />
parlare <strong>di</strong> un vero e proprio<br />
percorso per descrivere l’esperienza<br />
modenese nel campo della prevenzione<br />
del <strong>di</strong>sagio e della <strong>di</strong>spersione<br />
scolastica. Avviato ormai nove<br />
anni fa, il percorso ha coinvolto tutte<br />
le scuole secondarie <strong>di</strong> primo grado<br />
(tabella 1) e ha da sempre avuto la caratteristica<br />
<strong>di</strong> rivolgersi a tutti gli alunni,<br />
nella convinzione che solo mutando<br />
il ‘clima’ interno alla scuola si riescano<br />
a coinvolgere anche gli alunni<br />
che manifestano <strong>di</strong>sagio.<br />
Questa convinzione è basata sull’esperienza<br />
quoti<strong>di</strong>ana e sull’osservazione<br />
delle crescenti manifestazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio<br />
personale e scolastico degli alunni,<br />
nonché sulla constatazione dell’inadeguatezza<br />
della scuola, se non ad<strong>di</strong>rittura<br />
dell’arretramento della stessa nella<br />
capacità <strong>di</strong> offrire strumenti adeguati<br />
alle nuove necessità.<br />
La crisi dei valori tra<strong>di</strong>zionali, delle figure<br />
genitoriali, della famiglia, dell’identità<br />
maschile, nonché la crescente affluenza<br />
<strong>di</strong> immigrati, con la conseguente<br />
crisi <strong>di</strong> identità personale e culturale<br />
delle seconde generazioni, costituiscono<br />
fattori che mettono a dura prova<br />
il sistema scolastico italiano, da anni<br />
bisognoso <strong>di</strong> riforme, e ne mostrano<br />
l’inadeguatezza ad assicurare risposte<br />
efficaci al <strong>di</strong>sagio, alle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento,<br />
alla mancanza <strong>di</strong> motivazione,<br />
alla <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> accettazione delle<br />
regole della convivenza sociale, alla<br />
<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> relazione interpersonale<br />
che i ragazzi e le ragazze manifestano<br />
in maniera sempre più evidente.<br />
Un percorso <strong>di</strong> ricerca-azione<br />
Il percorso ha inteso offrire risposte a<br />
queste necessità, ponendosi come riferimento<br />
per le nuove generazioni che<br />
l’attraversano, per le loro famiglie e per<br />
le <strong>di</strong>verse istituzioni che si occupano <strong>di</strong><br />
infanzia e adolescenza. Per questo l’intento<br />
prioritario è stato quello <strong>di</strong> dare<br />
l’avvio ad una fitta rete <strong>di</strong> relazioni tra<br />
tutti gli interlocutori.<br />
Abbiamo proceduto attraverso un progetto<br />
pragmatico <strong>di</strong> ricerca-azione, con<br />
l’obiettivo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare gli strumenti più<br />
idonei a consentire ai ragazzi <strong>di</strong> scuola<br />
me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> affrontare con serenità il percorso<br />
formativo e il processo <strong>di</strong> sviluppo<br />
personale. Nel percorso abbiamo maturato<br />
la convinzione che il nostro sforzo,<br />
per <strong>di</strong>mostrarsi efficace, non possa prescindere<br />
dalla collaborazione dell’intero<br />
territorio per la messa a punto <strong>di</strong> azioni<br />
sempre più coor<strong>di</strong>nate tra scuola, famiglie,<br />
servizi territoriali e volontariato. Durante<br />
tutto il percorso, fondamentale è<br />
stato il sostegno da parte dell’Assessorato<br />
all’istruzione del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>.<br />
Una strategia <strong>di</strong> ‘rapido’<br />
intervento<br />
Abbiamo ritenuto necessario garantire<br />
ai ragazzi un contesto ricco, stimolante<br />
e vario; per questo abbiamo aperto la<br />
scuola al territorio e interagito con tutte<br />
le realtà che si occupano <strong>di</strong> infanzia<br />
e adolescenza a partire dal volontariato<br />
sociale.<br />
Di fronte<br />
a crisi sociale,<br />
<strong>di</strong> valori<br />
e <strong>di</strong> stili<br />
<strong>di</strong> vita<br />
il progetto<br />
modenese<br />
ha chiamato<br />
attorno<br />
alla questione<br />
educativa<br />
una pluralità<br />
<strong>di</strong> soggetti<br />
del territorio<br />
Tabella 1 – Percentuali <strong>di</strong> alunni con problemi <strong>di</strong> alfabetizzazione, comportamento o<br />
nella preparazione nelle scuole secondarie <strong>di</strong> primo grado modenesi. A.s. 2010-<strong>11</strong><br />
N. plessi N. alunni<br />
% alunni da seguire<br />
con alfabetizzazione<br />
% alunni con problemi<br />
<strong>di</strong> comportamento<br />
% alunni con problemi<br />
nella preparazione<br />
10 4.431 4, 6 4, 2 20, 0<br />
53
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Il progetto<br />
si articola<br />
in numerose azioni,<br />
finalizzate<br />
a <strong>di</strong>versificare<br />
le proposte<br />
formative<br />
per sostenere<br />
e orientare<br />
allievi<br />
e genitori<br />
Abbiamo cercato <strong>di</strong> garantire una capacità<br />
<strong>di</strong> ascolto imme<strong>di</strong>ata e tempestiva,<br />
per dare risposte efficaci alle necessità<br />
manifestate. In particolare abbiamo<br />
costruito insieme ai Servizi sociali<br />
e all’USL percorsi rapi<strong>di</strong> <strong>di</strong> intervento,<br />
pre<strong>di</strong>sponendo protocolli d’azione<br />
e <strong>di</strong> scambio <strong>di</strong> informazioni.<br />
Al tempo stesso abbiamo voluto garantire<br />
alle singole istituzioni scolastiche<br />
la capacità <strong>di</strong> sviluppare al loro interno<br />
strumenti <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> intervento sempre<br />
più precisi ed efficaci, mettendole<br />
in grado <strong>di</strong> riformularli (pianificando,<br />
monitorando e valutando) e <strong>di</strong> adattarli<br />
alle specifiche esigenze. In particolare<br />
abbiamo promosso la costituzione in<br />
ciascuna scuola <strong>di</strong> un’équipe <strong>di</strong> docenti<br />
(supportandoli anche con azioni specifiche<br />
<strong>di</strong> aggiornamento) in grado <strong>di</strong> analizzare<br />
e gestire le informazioni per in<strong>di</strong>rizzare<br />
i colleghi nel lavoro quoti<strong>di</strong>ano e<br />
i consigli <strong>di</strong> classe nella programmazione<br />
degli interventi necessari.<br />
Gli elementi caratterizzanti<br />
Punti car<strong>di</strong>ne degli interventi attuati sono<br />
stati:<br />
1. l’arricchimento dell’offerta formativa:<br />
aprendo le scuole oltre l’orario<br />
curricolare per la realizzazione <strong>di</strong> attività,<br />
laboratori e iniziative, affidati<br />
anche alla gestione <strong>di</strong> genitori, <strong>di</strong><br />
volontari e associazioni o istituzioni<br />
del territorio (tabella 2);<br />
2. un efficace supporto all’appren<strong>di</strong>mento<br />
degli alunni più deboli, nonché<br />
degli alunni stranieri: organizzando<br />
sportelli <strong>di</strong>dattici, attività <strong>di</strong> ‘compiti<br />
insieme’, avvalendosi <strong>di</strong> contributi<br />
esterni quali doposcuola, centri <strong>di</strong>urni,<br />
ecc.; sapendo costruire rete con<br />
tutte queste <strong>di</strong>verse realtà; favorendo<br />
il <strong>di</strong>alogo tra scuola e territorio;<br />
3. un altrettanto efficace supporto alla<br />
persona: avviando e successivamente<br />
consolidando l’esperienza<br />
dei tutor e degli sportelli d’ascolto<br />
come strumenti <strong>di</strong> intervento, durante<br />
la permanenza a scuola; collaborando<br />
con i servizi del territorio in<br />
presenza <strong>di</strong> problematiche più gravi<br />
in carico ai servizi stessi;<br />
4. azioni rivolte ai genitori, in quanto<br />
primi educatori dei propri figli, per favorire:<br />
la consapevolezza del ruolo <strong>di</strong><br />
genitore; la concertazione <strong>di</strong> strategie<br />
efficaci; la progettazione e la realizzazione<br />
<strong>di</strong> azioni significative finalizzate<br />
sia al bene personale (benessere<br />
psicofisico-relazionale; ricerca<br />
della propria autonomia personale:<br />
orientamento alla vita) sia al bene comune<br />
(puntando sui valori costituzionali<br />
della citta<strong>di</strong>nanza attiva, della legalità,<br />
della partecipazione democratica<br />
e della convivenza civile);<br />
5. il reperimento <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> necessari alla<br />
realizzazione degli interventi, rivolgendoci<br />
a varie istituzioni del territorio:<br />
fondazioni bancarie, regione,<br />
comune (tabella 3).<br />
Nell’imme<strong>di</strong>ato futuro inten<strong>di</strong>amo av<br />
Tabella 2 – Attività svolte nell’ambito del progetto. A.s. 2010-<strong>11</strong><br />
Attività<br />
N. ore <strong>di</strong> attività<br />
Operatori Volontari Totale<br />
N. ragazzi<br />
coinvolti<br />
Laboratori pomeri<strong>di</strong>ani 321 1562 1.883 1.390<br />
Tutoraggio 1.187 315 1.502 156<br />
Compiti insieme 1.442 1.288 2.730 516<br />
Totale 2.950 3.165 6<strong>11</strong>5 2.062<br />
54<br />
Tabella 3 – Risorse economiche. A.s. 2010-<strong>11</strong><br />
Fondazione Cassa <strong>di</strong><br />
Scuole secondarie<br />
Risorse<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />
Risparmio <strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />
<strong>di</strong> primo grado<br />
Importo in euro 70. 000 15. 000 30. 000
viare con le scuole superiori <strong>di</strong> <strong>Modena</strong><br />
un percorso <strong>di</strong> collaborazione per dare<br />
il via ad azioni sinergiche con il comune<br />
intento <strong>di</strong> facilitare il passaggio da un<br />
or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> scuola all’altro e <strong>di</strong> ridurre gli<br />
insuccessi e gli abbandoni, <strong>di</strong> allargare<br />
il coinvolgimento delle realtà territoriali<br />
anche al mondo delle realtà produttive<br />
per realizzare azioni <strong>di</strong> orientamento<br />
rivolte ad alunni e famiglie.<br />
La governance del progetto<br />
Ben presto è maturata la convinzione<br />
che soltanto il coor<strong>di</strong>namento tra scuole,<br />
famiglie, servizi territoriali e volontariato<br />
potesse rendere efficaci le azioni<br />
intraprese. Era pertanto necessario<br />
lavorare alla realizzazione delle azioni<br />
previste dal progetto e al tempo stesso<br />
avviare una rete citta<strong>di</strong>na a partire da<br />
una ben strutturata rete tra le scuole.<br />
La rete delle scuole si basa su due organismi<br />
fondamentali: il Comitato tecnico-scientifico<br />
e il Coor<strong>di</strong>namento citta<strong>di</strong>no<br />
dei docenti. Parallelamente a<br />
quest’ultimo si è costituito un Coor<strong>di</strong>namento<br />
dei comitati dei genitori con<br />
i quali da subito si è avviata una collaborazione<br />
operativa per l’apertura pomeri<strong>di</strong>ana<br />
delle scuole, per svolgervi<br />
attività laboratoriali (brevi esperienze,<br />
generalmente a carattere tecnico-pratico,<br />
gestite in prima persona dai genitori<br />
nell’ine<strong>di</strong>to ruolo <strong>di</strong> insegnanti).<br />
Nel Coor<strong>di</strong>namento tecnico-scientifico<br />
sono rappresentate le scuole e il territorio.<br />
Ne fanno parte, oltre al <strong>di</strong>rigente<br />
della scuola capofila, rappresentanti<br />
dei docenti, dei genitori, delle istituzioni<br />
locali e delle realtà territoriali che<br />
si occupano <strong>di</strong> infanzia e adolescenza.<br />
Ha funzioni <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo,<br />
nonché <strong>di</strong> verifica della congruità<br />
delle azioni con le finalità del progetto.<br />
Il Coor<strong>di</strong>namento citta<strong>di</strong>no dei docenti ha<br />
funzioni <strong>di</strong> progettazione, confronto e verifica<br />
delle attività realizzate ed è costituito<br />
da un rappresentante per ogni scuola<br />
(nominato dal collegio docenti, generalmente<br />
è una ‘funzione strumentale’,<br />
solo in taluni casi è ‘funzione specifica’).<br />
Non sembri secondario quest’ultimo<br />
aspetto, che riteniamo importante perché<br />
implica il coinvolgimento <strong>di</strong> tutto il<br />
collegio dei docenti. In tal modo vengono<br />
<strong>di</strong>scusse e con<strong>di</strong>vise le articolazioni<br />
specifiche del progetto da adottare<br />
nelle scuole e si destinano le risorse<br />
necessarie; si conferisce ad un collega<br />
l’incarico <strong>di</strong> rappresentare la scuola<br />
nel Coor<strong>di</strong>namento citta<strong>di</strong>no e ad un<br />
numero congruo <strong>di</strong> docenti il compito<br />
<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare il progetto d’istituto.<br />
Attività da ricomporre<br />
nel curricolo<br />
Le articolazioni delle attività sono molteplici.<br />
Si prevedono:<br />
a. laboratori pomeri<strong>di</strong>ani, la cui organizzazione<br />
comporta tempo e impegno<br />
<strong>di</strong>retto degli insegnanti perché,<br />
pur essendo condotti dai genitori,<br />
necessitano <strong>di</strong> momenti organizzativi,<br />
<strong>di</strong> un costante controllo durante<br />
la realizzazione e <strong>di</strong> verifiche (delle<br />
presenze e del ren<strong>di</strong>mento) <strong>di</strong> competenza,<br />
appunto, dei docenti;<br />
b. attività <strong>di</strong> ‘compiti insieme’ che richiedono<br />
altrettanto sforzo organizzativo<br />
quando non anche partecipazione<br />
<strong>di</strong>retta dei docenti;<br />
c. attività <strong>di</strong> tutoraggio, <strong>di</strong> sportello, <strong>di</strong><br />
raccordo con i doposcuola presenti<br />
sul territorio, e ancora perio<strong>di</strong>ci contatti<br />
con gli assistenti sociali dei poli<br />
territoriali e con le agenzie ad essi<br />
collegati, o con l’Usl: tutti impegni<br />
<strong>di</strong>retti e <strong>di</strong> collegamento con i singoli<br />
consigli <strong>di</strong> classe coinvolti che vanno<br />
organizzati, condotti, coor<strong>di</strong>nati.<br />
La convinzione che sia importante<br />
stabilire un legame forte tra progetto<br />
e programmazione <strong>di</strong> ciascun consiglio<br />
<strong>di</strong> classe, perché tutte le attività <strong>di</strong><br />
supporto siano riconosciute e apprezzate<br />
come parti integranti <strong>di</strong> un unico<br />
curricolo dell’alunno, ci ha portato<br />
all’elaborazione <strong>di</strong> strumenti (schede<br />
e calendari) <strong>di</strong> rilevazione e <strong>di</strong> controllo<br />
della situazione della classe in relazione<br />
al <strong>di</strong>sagio e, più in generale, alle<br />
<strong>di</strong>fficoltà scolastiche, che sono stati<br />
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Organismi<br />
<strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione<br />
(scientifica,<br />
professionale,<br />
per i genitori)<br />
consentono<br />
<strong>di</strong> monitorare<br />
i progetti<br />
e integrarli<br />
nel curricolo<br />
scolastico<br />
55
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
I genitori<br />
hanno assunto<br />
un ruolo <strong>di</strong>namico<br />
per la promozione,<br />
la gestione,<br />
la <strong>di</strong>ffusione<br />
<strong>di</strong> esperienze formative<br />
rivolte<br />
ai ragazzi<br />
(laboratori,<br />
compiti)<br />
e agli adulti<br />
(consulenza,<br />
tutoraggio)<br />
messi a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> ogni scuola e<br />
costituiscono ormai un’esperienza comune<br />
in città.<br />
L’effetto contagio della rete<br />
Lavorare in rete ha consentito <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere<br />
pratiche e metodologie rilevatesi<br />
efficaci in alcune scuole e <strong>di</strong> applicarle,<br />
adattandole, nelle altre. Valga per tutte<br />
l’esperienza positiva dei laboratori pomeri<strong>di</strong>ani<br />
gestiti dai genitori, che avviati<br />
inizialmente in due sole scuole hanno<br />
visto una rapida <strong>di</strong>ffusione in tutti gli altri<br />
istituti attraverso un’encomiabile operazione<br />
<strong>di</strong> supporto che i genitori già<br />
esperti hanno condotto nei confronti <strong>di</strong><br />
chi si accingeva per la prima volta a realizzarli<br />
(giungendo persino alla compilazione<br />
<strong>di</strong> un vero e proprio manuale dei<br />
laboratori, un piccolo strumento operativo<br />
con consigli, suggerimenti e modelli<br />
a cui ispirarsi); così pure i compiti insieme,<br />
patrimonio esperienziale <strong>di</strong> una delle<br />
<strong>di</strong>eci scuole citta<strong>di</strong>ne, sono <strong>di</strong>ventati,<br />
con <strong>di</strong>fferenti modelli, esperienze presenti<br />
in tutte le altre.<br />
La rete tra scuole si è estesa e rafforzata<br />
anche attraverso il coor<strong>di</strong>namento<br />
dei comitati genitori che hanno successivamente<br />
organizzato una propria<br />
struttura autonoma (l’Associazione<br />
Città & Scuola) col compito <strong>di</strong> collaborare<br />
alla realizzazione del progetto<br />
curando in modo particolare il supporto<br />
alle azioni dei genitori (mettendo<br />
in opera varie forme <strong>di</strong> collaborazione,<br />
organizzando momenti <strong>di</strong> formazione,<br />
contribuendo alla progettazione<br />
<strong>di</strong> nuove iniziative e al reperimento<br />
delle risorse necessarie). Di particolare<br />
rilievo il fatto che nell’associazione,<br />
pur destinando i propri sforzi a<br />
favore dei soli alunni <strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a,<br />
continuano a garantire la propria attività<br />
volontaria un buon numero <strong>di</strong> genitori<br />
i cui figli già da alcuni anni frequentano<br />
le scuole superiori.<br />
La mappa delle opportunità<br />
La rete territoriale è costituita innanzitutto<br />
dall’intreccio della rete delle scuole<br />
me<strong>di</strong>e con reti istituzionali (istruzione<br />
e servizi sociali e le numerose strutture<br />
ad essi collegati); protocolli e calendari<br />
per incontri perio<strong>di</strong>ci sono le realizzazioni<br />
più significative. Questa già importante<br />
struttura si è andata via via arricchendo<br />
tramite la tessitura <strong>di</strong> nuove relazioni<br />
e la sollecitazione alla costruzione <strong>di</strong><br />
nuove reti. In particolare ciò è stato ottenuto<br />
con agenzie territoriali quali centri<br />
<strong>di</strong> aggregazione giovanile, cooperative<br />
sociali, associazioni <strong>di</strong> volontariato,<br />
centri culturali che si occupano <strong>di</strong> infanzia<br />
e adolescenza, nella consapevolezza<br />
che il coor<strong>di</strong>namento delle azioni, lo<br />
scambio <strong>di</strong> informazioni sulle esperienze<br />
attuate dai ragazzi, il confronto metodologico<br />
potessero essere strumenti utili al<br />
conseguimento degli obiettivi comuni.<br />
Nello specifico abbiamo operato con<br />
i <strong>di</strong>versi doposcuola esistenti sul territorio<br />
dapprima per una maggior conoscenza<br />
reciproca, quin<strong>di</strong> per un<br />
confronto metodologico e per mettere<br />
a punto modalità che favorissero lo<br />
scambio delle informazioni, la collaborazione<br />
con le scuole e con i singoli<br />
consigli <strong>di</strong> classe interessati.<br />
La <strong>di</strong>somogeneità della <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />
queste offerte e la scarsa conoscenza<br />
delle stesse ci hanno indotti a elaborare<br />
una mappa delle <strong>di</strong>verse iniziative, creando<br />
in questo modo, oltre che un utile<br />
strumento informativo, anche un legame<br />
più forte tra realtà omogenee, possibilità<br />
<strong>di</strong> confronto e scambi efficaci<br />
con le scuole <strong>di</strong> riferimento (tabella 4).<br />
56<br />
Tabella 4 – Doposcuola funzionanti sul territorio citta<strong>di</strong>no. A.s. 2010-<strong>11</strong><br />
N.<br />
doposcuola<br />
esterni alla scuola<br />
N.<br />
alunni<br />
frequentanti<br />
N.<br />
aperture<br />
settimanali<br />
N.<br />
volontari<br />
coinvolti<br />
N.<br />
operatori<br />
retribuiti<br />
15 323 2-3 199 17
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Il ruolo del volontariato<br />
La presenza<br />
<strong>di</strong> un volontariato<br />
<strong>di</strong>ffuso<br />
(<strong>di</strong> pensionati,<br />
genitori,<br />
docenti,<br />
studenti)<br />
è il segno tangibile<br />
<strong>di</strong> una comunità<br />
che si prende cura<br />
dell’educazione<br />
dei giovani<br />
Vero e proprio tessuto connettivo degli<br />
interventi è rappresentato dalla rete<br />
del volontariato.<br />
Essa è presente nelle <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong><br />
partecipazione e coinvolgimento dei<br />
genitori; nella realizzazione dei laboratori<br />
pomeri<strong>di</strong>ani (oltre che da genitori<br />
e nonni, questi laboratori sono attivati<br />
anche grazie alla presenza <strong>di</strong> alcune<br />
organizzazioni <strong>di</strong> pensionati e <strong>di</strong> alcune<br />
associazioni <strong>di</strong> artigiani); nell’intervento<br />
<strong>di</strong> tanti studenti delle me<strong>di</strong>e superiori<br />
che prestano le loro competenze<br />
nelle attività <strong>di</strong> compiti insieme; negli<br />
interventi <strong>di</strong> docenti in pensione che<br />
continuano a prestare la loro opera in<br />
attività <strong>di</strong> recupero o <strong>di</strong> insegnamento<br />
dell’italiano agli stranieri; nell’impegno<br />
quoti<strong>di</strong>ano dei docenti che si spendono<br />
per la realizzazione del progetto; nelle<br />
realtà <strong>di</strong> doposcuola territoriali attivati<br />
e sostenuti dal contributo <strong>di</strong> decine e<br />
decine <strong>di</strong> persone.<br />
Si tratta <strong>di</strong> uno degli aspetti più significativi<br />
dell’intero progetto. Questa risorsa,<br />
cui abbiamo fatto ricorso inizialmente<br />
per supplire alle carenze, si è imposta<br />
come straor<strong>di</strong>naria ricchezza <strong>di</strong><br />
un territorio che crede nel futuro e si<br />
de<strong>di</strong>ca ai propri ragazzi: testimonianza<br />
esemplare che ra<strong>di</strong>ca in profon<strong>di</strong>tà<br />
e conferisce senso allo stare insieme,<br />
all’essere comunità.<br />
Mario Menziani<br />
Docente nella scuola secondaria <strong>di</strong> primo grado<br />
“Ferraris-Marconi” <strong>Modena</strong><br />
57
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Attività extracurricolari<br />
a sostegno<br />
dell’impegno scolastico<br />
Il caso del progetto “Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta”<br />
<strong>di</strong> Francesco Pisanu<br />
Più che<br />
<strong>di</strong> ‘recupero’<br />
si tratta<br />
<strong>di</strong> promuovere<br />
attività mirate<br />
a far riacquisire<br />
autostima<br />
e motivazione<br />
ai ragazzi<br />
in <strong>di</strong>fficoltà<br />
58<br />
Prevenire l’abbandono<br />
La ricerca e la prassi in ambito educativo<br />
hanno ormai consolidato la<br />
prospettiva <strong>di</strong> un contributo positivo<br />
delle Attività strutturate extracurricolari<br />
nella prevenzione dell’abbandono<br />
scolastico. In genere, gli studenti<br />
considerati a rischio abbandono (per<br />
caratteristiche in<strong>di</strong>viduali, familiari e<br />
<strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento scolastico) che possono<br />
beneficiare <strong>di</strong> continue e significative<br />
attività extracurricolari, che<br />
stimolano il coinvolgimento rispetto<br />
allo stu<strong>di</strong>o e all’appren<strong>di</strong>mento, hanno<br />
poi tassi <strong>di</strong> abbandono molto più<br />
bassi rispetto a coloro che non hanno<br />
avuto questa possibilità (Mahoney,<br />
Cairns, 1997).<br />
Dall’altra parte queste attività extracurricolari<br />
necessitano <strong>di</strong> essere svolte<br />
in piena continuità rispetto a quelle<br />
curricolari, e dunque con una partecipazione<br />
centrale da parte della scuola,<br />
per evitare possibili effetti negativi<br />
negli appren<strong>di</strong>menti e nei livelli <strong>di</strong><br />
competenze, simili a quelli in<strong>di</strong>viduati<br />
dalla ricerca educativa per quanto<br />
riguarda l’efficacia dei compiti a casa<br />
(Trautwein et al., 2006).<br />
Ancora, per chiudere il cerchio, recenti<br />
indagini qualitative sull’abbandono<br />
scolastico svolte nel contesto<br />
della Provincia <strong>di</strong> Trento (Tabarelli, Pisanu,<br />
Bertazzoni, 20<strong>11</strong>) hanno sottolineato<br />
l’importanza della cura e<br />
del potenziamento <strong>di</strong> alcune caratteristiche<br />
in<strong>di</strong>viduali già dalla scuola<br />
elementare. Tra questi l’impegno e<br />
la partecipazione percepita vengono<br />
considerati come prioritari, anche in<br />
un’ottica <strong>di</strong> equilibrio cognitivo e socio-affettivo<br />
del singolo studente, soprattutto<br />
nel passaggio dal primo al<br />
secondo ciclo <strong>di</strong> istruzione.<br />
Un progetto per il successo<br />
formativo<br />
Il progetto “Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta” della<br />
rete <strong>di</strong> scuole me<strong>di</strong>e del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Modena</strong>, che qui verrà descritto in base<br />
ad alcune caratteristiche strutturali<br />
e ad una serie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> tipo psico-sociale<br />
a livello studente, è centrato<br />
proprio su questi elementi: non sull’improvvisazione<br />
e la semplice delega alle<br />
famiglie, ma su piani e progetti strutturati<br />
che coinvolgono e responsabilizzano<br />
una <strong>di</strong>screta fetta della collettività<br />
locale, come le stesse famiglie e il mondo<br />
del volontariato.<br />
Il progetto, iniziato nell’anno scolastico<br />
2002-03, è nato da un gruppo <strong>di</strong><br />
docenti e genitori che hanno <strong>di</strong>ffuso e<br />
ampliato iniziative già avviate da tempo<br />
in alcune scuole della città <strong>di</strong> <strong>Modena</strong>.<br />
Si è partiti dalla constatazione che per<br />
i ragazzi <strong>di</strong>fficili non erano adeguate le<br />
attività scolastiche normalmente pre<strong>di</strong>sposte<br />
nel curricolo scolastico e che<br />
era necessario promuovere attività specifiche<br />
mirate a far riacquisire autostima<br />
e motivazione (come il tutoraggio, i<br />
compiti insieme, i laboratori pomeri<strong>di</strong>ani<br />
curricolari o extracurricolari, lo sportello<br />
<strong>di</strong> ascolto), ormai noti elementi basilari<br />
per la qualità degli appren<strong>di</strong>menti<br />
e del successo formativo.<br />
Il presente lavoro <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento<br />
sul progetto sarà, dunque, organizzato<br />
in questo modo: una prima parte<br />
sarà de<strong>di</strong>cata ad una sequenza <strong>di</strong> dati<br />
strutturali che interessano la realizzazione<br />
delle attività extracurricolari considerate;<br />
una seconda parte approfon<strong>di</strong>rà<br />
gli esiti psico-sociali (legati a impegno<br />
e motivazione percepiti dagli studenti)<br />
<strong>di</strong> due attività extracurricolari in<br />
particolare, cioè il tutoraggio e i compiti<br />
insieme.
I destinatari delle attività<br />
realizzate<br />
Il primo dato interessante riguarda i destinatari<br />
del progetto. È in<strong>di</strong>viduabile<br />
una lunga serie <strong>di</strong> situazioni ‘a rischio’,<br />
che variano da situazioni più o meno<br />
strutturate e certificate ad altre identificabili<br />
all’interno della categoria delle<br />
situazioni problematiche o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio,<br />
in termini generali. È presente, inoltre,<br />
un numero consistente <strong>di</strong> alunni stranieri<br />
(<strong>di</strong> poco superiore al 15% del totale<br />
degli studenti). A seguire, in termini<br />
quantitativi, anche se in parte frutto<br />
delle attribuzioni degli insegnanti nei loro<br />
confronti, c’è la presenza <strong>di</strong> un gruppo<br />
identificabile in termini molto generali<br />
con lacune nella preparazione (il<br />
20% degli studenti).<br />
Ci sono altri due potenziali raggruppamenti<br />
<strong>di</strong> interesse.<br />
Un primo raggruppamento intercetta<br />
problematiche più <strong>di</strong> tipo cognitivo, ed<br />
è rappresentato dall’unione delle categorie<br />
alunni certificati e alunni DSA segnalati<br />
o da accertare; queste due categorie<br />
raggruppano circa 350 studenti<br />
(circa l’8% degli studenti).<br />
Un secondo gruppo è riconducibile a<br />
problematiche <strong>di</strong> natura maggiormente<br />
comportamentale e relazionale, cioè<br />
i ragazzi ‘seguiti dai servizi sociali’ e<br />
quelli ‘seguiti dal doposcuola esterno’;<br />
complessivamente questo raggruppamento<br />
comprende più <strong>di</strong> 400 studenti<br />
(oltre il 9% del totale).<br />
Finanziamenti e attività<br />
Un altro dato strutturale importante per<br />
l’analisi del progetto sono la tipologia e il<br />
‘peso’ dei soggetti che realizzano le attività<br />
attraverso un’intensa azione <strong>di</strong> rete.<br />
Tale rete appare stabilizzata su due versanti<br />
principali: un versante istituzionale<br />
composto dalla locale Fondazione Cassa<br />
<strong>di</strong> Risparmio e dal <strong>Comune</strong>, e un versante<br />
meno istituzionalizzato, ma non<br />
per questo meno importante, costituito<br />
dal mondo del volontariato, attraverso<br />
le famiglie e le associazioni.<br />
Il primo versante contribuisce da un<br />
punto <strong>di</strong> vista economico (in un rapporto<br />
tra fon<strong>di</strong> della Fondazione e fon<strong>di</strong> del<br />
<strong>Comune</strong> pari a 7 a 1), principalmente<br />
per finanziare le attività specifiche (oltre<br />
il 63% dei fon<strong>di</strong> messi a <strong>di</strong>sposizione),<br />
e in seconda battuta per le spese<br />
<strong>di</strong> organizzazione (circa il 13% del totale).<br />
Il confronto vero e proprio tra i due<br />
versanti si realizza pienamente rispetto<br />
alle ore finanziate (per quanto riguarda<br />
la Fondazione e il <strong>Comune</strong>) e messe a<br />
<strong>di</strong>sposizione (per quanto riguarda il volontariato)<br />
sulle singole attività <strong>di</strong> progetto.<br />
Se Fondazione e <strong>Comune</strong> in un<br />
anno arrivano a finanziare 3.144 ore <strong>di</strong><br />
attività nelle nove scuole considerate,<br />
il volontariato si stabilizza poco sopra<br />
le 3.150 ore.<br />
È interessante esplorare i contributi a<br />
questo monte ore: se un’attività come<br />
il tutoraggio è praticamente tutta a carico<br />
dell’attività finanziata dalla Fondazione<br />
e dal <strong>Comune</strong>, i laboratori sono in<br />
buona parte frutto <strong>di</strong> un’attività volontaria;<br />
una posizione interme<strong>di</strong>a, e per<br />
questo più potenzialmente interessante<br />
è rappresentata dai compiti assieme,<br />
che nonostante vedano una prevalenza<br />
<strong>di</strong> ore finanziate dalla Fondazione<br />
e dal <strong>Comune</strong>, hanno comunque una<br />
presenza del volontariato non secondaria.<br />
Si tratta dunque <strong>di</strong> attività nelle<br />
quali la rete nel suo complesso ha effettuato<br />
dei dosaggi <strong>di</strong> risorse (finanziarie<br />
e umane) a misura variabile, muovendosi<br />
seguendo una sorta <strong>di</strong> criterio <strong>di</strong><br />
congruenza formativa: i maggiori carichi<br />
pedagogici e formativi per le ore finanziate,<br />
minori carichi <strong>di</strong> questo tipo<br />
per le ore <strong>di</strong> volontariato.<br />
Le percezioni degli studenti<br />
sulle attività: un approfon<strong>di</strong>mento<br />
sui compiti assieme<br />
Un altro aspetto interessante <strong>di</strong> questo<br />
progetto è la metodologia della ricercaazione,<br />
i cui esiti si utilizzano per attivare<br />
processi <strong>di</strong> miglioramento e <strong>di</strong> potenziamento<br />
delle attività. In questo lavoro,<br />
verranno presentati gli esiti <strong>di</strong> una<br />
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Gli utenti<br />
del progetto<br />
modenese<br />
sono soggetti<br />
con problematiche<br />
relazionali,<br />
ragazzi<br />
in ritardo<br />
nella preparazione,<br />
stranieri,<br />
allievi certificati<br />
o DSA<br />
59
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Svolgere<br />
i compiti<br />
assieme<br />
e con la guida<br />
<strong>di</strong> adulti ‘esperti’<br />
sembra migliorare<br />
il senso<br />
<strong>di</strong> autoefficacia<br />
e <strong>di</strong> fiducia<br />
dei ragazzi<br />
in <strong>di</strong>fficoltà<br />
Tabella 1 – Effetti significativi delle variabili <strong>di</strong> sfondo considerate sulle variabili<br />
psico-sociali per quanto riguarda i “compiti assieme”<br />
Variabili legate a impegno e<br />
coinvolgimento<br />
1) Controllo percepito e<br />
rilevanza del lavoro a scuola<br />
Es. item: “Ho dei buoni<br />
risultati in questa attività<br />
perché mi impegno tanto”<br />
2) Future aspirazioni e obiettivi<br />
Es. item: “Grazie a questa<br />
attività, avrò maggiori<br />
opportunità in futuro”<br />
3) Motivazione estrinseca<br />
Es. item: “Mi sembra <strong>di</strong><br />
imparare meglio con questa<br />
attività se l’insegnante mi<br />
supporta e mi premia (ad<br />
esempio con un ‘bravo!’ detto<br />
a voce) per quello che faccio”<br />
4) Supporto familiare<br />
Es. item: “Se dovessi avere<br />
dei problemi in questa attività<br />
i miei genitori sarebbero<br />
sempre pronti ad aiutarmi”<br />
5) Supporto tra pari per<br />
l’appren<strong>di</strong>mento<br />
Es. item: “Grazie a questa<br />
attività, mi sembra <strong>di</strong> avere<br />
rapporti migliori con i miei<br />
compagni <strong>di</strong> classe”<br />
6) Relazioni studenti-adulti<br />
Es. item: “Mi piace parlare<br />
con l’insegnante in questa<br />
attività”<br />
% <strong>di</strong><br />
risposte<br />
positive<br />
*<br />
Genere<br />
100 ND<br />
Tipo<br />
Classe<br />
Prima ><br />
seconda e<br />
terza<br />
Durata<br />
attività<br />
ND<br />
84,4 ND ND ND<br />
76,5 ND<br />
Prima ><br />
seconda e<br />
terza<br />
Frequenza<br />
microattività<br />
Verifiche<br />
frequenti ><br />
verifiche non<br />
frequenti<br />
Verifiche<br />
frequenti ><br />
verifiche non<br />
frequenti<br />
Nazionalità<br />
genitori<br />
ND<br />
Non italiani<br />
> italiani<br />
ND ND ND<br />
76,5 ND ND ND ND ND<br />
83,9 ND<br />
83,9 ND<br />
Prima ><br />
seconda e<br />
terza<br />
Prima ><br />
seconda e<br />
terza<br />
*Nelle modalità alta e me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> ciascuna considerata.<br />
ND: nessuna <strong>di</strong>fferenza significativa.<br />
ND<br />
ND<br />
ND<br />
Verifiche<br />
frequenti ><br />
verifiche non<br />
frequenti<br />
Non italiani<br />
> italiani<br />
ND<br />
60<br />
rilevazione tramite un questionario che<br />
misurava, tra gli altri, i livelli <strong>di</strong> impegno<br />
e <strong>di</strong> coinvolgimento percepiti dagli studenti,<br />
utilizzando la versione italiana<br />
dello Student Engagement Instrument<br />
(SEI, Appleton et al., 2006), rispetto a<br />
due attività: il tutoraggio e i compiti assieme.<br />
Vista la quantità <strong>di</strong> dati raccolti<br />
per questa secondo tipologia (N = 243),<br />
verranno considerati solo questi dati.<br />
L’attività denominata compiti assieme<br />
consiste principalmente in stu<strong>di</strong>o guidato<br />
da un adulto esperto. Per uno o<br />
due pomeriggi alla settimana (o spesso<br />
anche più, se possibile) i ragazzi in attività<br />
pomeri<strong>di</strong>ane vengono aiutati ad attivare<br />
una serie <strong>di</strong> processi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento,<br />
per favorire il realizzarsi <strong>di</strong> performance<br />
scolastiche future. La tabella<br />
(cfr. seconda colonna da sinistra) ci in<strong>di</strong>ca<br />
come in genere l’attività dei compiti<br />
assieme sia stata valutata positivamente<br />
per quanto riguarda le variabili<br />
riferite a impegno e coinvolgimento,<br />
premiando in sostanza il livello <strong>di</strong> autoefficacia<br />
percepita dagli studenti nel<br />
realizzare l’attività, gli aspetti strumentali<br />
per il futuro e gli aspetti sociali e relazionali.<br />
Nelle altre colonne si possono<br />
vedere gli esiti degli impatti che alcune<br />
variabili <strong>di</strong> sfondo (come il genere,<br />
la classe frequentata, la durata delle<br />
attività…) hanno avuto sulle variabili<br />
<strong>di</strong> impegno e coinvolgimento considerate.<br />
Come si può notare, la variabile<br />
‘genere’ non ha prodotto delle <strong>di</strong>fferenze<br />
significative, nel senso che le attività<br />
svolte all’interno dei “compiti as
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
sieme” e i giu<strong>di</strong>zi dati rispetto a questa<br />
attività non <strong>di</strong>fferenziano i maschi e le<br />
femmine. Le <strong>di</strong>fferenze, in parte, ci sono<br />
sulla tipologia <strong>di</strong> classe; infatti c’è<br />
un maggior controllo percepito, da parte<br />
degli studenti della prima, che probabilmente<br />
sono più seguiti, più monitorati,<br />
rispetto a quelli della seconda e<br />
della terza classe.<br />
In maniera abbastanza particolare,<br />
la durata dell’attività non ha sancito<br />
delle <strong>di</strong>fferenze: le persone che hanno<br />
seguito per più tempo questa attività<br />
non hanno <strong>di</strong>fferenze nella percezione<br />
rispetto a quelle che l’hanno<br />
seguita <strong>di</strong> meno. Le <strong>di</strong>fferenze si manifestano<br />
per la frequenza <strong>di</strong> una particolare<br />
tipologia <strong>di</strong> attività svolta nei<br />
“compiti assieme”, cioè le preparazioni<br />
alle verifiche. Si tratta <strong>di</strong> un’attività<br />
molto strumentale, fatta in preparazione<br />
<strong>di</strong> un evento che poi sta per<br />
realizzarsi in classe. Un altro aspetto<br />
interessante è rivolto alla nazionalità<br />
dei genitori: si evidenzia come i punteggi<br />
<strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione e <strong>di</strong> motivazione<br />
siano più alti negli studenti che appartengono<br />
a famiglie in parte eterogenee,<br />
quin<strong>di</strong> con almeno un genitore<br />
non italiano, rispetto a quelli che,<br />
invece, hanno dei genitori completamente<br />
italiani.<br />
L’equilibrio tra ‘professionisti’<br />
e ‘volontari’<br />
In base ai dati presentati nelle sezioni<br />
precedenti è possibile in<strong>di</strong>care alcuni<br />
punti <strong>di</strong> rilievo che interessano il progetto<br />
“Citta<strong>di</strong>ni si <strong>di</strong>venta”.<br />
Per quanto riguarda gli elementi strutturali,<br />
non si può che sottolineare positivamente<br />
l’impegno della rete, <strong>di</strong> scuole<br />
e altri attori sul territorio, nell’attivare<br />
azioni su aspetti cognitivi e psico-sociali<br />
(ren<strong>di</strong>mento e comportamento),<br />
in cui sono sempre meno le possibilità<br />
<strong>di</strong> supporto per studenti in <strong>di</strong>fficoltà. Il<br />
coinvolgimento <strong>di</strong> attori <strong>di</strong>versi sul territorio,<br />
in una buona integrazione tra ambiti<br />
istituzionali e non, appare centrato,<br />
in base ai dati a <strong>di</strong>sposizione, nell’attribuire<br />
agli attori istituzionali della rete<br />
maggiori responsabilità sul versante<br />
‘accademico’ e cognitivo, per delegare<br />
invece ai meno istituzionali (ad esempio<br />
famiglie e volontariato) azioni che solo<br />
in parte sono centrate sul successo<br />
La rete istituzionale<br />
(scuole, ecc.)<br />
si impegna<br />
sugli aspetti<br />
cognitivi,<br />
quella informale<br />
sulle <strong>di</strong>mensioni<br />
motivazionali<br />
e relazionali<br />
61
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
62<br />
<strong>Focus</strong><br />
Prepararsi<br />
<strong>di</strong> frequente<br />
alle verifiche,<br />
con un supporto<br />
autorevole,<br />
è un fattore<br />
<strong>di</strong> gratificazione<br />
e <strong>di</strong> successo<br />
formativo. Questo è uno snodo decisivo,<br />
soprattutto in scenari in cui potrebbe<br />
essere possibile lavorare con sempre<br />
meno risorse a <strong>di</strong>sposizione e nei<br />
quali, dunque, il volontariato assumerà<br />
maggiore importanza. Da questo punto<br />
<strong>di</strong> vista <strong>di</strong>venta necessaria la con<strong>di</strong>visione<br />
<strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> ‘assunti <strong>di</strong> base’<br />
(ad esempio attraverso il rilascio <strong>di</strong><br />
vademecum, come già sta accadendo<br />
all’interno del progetto) che possano<br />
consentire ai <strong>di</strong>versi attori in gioco <strong>di</strong><br />
avere un approccio comune e comunque<br />
una soglia minima <strong>di</strong> professionalità<br />
<strong>di</strong>dattica e pedagogica per affrontare<br />
al meglio ambedue i versanti (cognitivo<br />
e comportamentale), in un’ottica<br />
<strong>di</strong> continuità e congruenza rispetto<br />
a ciò che si svolge in classe. È ciò che<br />
probabilmente si è realizzato all’interno<br />
dell’attività “compiti assieme”, attraverso<br />
un buon bilanciamento tra ruoli<br />
‘professionali’ e non (ma non per questo<br />
meno efficaci).<br />
La percezione <strong>di</strong> efficacia<br />
degli studenti<br />
Sulle percezioni degli studenti, in particolare<br />
per quanto riguarda l’attività presa<br />
in esame dei “compiti assieme”, si<br />
evidenziano come elementi <strong>di</strong> rilievo il<br />
possibile transfer tra la strategia extrascolastica<br />
e l’attività prettamente scolastica<br />
e gli aspetti sociali e relazionali<br />
legati alla strategia stessa. Si tratta,<br />
inoltre, <strong>di</strong> un’attività altamente inclusiva:<br />
come si è visto, non crea <strong>di</strong>fferenze<br />
tra maschi e femmine e tra studenti<br />
italiani e non italiani. I dati raccolti ci<br />
restituiscono una rappresentazione in<br />
cui, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quello che in genere<br />
ci si aspetta, più l’attività è strumentalmente<br />
legata a ciò che avviene<br />
in classe, più positive sono le percezioni<br />
degli studenti. L’unico elemento, infatti,<br />
che crea delle <strong>di</strong>fferenziazioni per<br />
quanto riguarda la durata delle attività<br />
a cui partecipano gli studenti è la tipologia<br />
<strong>di</strong> queste attività. Nello specifico<br />
i dati ci <strong>di</strong>cono che preparare le verifiche<br />
in maniera molto frequente aumen<br />
ta la probabilità <strong>di</strong> avere maggior controllo<br />
percepito e rilevanza del lavoro<br />
a scuola e maggiori future aspirazioni<br />
e obiettivi. Inoltre, il livello alto <strong>di</strong> frequenza<br />
nella preparazione delle verifiche<br />
modula in maniera più positiva la<br />
relazione tra studenti e adulti. In linea<br />
<strong>di</strong> massima questo elemento potrebbe<br />
essere considerato come una possibile<br />
traccia <strong>di</strong> sviluppo per le prossime e<strong>di</strong>zioni<br />
delle attività.<br />
Bibliografia<br />
Appleton J.J., Christenson S.L., Kim D.,<br />
Reschly A.L., Measuring cognitive and<br />
psychological engagement: Validation<br />
of the Student Engagement Instrument,<br />
in “Journal of School Psychology”, 44,<br />
2006.<br />
Mahoney J.L., Cairns R.B., Do extracurricular<br />
activities protect against early<br />
school dropout?, in “Developmental<br />
Psychology”, vol. 33(2), 1997.<br />
Tabarelli S., Pisanu F., Bertazzoni C., Indagine<br />
sui fattori <strong>di</strong> rischio e <strong>di</strong> protezione<br />
del fenomeno <strong>di</strong>spersione scolastica,<br />
Report <strong>di</strong> ricerca, IPRASE Trentino,<br />
20<strong>11</strong>.<br />
Trautwein U., Ludtke O., Schnyder<br />
I., Niggli A., Pre<strong>di</strong>cting homework effort:<br />
support for a domain-specific,<br />
multilevel homework model, in “Journal<br />
of Educational Psychology”, 98, 2006.<br />
Francesco Pisanu<br />
Ricercatore area educativa IPRASE Trentino, docente <strong>di</strong><br />
Psicologia della formazione e dell’orientamento, Facoltà<br />
<strong>di</strong> Scienze cognitive – Università <strong>di</strong> Trento
Capability<br />
e Developmental<br />
Approach: possibili<br />
implicazioni<br />
nell’esperienza<br />
scolastica<br />
Lo scopo <strong>di</strong> questo intervento è <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care<br />
le implicazioni, per l’organizzazione<br />
dell’esperienza scolastica, del concetto<br />
<strong>di</strong> Capability e <strong>di</strong> una teoria dello<br />
sviluppo ad esso congruente (Applied<br />
Developmental Science Approach). Il<br />
nostro assunto <strong>di</strong> base è che il concetto<br />
<strong>di</strong> capability sia in grado <strong>di</strong> orientare<br />
azioni sinergiche e, per questo, potenzialmente<br />
più efficaci <strong>di</strong> tutte le agenzie<br />
(politiche, sociali e sanitarie) <strong>di</strong> una<br />
comunità.<br />
Innovative Care for Chronic<br />
Con<strong>di</strong>tion<br />
<strong>di</strong> Ciro Ruggerini e Sumire Manzotti<br />
L’Organizzazione Mon<strong>di</strong>ale della Sanità<br />
(OMS) ha pubblicato nel 2002 un<br />
documento intitolato “Innovative Care<br />
for Chronic Con<strong>di</strong>tion” (ICCC), che<br />
sostiene la necessità <strong>di</strong> un cambio <strong>di</strong><br />
para<strong>di</strong>gma nell’assistenza alle con<strong>di</strong>zioni<br />
croniche. Questo documento ha<br />
un’importanza cruciale nelle con<strong>di</strong>zioni<br />
me<strong>di</strong>che non suscettibili <strong>di</strong> guarigione,<br />
ma il modello che esso propone è applicabile<br />
anche all’assistenza alle persone<br />
con <strong>di</strong>sabilità (Ruggerini, Vezzosi,<br />
Dalla Vecchia, 2008) e alle persone<br />
che presentano uno sviluppo atipico,<br />
espressione della neuro<strong>di</strong>versità interin<strong>di</strong>viduale<br />
( 1 ).<br />
A nostro parere si può sostenere che il<br />
1) Si veda, ad esempio, il documento del<br />
Panel <strong>di</strong> aggiornamento e revisione della<br />
Consensus Conference sui Disturbi Specifici<br />
<strong>di</strong> Appren<strong>di</strong>mento (PARCC) in Marchiori,<br />
Ruggerini, Lorusso, Tressol<strong>di</strong> (20<strong>11</strong>).<br />
documento ICCC, nato in ambito sanitario,<br />
propone un modello <strong>di</strong> rapporto<br />
collaborativo tra citta<strong>di</strong>ni, famiglie e<br />
Agenzie della Comunità.<br />
Per gli obiettivi <strong>di</strong> questo lavoro possiamo<br />
osservare che i contenuti essenziali<br />
<strong>di</strong> questo documento sono:<br />
la persona alla quale sono <strong>di</strong>retti atti<br />
<strong>di</strong> assistenza o aiuti allo sviluppo<br />
non va considerata un recettore<br />
passivo ma un agente in grado <strong>di</strong><br />
identificare obiettivi prioritari;<br />
la persona e le agenzie della sua<br />
Comunità possono funzionare al<br />
meglio in un terreno culturale esplicitamente<br />
con<strong>di</strong>viso.<br />
In questa relazione sosteniamo che il<br />
concetto <strong>di</strong> capability e una teoria dello<br />
sviluppo ad esso congruente (Developmental<br />
Approach) possono costituire<br />
la trama essenziale <strong>di</strong> questo terreno.<br />
Anche la cultura alla base dell’organizzazione<br />
scolastica può essere profondamente<br />
influenzata.<br />
Il concetto <strong>di</strong> Capability<br />
Il concetto <strong>di</strong> capability, nato negli anni<br />
’80 nell’area dell’Economia del benessere<br />
( 2 ), è stato proposto da Amartya<br />
Sen, premio Nobel 1998 per il suo contributo<br />
alla scienza economica e alla<br />
teoria della politica sociale.<br />
Secondo Sen l’obiettivo etico-egualitario<br />
della <strong>di</strong>stribuzione delle risorse socio-economiche<br />
deve essere raggiunto<br />
tramite la massimizzazione della capa-<br />
2) Welfare Economics, Sen, 1992; 1999; 2009.<br />
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Documenti<br />
elaborati<br />
dall’Organizzazione<br />
Mon<strong>di</strong>ale della<br />
Sanità<br />
propongono<br />
modelli<br />
<strong>di</strong> ‘cura’<br />
centrati<br />
sull’iniziativa<br />
delle persone<br />
e della comunità<br />
63
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Tabella 1 – Rappresentazione schematica dell’approccio capability<br />
Dotazione<br />
in<strong>di</strong>viduale<br />
Set<br />
in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong><br />
capabilities<br />
Il concetto<br />
<strong>di</strong> capability,<br />
introdotto<br />
da Amartya Sen,<br />
è centrato<br />
sul benessere<br />
<strong>di</strong> persone libere<br />
e consapevoli<br />
delle proprie scelte<br />
e risorse<br />
64<br />
Vettore delle<br />
risorse<br />
Caratteristiche<br />
del contesto<br />
Mezzi per<br />
raggiungere i<br />
propri obiettivi<br />
Funzione<br />
in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong><br />
conversione<br />
dei fattori<br />
personali,<br />
sociali e<br />
ambientali<br />
bility, ossia la scelta <strong>di</strong> possibili opportunità<br />
<strong>di</strong> ‘essere o fare’ (functioning) <strong>di</strong><br />
tutti i citta<strong>di</strong>ni.<br />
L’approccio capability ha un’influenza<br />
che oltrepassa l’analisi economica della<br />
<strong>di</strong>stribuzione della ricchezza e concorre<br />
alla definizione dei concetti <strong>di</strong> benessere<br />
personale, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto umano universale<br />
e <strong>di</strong> giustizia sociale.<br />
Per Sen, il benessere deve essere concettualizzato<br />
in termini <strong>di</strong> Capabilities:<br />
esse rappresentano le libertà o le opportunità<br />
che le persone hanno <strong>di</strong> essere<br />
e <strong>di</strong> fare quello che vogliono in realtà<br />
essere e fare. I funzionamenti realizzati<br />
– e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>rettamente osservabili<br />
– sono il prodotto delle scelte personali<br />
che un in<strong>di</strong>viduo opera all’interno<br />
del suo insieme <strong>di</strong> capacità con il fine<br />
<strong>di</strong> compiere il proprio progetto <strong>di</strong> vita.<br />
La conversione <strong>di</strong> beni e servizi (i mezzi)<br />
in benessere umano (capacità e funzionamenti)<br />
è influenzata da tre gruppi<br />
<strong>di</strong> fattori <strong>di</strong> conversione:<br />
in<strong>di</strong>viduali (ad esempio: con<strong>di</strong>zioni<br />
fisiche, sesso, abilità cognitive...);<br />
sociali (norme sociali, pratiche <strong>di</strong>scriminatorie,<br />
ruoli legati al genere, gerarchie<br />
sociali, relazioni <strong>di</strong> potere...);<br />
ambientali (clima, localizzazione<br />
geo grafica...) (tabella 1).<br />
Più vettori <strong>di</strong><br />
funzionamenti<br />
potenziali<br />
Libertà <strong>di</strong><br />
raggiungere<br />
i propri<br />
obiettivi<br />
Scelta<br />
Il benessere e la libertà<br />
delle persone<br />
Un vettore <strong>di</strong><br />
funzionamenti<br />
realizzati<br />
Obiettivi<br />
effettivamente<br />
raggiunti<br />
Un punto <strong>di</strong> forza dell’approccio capability<br />
è la possibilità <strong>di</strong> tenere conto <strong>di</strong><br />
variazioni interpersonali nel convertire<br />
le caratteristiche dei beni in funzionamenti.<br />
La risultante caratteristica multi<strong>di</strong>mensionale<br />
si <strong>di</strong>stingue nettamente<br />
dalla meto<strong>di</strong>ca tra<strong>di</strong>zionale dell’impostazione<br />
welfarista, che non tiene conto<br />
delle <strong>di</strong>versità in<strong>di</strong>viduali e del ruolo<br />
fondante della libertà umana.<br />
Per il suo aspetto multi-<strong>di</strong>mensionale,<br />
oggi quello <strong>di</strong> capability è <strong>di</strong>ventato<br />
un concetto guida per le scelte politiche<br />
(Manzotti, 2010). Si può ricordare,<br />
ad esempio, che l’In<strong>di</strong>ce dello Sviluppo<br />
Umano (Human Development Index,<br />
HDI) dell’ONU è costituito sulla base<br />
del para<strong>di</strong>gma capability.<br />
L’in<strong>di</strong>ce HDI rappresenta il benessere<br />
collettivo <strong>di</strong> un paese; la ricchezza <strong>di</strong> un<br />
paese si valuta per la riuscita (politica<strong>di</strong>stributiva)<br />
nel raggiungere un’aggregazione<br />
del benessere dei citta<strong>di</strong>ni nella<br />
maniera più equa possibile.<br />
L’HDI, nella sua versione del 2010, è<br />
composto da 3 <strong>di</strong>mensioni:<br />
1. livello della salute;<br />
2. livello dell’istruzione;
3. livello della produzione economica.<br />
Ciò evidenzia l’importanza della gestione<br />
del sistema sanitario e del sistema<br />
scolastico.<br />
Ogni decisione sia politica che operativa<br />
a <strong>di</strong>versi livelli dell’erogazione dei<br />
servizi sanitari e <strong>di</strong> quelli della pubblica<br />
istruzione deve essere guidata dal<br />
concetto <strong>di</strong> capability; il nostro compito<br />
è <strong>di</strong> contribuire al benessere attuale<br />
e futuro delle persone, tramite l’esercizio<br />
del <strong>di</strong>ritto della libertà <strong>di</strong> realizzarsi<br />
nella società secondo scelte personali<br />
ragionevoli, cioè del <strong>di</strong>ritto alla ‘fioritura<br />
come persona’.<br />
Capability, Qualità della Vita,<br />
ICF<br />
Qualità della Vita (QdV) è un concetto<br />
filosofico che si pone, oggi, come<br />
un obiettivo sociale, politico ed economico.<br />
Il concetto <strong>di</strong> QdV può essere, ad un<br />
estremo, fatto coincidere con la possibilità<br />
<strong>di</strong> accesso a risorse materiali; ad<br />
un altro con una <strong>di</strong>mensione totalmente<br />
soggettiva descritta dai termini ‘felicità’<br />
o ‘sod<strong>di</strong>sfazione’.<br />
Vi sono <strong>di</strong>versi strumenti psicometrici<br />
che tentano <strong>di</strong> rendere operativo il concetto<br />
<strong>di</strong> QdV; per ognuno si può constatare<br />
come si raggiunga una misura<br />
statica <strong>di</strong> benessere personale. Va sottolineato<br />
che il concetto <strong>di</strong> QdV:<br />
1. non esplicita i fattori connessi al<br />
percorso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> uno stato<br />
<strong>di</strong> benessere;<br />
2. non comprende la nozione <strong>di</strong> benessere<br />
collettivo, cioè la somma<br />
<strong>di</strong> benessere <strong>di</strong> tutte le persone in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dalle risorse personali.<br />
La considerazione della libertà (<strong>di</strong> essere<br />
protagonista della propria vita) e<br />
quella della giustizia riguardo alla <strong>di</strong>stribuzione<br />
<strong>di</strong> questa libertà tra le persone<br />
sono le <strong>di</strong>mensioni che rendono<br />
la nozione <strong>di</strong> capability, a nostro parere,<br />
sovraor<strong>di</strong>nata a quella <strong>di</strong> QdV: essa<br />
suggerisce <strong>di</strong> identificare l’essenza<br />
della QdV nella possibilità <strong>di</strong> funzionare<br />
in <strong>di</strong>versi domini della vita sociale<br />
in mo<strong>di</strong> scelti, tra <strong>di</strong>verse opportunità,<br />
sulla base dei propri valori personali.<br />
Inoltre, con la sua enfasi sulla centralità<br />
del soggetto come agente attivo nelle<br />
scelte arricchisce anche le descrizioni<br />
più complete del funzionamento personale<br />
(si pensi, a questo proposito, al<br />
modello ICF) introducendo una <strong>di</strong>mensione<br />
che spesso è, <strong>di</strong> fatto, trascurata<br />
(Morris, 2009).<br />
Capability e approccio<br />
inter<strong>di</strong>sciplinare<br />
Il concetto <strong>di</strong> capability può essere<br />
parte <strong>di</strong> quella cultura comune che,<br />
nel linguaggio del documento ICCC,<br />
“prepara, informa e motiva” la partnership<br />
tra il citta<strong>di</strong>no e le agenzie della<br />
sua Comunità. Vogliamo specificare,<br />
inoltre, che il concetto <strong>di</strong> capability costituisce<br />
un quadro concettuale <strong>di</strong> riferimento<br />
sovraor<strong>di</strong>nato per una comprensione<br />
inter<strong>di</strong>sciplinare del processo<br />
educativo.<br />
Il Centro per l’educazione e la ricerca<br />
sulla capability dell’Università <strong>di</strong> Bielefeld<br />
(Germania) ( 3 ) in<strong>di</strong>ca nel concetto<br />
<strong>di</strong> capability uno “strumento analitico<br />
che permette <strong>di</strong> concettualizzare e valutare<br />
le cause della <strong>di</strong>seguaglianza in<br />
campo educativo”; esso quin<strong>di</strong> può essere<br />
la base dell’integrazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi<br />
ambiti culturali e il terreno nel quale<br />
le azioni delle agenzie <strong>di</strong> una comunità<br />
si mettono in sintonia.<br />
Il documento ICCC in<strong>di</strong>vidua tre livelli<br />
<strong>di</strong> articolazione della partnership tra il<br />
citta<strong>di</strong>no e le agenzie:<br />
- microlivello, che considera il modo<br />
in cui il soggetto interpreta il suo<br />
ruolo <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>no;<br />
- mesolivello, che considera il modo<br />
in cui avviene l’interazione tra il soggetto<br />
e le agenzie della sua Comunità;<br />
- macrolivello, che considera l’ambiente<br />
politico.<br />
3) www.bca-research.net/.<br />
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
La capability<br />
è qualcosa<br />
<strong>di</strong> più<br />
del capitale umano<br />
e sgancia<br />
la scuola<br />
dalla <strong>di</strong>pendenza<br />
lineare<br />
delle esigenze<br />
del mercato<br />
del lavoro<br />
65
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
L’attivazione<br />
<strong>di</strong> progetti<br />
personalizzati,<br />
basati<br />
sull’empowerment<br />
in<strong>di</strong>viduale<br />
e sociale,<br />
è una strategia<br />
vincente<br />
nelle situazioni<br />
Un esempio<br />
Un esempio <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza attiva esercitata in ambito scolastico (Ruggerini, Vicini,<br />
Manzotti e Griffo, 2010) è il seguente:<br />
M. frequenta una 5 a classe elementare quando viene inviata ad un consulto per una<br />
<strong>di</strong>fficoltà scolastica. La sua storia è suggestiva <strong>di</strong> un Disturbo Specifico <strong>di</strong> Appren<strong>di</strong>mento<br />
(DSA): “Fin dai primi anni piangeva prima <strong>di</strong> leggere; spesso ha cefalea dopo<br />
le attività scolastiche; vi è, probabilmente, familiarità (a uno zio materno attualmente<br />
trentenne venne riconosciuto un problema <strong>di</strong> <strong>di</strong>slessia in età scolare)”.<br />
Il suo ambiente psicosociale è molto favorevole: entrambi i genitori sono plurilaureati;<br />
la madre, traduttrice, lavora a casa e ha tempo per aiutarla nelle attività scolastiche.<br />
La valutazione psico<strong>di</strong>agnostica conclude senza <strong>di</strong>fficoltà per un quadro <strong>di</strong> <strong>di</strong>slessia:<br />
M. è molto brillante ai test <strong>di</strong> efficienza intellettiva e risulta eccessivamente lenta<br />
a due prove <strong>di</strong> lettura.<br />
Nella restituzione della valutazione si enfatizzano: la necessità <strong>di</strong> una filosofia degli<br />
Aiuti orientati allo sviluppo <strong>di</strong> un interesse autentico per ‘l’imparare a conoscere’<br />
e la necessità, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> fare prevalere nettamente gli Aiuti abilitativi sul Trattamento<br />
della caratteristica.<br />
L’in<strong>di</strong>cazione trova consenso nei genitori ma non negli insegnanti che riconoscono<br />
la loro mancanza <strong>di</strong> esperienza nel campo (M. frequenta una scuola <strong>di</strong> montagna<br />
con pochi scolari e piuttosto isolata dalle altre scuole). I genitori si attivano a<br />
sostegno dell’istituzione scolastica: stabiliscono contatti con la sezione provinciale<br />
dell’Associazione Italiana Dislessia e con gli esecutori <strong>di</strong> una ricerca avvenuta in<br />
una provincia limitrofa.<br />
Sulla base della necessità degli insegnanti della scuola i genitori <strong>di</strong> M. trovano nella<br />
comunità risorse economiche per organizzare un corso <strong>di</strong> formazione sugli Aiuti<br />
abilitativi da attuare in ambito scolastico.<br />
A <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 8 mesi dalla prima valutazione M. ha mutato ra<strong>di</strong>calmente il suo atteggiamento<br />
verso la lettura, <strong>di</strong>ventando più sereno. La sua età <strong>di</strong> lettura – in assenza<br />
<strong>di</strong> un Trattamento specifico – è aumentata, in 8 mesi, <strong>di</strong> 22 mesi, pur rimanendo insufficiente<br />
per la classe frequentata.<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà Microlivello: il progetto <strong>di</strong> vita<br />
66<br />
Il concetto <strong>di</strong> capability implica che un<br />
soggetto interpreti in modo attivo la<br />
propria citta<strong>di</strong>nanza.<br />
Per le persone con <strong>di</strong>sabilità ciò è<br />
espresso con chiarezza dalla seguente<br />
formulazione ( 4 ):<br />
“Il progetto <strong>di</strong> vita è lo strumento perno<br />
delle nuove politiche sulla <strong>di</strong>sabilità.<br />
Il progetto <strong>di</strong> vita richiede <strong>di</strong> intraprendere<br />
un percorso <strong>di</strong> presa <strong>di</strong> coscienza<br />
in<strong>di</strong>viduale (<strong>di</strong> agency) che conduce la<br />
persona con <strong>di</strong>sabilità a conoscere la<br />
propria con<strong>di</strong>zione e gli impoverimenti<br />
in<strong>di</strong>viduali e sociali che la società ha<br />
prodotto, a definire i propri obiettivi <strong>di</strong><br />
vita e a motivarli secondo un progetto<br />
personalizzato. Questo processo, essendo<br />
basato sull’empowerment in<strong>di</strong>viduale<br />
e sociale (…) richiede la parteci-<br />
4) Barbuto, Biggeri e Griffo, in stampa.<br />
pazione della persona con <strong>di</strong>sabilità (…)<br />
nel processo decisionale e nella ricerca<br />
<strong>di</strong> supporto alle istituzioni pubbliche”.<br />
Ciò che viene espresso in modo esplicito<br />
per le persone con <strong>di</strong>sabilità rimane<br />
implicitamente esteso alla totalità<br />
dei citta<strong>di</strong>ni – per la maggioranza dei<br />
quali si assume che ciò che chiamiamo<br />
citta<strong>di</strong>nanza attiva sia un correlato<br />
necessario dello sviluppo tipico.<br />
Mesolivello: le con<strong>di</strong>zioni<br />
per uno sviluppo attivo positivo<br />
Il concetto <strong>di</strong> capability getta luce sulle<br />
teorie dello sviluppo e sulla teoria<br />
dell’educazione negli studenti con sviluppo<br />
tipico e atipico.<br />
Lo sviluppo in<strong>di</strong>viduale si accompagna<br />
da una parte alla comparsa <strong>di</strong> capacità<br />
e, dall’altra, <strong>di</strong> possibili <strong>di</strong>sadattamenti<br />
ai nuovi compiti evolutivi. La psichiatria
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
infantile e la psicologia dello sviluppo<br />
hanno sottolineato per lo più la seconda<br />
parte <strong>di</strong> questa affermazione e hanno<br />
puntato il loro interesse più sui fattori<br />
del <strong>di</strong>sadattamento che sui fattori<br />
che favoriscono il benessere e l’adattamento.<br />
La cornice culturale che ha<br />
sostenuto questa visione è quella della<br />
Psicopatologia dello sviluppo (Cicchetti<br />
e Rogosch, 2002).<br />
Negli ultimi anni si è delineato un nuovo<br />
orizzonte definito come Applied Developmental<br />
Science Approach ( 5 ), fondato<br />
su due ipotesi.<br />
La prima è che sia possibile definire<br />
gli attributi <strong>di</strong> uno sviluppo positivo dei<br />
giovani secondo le ‘5 C’ <strong>di</strong> Lerner et al.<br />
(2010) (tab. 2); la seconda è che questo<br />
sviluppo si realizza se l’interazione tra<br />
il soggetto e la sua comunità permette<br />
l’esercizio <strong>di</strong> scelta tra <strong>di</strong>verse, possibili,<br />
opportunità.<br />
Il fattore chiave <strong>di</strong> questa concezione<br />
è la possibilità per il soggetto <strong>di</strong> esse<br />
5) Schwartz, Pantin, Coatsworth, Szapocznik,<br />
2007.<br />
re agente attivo nella scelta dei funzionamenti<br />
(agency).<br />
Il risultato <strong>di</strong> questo sviluppo è positivo<br />
non solo nel senso che il soggetto si allontana<br />
dai comportamenti <strong>di</strong>sadattati<br />
e dalla sofferenza mentale, ma realizza<br />
l’aspirazione <strong>di</strong> essere un membro attivo<br />
della sua comunità.<br />
Capability e educazione<br />
Saito (2003) ha condotto una delle prime<br />
esplorazioni del rapporto tra capability<br />
e educazione e ha messo in risalto<br />
due <strong>di</strong>rettive.<br />
La prima è che educazione e istruzione<br />
aumentano le capacità (o abilità) del<br />
soggetto e, con questo, lo mettono in<br />
grado <strong>di</strong> accedere ad un numero più<br />
ampio <strong>di</strong> opportunità. Tuttavia “Un’istruzione<br />
obbligatoria non è sufficiente,<br />
in sé, alla realizzazione della capability<br />
(…) se un sistema educativo utilizza,<br />
portandolo all’estremo, un approccio<br />
top-down e enfatizza la competitività,<br />
i bambini tendono a stu<strong>di</strong>are in funzione<br />
del successo nelle valutazioni (…) e<br />
possono avere <strong>di</strong>fficoltà nell’apprendere<br />
Tabella 2 – Attributi <strong>di</strong> uno sviluppo positivo dei giovani secondo Lerner et al.:<br />
le ‘5 C’<br />
Competenza (Competence)<br />
<strong>Focus</strong><br />
Uno sviluppo<br />
positivo<br />
dei giovani<br />
si basa<br />
sul rafforzamento<br />
<strong>di</strong> alcuni attributi<br />
cognitivi,<br />
relazionali<br />
ed etici,<br />
per apprendere<br />
a <strong>di</strong>ventare<br />
autonomi<br />
Valutazione positiva delle proprie azioni in determinate aree: sociale, accademica, cognitiva,<br />
lavorativa, ecc. Esempio <strong>di</strong> competenza sociale è la capacità <strong>di</strong> risolvere i conflitti;<br />
esempio <strong>di</strong> competenza cognitiva è la capacità nel prendere decisioni.<br />
Fiducia in sé (Confidence)<br />
Una percezione positiva <strong>di</strong> sé – <strong>di</strong> valore e <strong>di</strong> autoefficacia – che va oltre la constatazione<br />
della possibilità <strong>di</strong> successo in qualche area.<br />
Relazioni interpersonali (Connection)<br />
Possibilità <strong>di</strong> partecipare a legami con persone o istituzioni che si esprimono in scambi<br />
bi<strong>di</strong>rezionali con pari, famiglia, scuola e agenzie della comunità.<br />
Ruolo (Character)<br />
Rispetto delle regole sociali e culturali, senso <strong>di</strong> ciò che è giusto o sbagliato (moralità)<br />
e integrità.<br />
Prendersi cura (Caring)<br />
Comprensione ed empatia per gli altri.<br />
67
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
68<br />
<strong>Focus</strong><br />
Sia nel campo<br />
dell’han<strong>di</strong>cap,<br />
sia nell’ambito<br />
DSA,<br />
ciò che conta<br />
è apprendere<br />
ad essere<br />
consapevole<br />
del proprio progetto<br />
esistenziale<br />
come <strong>di</strong>ventare autonomi”.<br />
La seconda implicazione <strong>di</strong> un approccio<br />
capability è la necessità <strong>di</strong> insegnamento<br />
dei valori che guidano la scelta<br />
dei funzionamenti.<br />
Capability e bisogni educativi speciali<br />
Sviluppi recenti nella risposta ai bisogni<br />
educativi speciali hanno affinità rilevanti<br />
con l’approccio capability, anche<br />
se non ne costituiscono una declinazione<br />
esplicita.<br />
Nel campo dell’educazione dei bambini<br />
con Disabilità Intellettiva, Harvey (2009)<br />
ha delineato un percorso <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong><br />
un’identità positiva il cui nucleo essenziale<br />
è il riconoscimento dei propri bisogni<br />
emotivi e dei propri valori e una<br />
pratica <strong>di</strong> scelta consapevole dei propri<br />
funzionamenti.<br />
Nel campo dei Disturbi Specifici <strong>di</strong><br />
Appren<strong>di</strong>mento un documento recente<br />
( 6 ) mette in risalto come tra i fattori<br />
che rendono possibile un adattamento<br />
<strong>di</strong> successo in età giovane adulta<br />
sia in primo piano la capacità <strong>di</strong> stabilire<br />
obiettivi appropriati e <strong>di</strong> vedersi proiettati<br />
nel futuro.<br />
In entrambi i casi è al centro delle proposte<br />
educative la sperimentazione<br />
della possibilità <strong>di</strong> essere agente consapevole<br />
delle proprie azioni e del proprio<br />
progetto esistenziale.<br />
Macrolivello: costruire<br />
opportunità nella comunità<br />
Nel para<strong>di</strong>gma capability il compito politico<br />
è <strong>di</strong> sostenere la costruzione <strong>di</strong><br />
una rete <strong>di</strong> servizi nella comunità e <strong>di</strong><br />
assicurare l’eguaglianza della <strong>di</strong>stribuzione<br />
delle opportunità.<br />
Le risorse economiche, sociali e umane<br />
sono limitate anche nei servizi pubblici,<br />
come la sanità e la pubblica istruzione.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione delle risorse limitate<br />
va finalizzata alle capability degli<br />
utenti. Ogni unità <strong>di</strong> input dovrebbe<br />
produrre un massimo <strong>di</strong> capability.<br />
Il compito essenziale degli ammini<br />
6) Timmons, Wills, Kemp, Basha, Mooney, 2010.<br />
stratori pubblici è, perciò, <strong>di</strong> allocare il<br />
totale delle risorse <strong>di</strong>sponibili in modo<br />
che, a tutti i citta<strong>di</strong>ni, in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dalle loro caratteristiche <strong>di</strong> sviluppo<br />
tipico o atipico, siano offerte opportunità<br />
<strong>di</strong> ‘fioritura’.<br />
Khader (2008) ha mostrato, ad esempio,<br />
una declinazione del concetto <strong>di</strong><br />
capability in una filosofia <strong>di</strong> sostegno<br />
allo sviluppo delle persone con Disabilità<br />
intellettiva grave, basata su un principio<br />
<strong>di</strong> giustizia sociale. I car<strong>di</strong>ni sono:<br />
1. “rispettare la <strong>di</strong>gnità della persona<br />
con Disabilità Intellettiva (DI) presuppone<br />
il loro riconoscimento come<br />
membri <strong>di</strong> un gruppo oppresso,<br />
laddove ‘oppressione’ è ogni azione<br />
che ‘impone socialmente’ qualcosa<br />
a qualcuno;<br />
2. pensare in termini <strong>di</strong> giustizia per le<br />
persone con DI significa rifiutare <strong>di</strong><br />
creare standard separati per ciò che<br />
è ad essi dovuto;<br />
3. immaginare giustizia per le persone<br />
con DI richiede rispetto per le <strong>di</strong>fferenze<br />
in<strong>di</strong>viduali; ‘fiorire’ significa<br />
cose <strong>di</strong>verse per una persona con<br />
DI grave e una persona che non ha<br />
questa caratteristica ma ciò non si-
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
gnifica che sia impossibile, per una<br />
persona con DI grave, ‘fiorire’;<br />
4. ottenere giustizia per le persone con<br />
DI grave richiede attenzioni aggiuntive<br />
alla nozione <strong>di</strong> ‘fioritura’ rispetto<br />
alla tra<strong>di</strong>zionale enfasi liberale sulla<br />
libertà politica; (…) le persone con<br />
DI grave hanno bisogno <strong>di</strong> un sostegno<br />
concreto e non solo <strong>di</strong> una libertà<br />
teorica <strong>di</strong> realizzare funzionamenti<br />
secondo scelte <strong>di</strong> libertà”.<br />
Bibliografia<br />
Barbuto P.R., Biggeri M., Griffo G., Project<br />
of life, peer counselling and selfhelp<br />
group as tools to expand capabilities,<br />
agency and human rights (20<strong>11</strong>,<br />
in stampa).<br />
Cicchetti D., Rogosch F.A., A developmental<br />
psychopathology perspective<br />
on adolescence, in “Journal of Consulting<br />
and Clinical Psychology”, 70, 2002.<br />
Deneulin S., Shahani L. (a cura <strong>di</strong>), An Introduction<br />
to the Human Development<br />
and Capability Approach, <strong>di</strong>sponibile<br />
nel sito www.idrc.ca/en, 2009.<br />
Khader S., Cognitive Disability, Capabilities<br />
and Justice, in “Essays in Philosophy”,<br />
9, 2008.<br />
Harvey K., Positive Identity Development.<br />
NADD Press, New York, 2009.<br />
Lerner R.M., von Eye A., Lerner J.V., Bizan<br />
L., Bowers E.P., Special Issue Introduction:<br />
The Meaning and Measurement<br />
of Thriving: A View of the Issues,<br />
in “Youth Adolescence”, 39, 2010.<br />
Manzotti S., Para<strong>di</strong>gmi <strong>di</strong> analisi economica<br />
applicati al settore sanitario: alcuni<br />
casi <strong>di</strong> prassi assistenziali nel campo<br />
della NPIA. Tesi <strong>di</strong> specializzazione<br />
in Neuropsichiatria infantile, Università<br />
degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Modena</strong> e Reggio Emilia,<br />
a.a. 2009-10.<br />
Marchiori M., Ruggerini C., Lorusso<br />
M.L., Tressol<strong>di</strong> P., (coor<strong>di</strong>natori), DSA<br />
Documento d’intesa, PARCC, www.lineeguidadsa.it.,<br />
20<strong>11</strong>.<br />
Morris C., Measuring participation in<br />
childhood <strong>di</strong>sability: how does the capability<br />
approach improve our understan<strong>di</strong>ng?,<br />
in “Developmental Me<strong>di</strong>cine<br />
& Child Neurology”, 51, 2009.<br />
Ruggerini C., Vezzosi F., Dalla Vecchia<br />
A., Prendersi cura della <strong>di</strong>sabilità intellettiva.<br />
Coor<strong>di</strong>nate OMS, buone prassi,<br />
storie <strong>di</strong> vita, Erickson, Trento, 2008.<br />
Ruggerini C., Vicini S., Manzotti S., Griffo<br />
G., La ‘Cura della Comunità’ per la<br />
promozione della salute: il ruolo dei documenti<br />
clinici. Il caso della <strong>di</strong>sabilità<br />
intellettiva e delle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento,<br />
in G.B. Camerini, E. Sechi (a cura<br />
<strong>di</strong>), Riabilitazione psicosociale nell’infanzia<br />
e nell’adolescenza. Principi ed<br />
esperienze, Maggioli, Rimini, 2010.<br />
Schwartz S.J., Pantin H., Coatsworth<br />
J.D., Szapocznik J., Addressing the<br />
Challenges and Opportunities for Today’s<br />
Youth: Toward an Integrative<br />
Model and its Implications for Research<br />
and Intervention, in “The Journal of Primary<br />
Prevention”, 28, 2007.<br />
Saito M., Amartya Sen’s Capability Approach<br />
to Education: a Critical Exploration,<br />
in “Journal of Philosophy of Education”,<br />
2003.<br />
Sen A., Inequality Re-examined, Oxford<br />
University Press, Oxford, 1992.<br />
Sen A., Development as Freedom, Oxford<br />
University Press, Oxford, 1999.<br />
Sen A., The Idea of Justice, Allen Lane,<br />
London, 2009.<br />
Timmons J., Wills J., Kemp J., Basha R.,<br />
Mooney M., Charting the Course: Supporting<br />
the Career Development of<br />
Youth with Learning Disabilities, Institute<br />
for Educational Leadership, National<br />
Collaborative on Workforce and<br />
Disability for Youth, Washington DC,<br />
2010.<br />
<strong>Focus</strong><br />
Ciro Ruggerini<br />
Neuropsichiatra infantile, psichiatra, psicoterapeuta<br />
(SITCC); <strong>di</strong>rettore sanitario della Cooperativa <strong>di</strong> servizi<br />
l’arcobaleno (Reggio Emilia); presidente della Società<br />
italiana per lo stu<strong>di</strong>o del ritardo mentale (SIRM)<br />
Sumire Manzotti<br />
Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, dottore <strong>di</strong><br />
ricerca in economia aziendale (Università <strong>di</strong> Waseda,<br />
Tokyo); Socio Fondatore Minamiyachimata Mental<br />
Hospital (Chiba, Tokio)<br />
L’in<strong>di</strong>ce<br />
internazionale<br />
dello sviluppo<br />
umano (HDI)<br />
tiene insieme<br />
i livelli<br />
della salute,<br />
dell’istruzione<br />
e della produzione<br />
economica:<br />
la scuola<br />
ne esce<br />
comunque<br />
rispettata<br />
69
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
70<br />
<strong>Focus</strong><br />
L’idea <strong>di</strong> rete<br />
ci ricorda<br />
la cura<br />
<strong>di</strong> un interesse<br />
generale<br />
che oggi<br />
non può essere<br />
solo a carico<br />
delle strutture<br />
pubbliche<br />
La metafora della rete:<br />
aprire la scatola nera<br />
La rete: un concetto da<br />
esplorare<br />
“Rete” è uno dei termini che oggi ricorre<br />
maggiormente nelle riflessioni che<br />
riguardano la scuola e la relazione tra<br />
scuola e territorio. È anche uno dei termini<br />
più utilizzati nei ragionamenti sul<br />
<strong>di</strong>sagio scolastico e sulla progettazione<br />
degli interventi a contrasto della <strong>di</strong>spersione<br />
scolastica.<br />
Questo termine, che è <strong>di</strong>ventato una<br />
metafora, rischia <strong>di</strong> rimanere una sorta<br />
<strong>di</strong> scatola nera che, prima o poi, bisognerà<br />
aprire per analizzarne alcune<br />
caratteristiche e per capirne il funzionamento.<br />
Per analizzare i contenuti<br />
<strong>di</strong> questa scatola nera propongo un<br />
assunto: la rete non è qualche cosa <strong>di</strong><br />
virtuoso in sé.<br />
La rete rappresenta una delle tante<br />
possibili modalità <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e<br />
la sua specificità parrebbe essere quella<br />
<strong>di</strong> presentarsi come una modalità più<br />
paritaria e, almeno apparentemente,<br />
più democratica. Tuttavia ci sono molti<br />
esempi che dovrebbero indurci a usare<br />
con cautela questa affermazione.<br />
Mi è capitato <strong>di</strong> lavorare in una struttura<br />
residenziale per ragazzini vivaci e questi,<br />
appena collocati in qualsiasi contesto,<br />
fosse la scuola, la comunità in cui<br />
vivevano o altri luoghi, avevano formidabili<br />
competenze <strong>di</strong> rete. In tempi brevissimi<br />
costruivano le loro reti finalizzate<br />
al raggiungimento <strong>di</strong> personali obiettivi<br />
<strong>di</strong> crescita che spesso però contrastavano<br />
con gli obiettivi delle strutture<br />
<strong>di</strong> riferimento e non potevano sicuramente<br />
considerarsi virtuosi.<br />
Un altro esempio. Le reti migratorie<br />
rappresentano una risorsa in<strong>di</strong>spensabile<br />
senza la quale lo stesso processo<br />
migratorio nemmeno si compirebbe.<br />
Allo stesso tempo però, esse sono un<br />
formidabile strumento <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong><br />
esclusione <strong>di</strong> tutti i comportamenti e gli<br />
in<strong>di</strong>vidui non conformi alle caratteristiche<br />
<strong>di</strong> appartenenza familiare, culturale<br />
o nazionale, attraverso le quali quella<br />
rete si costituisce.<br />
<strong>di</strong> Vando Borghi<br />
Ancora si può riflettere sulla formidabile<br />
capacità <strong>di</strong> rete delle organizzazioni criminali,<br />
che ci <strong>di</strong>mostra che non si tratta<br />
<strong>di</strong> qualcosa <strong>di</strong> necessariamente positivo<br />
e quin<strong>di</strong>, dobbiamo chiederci che<br />
cosa determini la virtuosità delle reti.<br />
Le finalità delle reti:<br />
curare il bene pubblico<br />
Fra le molte proprietà delle reti, ho isolato<br />
tre aspetti che <strong>di</strong>rettamente determinano<br />
la virtuosità delle reti stesse: le<br />
finalità, i no<strong>di</strong>, la natura delle relazioni.<br />
Sicuramente rende virtuosa una rete il<br />
fatto che essa persegua qualche cosa<br />
che possiamo genericamente definire<br />
come interesse generale, e perseguire<br />
un interesse generale vuol <strong>di</strong>re, a<br />
mio parere, prendersi cura, avere cura<br />
dei più deboli.<br />
Chi è il responsabile del perseguimento<br />
dell’interesse generale? Qui sta un<br />
primo problema che il fare rete ci consegna,<br />
nello scenario della contemporaneità.<br />
Se è stato vero in passato che<br />
la realizzazione dell’interesse generale<br />
era imputabile a un unico attore, l’attore<br />
pubblico, che aveva per definizione<br />
l’obiettivo <strong>di</strong> realizzare l’interesse generale,<br />
oggi noi siamo in uno scenario<br />
in cui questo non si dà più. Gli attori<br />
che oggi sono chiamati a concorrere<br />
all’interesse generale sono <strong>di</strong>versi:<br />
soggetti pubblici, privati, for profit,<br />
no profit, associazioni, organizzazioni<br />
<strong>di</strong>verse.<br />
Quin<strong>di</strong> occorre riflettere sulle caratteristiche<br />
del processo che consente la<br />
realizzazione dell’interesse generale,<br />
perché oggi non possiamo più identificare<br />
l’interesse generale con un solo<br />
soggetto (pubblico), ma dobbiamo associarlo<br />
a un processo.<br />
Quando siamo in presenza dell’effettiva<br />
realizzazione dell’interesse generale?<br />
Quali ‘sintomi’ ce lo segnalano? Sicuramente<br />
la visibilità dei criteri sulla base<br />
dei quali viene perseguito un obiettivo<br />
<strong>di</strong> interesse generale, il fatto che si<br />
riconosca che le materie, i problemi, le
questioni <strong>di</strong> cui si sta trattando sono attinenti<br />
al bene pubblico. Ad esempio, se<br />
la questione della <strong>di</strong>spersione scolastica<br />
viene demandata ai soggetti singoli<br />
e alle famiglie <strong>di</strong>venta questione privata.<br />
Se, al contrario, la questione della <strong>di</strong>spersione<br />
scolastica viene collocata in<br />
una cornice finalizzata alla realizzazione<br />
dell’interesse pubblico perché si ritiene<br />
che l’esperienza <strong>di</strong> ingiustizia e <strong>di</strong><br />
esclusione del singolo rappresentino un<br />
vulnus all’interesse collettivo, allora essa<br />
<strong>di</strong>venta questione pubblica.<br />
Le relazioni nelle reti<br />
La rete, più che altre forme <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento,<br />
ha a che fare col tema della partecipazione.<br />
La partecipazione non è<br />
un dato <strong>di</strong> partenza ma, laddove si produce,<br />
è un esito, qualcosa che richiede<br />
un investimento <strong>di</strong> risorse materiali<br />
e immateriali, un sostegno, una manutenzione<br />
nel corso del tempo.<br />
Anche territori come il nostro che hanno<br />
una storia <strong>di</strong> partecipazione hanno,<br />
appunto, una storia. Non è detto<br />
che le nuove generazioni, i più giovani<br />
o coloro che arrivano da altrove,<br />
necessariamente la conoscano e la riproducano.<br />
La riproducono laddove si creano le<br />
strutture <strong>di</strong> opportunità per farlo. Le famiglie<br />
<strong>di</strong> immigrati interagiscono maggiormente,<br />
ad esempio, nei primi livelli<br />
della scolarizzazione perché è lì che<br />
trovano le occasioni più sostanziose,<br />
più concrete, più strutturate e favorenti<br />
la partecipazione attiva.<br />
Infine la modalità <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />
reticolare esige, più che altre forme<br />
<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento, che queste relazioni<br />
siano orientate alla creazione <strong>di</strong><br />
borderline, <strong>di</strong> terre <strong>di</strong> confine, alla costruzione<br />
<strong>di</strong> ponti, <strong>di</strong> spazi che mettano<br />
in contatto soggetti <strong>di</strong>versi per natura,<br />
estrazione sociale, appartenenza<br />
culturale. Il coltivare il contatto tra<br />
le <strong>di</strong>versità è infatti qualcosa che <strong>di</strong>venta<br />
sempre più artificiale: l’esperienza<br />
sociale urbana contemporanea<br />
è sempre più fortemente caratterizzata<br />
dal fatto <strong>di</strong> far incrociare fra<br />
loro i simili per natura culturale, provenienza,<br />
età.<br />
I no<strong>di</strong> delle reti:<br />
costruire capitale sociale<br />
I no<strong>di</strong> delle reti hanno a che fare con<br />
la struttura <strong>di</strong> opportunità. Una delle<br />
strutture reticolari per eccellenza è la<br />
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Nelle reti<br />
si favoriscono<br />
la partecipazione<br />
attiva<br />
e il confronto<br />
tra realtà sociali<br />
e culturali<br />
<strong>di</strong>verse<br />
71
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
La rete<br />
è la <strong>di</strong>mensione<br />
più appropriata<br />
per produrre<br />
capitale sociale,<br />
in<strong>di</strong>spensabile<br />
in una società<br />
che sembra<br />
aver smarrito<br />
il senso<br />
dei beni comuni<br />
72<br />
struttura cerebrale, fatta dalla rete delle<br />
sinapsi che, nel tempo, cambia, e<br />
quanto meno sono gli stimoli (e la <strong>di</strong>versità<br />
è uno stimolo al funzionamento<br />
della rete) tanto più quella rete si impoverisce.<br />
Le strutture <strong>di</strong> opportunità hanno a<br />
che fare con il capitale sociale, cioè<br />
con la dotazione <strong>di</strong> competenze, pratiche,<br />
esperienze, che facilitano il perseguimento<br />
dell’interesse generale. Il<br />
capitale sociale che le realtà sociali<br />
contemporanee esigono è <strong>di</strong>verso da<br />
quello della tra<strong>di</strong>zione: implica un <strong>di</strong><br />
più <strong>di</strong> riflessività, non si limita soltanto<br />
ad accumulare esperienze, ma ha<br />
bisogno <strong>di</strong> creare occasioni attraverso<br />
le quali, su quelle esperienze, ci si<br />
possa confrontare, si possa <strong>di</strong>scutere,<br />
si possa riflettere. E a fare questo<br />
siamo sempre meno abituati. È imme<strong>di</strong>ato<br />
l’esempio che ci riconsegna la<br />
vita politica attraverso una crescente<br />
incapacità <strong>di</strong> riflettere, <strong>di</strong>scutere, interpretare.<br />
Infine occorre ricordare che i no<strong>di</strong> si riproducono<br />
o, al contrario, vanno persi,<br />
anche sulla base della struttura <strong>di</strong><br />
opportunità presenti nel contesto. Noi<br />
dobbiamo quin<strong>di</strong> tenere conto della natura<br />
intrinsecamente politica <strong>di</strong> materie<br />
quali gli interventi contro la <strong>di</strong>spersione,<br />
il sostegno delle potenzialità in<strong>di</strong>viduali,<br />
gli interventi per la promozione<br />
del benessere.<br />
Performance vs citta<strong>di</strong>nanza?<br />
Sono in atto delle trasformazioni che<br />
hanno a che fare con il combinato <strong>di</strong><br />
un crescente attacco al lavoro e all’istruzione<br />
pubblica. Dal 1976 al 2006<br />
la percentuale <strong>di</strong> ricchezza complessiva<br />
prodotta che va al mondo del lavoro<br />
è <strong>di</strong>minuita, nei Paesi OCSE, del<br />
10%, in Italia del 14%. Osserviamo un<br />
attacco strutturale al lavoro delle persone<br />
e un analogo e strutturale attacco<br />
all’istruzione pubblica.<br />
Tutto ciò non riguarda esclusivamente<br />
l’Italia, ma ha a che fare con processi<br />
<strong>di</strong> natura e <strong>di</strong>mensione globale che<br />
stanno colpendo, in particolare, alcuni<br />
aspetti dell’istruzione pubblica, particolarmente<br />
tutto quello che ha a che<br />
fare con l’insegnamento delle cosiddette<br />
humanities o, più in generale, <strong>di</strong><br />
quelle competenze che non sono imme<strong>di</strong>atamente<br />
strumentali a una performance<br />
<strong>di</strong> tipo economico-professionale<br />
ma che sono esattamente il terreno<br />
sulla base del quale si costruisce la<br />
citta<strong>di</strong>nanza.<br />
Vando Borghi<br />
Docente <strong>di</strong> Sociologia dello sviluppo e Politiche del<br />
lavoro, Facoltà <strong>di</strong> Scienze Politiche, Dipartimento <strong>di</strong><br />
Sociologia, Università <strong>di</strong> Bologna
La gestione<br />
dei casi <strong>di</strong>fficili<br />
Scuola me<strong>di</strong>a del Canton Ticino (CH)<br />
<strong>di</strong> Flavia Cereghetti-Bion<strong>di</strong><br />
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Risorse supplementari<br />
Per affrontare le situazioni particolarmente<br />
complesse <strong>di</strong> allievi della scuola<br />
me<strong>di</strong>a nel Canton Ticino è stato istituito<br />
un gruppo <strong>di</strong> lavoro che, dopo aver<br />
analizzato le situazioni e la vastità del<br />
problema, ha proposto la creazione <strong>di</strong><br />
una commissione “Casi <strong>di</strong>fficili”.<br />
La denominazione “Casi <strong>di</strong>fficili” rinvia<br />
a una misura straor<strong>di</strong>naria particolarmente<br />
flessibile che gli istituti scolastici<br />
possono attivare su presentazione <strong>di</strong><br />
un progetto specifico all’apposita Commissione<br />
cantonale per l’ottenimento <strong>di</strong><br />
risorse finanziarie supplementari.<br />
In questo modo è possibile cercare una<br />
risposta per gli allievi che presentano<br />
situazioni complesse <strong>di</strong> forte <strong>di</strong>sadattamento,<br />
nel caso in cui le or<strong>di</strong>narie risorse<br />
a <strong>di</strong>sposizione della scuola non si rivelino<br />
sufficienti o efficaci a contenerli.<br />
Nascono così i Gruppi operativi (GO)<br />
composti dal <strong>di</strong>rettore della sede, dal<br />
capo-gruppo del Servizio <strong>di</strong> sostegno,<br />
dal docente <strong>di</strong> classe, dal docente SP<br />
e dalle figure esterne (psicologi, assistenti<br />
sociali, tutori...) legate all’allievo<br />
in questione che, in un prezioso lavoro<br />
<strong>di</strong> rete, accompagnano, monitorano, rielaborano<br />
il progetto non perdendo <strong>di</strong><br />
vista gli obiettivi prefissati.<br />
Strategie <strong>di</strong>fferenziate<br />
Accanto al Gruppo operativo vi sono<br />
anche azioni chiamate ‘Misura F’ e ‘Misura<br />
G’ che, pur avendo caratteristiche<br />
organizzative <strong>di</strong>verse, perseguono lo<br />
stesso obiettivo: mantenere i ragazzi<br />
‘dentro’ la scuola.<br />
La prima Misura si caratterizza per la<br />
creazione, nel rispetto del principio <strong>di</strong><br />
integrazione, <strong>di</strong> zone tampone interne<br />
agli istituti come momenti <strong>di</strong> ‘time out’<br />
durante i quali l’allievo può essere accolto<br />
per tempi limitati con l’obiettivo <strong>di</strong><br />
un rientro (parziale o totale) nella normale<br />
attività scolastica. Lo scopo <strong>di</strong> questa<br />
Misura è quello <strong>di</strong> permettere agli allievi<br />
e ai docenti <strong>di</strong> beneficiare <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stanza<br />
fisica e psicologica dalle situazioni stressanti,<br />
limitata nel tempo e in previsione<br />
<strong>di</strong> un reinserimento rapido nell’attività<br />
scolastica o in ambito pre-professionale.<br />
La ‘Misura G’ riguarda, invece, la creazione<br />
<strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> collaborazioni con<br />
le istanze esterne alla scuola, sia pubbliche<br />
che private, <strong>di</strong>sposte ad accogliere,<br />
per un lasso <strong>di</strong> tempo ben definito,<br />
gli allievi che svolgono un’esperienza<br />
lavorativa e personale <strong>di</strong>versa<br />
da quella scolastica. Una figura della<br />
scuola (docente, educatore) svolge la<br />
funzione <strong>di</strong> collegamento e <strong>di</strong> accompagnamento<br />
all’esperienza.<br />
L’interesse <strong>di</strong> questa procedura istituzionalizzata<br />
è che, <strong>di</strong> fronte a una situazione<br />
<strong>di</strong>fficile, la pratica <strong>di</strong> collaborazione<br />
genera soluzioni nuove scaturite<br />
dalla forza del gruppo, soluzioni<br />
che non erano state immaginate a livello<br />
in<strong>di</strong>viduale.<br />
Si possono<br />
sperimentare<br />
situazione<br />
<strong>di</strong> ‘<strong>di</strong>stanziamento’<br />
temporaneo<br />
e reti<br />
<strong>di</strong> collaborazione<br />
per ‘affidamento’<br />
esterno finalizzato<br />
al rientro<br />
a scuola<br />
Flavia Cereghetti-Bion<strong>di</strong><br />
Ufficio insegnamento me<strong>di</strong>o - Divisione scuola -<br />
Dipartimento educazione cultura sport (DECS)<br />
73
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
I laboratori del fare<br />
e del sapere<br />
nell’esperienza trentina<br />
<strong>di</strong> Silvia Tabarelli<br />
Attraverso<br />
laboratori<br />
non strettamente<br />
attinenti<br />
alle <strong>di</strong>scipline<br />
(quin<strong>di</strong> cucina,<br />
riparazioni,<br />
falegnameria, ecc.)<br />
si promuovono<br />
abilità, saperi,<br />
comportamenti<br />
consapevoli<br />
74<br />
Contrastare il <strong>di</strong>sagio<br />
La presentazione descrive la metodologia,<br />
le fasi e gli esiti <strong>di</strong> un’azione <strong>di</strong> ricerca<br />
collocata in un più ampio progetto,<br />
promosso dalla Provincia <strong>di</strong> Trento,<br />
riguardante “Interventi strutturati in<br />
materia <strong>di</strong> lotta alla <strong>di</strong>scriminazione in<br />
contesto formativo e conseguentemente<br />
<strong>di</strong> inclusione sociale dei beneficiari”.<br />
Il campo <strong>di</strong> ricerca ha riguardato tre Istituti<br />
comprensivi della Provincia coinvolgendo,<br />
per ciascun istituto, un gruppo<br />
<strong>di</strong> studenti che ha partecipato ai “Laboratori<br />
del fare e del sapere” (LFS), un<br />
docente <strong>di</strong>sciplinare, un docente o un<br />
educatore responsabile della gestione<br />
dei laboratori.<br />
La presa in carico del <strong>di</strong>sagio scolastico<br />
è, tra le pratiche in uso nella scuola<br />
trentina, <strong>di</strong> particolare interesse perché<br />
sembra accogliere sia le istanze <strong>di</strong><br />
personalizzazione proprie della <strong>di</strong>dattica<br />
per competenze, sia la necessità<br />
dell’in<strong>di</strong>vidualizzazione dei tempi e delle<br />
mete <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento.<br />
I compiti <strong>di</strong> realtà<br />
Sotto l’etichetta “LFS” si raccolgono<br />
esperienze molto <strong>di</strong>versificate che hanno<br />
in comune l’organizzazione <strong>di</strong> spazi<br />
appositamente allestiti a laboratorio<br />
dove i ragazzi ‘apprendono facendo’,<br />
impegnandosi in compiti <strong>di</strong> realtà.<br />
Sono i laboratori <strong>di</strong> falegnameria, <strong>di</strong> riparazione<br />
<strong>di</strong> biciclette, <strong>di</strong> cucina, <strong>di</strong> legatoria,<br />
<strong>di</strong> cucito, ecc., <strong>di</strong>versi da quelli<br />
de<strong>di</strong>cati alla <strong>di</strong>dattica laboratoriale delle<br />
<strong>di</strong>scipline. L’ipotesi che la ricerca intende<br />
verificare è se i “LFS” con<strong>di</strong>vidono<br />
con la <strong>di</strong>dattica laboratoriale la caratteristica<br />
<strong>di</strong> essere luoghi del ‘fare’ –<br />
in quanto attivano abilità operative, abilità<br />
cognitive, comportamenti sociali –<br />
e del ‘sapere’, in quanto danno accesso<br />
a un sapere critico, alla consapevolezza<br />
<strong>di</strong> sé costruita con la metacognizione.<br />
I “LFS” sono anche luoghi capaci<br />
<strong>di</strong> accogliere le <strong>di</strong>verse esigenze formative;<br />
essi assumono un’importanza<br />
particolare per l’accoglienza <strong>di</strong> quegli<br />
studenti che si <strong>di</strong>scostano dal normale<br />
percorso scolastico, secondo quanto<br />
espresso nel “Regolamento per favorire<br />
l’integrazione e l’inclusione degli<br />
studenti con Bisogni educativi speciali<br />
(BES)” riguardo a fenomeni come<br />
la <strong>di</strong>spersione scolastica, l’eterogeneità<br />
delle classi, le situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio e<br />
<strong>di</strong> abbandono scolastico.<br />
Scoprire pratiche positive<br />
In risposta a queste criticità, gli obiettivi<br />
principali del progetto della Provincia<br />
<strong>di</strong> Trento sono:<br />
rilevare la <strong>di</strong>ffusione, nel sistema<br />
scolastico trentino, <strong>di</strong> pratiche <strong>di</strong>dattiche<br />
e <strong>di</strong> scelte organizzative<br />
tese all’inclusione dei soggetti destinatari<br />
del progetto e in<strong>di</strong>viduare<br />
possibili azioni <strong>di</strong> sistema per una<br />
maggiore <strong>di</strong>ffusione;<br />
in<strong>di</strong>viduare le prassi <strong>di</strong>dattiche e organizzative<br />
finalizzate al successo<br />
formativo presenti nel secondo ciclo<br />
<strong>di</strong> istruzione e formazione e promuovere<br />
azioni <strong>di</strong> sistema per la loro<br />
<strong>di</strong>ffusione;<br />
- promuovere la cultura e le modalità<br />
<strong>di</strong> lavoro in rete nelle specifiche realtà<br />
territoriali, nell’ottica dell’integrazione<br />
delle risorse e della valorizzazione<br />
delle opportunità formative<br />
presenti nella comunità.<br />
Le caratteristiche fondamentali dei “Laboratori<br />
del fare e del sapere” descritte<br />
nella ricerca riguardano anche i meto<strong>di</strong><br />
utilizzati, i network attivati all’interno<br />
e all’esterno della scuola e gli esiti,<br />
seppur parziali, acquisiti in questi anni<br />
<strong>di</strong> sperimentazione.<br />
Silvia Tabarelli<br />
IPRASE Trentino
Provaci ancora,<br />
Sam!<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Torino<br />
<strong>di</strong> Marina Busso e Barbara Rivoira<br />
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Obiettivo integrazione<br />
“Provaci ancora, Sam!” è un progetto<br />
interistituzionale che si realizza nel territorio<br />
del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Torino con il coinvolgimento<br />
dei Servizi educativi e sociali<br />
comunali, dell’Ufficio scolastico<br />
provinciale, dell’Ufficio Pio della Compagnia<br />
<strong>di</strong> San Paolo e <strong>di</strong> alcune associazioni<br />
<strong>di</strong> volontariato.<br />
Si rivolge alla popolazione scolastica<br />
italiana e straniera anche <strong>di</strong> recentissima<br />
immigrazione (arrivi in corso d’anno).<br />
Infatti le finalità legate all’integrazione<br />
e alla lotta al <strong>di</strong>sagio sociale sono<br />
una delle parti strutturali del progetto.<br />
Le figure professionali coinvolte sono:<br />
insegnanti, educatori, funzionari comunali,<br />
operatori delle associazioni <strong>di</strong><br />
volontariato, psicologi.<br />
Si svolge in parte presso le se<strong>di</strong> scolastiche,<br />
in parte in strutture delle Associazioni,<br />
del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Torino o <strong>di</strong><br />
altri enti.<br />
Rafforzare l’autonomia<br />
Lo sviluppo del progetto ha una durata<br />
annuale. Per i ragazzi <strong>di</strong> prima me<strong>di</strong>a<br />
l’obiettivo principale è la promozione<br />
in seconda, per i ragazzi inseriti<br />
nei percorsi <strong>di</strong> recupero scolastico<br />
l’obiettivo invece è la licenza me<strong>di</strong>a.<br />
Si mira al raggiungimento <strong>di</strong> obiettivi<br />
sia <strong>di</strong>dattici sia <strong>di</strong> tipo relazionale,<br />
comportamentale, pratico-organizzativo<br />
e <strong>di</strong> autonomia nello stu<strong>di</strong>o. Le<br />
aree tematiche su cui il progetto si<br />
concentra sono prevalentemente la<br />
linguistica e la logico-matematica; le<br />
altre aree (artistica, motoria o tecnica)<br />
non sono però escluse, poiché in<br />
esse l’allievo ha la possibilità <strong>di</strong> rilevare<br />
competenze non formali e informali,<br />
utili alla definizione del suo programma<br />
in<strong>di</strong>viduale da cui partire anche<br />
per l’appren<strong>di</strong>mento dell’italiano<br />
e della matematica.<br />
Questo risultato da raggiungere è accompagnato<br />
da una serie <strong>di</strong> altri obiettivi<br />
specifici (in alcuni casi definiti per<br />
il singolo allievo) che mirano al miglioramento<br />
delle capacità <strong>di</strong> attenzione,<br />
appren<strong>di</strong>mento, partecipazione, consapevolezza,<br />
adeguatezza per rendere<br />
gli allievi capaci <strong>di</strong> essere giovani citta<strong>di</strong>ni<br />
maturi e attivi.<br />
La ricerca-azione<br />
Il metodo <strong>di</strong> lavoro adottato è quello<br />
della ricerca-azione poiché la caratteristica<br />
del progetto è sempre rimasta<br />
<strong>di</strong> tipo sperimentale. Nonostante<br />
la struttura sia piuttosto definita,<br />
ogni anno, ciascuna realtà territoriale<br />
provvede ad una propria progettazione<br />
e programmazione dettagliata. I<br />
partner contribuiscono, infatti, alla definizione<br />
del programma <strong>di</strong> lavoro portando<br />
e confrontando la propria analisi<br />
dei bisogni, delle motivazioni e delle<br />
possibili soluzioni con quella degli altri.<br />
Da questa prima analisi scaturisce<br />
la proposta educativa che comprende<br />
l’aspetto <strong>di</strong>dattico che si realizza durante<br />
l’anno con un monitoraggio costante<br />
che consente correzioni e revisioni<br />
del programma. In questa situazione<br />
<strong>di</strong> confronto iniziale vengono anche<br />
in<strong>di</strong>viduati alcuni allievi che si trovano<br />
in <strong>di</strong>fficoltà particolari, per i quali<br />
viene richiesto un intervento più articolato<br />
e specifico. Gli incontri <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />
e <strong>di</strong> monitoraggio hanno<br />
anche lo scopo <strong>di</strong> far procedere il percorso<br />
su una traccia comune che garantisca<br />
la congruenza con la <strong>di</strong>mensione<br />
citta<strong>di</strong>na del progetto.<br />
Marina Busso<br />
Ufficio Pio della Compagnia <strong>di</strong> San Paolo<br />
Barbara Rivoira<br />
Coor<strong>di</strong>natrice del progetto “Provaci ancora, Sam!”<br />
Di fronte<br />
ai casi <strong>di</strong>fficili<br />
si definiscono<br />
progetti<br />
personalizzati<br />
con obiettivi<br />
comportamentali,<br />
praticoorganizzativi,<br />
<strong>di</strong> autonomia<br />
nello stu<strong>di</strong>o<br />
75
<strong>Rivista</strong><br />
dell’istruzione<br />
4 - 20<strong>11</strong><br />
<strong>Focus</strong><br />
Scuola per prevenire,<br />
scuola per recuperare<br />
Quarto Oggiaro (MI)<br />
<strong>di</strong> Daniele Giar<strong>di</strong>na e Edda Odorici<br />
In un ambiente<br />
<strong>di</strong>fficile<br />
scuole<br />
e soggetti esterni<br />
si impegnano<br />
per aiutare<br />
i ragazzi<br />
attraverso percorsi<br />
personali,<br />
non costrittivi,<br />
agiti<br />
in vari contesti<br />
76<br />
Aree a rischio<br />
Dal 1999 l’Istituto comprensivo “Trilussa”<br />
<strong>di</strong> Quarto Oggiaro (Mi) è riconosciuto<br />
come ‘scuola in area a rischio’.<br />
Il contesto, infatti, rispetto ad altre zone<br />
<strong>di</strong> Milano, si presenta con un alto<br />
in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio rispetto a: con<strong>di</strong>zione<br />
abitativa, composizione delle famiglie,<br />
livello <strong>di</strong> istruzione, tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione,<br />
con<strong>di</strong>zione lavorativa,<br />
problemi giu<strong>di</strong>ziari. Alta è la percentuale<br />
degli alunni all’attenzione del Tribunale<br />
dei minori (alcuni anche seguiti<br />
per provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> allontanamento<br />
dal nucleo familiare); oppure con la<br />
famiglia seguita dai servizi sociali; o<br />
ancora che presentano problematiche<br />
<strong>di</strong> devianza/<strong>di</strong>pendenza documentate,<br />
con frequenza irregolare o a rischio <strong>di</strong><br />
insuccesso formativo e a volte <strong>di</strong> abbandono<br />
scolastico.<br />
Da allora l’impegno nelle azioni atte ad<br />
affrontare il <strong>di</strong>sagio degli alunni e far<br />
loro raggiungere il successo scolastico<br />
e formativo viene sistematizzato in<br />
un unico progetto che coinvolge tutte<br />
le componenti scolastiche in un intreccio<br />
<strong>di</strong> attività e collaborazione con molteplici<br />
partner esterni.<br />
Risposte ai bisogni speciali<br />
Le azioni sono svolte in orario sia<br />
scolastico sia extrascolastico; sono<br />
condotte dai docenti, ma anche da<br />
educatori esterni, psicologi, volontari;<br />
perseguono obiettivi <strong>di</strong> recupero<br />
strumentale delle abilità, ma offrono<br />
anche spazi <strong>di</strong> ascolto e <strong>di</strong> relazione<br />
<strong>di</strong>versificati, costruendo percorsi ‘cuciti<br />
addosso’ alle esigenze degli alunni<br />
in <strong>di</strong>fficoltà.<br />
Per rispondere ai bisogni speciali che<br />
gli alunni manifestano, il progetto cerca<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare verso queste strade:<br />
un percorso personalizzato che<br />
permetta <strong>di</strong> realizzare una situazione<br />
positiva <strong>di</strong> crescita in<strong>di</strong>viduale<br />
(raggiungimento della sufficienza in<br />
una certa <strong>di</strong>sciplina, raggiungimento<br />
della licenza me<strong>di</strong>a…);<br />
la riduzione del tempo <strong>di</strong> esposizione<br />
a situazioni <strong>di</strong> stress (la lezione<br />
frontale, la verifica, il compito…),<br />
al fine <strong>di</strong> limitare l’adozione<br />
<strong>di</strong> comportamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa/attacco<br />
verso se stessi e gli altri e <strong>di</strong><br />
migliorare l’approccio alla partecipazione<br />
scolastica;<br />
- il bisogno <strong>di</strong> agire il proprio ruolo in<br />
contesti <strong>di</strong>versi da quelli della scuola,<br />
scar<strong>di</strong>nando l’obbligo per molti<br />
ragazzi <strong>di</strong> rappresentarsi al gruppo<br />
dei pari come leader o come gregario<br />
negativo.<br />
Dall’emergenza alla personalizzazione<br />
I progetti realizzati in questi anni si possono<br />
così accorpare:<br />
- progetti per le emergenze;<br />
personalizzazione del percorso scolastico;<br />
- progetti <strong>di</strong> prevenzione;<br />
i progetti esterni che però vedono<br />
anche il coinvolgimento della scuola.<br />
Per molti alunni gli esiti delle attività sono<br />
stati passi positivi rispetto alla situazione<br />
<strong>di</strong> partenza e complessivamente<br />
hanno determinato un forte abbattimento<br />
dell’abbandono scolastico.<br />
Di fronte al profondo <strong>di</strong>sagio degli alunni<br />
la scuola non può farcela da sola: solo<br />
una rete a maglie ben strette <strong>di</strong> attori<br />
e azioni può offrire delle occasioni <strong>di</strong><br />
crescita percorribili.<br />
Daniele Giar<strong>di</strong>na - Edda Odorici<br />
Docenti nell’Istituto comprensivo “Trilussa”,<br />
scuola secondaria <strong>di</strong> primo grado – Quarto Oggiaro (MI)