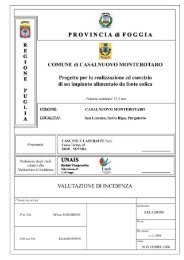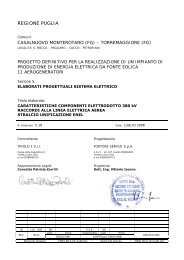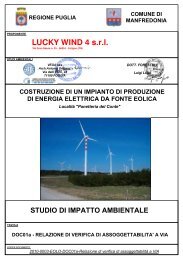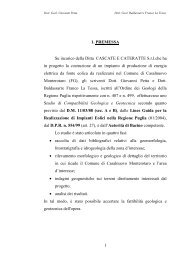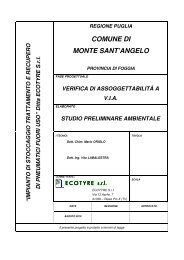impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali solide
impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali solide
impianto di cogenerazione alimentato a biomasse vegetali solide
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IMPIANTO DI COGENERAZIONE<br />
ALIMENTATO A BIOMASSE VEGETALI SOLIDE<br />
S. Agata <strong>di</strong> Puglia (FG)<br />
PROPONENTE/PROMOTER<br />
IL PRESIDENTE<br />
VIA ZUCCHERIFICIO, 10 - 48213 - MEZZANO (RA)<br />
DOCUMENTAZIONE TECNICA AI FINI AUTORIZZATIVI<br />
UNITA' FUNZIONALE/FUNCTIONAL UNIT<br />
Documenti generali<br />
RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE<br />
CONSULENZA/GENERAL CONTRACTOR<br />
IL PRESIDENTE<br />
CONSULENZA/SUBCONTRACTOR<br />
VIALE COLOMBO, 13 - 71121 FOGGIA, ITALIA<br />
TEL. +39 0881 665635 FAX +39 0881 881672<br />
e-mail: info@unais.it www.unais.it<br />
IL DIRETTORE GENERALE<br />
(Ing.Roberto Carpaneto)<br />
VIA SAN NAZARO, 19 - 16145 GENOVA, ITALIA<br />
TEL. +39 010 362 8148 FAX +39 010 362 1078 P. IVA 03476550102<br />
e-mail dappolonia@dappolonia.it www.dappolonia.it<br />
DATE/DATA SCALA/SCALE N. INT/ INTERNAL N. TAV/PLATE N. REV SH<br />
20/06/2011 10 625 SAG 00 G 001 2
Doc. No. SAG-00-P-016-1<br />
Rev. 2 - Giugno 2011<br />
INDICE<br />
Pagina<br />
1 PREMESSA 1<br />
2 BIOMASSE QUALE FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE 2<br />
3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 4<br />
3.1 ACCORDI INTERNAZIONALI - IL PROTOCOLLO DI KYOTO 4<br />
3.2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 4<br />
3.2.1 Direttiva 2001/77/CE 4<br />
3.2.2 Direttiva 2009/28/CE 5<br />
3.3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE 5<br />
3.3.1 Il Piano <strong>di</strong> Azione Nazionale per le energie rinnovabili (P.A.N.) 5<br />
3.3.2 Il quadro <strong>di</strong> riferimento regionale 6<br />
4 IL CONTESTO NORMATIVO 7<br />
4.1 IL CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE 7<br />
4.2 IL CONTESTO NORMATIVO REGIONALE 7<br />
5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 9<br />
5.1 UBICAZIONE 9<br />
5.2 CRITERI PROGETTUALI 10<br />
5.2.1 Sezione stoccaggio e movimentazione della biomassa 15<br />
5.2.2 Sezione generazione vapore 16<br />
5.2.3 Sezione trattamento e evacuazione fumi 19<br />
5.2.4 Sezione produzione energia elettrica 23<br />
5.2.5 Ciclo vapore 24<br />
5.2.6 Apparecchiature e strumentazioni elettriche 26<br />
5.2.7 Sistemi Ausiliari 28<br />
5.2.8 Opere civili e infrastrutture <strong>di</strong> <strong>impianto</strong> 30<br />
6 LA FILIERA AGRICOLA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE BIOMASSE 33<br />
6.1 CARATTERISTICHE DELLE PAGLIE AI FINI DELLA RACCOLTA E DEL LORO IMPIEGO<br />
ENERGETICO 33<br />
6.2 QUANTITATIVI DI PAGLIA ED AMPIEZZA DEL BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO 34<br />
6.3 DIFFERENTI IPOTESI DI APPROVVIGIONAMENTO INTEGRATIVO 36<br />
6.4 LOGISTICA DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA E TRASPORTO DELLE PAGLIE E<br />
RELATIVI COSTI 37<br />
6.5 GESTIONE AGRONOMICA OTTIMALE DELLE PAGLIE 38<br />
6.6 CALCOLO DEL BILANCIO DELLE EMISSIONI CO2-EQUIVALENTI 39<br />
6.7 RECUPERO DELLE CENERI 40<br />
6.8 ANALISI ECONOMICA DEL PROGETTO D’IMPIANTO IN RAPPORTO AL SUO<br />
DIMENSIONAMENTO 40<br />
6.9 EFFETTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ED APPLICAZIONE DEL PREZZO “PLUS”<br />
DELLE BIOMASSE 41<br />
6.10 CONCLUSIONI 42<br />
7 TOPOGRAFIA, GEOLOGIA, IDROLOGIA, PAESAGGIO E AMBIENTE 43<br />
Agritre<br />
Relazione Descritiva Generale<br />
Pag. i
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
7.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROLOGICO DELL’AREA 43<br />
7.2 PAESAGGIO 47<br />
8 ASPETTI ECONOMICI ED OCCUPAZIONALI 50<br />
8.1 ADDESTRAMENTO E SERVIZI TECNICI 51<br />
Agritre<br />
Relazione Tecnica Generale<br />
Pag. ii
Doc. No. SAG-00-P-016-1<br />
Rev. 2 - Giugno 2011<br />
RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE<br />
1 PREMESSA<br />
La AGRITRE srl, Società controllata da TRE Spa (Tozzi Renewable Energy del gruppo Tozzi<br />
Hol<strong>di</strong>ng), sulla base dell’accordo <strong>di</strong> filiera siglato con le Organizzazioni Agricole Provinciali<br />
Col<strong>di</strong>retti, Confagricoltura, CIA e COPAGRI, teso alla valorizzazione energetica <strong>di</strong> <strong>biomasse</strong><br />
provenienti dalle attività agricole del territorio provinciale (filiera corta), ha elaborato la<br />
documentazione progettuale necessaria ad ottenere l’autorizzazione a costruire ed esercire<br />
l’<strong>impianto</strong>, in località Viticone in agro <strong>di</strong> Sant’Agata <strong>di</strong> Puglia da parte degli uffici regionali<br />
competenti.<br />
Il progetto è coerente e rispettoso <strong>di</strong> tutti i parametri e le previsioni contenute nel Piano Energetico<br />
Ambientale della Regione Puglia e delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.<br />
In particolare, l’<strong>impianto</strong> rientra nell’ambito delle previsioni <strong>di</strong> potenza installabile nella Regione<br />
per impianti a <strong>biomasse</strong>; è conforme a quanto previsto dalle norme regionali sulla localizzazione <strong>di</strong><br />
tali impianti; è alimentata totalmente con <strong>biomasse</strong> <strong>di</strong> filiera garantite da tracciabilità ed esclude<br />
l’utilizzo anche parziale <strong>di</strong> rifiuti o CDR (combustibile derivato da rifiuti).<br />
Il progetto assume come riferimento le migliori tecnologie esistenti per minimizzare le emissioni in<br />
atmosfera e garantire in questo modo valori al <strong>di</strong> sotto dei limiti <strong>di</strong> legge per tutte le sostanze,<br />
garantisce che il consumo d’acqua è estremamente basso grazie al sistema <strong>di</strong> raffreddamento ad aria,<br />
che le emissione rumorose saranno opportunamente contenute grazie all’utilizzo <strong>di</strong> macchinari<br />
progettati per garantire livelli <strong>di</strong> rumore compatibili con le migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili al<br />
momento dell’acquisto e che ci sarà un traffico veicolare facilmente assorbibile dall’asse viario<br />
esistente.<br />
Questo progetto è un’occasione <strong>di</strong> sviluppo per il territorio, non solo per la creazione <strong>di</strong> posti <strong>di</strong><br />
lavoro <strong>di</strong>retti e in<strong>di</strong>retti (complessivamente si stimano oltre 100 posti <strong>di</strong> lavoro su base continuativa<br />
fra <strong>di</strong>pendenti della centrale ed occupati in attività <strong>di</strong> terzi a servizio della centrale stessa) e per<br />
l’investimento complessivo pari ad almeno 75 milioni <strong>di</strong> euro, ma anche perché fornisce un<br />
contributo concreto alla costituzione e gestione <strong>di</strong> una filiera su base territoriale per la raccolta,<br />
<strong>di</strong>stribuzione e valorizzazione delle <strong>biomasse</strong> agricole, oggi molto presenti nella zona ma<br />
valorizzate poco o nulla e comunque mai in maniera organica.<br />
Agritre Pag. 1<br />
Relazione Descritiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
2 BIOMASSE QUALE FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE<br />
Dal Rapporto “Le Fonti Rinnovabili 2010” a cura dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,<br />
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) emerge che l’incidenza delle <strong>di</strong>verse fonti<br />
energetiche sull’offerta mon<strong>di</strong>ale totale <strong>di</strong> energia primaria nel 2007, equivalente a 12.026 Mtep, è<br />
stata del 34% per il petrolio, del 26,4% per il carbone, del 20,9% per il gas naturale, del 5,9% per<br />
l’energia nucleare e del 12,4% per le fonti energetiche rinnovabili. Queste ultime hanno consentito<br />
<strong>di</strong> produrre complessivamente 1.492 Mtep <strong>di</strong> energia primaria, <strong>di</strong> cui la quota più grande derivante<br />
dall’uso <strong>di</strong> biomassa solida, pari al 9,3% dell’offerta mon<strong>di</strong>ale ed al 73% del totale da rinnovabili.<br />
Nei Paesi dell’Unione Europea la quantità <strong>di</strong> energia rinnovabile consumata ha raggiunto nel 2008<br />
quota 147,7 Mtep, aumentando <strong>di</strong> 9,2 Mtep rispetto all’anno precedente. La quota da rinnovabili dei<br />
consumi <strong>di</strong> energia primaria è salita a 8,2% nel 2008, dal 7,7% nel 2007.<br />
Il Paese che ha contribuito maggiormente a questo incremento è l’Italia con 2,6 Mtep in più rispetto<br />
al 2007, grazie al forte aumento della produzione dei settori biomassa solida e biocarburanti, oltre al<br />
considerevole contributo dell’idroelettrico.<br />
Osservando il contributo dei singoli settori all’aumento <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia rinnovabile<br />
nell’Unione Europea, quello della biomassa solida è il principale responsabile con una crescita <strong>di</strong><br />
2,9 Mtep, <strong>di</strong> cui gran parte attribuibile alla produzione italiana (+1,3 Mtep). In termini percentuali, si<br />
nota chiaramente la netta prevalenza della biomassa con una quota del 66,1% rispetto all’incidenza<br />
delle altre fonti rinnovabili sul totale dell’energia primaria rinnovabile consumata nel 2008.<br />
La produzione <strong>di</strong> energia primaria attraverso l’uso <strong>di</strong> biomassa solida nei Paesi UE è stata nel 2008<br />
<strong>di</strong> 70,3 Mtep, manifestando una crescita positiva (+4,6%) rispetto al 2007 (67,2 Mtep).<br />
A livello nazionale, le fonti rinnovabili <strong>di</strong> energia hanno contribuito complessivamente al consumo<br />
interno lordo (CIL) nel 2008 per una percentuale <strong>di</strong> poco superiore al 9,6%. Complessivamente nel<br />
2008 si è avuto un aumento della produzione da fonti rinnovabili in Italia del 18%. È da notare come<br />
l’incremento percentualmente più significativo, pur restando su valori assoluti molto bassi, provenga<br />
da fonti non tra<strong>di</strong>zionali quali l’eolico, il fotovoltaico, i rifiuti e le <strong>biomasse</strong> (legna, biocombustibili,<br />
biogas) che passano, sul totale delle rinnovabili, da poco più del 14% del 2000 al 34% del 2008,<br />
sebbene il contributo della biomassa legnosa (+5%) si attesti su valori ancora lontani da quelli tipici<br />
dei Paesi europei.<br />
Agritre Pag. 2<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
La generazione <strong>di</strong> energia elettrica da biomassa (legna, biogas e RSU), che dovrebbe sostenere la<br />
crescita del contributo delle rinnovabili del nostro Paese, ha registrato, infatti, una crescita limitata,<br />
pari 0,5 TWh, tra le più basse negli ultimi anni.<br />
Pertanto le <strong>biomasse</strong> presentano elevate potenzialità <strong>di</strong> sviluppo nel Paese, e rivestiranno certamente<br />
un ruolo rilevante, soprattutto nel breve/me<strong>di</strong>o periodo (2020).<br />
Nelle regioni meri<strong>di</strong>onali si evidenzia già uno sviluppo significativo della generazione elettrica con<br />
<strong>biomasse</strong> (+820% nel Sud, rispetto all’incremento del 209% nelle regioni settentrionali e del 248%<br />
in quelle centrali), avendo più che raddoppiato il peso del loro ruolo nella produzione dal 2000 al<br />
2008. Tale risultato, sebbene ancora poco significativo rispetto agli impegni che l’Italia ha assunto<br />
in ambito internazionale, è stato comunque raggiunto anche grazie al fatto che le Regioni sono<br />
<strong>di</strong>ventate le principali protagoniste delle politiche <strong>di</strong> incentivazione delle fonti rinnovabili tramite<br />
l’erogazione <strong>di</strong> incentivi agli investimenti per la realizzazione degli impianti. Il sostegno e<br />
l’interessamento al settore è testimoniato dal fatto che più del 50% delle risorse pubbliche<br />
finalizzate a sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e provenienti dall’Unione Europea sono<br />
state destinate per le <strong>biomasse</strong>, tramite i Programmi Operativi Regionali (POR) ed i Programmi <strong>di</strong><br />
Sviluppo Rurale (PSR).<br />
La biomassa, quin<strong>di</strong>, se utilizzata in modo sostenibile in tutte le fasi (accrescimento, raccolta,<br />
conferimento e conversione energetica), rappresenta una fonte <strong>di</strong> energia rinnovabile e <strong>di</strong>sponibile<br />
localmente ed il suo impiego può consentire la produzione <strong>di</strong> energia elettrica e calore limitando le<br />
emissioni complessive <strong>di</strong> CO2, oltre a rappresentare la possibilità <strong>di</strong> sviluppare interessanti nicchie<br />
<strong>di</strong> mercato e <strong>di</strong> specializzazione.<br />
In Puglia si ha un buon potenziale <strong>di</strong> biomassa <strong>di</strong>sponibile da residui agroindustriali che<br />
permetterebbero uno sviluppo notevole del settore, come evidenzia la seguente tabella, in cui è<br />
riportata una stima del potenziale <strong>di</strong> biomassa in Italia (dati ENEA), a livello regionale.<br />
Il progetto dell‘<strong>impianto</strong> è nato e si è sviluppato, pertanto, nell’ipotesi <strong>di</strong> utilizzo esclusivo <strong>di</strong><br />
<strong>biomasse</strong> <strong>vegetali</strong> <strong>solide</strong> <strong>di</strong> origine agricola, in primo luogo la paglia <strong>di</strong> grano che rappresenta, in<br />
provincia <strong>di</strong> Foggia, la biomassa principalmente <strong>di</strong>sponibile.<br />
Agritre Pag. 3<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO<br />
3.1 ACCORDI INTERNAZIONALI - IL PROTOCOLLO DI KYOTO<br />
Impropriamente denominato protocollo, esso è un trattato internazionale, siglato nel 1997, che<br />
impegna 40 Paesi industrializzati e quelli con economia in transizione a contenere le loro emissioni<br />
<strong>di</strong> gas serra entro limiti ben definiti.<br />
E’ entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e, al momento, è stato ratificato da 177 Paesi.<br />
Il Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC) ha documentato che esiste una<br />
«significativa» evidenza che l’atmosfera terrestre si stia riscaldando e che la causa principale <strong>di</strong> ciò<br />
sia l’effetto serra, ovvero la capacità <strong>di</strong> certi gas, quali l’anidride carbonica (CO2), l’ossido <strong>di</strong><br />
azoto (N2O), il metano (CH4) e altri gas d’origine industriale <strong>di</strong> intrappolare il calore solare ed<br />
evitare che questo si allontani dall’atmosfera. Secondo l’IPCC, l’accumulo <strong>di</strong> gas serra<br />
nell’atmosfera ha prodotto, nel corso del ventesimo secolo, un riscaldamento della temperatura<br />
me<strong>di</strong>a globale <strong>di</strong> circa 0,6°C.<br />
Per il futuro, gli scenari prospettati dagli scienziati sono ancora meno rassicuranti. Il pianeta sta<br />
attualmente assorbendo un’energia dal sole in eccesso rispetto a quella che è ri-emessa nello spazio<br />
(Hansen et al., 2005; Hansen et al., 2008). Anche se il livello della concentrazione dei gas serra si<br />
stabilizzasse al livello dell’anno 2000, comunque si verificherà un riscaldamento globale (<strong>di</strong> circa<br />
0,1 °C ogni <strong>di</strong>eci anni) e un innalzamento del livello dei mari (tra 0,2 – 0,6 m, entro la fine del<br />
secolo). Se invece la concentrazione in atmosfera dovessero continuare a crescere al ritmo attuale,<br />
allora la temperatura me<strong>di</strong>a globale potrà salire da 0,2 °C fino 0,4 °C ogni <strong>di</strong>eci anni.<br />
Sulla base <strong>di</strong> queste evidenze <strong>di</strong>versi Paesi si sono impegnati a tagliare le loro emissioni<br />
complessive <strong>di</strong> sei gas serra del 5,2% rispetto a quelle registrate nel 1990, entro il periodo 2008-<br />
2012. I sei gas serra sono la CO2, il metano (CH4), il protossido <strong>di</strong> azoto (N2O), gli<br />
idrofluorocarburi (HFC); i perfluorocarburi (PFC); l'esafluoruro <strong>di</strong> zolfo (SF6).<br />
Le misure per raggiungere gli impegni <strong>di</strong> riduzione delle emissioni riguardano in primis il<br />
miglioramento dell'efficienza energetica in settori rilevanti dell'economia nazionale; lo sviluppo e<br />
maggiore utilizzazione <strong>di</strong> energia rinnovabile; l'adozione <strong>di</strong> misure per limitare le emissioni <strong>di</strong> gas<br />
ad effetto serra nel settore dei trasporti, la limitazione e/o la riduzione delle emissioni <strong>di</strong> metano<br />
attraverso il recupero e utilizzazione del gas nel settore della gestione dei rifiuti, nonché nella<br />
produzione, il trasporto e la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia.<br />
3.2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO<br />
3.2.1 Direttiva 2001/77/CE<br />
Nel 2001 la Comunità Europea considera che occorre promuovere la produzione <strong>di</strong> elettricità da<br />
fonti energetiche rinnovabili, sia per conformarsi a quanto previsto dal Protocollo <strong>di</strong> Kyoto per la<br />
riduzione dei gas serra, che per motivi <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong>versificazione dell'approvvigionamento<br />
energetico, per la protezione dell'ambiente e per la coesione economica e sociale della Comunità<br />
stessa. Per questo emana la <strong>di</strong>rettiva in calce con la quale ogni Paese facente parte della CE,<br />
applicando apposite misure incentivanti, è chiamato ad aumentare l’apporto percentuale <strong>di</strong> FER<br />
Agritre Pag. 4<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
(Fonti <strong>di</strong> Energia Rinnovabile) sul consumo <strong>di</strong> elettricità totale per raggiungere nel 2010 gli obiettivi<br />
stabiliti.<br />
L’obiettivo globale in<strong>di</strong>cativo è raggiungere il 12% del consumo interno lordo <strong>di</strong> energia con una<br />
quota del 22,1% <strong>di</strong> elettricità prodotta da FER sul consumo totale <strong>di</strong> elettricità.<br />
Gli Stati membri hanno l’obbligo <strong>di</strong> adeguare <strong>di</strong> conseguenza la loro normativa entro il 27/10/2003.<br />
All’Italia viene in<strong>di</strong>cato l’obiettivo del 25% <strong>di</strong> energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili rispetto<br />
al 16% prodotta sul totale nel 1997.<br />
3.2.2 Direttiva 2009/28/CE<br />
L’ultima Direttiva, emanata nell’aprile del 2009, aggiorna le precedenti <strong>di</strong>rettive 2001/77/CE e<br />
2003/30/CE, e pone alla Unione Europea l’obiettivo <strong>di</strong> raggiungere, entro il 2020, il 20% della quota<br />
<strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo <strong>di</strong> energia della Comunità e il 10% della<br />
quota <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili sul consumo <strong>di</strong> energia per autotrazione.<br />
3.3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE<br />
3.3.1 Il Piano <strong>di</strong> Azione Nazionale per le energie rinnovabili (P.A.N.)<br />
Emanato nel giugno del 2010 in ottemperanza alla Direttiva 2009/28/CE, ripropone l’obiettivo<br />
previsto da questa per l’Italia.<br />
In esso viene in<strong>di</strong>cato che la quota <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili, sul consumo finale <strong>di</strong> energia,<br />
deve passare dal 5,2% del 2005 al 17% nel 2020. Per la specifica quota <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> elettricità,<br />
l’obiettivo è <strong>di</strong> produrre da FER circa il 29% del consumo totale.<br />
L’Italia ha delineato nel PAN i seguenti obiettivi strategici:<br />
• sicurezza dell’approvvigionamento energetico,<br />
• riduzione dei costi dell’energia per le imprese e i citta<strong>di</strong>ni,<br />
• promozione <strong>di</strong> filiere tecnologiche innovative,<br />
• tutela ambientale (riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti),<br />
La valorizzazione energetica delle <strong>biomasse</strong> è, altresì, uno dei punti <strong>di</strong> riferimento della strategia<br />
nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, in particolare <strong>di</strong> anidride carbonica,<br />
nell’ambito degli impegni internazionali.<br />
Le azioni intraprese dalla nostra Nazione per implementare il contributo delle Fonti <strong>di</strong> Energia<br />
Rinnovabile (FER) sono state <strong>di</strong>verse: dal D. Lgs. 79/1999 (Decreto Bersani) che ha introdotto<br />
l’obbligo <strong>di</strong> immissione <strong>di</strong> quote da Fonti Rinnovabili nella produzione elettrica complessiva, al D.<br />
Lgs. 387/2003, nel quale sono ripresi gli obiettivi fissati in sede europea nel 2001 e si decreta<br />
l’incremento annuale che devono avere le FER sulla produzione elettrica totale nei trienni 2004-<br />
2006, 2007-2009, 2010–2012, nonché la semplificazione delle procedure amministrative, fino alla<br />
L. 99/2009 che ha previsto il varo <strong>di</strong> un Piano straor<strong>di</strong>nario per l’efficienza e il risparmio energetico.<br />
Le leggi finanziarie del 2007 (L. 296/2006) e del 2008 (L. 244/2007) con relativo Collegato (L.<br />
222/07) hanno voluto <strong>di</strong>fferenziare l’incentivazione tra le varie FER.<br />
Agritre Pag. 5<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
La produzione <strong>di</strong> energia elettrica effettuata da impianti <strong>di</strong> potenza superiore ad 1 MW è incentivata<br />
dal rilascio <strong>di</strong> 1,8 Certificati Ver<strong>di</strong> ogni MWh prodotto <strong>di</strong> energia elettrica.<br />
Questo però solo se vengono utilizzate <strong>biomasse</strong> <strong>vegetali</strong> agro-forestali provenienti da Filiera Corta<br />
(massimo 70 km dall’<strong>impianto</strong> o tramite intese <strong>di</strong> filiera raggiunte nell’ambito del DLgs 102/2005),<br />
garantite da un sistema <strong>di</strong> tracciabilità e <strong>di</strong> rintracciabilità normato dal recente decreto 2 marzo<br />
2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010.<br />
Questo particolare incentivo, maggiore rispetto alle altre FER, è stato appositamente previsto dal<br />
legislatore al fine <strong>di</strong> implementare l’uso, nell’<strong>impianto</strong>, <strong>di</strong> <strong>biomasse</strong> <strong>di</strong> provenienza locale ancorché<br />
<strong>di</strong> costo più elevato rispetto a quelle <strong>di</strong> provenienza estera.<br />
3.3.2 Il quadro <strong>di</strong> riferimento regionale<br />
3.3.2.1 Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)<br />
Con Delibera <strong>di</strong> Giunta Regionale n. 827 dell’8 giugno 2007, la Regione Puglia ha adottato il<br />
P.E.A.R. (Piano Energetico Ambientale Regionale), strumento programmatico necessario al<br />
miglioramento della qualità della proposta energetica regionale.<br />
Esso analizza il sistema energetico attuale, stu<strong>di</strong>a la probabile evoluzione a me<strong>di</strong>o e lungo termine e<br />
definisce le linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo che l’ente intende dare al suo territorio sia per quel che riguarda la<br />
domanda che per quel che riguarda l’offerta, ponendosi degli obiettivi e dotandosi degli strumenti<br />
necessari.<br />
In questo contesto e nell’ambito <strong>di</strong> uno sviluppo energetico ambientale sostenibile, emerge il settore<br />
delle fonti rinnovabili.<br />
Il PEAR si pone come obiettivo <strong>di</strong> arrivare nel 2020 ad una produzione <strong>di</strong> energia elettrica da fonte<br />
rinnovabile del 18% rispetto al 3% riscontrato sul totale nel 2004.<br />
Questo dovrebbe avvenire incrementando la produzione del 40% ma al tempo stesso riducendo le<br />
emissioni <strong>di</strong> CO2 del 9%.<br />
Se l’energia da fonte rinnovabile, fino agli inizi degli anni 90, era rappresentata essenzialmente da<br />
legna da ardere, da allora fino ad oggi si è sviluppata nel contesto regionale soprattutto con l’eolico<br />
e, più recentemente, con il fotovoltaico.<br />
Nonostante la preminente vocazione agricola del territorio e le <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> materia prima, il<br />
capitolo delle rinnovabili rappresentato dalla biomassa vegetale, rimane “in<strong>di</strong>etro” con una potenza<br />
installata <strong>di</strong> gran lunga inferiore alle potenzialità regionali e a questo proposito il Pear così si<br />
esprime:<br />
“rappresentano, per la regione Puglia, una delle opzioni più concrete in termini <strong>di</strong> potenziale<br />
energetico e <strong>di</strong> sviluppo tecnologico. In aggiunta, potrebbero contribuire fattivamente al rilancio<br />
delle attività agricole, forestali e zootecniche che nella regione rappresentano un importante tassello<br />
dell’economia locale ed elemento prioritario <strong>di</strong> conservazione del territorio. Questa importante fonte<br />
rinnovabile si presta anche per favorire la <strong>di</strong>versificazione produttiva <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> soggetti<br />
impren<strong>di</strong>toriali e per conseguire finalità <strong>di</strong> stretto carattere ambientale.”<br />
Agritre Pag. 6<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
4 IL CONTESTO NORMATIVO<br />
4.1 IL CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE<br />
A livello nazionale il quadro normativo <strong>di</strong> riferimento è rappresentato dal:<br />
Decreto Legislativo 29 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 387 "Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2001/77/CE relativa alla<br />
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno<br />
dell'elettricità", finalizzato a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili<br />
alla produzione <strong>di</strong> elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario, introducendo misure<br />
nazionali per promuovere l'aumento del consumo <strong>di</strong> elettricità da fonti rinnovabili, tra cui<br />
l’incremento della quota minima <strong>di</strong> cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,<br />
la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative e l’istituzione dell'Osservatorio<br />
nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia;<br />
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee Guida per<br />
l’autorizzazione degli impianti da fonti alimentati da fonti rinnovabili”, le quali costituiscono una<br />
<strong>di</strong>sciplina unica, valida su tutto il territorio nazionale, per il proce<strong>di</strong>mento autorizzativo degli<br />
impianti alimentati da fonti rinnovabili, <strong>di</strong>fferenziato per tipologia <strong>di</strong> <strong>impianto</strong> e per taglia <strong>di</strong><br />
potenza. Tali linee guida hanno, tra l’altro, la finalità <strong>di</strong> assicurare un corretto inserimento degli<br />
impianti nel paesaggio, con particolare attenzione per gli impianti eolici;<br />
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”e, precisamente, dalla<br />
Parte Seconda del decreto, relativamente alle procedure per la valutazione d'impatto ambientale<br />
(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). La valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale ha<br />
la finalità <strong>di</strong> assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le con<strong>di</strong>zioni per uno sviluppo<br />
sostenibile, e quin<strong>di</strong> nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della<br />
salvaguar<strong>di</strong>a della bio<strong>di</strong>versità e <strong>di</strong> un'equa <strong>di</strong>stribuzione dei vantaggi connessi all'attività<br />
economica. L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto, invece, la prevenzione e la<br />
riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da determinate categorie <strong>di</strong> attività industriali e<br />
prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel<br />
suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato <strong>di</strong> protezione<br />
dell'ambiente, salve le <strong>di</strong>sposizioni sulla valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale.<br />
4.2 IL CONTESTO NORMATIVO REGIONALE<br />
A livello regionale il quadro normativo <strong>di</strong> riferimento è rappresentato dal :<br />
Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e<br />
ss.mm.ii, che <strong>di</strong>sciplina le procedure a livello regionale, con lo scopo <strong>di</strong> assicurare che nei processi<br />
decisionali relativi a piani, programmi <strong>di</strong> intervento e progetti <strong>di</strong> opere o <strong>di</strong> interventi, <strong>di</strong> iniziativa<br />
pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il<br />
mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguar<strong>di</strong>a della<br />
molteplicità delle specie, l'impiego <strong>di</strong> risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse;<br />
Legge Regionale 14 Giugno 2007, n. 17 – “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al<br />
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, con la quale la Regione ha<br />
delegato l’istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla provincia competente<br />
per territorio, a decorrere dal 1° luglio 2007.<br />
Regolamento Regionale 14 luglio 2008, n. 12 per la realizzazione degli impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong><br />
energia alimentata a <strong>biomasse</strong>, finalizzato favorire lo sviluppo <strong>di</strong> impianti alimentati da <strong>biomasse</strong> in<br />
Agritre Pag. 7<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
particolare <strong>di</strong> origine agricola e forestale prodotte localmente, definendo criteri per la localizzazione<br />
<strong>di</strong> impianti alimentati a biomassa, ivi compresa la coerenza del piano <strong>di</strong> approvvigionamento<br />
rispetto alla scelta localizzativa ed alle risorse locali effettivamente <strong>di</strong>sponibili;<br />
Regolamento Regionale 30 Dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero<br />
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti<br />
alimentati da fonti rinnovabili”, recante la in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> aree e siti non idonei alla installazione<br />
<strong>di</strong> specifiche tipologie <strong>di</strong> impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”,<br />
basata sulla ricognizione delle <strong>di</strong>sposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del<br />
patrimonio storico e artistico, delle tra<strong>di</strong>zioni agroalimentari locali, della bio<strong>di</strong>versità e del<br />
paesaggio rurale che identificano obiettivi <strong>di</strong> protezione non compatibili con l’inse<strong>di</strong>amento, in<br />
determinate aree, <strong>di</strong> specifiche tipologie e/o <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> impianti;<br />
Delibera <strong>di</strong> Giunta Regionale 30 <strong>di</strong>cembre 2010, n. 3029 “Approvazione della <strong>di</strong>sciplina del<br />
proce<strong>di</strong>mento unico <strong>di</strong> autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong><br />
energia elettrica”, atto che regolamenta il proce<strong>di</strong>mento autorizzativo regionale <strong>di</strong> impianti,<br />
alimentati da fonti rinnovabili, che generano elettricità.<br />
Determinazione del <strong>di</strong>rigente servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 3<br />
gennaio 2011, n. 1 con cui sono state approvate le “Istruzioni tecniche per la informatizzazione<br />
della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura<br />
Telematica”, ai sensi della <strong>di</strong>sciplina approvata con Delibera <strong>di</strong> Giunta Regionale n. 3029/2010;<br />
Agritre Pag. 8<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO<br />
Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le opere da realizzare nell’ambito del progetto con<br />
particolare riferimento ai criteri utilizzati per le scelte progettuali, agli aspetti dell'inserimento<br />
dell'intervento sul territorio, alle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti,<br />
nonché ai criteri <strong>di</strong> progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda<br />
la sicurezza, la funzionalità e l'economia <strong>di</strong> gestione.<br />
5.1 UBICAZIONE<br />
Il progetto prevede che l’<strong>impianto</strong> sorga in un’area lontana all’incirca 12 km dal centro abitato<br />
<strong>di</strong> Sant’Agata <strong>di</strong> Puglia, in località Viticone.<br />
L’area si presta particolarmente per questo tipo <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento industriale agroenergetico, sia per la<br />
prossimità <strong>di</strong> arterie stradali provinciali, regionali e statali, ai fini del traffico veicolare in entrata, sia<br />
per la vicinanza alla costruenda sotto stazione elettrica ad alta tensione TERNA in Comune <strong>di</strong><br />
Deliceto in<strong>di</strong>spensabile per la connessione.<br />
L’area non è sottoposta a vincoli <strong>di</strong> nessun tipo.<br />
Nel raggio circostante sono situate poche masserie abitate delle quali la più prossima all’area<br />
dell’<strong>impianto</strong> è <strong>di</strong>stante oltre 300 metri.<br />
Agritre Pag. 9<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
5.2 CRITERI PROGETTUALI<br />
L’<strong>impianto</strong> è costituito da una centrale termoelettrica a <strong>biomasse</strong> <strong>vegetali</strong> <strong>solide</strong> da 25 MWe (lordo<br />
– full electric). I componenti principali che costituiscono il cuore del sistema impiantistico sono<br />
costituiti dalla caldaia alimentata a <strong>biomasse</strong> della potenza <strong>di</strong> 80 MWt e da un turbogruppo da 31,5<br />
MVA.<br />
L’<strong>impianto</strong> ha le seguenti caratteristiche principali:<br />
• Combustibile: Biomasse <strong>vegetali</strong> <strong>solide</strong>;<br />
• Configurazione: produzione <strong>di</strong> energia elettrica;<br />
• Condensazione: condensatore ad aria;<br />
• Abbattimento degli NOx nei fumi me<strong>di</strong>ante sistema SNCR (Selective Non Catalitic Reduction),<br />
basato sull’iniezione <strong>di</strong> urea in caldaia;<br />
• Neutralizzazione <strong>di</strong> eventuali gas aci<strong>di</strong>, me<strong>di</strong>ante l’aggiunta <strong>di</strong> un reagente alcalino, come ad<br />
esempio la calce idrata – Ca (OH)2;<br />
• Abbattimento delle polveri me<strong>di</strong>ante filtro a maniche.<br />
Il progetto è coerente e rispettoso <strong>di</strong> tutti i parametri e le previsioni contenute nel Piano Energetico<br />
Ambientale della Regione Puglia e delle Leggi e dei Regolamenti emanati in materia.<br />
In particolare, l’<strong>impianto</strong> rientra nell’ambito delle previsioni <strong>di</strong> potenza installabile nella Regione<br />
per impianti a <strong>biomasse</strong>; è conforme a quanto previsto dalle norme regionali sulla localizzazione <strong>di</strong><br />
tali impianti; è alimentata totalmente con <strong>biomasse</strong> <strong>di</strong> filiera garantite da tracciabilità ed esclude<br />
l’utilizzo anche parziale <strong>di</strong> rifiuti o CDR (combustibile derivato da rifiuti).<br />
Il progetto dell’<strong>impianto</strong> utilizza le migliori tecnologie che costituiscono l’attuale stato dell’arte in<br />
materia seguendo i principi ispiratori delle BAT (Best Available Techniques). L'uso delle BAT<br />
consente <strong>di</strong> ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente, riducendo nel contempo i consumi<br />
energetici e migliorando la produttività e/o la qualità della produzione.<br />
Con il termine BAT si intende:<br />
• per tecniche, sia le tecniche impiegate sia le modalità <strong>di</strong> progettazione, costruzione,<br />
manutenzione, esercizio e chiusura dell’<strong>impianto</strong>;<br />
• per <strong>di</strong>sponibili, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in con<strong>di</strong>zioni<br />
economicamente e tecnicamente valide, nell’ambito del pertinente comparto industriale,<br />
prendendo in considerazione i costi e i vantaggi. Questo in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che siano o<br />
no applicate o prodotte nello Stato membro <strong>di</strong> cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso<br />
a con<strong>di</strong>zioni ragionevoli; migliori, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello <strong>di</strong><br />
protezione dell’ambiente nel suo complesso.<br />
La BAT comprende procedure, tecniche, tecnologie ed altri aspetti quali manutenzione, standard<br />
operativi e verifiche <strong>di</strong> consumi energetici e <strong>di</strong> efficienza. La BAT riguarda tutti gli aspetti del<br />
funzionamento <strong>di</strong> un <strong>impianto</strong> o <strong>di</strong> un’industria che influenzano l’ambiente. In quest’ottica,<br />
l’inquinamento comprende le sostanze tra<strong>di</strong>zionali e il calore, il rumore e le vibrazioni, nonché il<br />
consumo delle risorse: acqua, materie prime ed energia.<br />
La scelte tecnologiche effettuate per l’<strong>impianto</strong>, sono in accordo ai principi ispiratori delle BAT.<br />
Agritre Pag. 10<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Infatti, al fine <strong>di</strong> minimizzare le emissioni in atmosfera e garantire in questo modo valori molto al <strong>di</strong><br />
sotto dei limiti <strong>di</strong> legge per tutte le sostanze, sono state previste le migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili<br />
allo stato dell’arte. In particolare, per rispondere ai limiti dell’attuale normativa sulle emissioni <strong>di</strong><br />
CO, sono stati previsti particolari accorgimenti relativi alla sezione <strong>di</strong> combustione della caldaia e<br />
alla configurazione <strong>di</strong> <strong>impianto</strong>. Questo, consente <strong>di</strong> ottenere comunque elevati standard <strong>di</strong><br />
efficienza sod<strong>di</strong>sfacendo allo stesso tempo i più stretti requisiti d’impatto ambientale.<br />
Il progetto ottimizza i consumi <strong>di</strong> acqua grazie al sistema <strong>di</strong> raffreddamento ad aria: il contenimento<br />
dell’utilizzo delle risorse idriche è infatti una delle linee guida che hanno spinto alla scelta <strong>di</strong> questa<br />
soluzione impiantistica. Un ulteriore vantaggio derivante da questa scelta deriva dall’assenza delle<br />
vistose nubi <strong>di</strong> vapor d’acqua caratteristiche dei condensatori ad acqua. Viene inoltre previsto un<br />
parziale recupero delle acque utilizzate nei processi e successivamente raccolte e opportunamente<br />
trattate, in modo da garantire un’ ulteriore ottimizzazione dei consumi idrici.<br />
Il progetto garantisce che le emissione rumorose saranno opportunamente contenute grazie<br />
all’utilizzo <strong>di</strong> macchinari progettati e realizzati per garantire livelli <strong>di</strong> rumore compatibili con le<br />
attuali normative. Sono inoltre previsti tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle<br />
emissioni <strong>di</strong> rumore, quali griglie afoniche, tamponature opportunamente progettate con funzione <strong>di</strong><br />
insonorizzazione, sistemi cabinati insonorizzati per i componenti che lo consentono.<br />
Nella scelta dei materiali per i componenti, le tubazioni, i collettori e nella determinazione delle<br />
temperature e delle pressioni <strong>di</strong> progetto sono prese in considerazione tutte le con<strong>di</strong>zioni critiche più<br />
gravose, in modo che siano garantite con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza e le prestazioni necessarie al corretto<br />
funzionamento. In tutti i casi la scelta dei materiali e i calcoli per determinare le caratteristiche<br />
principali dei materiali, sono effettuati in considerazione della più alta temperatura e pressione<br />
possibile compresi i margini <strong>di</strong> sicurezza in conformità ai requisiti <strong>di</strong> legge e gli standard applicabili.<br />
Particolare attenzione è stata posta nell’in<strong>di</strong>viduare soluzioni progettuali in<strong>di</strong>rizzate ad una gestione<br />
integrata <strong>di</strong> tutti i sottosistemi impiantistici, con l’obiettivo <strong>di</strong> ottimizzare il monitoraggio dei<br />
processi da remoto, favorire l’efficienza operativa e agevolare le operazioni <strong>di</strong> manutenzione.<br />
L’<strong>impianto</strong> prevede quin<strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> automazione e controllo che consente la conduzione<br />
automatizzata della centrale e la protezione delle sue apparecchiature qualora si dovessero verificare<br />
con<strong>di</strong>zioni anomale <strong>di</strong> esercizio. Il sistema <strong>di</strong> automazione integrerà molteplici funzioni inclusa la<br />
supervisione e controllo delle apparecchiature in campo, la gestione degli allarmi, l’ottimizzazione<br />
dei processi e la raccolta ed archiviazione delle informazioni. Il sistema permetterà sia la gestione<br />
tecnico-operativa delle infrastrutture impiantistiche, sia la gestione della sicurezza e dovrà quin<strong>di</strong><br />
essere in grado <strong>di</strong> svolgere molteplici funzioni tra cui:<br />
• Acquisizione dati (misure, stati <strong>di</strong> funzionamento ed allarmi) relativi agli elementi impiantistici;<br />
• Generazione <strong>di</strong> coman<strong>di</strong> verso gli organi <strong>di</strong> attuazione, con modalità automatica o manuale,<br />
secondo la logica programmata.<br />
• Controllo dei valori acquisiti in riferimento ai valori limite configurati e generazione automatica<br />
delle segnalazioni per le misure “non validate” (allarmi software).<br />
• Elaborazione degli allarmi tecnici, sud<strong>di</strong>visi per livelli <strong>di</strong> priorità e classi <strong>di</strong> appartenenza.<br />
• Controllo della integrità e della funzionalità del sistema, con propria auto<strong>di</strong>agnostica.<br />
L’architettura del sistema utilizzerà protocolli evoluti e specificatamente progettati per le funzioni<br />
specifiche <strong>di</strong> ogni livello funzionale in modo da garantire la massima flessibilità e apertura, totale<br />
interoperabilità dei sottosistemi, massima espansibilità attraverso una struttura modulare e massimo<br />
uso delle tecnologie <strong>di</strong> comunicazione dell’ Information Technology. In questo modo sarà possibile<br />
Agritre Pag. 11<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
attuare tutte le strategie <strong>di</strong> risparmio energetico e <strong>di</strong> ottimizzazione che consentono il contenimento<br />
dei costi <strong>di</strong> manutenzione e dei tempi <strong>di</strong> intervento.<br />
L’<strong>impianto</strong> sarà realizzato e gestito in modo da garantire la massima <strong>di</strong>sponibilità e sicurezza <strong>di</strong><br />
esercizio. A tal fine sono stati adottati abbondanti margini <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensionamento, opportune<br />
ridondanze e soluzioni tecniche atte ad evitare e prevenire ogni criticità <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> blocchi e<br />
protezioni.<br />
L’<strong>impianto</strong> è basato su un progetto intrinsecamente sicuro: in caso <strong>di</strong> malfunzionamenti operativi<br />
non ci saranno pericoli per gli operatori, la popolazione e per l’ambiente circostante.<br />
In con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> emergenza, sono state prese adeguate misure <strong>di</strong> protezione tali da portare l’<strong>impianto</strong><br />
in con<strong>di</strong>zioni operative sicure in modo automatico.<br />
In caso <strong>di</strong> avaria <strong>di</strong> unità operative ausiliarie, la loro sostituzione avverrà in tempi rapi<strong>di</strong> senza<br />
compromettere l’esercizio dell’<strong>impianto</strong>:in ogni caso l’<strong>impianto</strong> è dotato <strong>di</strong> una adeguata scorta <strong>di</strong><br />
parti <strong>di</strong> ricambio.<br />
L’<strong>impianto</strong> può essere condotto per produrre solo energia elettrica (conduzione full electric) o per<br />
produrre energia elettrica ed energia termica (conduzione cogenerativa).<br />
Al fine <strong>di</strong> rendere minimo l’impatto visivo delle varie strutture del progetto e perseguire la migliore<br />
integrazione dell’intero <strong>impianto</strong> nel paesaggio è necessario adottare delle misure che mitighino<br />
l’impatto sul territorio. Le prescrizioni progettuali adottate, sono <strong>di</strong> seguito descritte:<br />
• I colori delle facciate esterne dei fabbricati, compresi quelli destinati ad ospitare gli impianti,<br />
dovranno essere tenui e scelti tra le tipiche tonalità in uso per l’e<strong>di</strong>lizia rurale tra<strong>di</strong>zionale, al fine<br />
<strong>di</strong> ridurne la visibilità<br />
• sistemazione con piantumazioni nell’area perimetrale dell’<strong>impianto</strong> con essenze arbustive<br />
autoctone al fine <strong>di</strong> attenuare il più possibile la <strong>di</strong>scontinuità tra opere tecnologiche ed ambiente<br />
circostante;<br />
• le <strong>di</strong>rettrici dei cavidotti, interni ed esterni all’<strong>impianto</strong>, seguiranno i percorsi delle vie <strong>di</strong><br />
circolazione, al fine <strong>di</strong> ridurre gli scavi per la loro messa in opera;<br />
• massimizzazione delle <strong>di</strong>stanze dell’<strong>impianto</strong> da unità abitative regolarmente censite e<br />
stabilmente abitate;<br />
• minimizzazione dei i tempi <strong>di</strong> costruzione;<br />
• ripristino dello stato dei luoghi dopo la <strong>di</strong>smissione dell'<strong>impianto</strong> o destinazione del suolo alla<br />
rinaturalizzazione con specie autoctone scelte in base alle peculiarità dell'area; la vegetazione<br />
presente, dunque, va mantenuta o quantomeno rimpiazzata a fine ciclo;<br />
Per ridurre l’impatto sul paesaggio della caldaia, che costituisce il componente più consistente dal<br />
punto <strong>di</strong> vista dell’ingombro visivo, è stata prevista una boiler house costituita da una copertura e da<br />
un sistema <strong>di</strong> alettature inclinate fissate sulle facciate verticali in grado <strong>di</strong> nascondere il corpo<br />
caldaia consentendo allo stesso tempo la corretta ventilazione e <strong>di</strong>ssipazione del calore.<br />
La sempre crescente sensibilità per le problematiche <strong>di</strong> risparmio energetico e <strong>di</strong> sostenibilità<br />
ambientale in ambito e<strong>di</strong>lizio, ha imposto anche una particolare attenzione nell’in<strong>di</strong>viduare soluzioni<br />
progettuali che privilegino il contenimento dei consumi energetici degli e<strong>di</strong>fici climatizzati. Pertanto<br />
sono previste soluzioni impiantistiche e architettoniche in accordo alla recente normativa in materia<br />
<strong>di</strong> risparmio energetico (D.Lgs.311/06). In questa ottica l’ integrazione architettonico-impiantistica è<br />
realizzata scegliendo gli elementi <strong>di</strong>sperdenti principali quali infissi e tamponamenti perimetrali, in<br />
Agritre Pag. 12<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
modo da coniugare la contestualizzazione dell’immagine complessiva degli e<strong>di</strong>fici e la <strong>di</strong>minuzione<br />
delle <strong>di</strong>spersioni termiche.<br />
Particolare cura è stata posta nella definizione della planimetria, alla ricerca della semplicità <strong>di</strong><br />
movimento degli operatori e <strong>di</strong> accesso alle aree funzionali, che si ritiene premessa in<strong>di</strong>spensabile<br />
per la sicurezza. Sono stati mantenuti gli spazi necessari a consentire le operazioni <strong>di</strong> manutenzione<br />
ed esercizio in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> massima sicurezza ed è stato stu<strong>di</strong>ato il layout in modo da favorire<br />
l’accesso a tutte le aree <strong>di</strong> <strong>impianto</strong> in modo semplice e funzionale.<br />
L’uso <strong>di</strong> tecnologie consolidate e <strong>di</strong> schemi funzionali ampiamente sperimentati consente l’utilizzo<br />
<strong>di</strong> superfici ridotte e l’ottimizzazione <strong>di</strong> strutture e funzioni <strong>di</strong> controllo in comune a più aree<br />
funzionali.<br />
L’<strong>impianto</strong> è sud<strong>di</strong>viso nelle seguenti sezioni principali:<br />
sezione stoccaggio e movimentazione della biomassa<br />
• ricevimento, stoccaggio e movimentazione del combustibile;<br />
• caricamento del combustibile alla sezione <strong>di</strong> combustione;<br />
Agritre Pag. 13<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
sistema <strong>di</strong> generazione vapore<br />
• sistema <strong>di</strong> combustione e generazione vapore;<br />
• sistema <strong>di</strong> rimozione ceneri;<br />
sistema <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia elettrica<br />
• turbogeneratore;<br />
• sistema by-pass turbina;<br />
ciclo vapore<br />
• sistema <strong>di</strong> condensazione ad aria;<br />
• degasatore<br />
sezione trattamento e evacuazione fumi<br />
• sistema <strong>di</strong> depurazione ed evacuazione fumi e sistemi ausiliari per il controllo delle emissioni;<br />
• sistema <strong>di</strong> analisi fumi;<br />
• camino per lo scarico dei fumi <strong>di</strong> combustione;<br />
apparecchiature e strumentazioni elettriche<br />
• sottostazione elettrica a 150 KV per il collegamento con la rete;<br />
• cavidotto a 30 kV per il collegamento tra il sito e la sottostazione;<br />
• sistema elettrico <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione me<strong>di</strong>a e bassa tensione con relativi quadri e trasformatori<br />
elettrici ;<br />
• sistemi <strong>di</strong> regolazione, supervisione e controllo;<br />
sistemi ausiliari <strong>di</strong> centrale<br />
• <strong>impianto</strong> <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong>stribuzione acqua demineralizzata;<br />
• impianti <strong>di</strong> iniezione ad<strong>di</strong>tivi chimici e campionamento chimico acqua <strong>di</strong> caldaia;<br />
• <strong>impianto</strong> i produzione e <strong>di</strong>stribuzione aria compressa;<br />
• <strong>impianto</strong> antincen<strong>di</strong>o (rivelazione e spegnimento);<br />
• <strong>impianto</strong> HVAC;<br />
• <strong>impianto</strong> adduzione, trattamento acque e rete <strong>di</strong> scarico acque reflue;<br />
opere civili e infrastrutture <strong>di</strong> <strong>impianto</strong><br />
• strade, piazzali, recinzioni, opere a verde;<br />
• fondazioni e opere <strong>di</strong> supporto agli impianti principali;<br />
• e<strong>di</strong>fici;<br />
Di seguito si fornisce una descrizione delle opere previste nel progetto<br />
Agritre Pag. 14<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
5.2.1 Sezione stoccaggio e movimentazione della biomassa<br />
La particolarità <strong>di</strong> queste tipologie <strong>di</strong> biomassa (paglia e potature) è che esse vengono prodotte in<br />
determinati brevi perio<strong>di</strong> dell’anno. La paglia <strong>di</strong> grano viene imballata nei mesi estivi successivi alla<br />
mietitura e, grazie alla sua ridotta umi<strong>di</strong>tà, può essere stoccata in cumuli (stoccaggi) <strong>di</strong>ffusi sul<br />
territorio, che alimenteranno in maniera programmata il magazzino dell’<strong>impianto</strong> mantenendo una<br />
<strong>di</strong>sponibilità costante e continua del materiale.<br />
Le potature <strong>di</strong> oliveti e vigneti dovranno essere invece sminuzzate per favorire il trasporto e smaltite<br />
in maniera più veloce rispetto alla paglia a causa della umi<strong>di</strong>tà più elevata che potrebbe favorire una<br />
degradazione del materiale.<br />
Nell’area dell’<strong>impianto</strong> verrà organizzata l’area <strong>di</strong> ricevimento e pesatura e verranno pre<strong>di</strong>sposti i<br />
depositi all’aperto per le balle <strong>di</strong> paglia e per il cippato <strong>di</strong> legno, equipaggiati con gru e pale<br />
semoventi.<br />
Il materiale sarà convogliato in sezioni <strong>di</strong>verse per la preparazione e la successiva introduzione in<br />
caldaia attraverso due <strong>di</strong>verse linee <strong>di</strong> alimentazione.<br />
5.2.1.1 Movimentazione paglia<br />
Tutta la sezione destinata alla ricezione della biomassa ed alla sua successiva movimentazione verso<br />
la sezione <strong>di</strong> combustione sarà costruita con standard <strong>di</strong> qualità, specie per quanto riguarda la<br />
<strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> polveri.<br />
La paglia verrà stoccata in un’area dell’e<strong>di</strong>ficio pari a 930 m 2 circa, per un’altezza netta complessiva<br />
<strong>di</strong> 4 metri. Il sistema <strong>di</strong> caricamento dei nastri trasportatori che alimentano la caldaia avverrà per<br />
mezzo <strong>di</strong> 2 carroponti che attraversano tutta la campata principale dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />
5.2.1.2 Movimentazione cippato<br />
Il deposito è costituito in senso longitu<strong>di</strong>nale da quattro corsie, le cui <strong>di</strong>mensioni sono circa 11 m <strong>di</strong><br />
lunghezza, 4 m <strong>di</strong> larghezza ed altezza utile <strong>di</strong> stoccaggio pari a 8 m.<br />
Questo stoccaggio assume un significato rilevante nella gestione dell’<strong>impianto</strong>: una tale autonomia<br />
permette <strong>di</strong> gestire con una certa flessibilità la sezione <strong>di</strong> cippatura ed il ricevimento della biomassa<br />
dall’esterno, con particolare riferimento alla programmazione delle manutenzioni e alla gestione <strong>di</strong><br />
particolari emergenze.<br />
All’interno del deposito <strong>di</strong> cippato, l’accumulo della biomassa lungo tutta la lunghezza delle corsie<br />
viene ottenuta con un raschiatore (o rastrello) che con movimenti <strong>di</strong> traslazione orizzontale e<br />
verticale <strong>di</strong>stribuisce la biomassa lungo la singola corsia. Questo stesso convogliatore permette<br />
anche lo scarico del cippato dal lato corto <strong>di</strong> ogni corsia, opposto a quello <strong>di</strong> alimentazione. Un<br />
sistema a fotocellule, nella parte finale delle corsie, verifica lo stato <strong>di</strong> riempimento ed influenza la<br />
logica <strong>di</strong> gestione delle fasi <strong>di</strong> carico e scarico del deposito.<br />
Lungo il fronte <strong>di</strong> scarico delle tre corsie, è presente un trasportatore a catena interrato che raccoglie<br />
tutto il cippato estratto dal deposito e lo convoglia ai nastri trasportatori che alimentano la caldaia.<br />
Agritre Pag. 15<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
5.2.1.3 Caricamento biomassa<br />
L’area <strong>di</strong> caricamento mette in contatto la sezione <strong>di</strong> stoccaggio con quella <strong>di</strong> combustione e serve<br />
essenzialmente a convogliare il combustibile in caldaia. Tramite le <strong>di</strong>verse linee <strong>di</strong> carico controllate<br />
dal sistema informatico si convoglieranno i balloni prismatici <strong>di</strong> paglia e il cippato <strong>di</strong> legna<br />
provenienti dai rispettivi stoccaggi.<br />
Le linee <strong>di</strong> carco saranno costituite da nastri trasportatori in grado <strong>di</strong> movimentare la biomassa dallo<br />
stoccaggio relativo alla sezione <strong>di</strong> caricamento.<br />
5.2.2 Sezione generazione vapore<br />
5.2.2.1 Sistema <strong>di</strong> combustione e generazione vapore<br />
Il generatore <strong>di</strong> vapore per la produzione <strong>di</strong> vapore surriscaldato ad elevata entalpia è costituito da<br />
una caldaia ad un solo corpo cilindrico superiore, progettata con tre passaggi. Il primo passo è la<br />
camera <strong>di</strong> combustione. Il secondo passo è il surriscaldatore. Il terzo passo contiene i restanti fasci<br />
tubieri dell'economizzatore.<br />
La tecnologia è del tipo a griglia mobile, così definita perché appunto i processi <strong>di</strong> combustione<br />
avvengono al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> una griglia <strong>di</strong> metallo. La combustione delle particelle più pesanti avverrà<br />
sulla griglia, mentre le particelle più leggere bruceranno in sospensione.<br />
L’aria primaria immessa attraverso la griglia la raffredda e garantisce la combustione sulla griglia,<br />
l’aria secondaria immessa con eiettori in camera <strong>di</strong> combustione garantisce la turbolenza e la<br />
miscelazione dell’ossigeno e dei composti volatili.<br />
L'<strong>impianto</strong> sarà progettato per avere le seguenti caratteristiche:<br />
• Bassi valori <strong>di</strong> emissione;<br />
• Massima affidabilità;<br />
• Lunghi perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> esercizio prima <strong>di</strong> ogni fermata per manutenzione;<br />
• Grande flessibilità sull'uso <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> combustibile;<br />
La camera <strong>di</strong> combustione avrà due <strong>di</strong>versi sistemi <strong>di</strong> combustione:<br />
• Griglia mobile per <strong>biomasse</strong><br />
(Max.80 MW)<br />
• Bruciatori a metano- per start-up (2 x 15 MW)<br />
La potenzialità massima con combustibile solido sarà <strong>di</strong> 80 MW.<br />
La zona ad irraggiamento è posizionata <strong>di</strong>rettamente sopra il forno contenente la griglia; il passaggio<br />
dei fumi è verticale <strong>di</strong>scendente per l’immissione nella sezione convettiva.<br />
La sezione <strong>di</strong> combustione è costituita da un forno a griglia mobile raffreddata ad aria in grado <strong>di</strong><br />
garantire il funzionamento continuo in automatico ed un’elevata efficienza <strong>di</strong> combustione, anche in<br />
presenza <strong>di</strong> caratteristiche del combustibile variabili. Il raffreddamento ad aria della griglia è<br />
funzione dei bassi carichi termici dovuti dal P.C.I. del combustibile e dall’elevata semplicità <strong>di</strong><br />
realizzazione e affidabilità <strong>di</strong> esercizio.<br />
L’alimentazione della griglia <strong>di</strong> combustione avviene dalla tramoggia <strong>di</strong> carico, dalla quale si<br />
<strong>di</strong>parte il canale <strong>di</strong> adduzione equipaggiato nella sezione <strong>di</strong> uscita da spintori idraulici.<br />
Agritre Pag. 16<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Il movimento dei barrotti <strong>di</strong> griglia, gestito in automatico oppure con una sequenza pre<strong>di</strong>sposta dalla<br />
Sala Controllo, consente quin<strong>di</strong> al combustibile <strong>di</strong> procedere lungo le sezioni <strong>di</strong> essicazione,<br />
combustione e scarico ceneri, per essere poi espulso, come ceneri alle tramoggie <strong>di</strong> scarico al<br />
collettore / trasportatore ceneri, in bagno d’acqua (guar<strong>di</strong>a idraulica).<br />
A valle del combustore a griglia è prevista una camera <strong>di</strong> combustione costituita da tubi lisci uniti<br />
tra loro me<strong>di</strong>ante interposta aletta saldata longitu<strong>di</strong>nalmente in modo da ottenere una struttura<br />
membranata costituente una camera a tenuta. L’isolamento refrattario <strong>di</strong> questa sezione del<br />
generatore consente <strong>di</strong> evitare la combustione incompleta nelle zone fredde che tendono a formarsi<br />
in corrispondenza delle pareti metalliche.<br />
Tale esecuzione del generatore permettere <strong>di</strong> abbattere la temperatura in camera <strong>di</strong> combustione, in<br />
quanto le pareti membranate sovrastanti la griglia assorbono una quota rilevante del calore <strong>di</strong><br />
irraggiamento. Inoltre, grazie alle tramogge delle ceneri poste in corrispondenza dei cambi <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rezione sul piano verticale e delle superfici <strong>di</strong> scambio convettive, si ottiene una migliore gestione<br />
del flusso dei fumi e un corrispondente minore grado <strong>di</strong> sporcamento delle superfici in oggetto. Ciò<br />
è garantito inoltre dalla bassa velocità dei fumi prevista in fase <strong>di</strong> progetto, la quale consente così un<br />
sufficiente tempo <strong>di</strong> permanenza degli stessi in camera <strong>di</strong> combustione con conseguente controllo<br />
delle emissioni <strong>di</strong> monossido <strong>di</strong> carbonio.<br />
La camera <strong>di</strong> combustione è dotata <strong>di</strong> strumenti adatti a rilevare costantemente tutti i parametri<br />
essenziali <strong>di</strong> funzionamento (temperatura, ossigeno, ecc.). In sostanza durante il suo funzionamento,<br />
agendo nella sala controllo con sistemi a <strong>di</strong>stanza, è possibile mo<strong>di</strong>ficare ed intervenire sui<br />
parametri <strong>di</strong> funzionamento, così da garantire sempre ed in ogni momento le migliori con<strong>di</strong>zioni<br />
operative e quin<strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> combustione ottimale.<br />
La camera <strong>di</strong> combustione può essere completamente ventilata e svuotata, cosa fondamentale<br />
durante i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> fermo e <strong>di</strong> start-up.<br />
I vantaggi <strong>di</strong> un tale sistema <strong>di</strong> combustione sono i seguenti:<br />
• Elevati rapporti <strong>di</strong> turndown<br />
• Flessibilità <strong>di</strong> combustibile<br />
• Combustibile <strong>di</strong> supporto non necessario<br />
• Basso eccesso <strong>di</strong> aria con alta efficienza e ridotta potenza del ventilatore aria comburente<br />
• Basso valore <strong>di</strong> emissioni<br />
• Massima affidabilità<br />
• Lunghi tempi <strong>di</strong> esercizio tra pulizie manuali della camera <strong>di</strong> combustione.<br />
A valle della camera <strong>di</strong> combustione, i fumi attraversano una sezione ra<strong>di</strong>ante, la quale abbassa la<br />
temperatura fino a circa 750°C, e una sezione convettiva, costituita dai seguenti elementi:<br />
• uno screen evaporatore il quale abbassa la temperatura fino a circa 650°C<br />
• i banchi surriscaldatori, dotati <strong>di</strong> attemperatori interme<strong>di</strong> che regolano la temperatura del vapore<br />
fino alla temperatura finale richiesta<br />
• i banchi economizzatori, i quali innalzano la temperatura dell’acqua <strong>di</strong> alimento fino a valori<br />
prossimi alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vaporizzazione, prima del suo ingresso nel corpo cilindrico<br />
I fumi cal<strong>di</strong> in uscita dall’economizzatore <strong>di</strong> caldaia hanno una temperatura intorno ai 170 °C e<br />
vengono inviati al trattamento <strong>di</strong> depolverizzazione costituito essenzialmente da un un filtro a<br />
Agritre Pag. 17<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
maniche, e successivamente vengono aspirati dal ventilatore <strong>di</strong> tiraggio indotti ed avviati al camino<br />
per il definitivo scarico all’atmosfera.<br />
Un sistema <strong>di</strong> ricircolo dei fumi in camera <strong>di</strong> combustione, garantisce il controllo accurato degli<br />
Ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> Azoto (NOx). I fumi esausti rilasciati dal generatore <strong>di</strong> vapore verranno pertanto ricircolati<br />
e immessi in camera <strong>di</strong> combustione per elevare la turbolenza e <strong>di</strong>minuire la produzione <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
azoto. Risulta comunque necessario la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un idoneo sistema DeNOx per rispettare i<br />
limiti imposti dalla normativa italiana, in termini <strong>di</strong> NOx.<br />
I collegamenti tra le superfici riscaldanti assicureranno una <strong>di</strong>stribuzione del flusso sulle superfici<br />
stesse stabile e regolare in tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio.<br />
Il progetto delle parti in pressione rispetta la normativa VSG e sarà approvato da ISPESL/PED.<br />
Per l’accensione della caldaia s prevede la presenza <strong>di</strong> 2 bruciatori per innescare la combustione: si<br />
tratta <strong>di</strong> bruciatori a gas naturale retrattili posti sulle pareti della camera <strong>di</strong> combustione della<br />
caldaia.<br />
5.2.2.2 Sistema <strong>di</strong> rimozione ceneri<br />
Il processo <strong>di</strong> combustione delle paglie, oltre al calore utile alla conversione elettrica, genera un<br />
residuo <strong>di</strong> combustione, rappresentato dalle ceneri; tale residuo deve essere allontanato e smaltito<br />
nel modo più corretto; in alternativa (allorché tecnicamente ed economicamente possibile), può<br />
essere valorizzato attraverso un impiego alternativo.<br />
Considerato che il contenuto in ceneri è pari al 6-7% della sostanza secca delle paglie, 131 mila<br />
tonnellate annue <strong>di</strong> paglia determinano la produzione <strong>di</strong> 8.000 – 9.000 tonnellate <strong>di</strong> ceneri all’anno<br />
(circa una tonnellata per ora <strong>di</strong> funzionamento dell’<strong>impianto</strong>).<br />
Le ceneri da raccogliere sono identificabili in <strong>di</strong>verse sezioni dell’<strong>impianto</strong>:<br />
• ceneri <strong>di</strong> fondo del letto che vengono scaricate ad umido;<br />
• ceneri leggere raccolte nella tramoggia <strong>di</strong> fondo del passaggio convettivo;<br />
• ceneri leggere raccolte nelle tramogge <strong>di</strong> scarico del filtro a maniche.<br />
Il sistema a umido per le ceneri pesanti consiste in un sistema <strong>di</strong> nastri trasportatori a catena che<br />
convogliano le ceneri umide fino a tre scarrabili. Le ceneri pesanti provenienti dalla superfìcie della<br />
griglia mobile sono trasportate al limite frontale della griglia stessa dalla quale cadono all'interno del<br />
trasportatore sopra descritto.<br />
Un secondo sistema <strong>di</strong> trasportatori meccanici raccoglie le ceneri provenienti dalla parte convettiva<br />
e dal filtro a maniche e le invia poi in un silo <strong>di</strong> stoccaggio a secco. Il sistema <strong>di</strong> evacuazione è<br />
<strong>di</strong>mensionato per raccogliere le ceneri leggere, trasportarle in maniera adeguatamente protetta per<br />
evitare pulviscolo nell’aria ed immagazzinarle in un silo.<br />
Il silo è dotato <strong>di</strong>:<br />
• filtro <strong>di</strong> sfiato;<br />
• sensore <strong>di</strong> livello a 3 posizioni;<br />
• sistema <strong>di</strong> estrazione residui sia a secco sia ad umido (umi<strong>di</strong>ficatore ceneri).<br />
La gestione delle ceneri da biomassa è <strong>di</strong>sciplinata dal D.Lgs. 152/2006 (parte IV) che le classifica<br />
come “rifiuti speciali non pericolosi” ed in particolare nella categoria dei rifiuti inorganici<br />
Agritre Pag. 18<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
provenienti da processi termici. E’ possibile <strong>di</strong>stinguere la frazione delle “ceneri pesanti” da quella<br />
<strong>di</strong> “ceneri leggere”. Ovviamente trattasi <strong>di</strong> ceneri che provengono da materiale non trattato con<br />
vernici, solventi o prodotti chimici in genere.<br />
La definizione <strong>di</strong> “rifiuto speciale non pericoloso” assegna al materiale <strong>di</strong> scarto la possibilità <strong>di</strong><br />
sottoporlo a procedure semplificate <strong>di</strong> smaltimento (D.M. 186/2006); laddove sia tecnicamente ed<br />
economicamente possibile, l’attuale orientamento normativo (sia con riferimento alla legislazione<br />
comunitaria che a quella nazionale) stabilisce in via preferenziale il recupero <strong>di</strong> materia ed energia,<br />
destinando il conferimento in <strong>di</strong>scarica solo come ultima possibilità.<br />
In particolare, sarebbe opportuno (in virtù della recente normativa in materia) qualificare le ceneri<br />
come “sottoprodotto” piuttosto che come materiale <strong>di</strong> “rifiuto”; questa <strong>di</strong>stinzione ha rilevanti<br />
ricadute in quanto escludere l’obbligo <strong>di</strong> avviare il materiale medesimo allo smaltimento ed offre<br />
nuove possibilità d’impiego.<br />
In sintesi, le potenziali possibilità <strong>di</strong> recupero sono:<br />
• produzione <strong>di</strong> conglomerati cementizi;<br />
• utilizzo in cementifici;<br />
• industria dei laterizi e dell’argilla espansa;<br />
• recuperi ambientali.<br />
Particolare interesse si intende però assegnare alla possibilità <strong>di</strong> procedere ad un recupero e<br />
valorizzazione agronomica delle ceneri, consapevoli che la sottrazione minerale ai campi coltivati<br />
eseguita con l’asporto delle paglie potrebbe essere perfettamente riequilibrata attraverso l’apporto<br />
concimante delle ceneri, tal quali od opportunamente compostate.<br />
Nel novero delle procedure semplificate previste dal D.M. 186/2006, sono proponibili, infatti, due<br />
ulteriori e <strong>di</strong>stinti processi <strong>di</strong> recupero:<br />
• produzione <strong>di</strong> compost ;<br />
• produzione <strong>di</strong> fertilizzanti (purché conformi alla L. 748 del 19 ottobre 1984).<br />
Un ulteriore riferimento normativo per il riutilizzo delle ceneri è il D. Lgs. 220/95 che ha recepito il<br />
Reg. CEE 2092/91 sull’utilizzo <strong>di</strong> “prodotti per la concimazione e l’ammendamento impiegabili in<br />
agricoltura biologica” il quale in<strong>di</strong>ca, tra questi, anche l’uso <strong>di</strong> cenere <strong>di</strong> legno vergine.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista prettamente agronomico, le ceneri possono essere considerate:<br />
• un concime, finalizzato ad apportare al suolo agrario elementi nutritivi utili all’accrescimento<br />
delle piante coltivate e, dunque, favorirne la produzione;<br />
• un correttivo-ammendante, finalizzato ad innalzare la reazione del suolo (pH), in ragione della<br />
presenza <strong>di</strong> metalli alcalino-terrosi insolubili o poco solubili (quali Ca e Mg) nonché metalli<br />
alcalini solubili (quali Na e K) sotto forma <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong>, idrossi<strong>di</strong> e carbonati.<br />
5.2.3 Sezione trattamento e evacuazione fumi<br />
Relativamente agli accorgimenti progettuali e tecnologici per la riduzione e il controllo delle<br />
emissioni, verranno adottati i sistemi e le tecnologie più efficaci ed affidabili oggi <strong>di</strong>sponibili, con i<br />
seguenti obiettivi primari:<br />
Agritre Pag. 19<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• controllo delle caratteristiche del combustibile perché rientri sempre nei limiti <strong>di</strong> legge e non<br />
contenga all’origine inquinanti in qualità e quantità superiori a quanto previsto dalla<br />
progettazione dell’<strong>impianto</strong>;<br />
• controllo della combustione e del suo completo svolgimento (minimizzazione delle emissioni <strong>di</strong><br />
CO) anche al fine <strong>di</strong> sfruttare al massimo il contenuto energetico del combustibile;<br />
• controllo in continuo delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> combustione e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> efficienza delle<br />
sezioni <strong>di</strong> abbattimento fumi sia in caldaia che al camino; questi controlli sono tra loro connessi,<br />
me<strong>di</strong>ante apposito HW e SW <strong>di</strong> processo (supervisione dei parametri <strong>di</strong> funzionamento, gestione<br />
attiva <strong>di</strong> eventuali allarmi e sicurezze intrinseche) e realizzano il mantenimento delle con<strong>di</strong>zioni<br />
ottimali <strong>di</strong> funzionamento <strong>di</strong> tutta la catena combustione;<br />
• elevata capacità <strong>di</strong> gestire i transitori senza produrre emissioni inquinanti indesiderate e, in ogni<br />
caso, <strong>di</strong> ridurre a tempi minimi le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> transitorio e <strong>di</strong> emergenza.<br />
Il sistema <strong>di</strong> trattamento e abbattimento delle emissioni si basa, essenzialmente su tre <strong>di</strong>verse<br />
meto<strong>di</strong>che:<br />
• denitrificazione<br />
• trattamento chimico e fisico dei fumi<br />
• sistemi <strong>di</strong> rilevazione e monitoraggio al camino<br />
La denitrificazione si basa su <strong>di</strong> un processo chimico <strong>di</strong> abbattimento degli ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> azoto (NOx)<br />
.attraverso l’iniezione, tramite ugelli, nel flusso gassoso prodotto dalla combustione, <strong>di</strong> una<br />
soluzione <strong>di</strong> acqua ed urea.<br />
Il reagente quando entra in contatto con le molecole degli ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> azoto, reagisce con loro e le<br />
trasforma in altri composti non inquinanti, garantendo quin<strong>di</strong> il rispetto dei limiti fissata dalla<br />
norma.<br />
Il trattamento fumi, è del tipo a secco e questo permette <strong>di</strong> ridurre <strong>di</strong> molto i consumi idrici della<br />
centrale. I gas <strong>di</strong> combustione che escono dalla sezione <strong>di</strong> combustione, sono convogliati ad una<br />
torre <strong>di</strong> reazione dove sono miscelati con idrossido <strong>di</strong> calce che reagisce con i composti alogenati<br />
(HCl, HF) e con anidride solforosa, trasformandoli in sali <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o, cloruri e solfati.<br />
Dopo questo primo trattamento chimico i fumi vengono sottoposti ad un successivo sta<strong>di</strong>o fisico<br />
tramite il passaggio del flusso <strong>di</strong> aria calda attraverso filtri a maniche appositamente realizzati per<br />
catturare particelle <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni piccolissime. Queste, una volta depositate nelle celle dei filtri,<br />
vengono poi recuperate e raccolte in un sistema <strong>di</strong> stoccaggio chiuso.<br />
Per garantirne il perfetto funzionamento, i filtri a manica sono monitorati costantemente, specie per<br />
quanto riguarda i parametri <strong>di</strong> temperatura dei fumi, onde evitare che una elevata temperatura li<br />
renda inefficaci. In quel caso è comunque previsto un sistema <strong>di</strong> immissione <strong>di</strong> aria esterna che<br />
abbassa la temperatura dei fumi a valori <strong>di</strong> normale funzionamento. Inoltre le maniche filtranti sono<br />
perio<strong>di</strong>camente pulite tramite getti <strong>di</strong> aria compressa per mantenerle in perfetto stato <strong>di</strong> efficienza.<br />
Le dotazioni che completano il sistema ambientale della centrale comprendono un sistema <strong>di</strong><br />
analizzatore dei fumi per garantire in continuo il monitoraggio ed il controllo delle emissioni al<br />
camino provenienti dal ciclo <strong>di</strong> combustione.<br />
Il sistema permetterà l’analisi e la rilevazione in continuo dei seguenti parametri:<br />
• Temperatura;<br />
Agritre Pag. 20<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• Portata volumetrica dell’effluente gassoso;<br />
• Ossigeno <strong>di</strong> riferimento;<br />
• Polveri totali;<br />
• Monossido <strong>di</strong> Carbonio (CO);<br />
• Ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> Azoto (NOx);<br />
• Sostanze organiche sotto forma <strong>di</strong> gas e vapori, espresse come Carbonio Organico Totale (COT);<br />
• Biossido <strong>di</strong> Zolfo (SO2).<br />
Il sistema <strong>di</strong> monitoraggio in continuo dovrà prevedere il controllo dei microinquinanti come IPA,<br />
metalli, composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl), composti inorganici del<br />
fluoro espressi come acido fluoridrico (HF), <strong>di</strong>ossine e furani (PCDD + PCDF).<br />
Inoltre, sempre in continuo, il sistema rileverà anche le concentrazioni <strong>di</strong> Carbonio Organico totale<br />
(COT), importante in<strong>di</strong>catore della concentrazione totale <strong>di</strong> sostanze organiche presenti negli<br />
scarichi inquinanti che serve per poter valutare in modo complessivo il carico inquinante e<br />
l’efficacia dei sistemi <strong>di</strong> abbattimento.<br />
I dati – insieme ad altri parametri funzionali – saranno raccolti da appositi analizzatori e trasmessi<br />
ad una postazione computerizzata presso la sala controllo che in tempo reale elabora i dati per<br />
permettere il controllo del rispetto dei limiti <strong>di</strong> legge.<br />
Il monitoraggio delle emissioni è basato sulla tecnica FTIR “Fourier Transformed Infrared”.<br />
Con il sistema FTIR è possibile effettuare misure in continuo <strong>di</strong> HCl, CO, NO, NO2, SO2, H2O,<br />
CO2, O2 e COT. Il camino <strong>di</strong> emissione sarà dotato <strong>di</strong> prese <strong>di</strong> misura posizionate in accordo con<br />
quanto specificatamente in<strong>di</strong>cato dal metodo U.N.I.CHIM. e U.N.I. 10169 e <strong>di</strong>mensionate in<br />
accordo con quanto in<strong>di</strong>cato dall’ASL. Per quanto riguarda l’accessibilità alle prese <strong>di</strong> misura,<br />
saranno garantite le norme <strong>di</strong> sicurezza previste dalla normativa vigente in materia <strong>di</strong> prevenzione<br />
degli infortuni e igiene del lavoro. I sistemi <strong>di</strong> abbattimento a presi<strong>di</strong>o delle emissioni saranno<br />
sottoposti a perio<strong>di</strong>ca manutenzione, al fine <strong>di</strong> garantire l’efficienza degli stessi, e prevenire danni<br />
ambientali.<br />
Le misure <strong>di</strong> concentrazione dei gas molecolari eteronucleari sono effettuate dallo strumento ad<br />
assorbimento Infrarosso a Trasformata <strong>di</strong> Fourier (FTIR) che garantisce: analisi simultanea dei gas<br />
in maniera omogenea e senza alterazione della loro composizione, elevata sensibilità, adattabilità a<br />
qualsiasi variazione dovuta al mutare delle con<strong>di</strong>zioni del processo o alle richieste legislative.<br />
La misura delle sostanze organiche sotto forma <strong>di</strong> gas e vapori è effettuata me<strong>di</strong>ante il metodo a<br />
ionizzazione <strong>di</strong> fiamma (FID). La misura della concentrazione <strong>di</strong> O2 è effettuata me<strong>di</strong>ante metodo<br />
elettrochimico. La misura delle concentrazione <strong>di</strong> polveri è effettuata tramite metodo<br />
<strong>di</strong>ffrattometrico, ovvero tramite la misura in-situ della <strong>di</strong>ffrazione ottica. La misura della portata è<br />
effettuata con principio <strong>di</strong> misura basato sulla pressione <strong>di</strong>fferenziale rilevata dalla sonda inserita<br />
per tutto il <strong>di</strong>ametro del camino, la misura della temperatura e della pressione sono effettuate<br />
utilizzando misuratori locali.<br />
Agritre Pag. 21<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
La seguente tabella riporta il confronto tra emissioni garantite dell’<strong>impianto</strong> con i limiti <strong>di</strong> legge<br />
richiesti dal R.R. 12/2008 che riprende i limiti del DLgs. 152/2006, Parte III dell'Allegato I alla<br />
parte V, riferiti a impianti fino a 50 MW <strong>di</strong> potenza termica installata.<br />
I limiti <strong>di</strong> legge sono sostanzialmente riferiti alla me<strong>di</strong>a giornaliera (infatti secondo il DLgs.<br />
152/2006 i valori limite <strong>di</strong> emissione sopra in<strong>di</strong>cati si considerano rispettati se la valutazione dei<br />
risultati evidenzia che, nelle ore <strong>di</strong> normale funzionamento, durante un anno civile, nessun valore<br />
me<strong>di</strong>o giornaliero valido supera i pertinenti valori limite <strong>di</strong> emissione ed il 95% <strong>di</strong> tutti i valori me<strong>di</strong><br />
orari convalidati nell’arco dell’anno non supera il 200% dei pertinenti valori limite <strong>di</strong> emissione) e a<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> gas secco con tenore <strong>di</strong> ossigeno <strong>di</strong> riferimento all’11% <strong>di</strong> ossigeno.<br />
Inquinante<br />
Dati stimati a monte<br />
del trattamento<br />
Emissioni garantite<br />
dell’<strong>impianto</strong><br />
Valori richiesti dal<br />
R.R. 12/2008<br />
Valore me<strong>di</strong>o stimato<br />
(mg/Nm³, secco, 11%<br />
O 2 )<br />
Valore me<strong>di</strong>o<br />
giornaliero (mg/Nm³,<br />
secco, 11% O 2 )<br />
(DLgs. 152/2006,<br />
Parte III dell'Allegato I<br />
alla parte V, impianti<br />
fino a 50 MW <strong>di</strong><br />
potenza termica<br />
installata)<br />
(mg/Nm³, secco, 11%<br />
O 2 )<br />
Polveri 2200 10 30<br />
Monossido <strong>di</strong> carbonio (CO) 100 100 100<br />
Carbonio organico totale<br />
(COT)<br />
10 10<br />
Ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> azoto (NO 2 ) 400 200 200<br />
Ammoniaca (NH 3 ) 20<br />
Biossido <strong>di</strong> zolfo (SO 2 ) 300 100 200<br />
Acido cloridrico (HCl) 400 10 /<br />
Acido fluoridrico (HF) 1 /<br />
Va infine tenuto presente che:<br />
• l’<strong>impianto</strong> ha caratteristiche <strong>di</strong> progetto note e consolidate e procedure <strong>di</strong> emergenza analoghe a<br />
quelle messe a punto in numerose applicazioni simili;<br />
• tutte le apparecchiature essenziali al corretto funzionamento sono coperte da scorta <strong>di</strong> stand-by o<br />
sono progettate a sezioni ridondanti ed hanno doppia alimentazione <strong>di</strong> energia;<br />
• l’intero sistema è coperto da SW e HW <strong>di</strong> controllo in grado <strong>di</strong> gestire <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong><br />
preallarme ed allarme e <strong>di</strong> attivare le procedure correttive prima che si vengano a creare<br />
situazioni che impongano la fermata;<br />
Agritre Pag. 22<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• l’<strong>impianto</strong> è sorvegliato a turni continui (24 ore su 24) da personale specializzato <strong>di</strong> conduzione e<br />
manutenzione;<br />
il sistema <strong>di</strong> combustione è supervisionato 24 ore su 24, dal conduttore caldaista in turno<br />
5.2.4 Sezione produzione energia elettrica<br />
La produzione <strong>di</strong> energia elettrica avviene tramite un turbo alternatore <strong>alimentato</strong> dal vapore<br />
prodotto dalla sezione sopra descritta.<br />
Il sistema della turbina a vapore, è fornito su uno skid compreso <strong>di</strong> tutti i sottosistemi necessari al<br />
suo corretto funzionamento. In particolare il gruppo comprende:<br />
• prelievo controllato per il degasatore a 3,5 bar (a), per preriscaldatore aria a 7,5 bar (a), per il<br />
preriscaldo condense e a per la produzione <strong>di</strong> acqua calda a 0,7 bar (a);<br />
• valvole <strong>di</strong> ammissione con sistema <strong>di</strong> regolazione della pressione e prelievo a pressione<br />
controllata<br />
• riduttore <strong>di</strong> velocità, completo <strong>di</strong> giunto <strong>di</strong> accoppiamento all’alternatore,<br />
• possibilità <strong>di</strong> funzionamento in “sli<strong>di</strong>ng pressure” con valore minimo <strong>di</strong> pressione,<br />
• sistema <strong>di</strong> lubrificazione completo <strong>di</strong> pompe principali e <strong>di</strong> emergenza, refrigerante dell’olio, 2<br />
filtri (ridondanza al 100%), serbatoio dell’olio, tubazioni <strong>di</strong> collegamento, valvole, sfiato olio con<br />
separazione olio/aria, ecc.;<br />
• viradore;<br />
• valvole <strong>di</strong> ammissione del vapore vivo ad alta pressione complete <strong>di</strong> accessori;<br />
• valvole <strong>di</strong> regolazione del vapore vivo complete <strong>di</strong> accessori;<br />
• filtri temporanei e permanenti sull’arrivo del vapore vivo;<br />
• sistema <strong>di</strong> regolazione <strong>di</strong> velocità <strong>di</strong> tipo elettro-idraulico;<br />
• sistema del vapore <strong>di</strong> tenuta completo <strong>di</strong> filtri, valvole e tubazioni;<br />
• <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> scatto per sovra velocità, bassa pressione olio lubrificazione, alta pressione scarico<br />
turbina, spostamento assiale eccessivo dell’albero, blocco a <strong>di</strong>stanza;<br />
• strumentazione per un esercizio sicuro ed affidabile dell’intero sistema incluso il sistema <strong>di</strong><br />
rilevazione vibrazioni e temperature metallo dei cuscinetti;<br />
• tubazioni <strong>di</strong> collegamento;<br />
• controflange, bulloni, guarnizioni per le eventuali estremità flangiate<br />
• piastre <strong>di</strong> fondazione, spessori <strong>di</strong> livello e bulloni per il collegamento al basamento ed eventuali<br />
inserti necessari per la posa in opera e per l’allineamento;<br />
• quadro <strong>di</strong> controllo e regolazione turbina;<br />
• quadro misure e protezioni del generatore completo <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> sincronizzazione per gestione<br />
parallelo rete automatico/manuale ed eventuale esercizio in isola;<br />
• coibentazioni <strong>di</strong> tutte le superfici con temperatura superiore ai 70 °C.<br />
Agritre Pag. 23<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Sarà presente un sistema <strong>di</strong> by-pass turbina, completo <strong>di</strong> valvola <strong>di</strong> riduzione della pressione e <strong>di</strong><br />
attemperatore <strong>alimentato</strong> con l’acqua in mandata dalle pompe <strong>di</strong> alimento, per lo scarico al<br />
condensatore <strong>di</strong> tutto il vapore generato dalla caldaia in emergenza su chiusura della valvola <strong>di</strong><br />
ammissione <strong>di</strong> turbina.<br />
5.2.5 Ciclo vapore<br />
5.2.5.1 Condensatore ad aria<br />
Il vapore scaricato dalla turbina, verrà inviato, tramite tubazione <strong>di</strong> adduzione, al condensatore ad<br />
aria. L’apparato è <strong>di</strong>mensionato per potere ricevere, in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> emergenza, il vapore dallo<br />
scarico del by-pass della turbina.<br />
Il condensatore ad aria si compone dei seguenti elementi:<br />
• collettore <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />
• fasci tubieri ;<br />
• ventilatori assiali;<br />
• motori elettrici con inverter o a doppia velocità.<br />
A valle del condensatore è installato il serbatoio condense (pozzo caldo) ed il gruppo del vuoto.<br />
Il condensatore ad aria opera me<strong>di</strong>ante la movimentazione <strong>di</strong> aria ambiente (20 °C).<br />
5.2.5.2 Pozzo caldo<br />
Successivamente al condensatore, il condensato si raccoglie nel pozzo caldo, dal quale le pompe <strong>di</strong><br />
estrazione provvedono al rilancio verso il degasatore.<br />
L’accumulatore <strong>di</strong> condense è <strong>di</strong>mensionato in modo da consentire la completa separazione dei gas<br />
dal liquido ed accumulare una quantità <strong>di</strong> condense sufficiente ad assicurare per queste ultime un<br />
tempo <strong>di</strong> permanenza <strong>di</strong> almeno 6 minuti alla massima portata <strong>di</strong> condense preve<strong>di</strong>bile (ovvero<br />
quando il by-pass <strong>di</strong> turbina è completamente aperto). Questo garantisce il controllo del livello delle<br />
condense stesse e la corretta alimentazione della pompa <strong>di</strong> estrazione delle condense. Il condensato<br />
viene estratto dal pozzo caldo da due pompe e inviato al degasatore.<br />
5.2.5.3 Sistema condensato e acqua <strong>di</strong> alimento<br />
Il sistema acqua alimento comprende il rilancio del condensato, la reintegrazione delle per<strong>di</strong>te e del<br />
blow-down con acqua demineralizzata, il degasaggio, il preriscaldo attraverso l’economizzatore<br />
della caldaia e infine l’alimentazione al corpo cilindrico della caldaia.<br />
Il sistema acqua alimento è costituito essenzialmente dai componenti descritti nel seguito.<br />
• Due elettropompe <strong>di</strong> estrazione del condensato, ciascuna <strong>di</strong>mensionata per il 100% della portata,<br />
per cui una è in servizio e la seconda <strong>di</strong> riserva, le quali aspirano dal pozzo caldo del<br />
condensatore ed erogano al degasatore;<br />
Agritre Pag. 24<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• Un Degasatore termofisico a bassa pressione, il quale dovrà anche svolgere la funzione <strong>di</strong><br />
accumulo dell’acqua per il generatore <strong>di</strong> vapore per un tempo sufficiente a fronteggiare un<br />
eventuale black-out dell’<strong>impianto</strong>. Le caratteristiche dell’acqua degasata devono essere conformi<br />
a quanto prescritto dalla normativa tecnica ed adeguate alle esigenze del generatore <strong>di</strong> vapore e<br />
comunque tali da mantenere il contenuto <strong>di</strong> ossigeno al <strong>di</strong> sotto dei 0,1 ppm.<br />
• Due pompe <strong>di</strong> alimento della caldaia a biomassa, ciascuna <strong>di</strong>mensionata al 105% della portata<br />
richiesta dalla caldaia, che aspirano dalla cassa accumulo del degasatore ed erogano la portata<br />
richiesta al corpo cilindrico.<br />
5.2.5.4 Degasatore<br />
Il degasatore sarà sistemato nella boiler house e normalmente verrà <strong>alimentato</strong> con vapore in bassa<br />
pressione spillato dalla turbina. Spora<strong>di</strong>camente il degasatore potrà essere <strong>alimentato</strong> dalla linea del<br />
vapore in alta pressione, previa depressurizzazione ed attemperamento. Questa con<strong>di</strong>zione si<br />
verifica quando la pressione all’interno del collettore <strong>di</strong> bassa pressione scende sotto un limite<br />
prefissato (durante il bypass turbina, durante la fase <strong>di</strong> avviamento, durante il funzionamento a<br />
carichi parziali).<br />
Il degasatore sarà installato nella boiler house a 15 m <strong>di</strong> altezza e dovrà essere completo <strong>di</strong> tutti gli<br />
accessori usuali per questo tipo <strong>di</strong> componente e necessari per il suo corretto funzionamento in tutte<br />
le con<strong>di</strong>zioni operative previste.<br />
In particolare il degasatore sarà costituito dai seguenti componenti<br />
• una torretta degasante (verticale);<br />
• un serbatoio <strong>di</strong> raccolta acqua degasata (orizzontale);<br />
• i bocchelli flangiati per l’ingresso e l’uscita dei flui<strong>di</strong><br />
• piastre, sottopiastre, piastre <strong>di</strong> teflon ed antivibranti, bulloni <strong>di</strong> ancoraggio;<br />
• coibentazione per mantenere una temperatura superficiale del lamierino <strong>di</strong> rivestimento non<br />
superiore ai 50 °C in corrispondenza <strong>di</strong> una temperatura dell’aria <strong>di</strong> 30 °C;<br />
• attacchi per la strumentazione <strong>di</strong> controllo e regolazione;<br />
• una colonna idrometrica completa degli accessori relativi;<br />
strumentazione e valvolame necessari al funzionamento del sistema;<br />
5.2.5.5 Sistema recupero condense<br />
Questo sottosistema provvede a raccogliere tutte le condense pulite recuperabili dal ciclo termico,<br />
per riadoperare come acqua <strong>di</strong> supplemento; le condense recuperabili possono giungere<br />
principalmente da:<br />
• Tenute manicotti della turbina a vapore<br />
• Eiettori del vuoto del condensatore<br />
Il sistema include un serbatoio <strong>di</strong> raccolta delle condense e due pompe <strong>di</strong> circolazione al 100%,<br />
adatte per il trasferimento delle condense al degasatore con una portata modulata automaticamente<br />
dal regolatore <strong>di</strong> livello del degasatore stesso.<br />
.<br />
Agritre Pag. 25<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
5.2.6 Apparecchiature e strumentazioni elettriche<br />
Gli impianti elettrici verranno realizzati in stretta osservanza delle normative CEI Italiane applicabili<br />
ed attualmente in vigore, con particolare riguardo alle norme CEI 64-8/ 1-2-3-4-5-6-e 7 ( Impianti<br />
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in<br />
corrente continua ), CEI 81-1 ( Protezione delle strutture contro i fulmini ) e CEI 99 ( Impianti<br />
elettrici <strong>di</strong> potenza con tensione nominale superiore ad 1KV in corrente alternata ).<br />
Per quanto concerne il collegamento in alta tensione ( 150KV ) alla rete nazionale verranno<br />
rispettate tutte le norme e prescrizioni Terna applicabili.<br />
Il sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione in bassa tensione sarà del tipo TN-S.<br />
5.2.6.1 Tensioni <strong>di</strong> <strong>impianto</strong><br />
I livelli <strong>di</strong> tensione <strong>di</strong> stabilimento saranno i seguenti:<br />
• Tensione <strong>di</strong> consegna a Terna : 150KV,trifase,50HZ , ottenuta me<strong>di</strong>ante due trasformatori<br />
elevatori: il primo, posizionato all’inizio del cavidotto <strong>di</strong> circa 6 km <strong>di</strong> collegamento alla<br />
sottostazione TERNA , da 11/30KV,da 27MVA ; il secondo, ubicato in sottostazione TERNA,<br />
Candela 2, in località Piano D’Isca, da 30/150KV,25MVA.<br />
• Tensione <strong>di</strong> generazione con turbogeneratore e <strong>di</strong>stribuzione MT interna : 11KV,trifase,50HZ<br />
• Tensione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione BT per utenze <strong>di</strong> elevata potenza unitaria , con azionamenti ad inverter<br />
: 690V,trifase,50HZ, ottenuta tramite due trasformatori riduttori 11/0,69KV, da 2 MVA cadauno,<br />
collegabili in parallelo. Detti trasformatori saranno costruiti in modo da minimizzare gli effetti<br />
delle armoniche generate dagli azionamenti a tiristori sulla rete.<br />
• Tensione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione BT per utenze forza, piccola forza ed illuminazione : 400V-<br />
230V,trifase + neutro, 50HZ , ottenuta tramite due trasformatori riduttori 11/0,4-0,23KV,<br />
trifase/trifase + neutro, da 2 MVA cadauno, collegabili in parallelo. La tensione <strong>di</strong> 230V sarà<br />
impiegata per alcune utenze minori <strong>di</strong> piccola taglia, per i circuiti <strong>di</strong> illuminazione ed i circuiti<br />
prese.<br />
• Tensioni 24V continua e 48V continua per i servizi <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> stabilimento e <strong>di</strong> centrale.<br />
• Tensione 110V alternata,50HZ, da UPS, per strumentazione e sistemi <strong>di</strong> controllo.<br />
5.2.6.2 Utenze elettriche<br />
Le utenze elettriche sono in<strong>di</strong>cate, ciascuna con la propria potenza nominale <strong>di</strong> primo<br />
<strong>di</strong>mensionamento , negli allegati schemi unifilari generali.<br />
La potenza totale installata in BT è <strong>di</strong> circa 5.900KW, con potenza complessiva assorbita in<br />
esercizio <strong>di</strong> circa 2.000KW ; con i dovuti margini <strong>di</strong> sicurezza sono stati quin<strong>di</strong> previsti , per le due<br />
tensioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione BT, 690Vca e 400-230Vca, due coppie <strong>di</strong> trasformatori, tra loro identici e<br />
parallelabili, da 2MVA cadauno.<br />
5.2.6.3 Distribuzione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a tensione<br />
Il turbogeneratore, la cui potenza nominale è <strong>di</strong> 31,9MVA, produce energia alla tensione <strong>di</strong><br />
11KV,50HZ,trifase ; a questa stessa tensione è stata quin<strong>di</strong> prevista la <strong>di</strong>stribuzione primaria in MT<br />
dello stabilimento ; verrà quin<strong>di</strong> fornito in opera un quadro generale MT 11KV, denominato QMT<br />
01, <strong>di</strong> tipo blindato, modulare, composto , in linea <strong>di</strong> massima , dalle seguenti sezioni:<br />
Agritre Pag. 26<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• Scomparto <strong>di</strong> arrivo linea dal generatore, incorporante :<br />
− Interruttore MT <strong>di</strong> protezione del generatore;<br />
− Misure <strong>di</strong> energia in uscita dal generatore ( produzione lorda richiesta da UTIF )<br />
− Gruppi <strong>di</strong> misura con riduttori <strong>di</strong> tensione e corrente, a monte ed a valle dell’interruttore, e<br />
quanto necessario alla sincronizzazione del medesimo con la rete ed al suo parallelo con la<br />
stessa.<br />
• N° 2 due scomparti identici, ciascuno equipaggiato con interruttore MT <strong>di</strong> idonee caratteristiche,<br />
riduttori <strong>di</strong> misura <strong>di</strong> tensione e corrente, circuiti <strong>di</strong> protezione e quant’altro necessario per la<br />
corretta protezione dei due trasformatori 11.000/690V,trifase,50HZ <strong>di</strong> alimentazione del quadro<br />
utenze a 690Vca.<br />
• N° 2 due scomparti identici, ciascuno equipaggiato con interruttore MT <strong>di</strong> idonee caratteristiche,<br />
riduttori <strong>di</strong> misura <strong>di</strong> tensione e corrente, circuiti <strong>di</strong> protezione e quant’altro necessario per la<br />
corretta protezione dei due trasformatori 11.000/400-230V,trifase,50HZ <strong>di</strong> alimentazione del<br />
quadro utenze a 400-230Vca.<br />
• N° 1 scomparto <strong>di</strong> alimentazione del primario del trasformatore elevatore<br />
11/30KV,50HZ,trifase, da 27MVA; lo scomparto è equipaggiato con idoneo interruttore<br />
automatico MT, e dei riduttori <strong>di</strong> misura amperometrici e voltmetrici, e dei <strong>di</strong>spositivi e<br />
apparecchiature per il parallelo della rete con il quadro 11KV, al ripristino delle con<strong>di</strong>zioni (<br />
dopo un’anomalia della rete ) che permettono <strong>di</strong> passare dal funzionamento in isola dell’<strong>impianto</strong><br />
al suo collegamento alla rete Terna.<br />
Tutti i componenti <strong>di</strong> misura e controllo saranno alimentati da una fonte <strong>di</strong> energia soccorsa da<br />
batterie a 48Vcc <strong>di</strong> adeguate caratteristiche.<br />
5.2.6.4 Sottostazione elettrica <strong>di</strong> alta tensione <strong>di</strong> collegamento alla rete nazionale<br />
La sottostazione <strong>di</strong> alta tensione,ubicata nella sottostazione Candela 2 in località Piano D’Isca, sarà<br />
costituita da un trasformatore 30/150KV,trifase,50HZ,triangolo/stella , in olio , con raffreddamento<br />
ONAN, <strong>di</strong> potenza nominale <strong>di</strong> 25MVA; il trasformatore è completo <strong>di</strong> regolazione <strong>di</strong> tensione<br />
secondaria , azionata da idoneo motore elettrico.<br />
A monte e valle del trasformatore sono previsti gli opportuni scaricatori <strong>di</strong> sovratensione.<br />
A valle del trasformatore , in conformità delle prescrizioni Terna, sarà realizzato uno stallo<br />
completo, includente:<br />
• barre isolate in aria<br />
• interruttore tripolare tipo SF6 ( 152T2 ), completo dei sezionatori 189TB1 e 189TB2 a monte ed<br />
a valle.<br />
• riduttori <strong>di</strong> misura voltmetrici (TV)<br />
• riduttori <strong>di</strong> misura amperometrici (TA)<br />
• scaricatori <strong>di</strong> sovratensioni e filtri.<br />
Agritre Pag. 27<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Nel locale <strong>di</strong> misura verranno istallati i relé <strong>di</strong> protezione della linea HV sino alla stazione Terna <strong>di</strong><br />
interconnessione; le misure fiscali dell’energia ceduta alla rete ; il gruppo 48Vcc <strong>di</strong> soccorso per gli<br />
ausiliari <strong>di</strong> sottostazione.<br />
Il collegamento alla rete Terna è definito nella STMG ( Specifica Tecnica Minima Generale )<br />
emessa da Terna stessa.<br />
5.2.6.5 Distribuzione <strong>di</strong> bassa tensione a 690vca,400vca e 230vca.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione alle utenze <strong>di</strong> bassa tensione ( 690Vca,400e 230Vca ) è realizzata a mezzo <strong>di</strong><br />
opportuni quadri power center-motor control center (PMCC) de<strong>di</strong>cati ; si vedano i due schemi<br />
unifilari generali per la relativa composizione .<br />
Caratteristica comune a tutti i PMCC è quella <strong>di</strong> essere sud<strong>di</strong>visi in due barramenti, uniti da idoneo<br />
congiuntore sbarre, con <strong>di</strong>stribuzione simmetrica delle utenze multiple sulle due sezioni; ciascun<br />
semibarramento riceve alimentazione da uno dei due trasformatori de<strong>di</strong>cati; in tal modo è garantita<br />
la massima flessibilità <strong>di</strong> funzionamento anche i occasione <strong>di</strong> potenziali guasti <strong>di</strong> una o più<br />
apparecchiature.<br />
5.2.6.6 Gruppo elettrogeno <strong>di</strong> emergenza<br />
E’ prevista la fornitura ed istallazione in opera <strong>di</strong> un gruppo elettrogeno <strong>di</strong> emergenza, <strong>di</strong> opportuna<br />
potenza ( stimata al momento in un massimo <strong>di</strong> 600KW ) , che produce energia alla tensione <strong>di</strong><br />
690Vca,trifase, 50HZ, ed è in grado <strong>di</strong> alimentare, tramite opportuno quadro <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione ad esso<br />
de<strong>di</strong>cato , le seguenti utenze :<br />
• Sistema <strong>di</strong> raffreddamento in ciclo chiuso.<br />
• Pompe <strong>di</strong> lubrificazione della turbina<br />
• Viradore<br />
• Ventilatori <strong>di</strong> caldaia<br />
• Pompe antincen<strong>di</strong>o<br />
• Illuminazione <strong>di</strong> emergenza<br />
• Carica batterie<br />
• Sistema UPS<br />
Il gruppo , raffreddato ad aria, sarà contenuto in un container da 20” ( munito <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>atore ad una<br />
estremità ) e verrà <strong>alimentato</strong> da opportuna cassa <strong>di</strong> deposito combustibile della capacità <strong>di</strong> circa<br />
3mc, sufficienti ad alimentare per circa 24 ore il gruppo alla piena potenza.<br />
5.2.7 Sistemi Ausiliari<br />
Tutti i processi ausiliari connessi al funzionamento dell’<strong>impianto</strong>, in particolare agli impianti <strong>di</strong><br />
demineralizzazione, compressori ad aria, trattamento acque, ventilazione e con<strong>di</strong>zionamento,<br />
antincen<strong>di</strong>o vengono controllati localmente da <strong>di</strong>spositivi de<strong>di</strong>cati, tipo PLC, interfacciati a loro<br />
volta con il DCS e monitorati nella sala controllo centralizzata delle stazioni operative. Per le<br />
descrizioni dei sistemi non riportate nei paragrafi successivi, si faccia riferimento ai calcoli<br />
preliminari e al <strong>di</strong>sciplinare tecnico prestazionale.<br />
Agritre Pag. 28<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
5.2.7.1 Sistema <strong>di</strong> raffreddamento in ciclo chiuso dei componenti ausiliari<br />
Il sistema <strong>di</strong> raffreddamento in ciclo chiuso è a servizio dei sistemi ausiliari dei componenti<br />
principali costituenti la centrale, quali principalmente:<br />
• Circuito <strong>di</strong> raffreddamento olio <strong>di</strong> lubrificazione turbina<br />
• Circuito <strong>di</strong> raffreddamento dell’alternatore della turbina<br />
• Circuito <strong>di</strong> raffreddamento pompe alimento<br />
Il sistema <strong>di</strong> raffreddamento previsto è a ciclo chiuso con acqua <strong>di</strong> demi opportunamente trattata;<br />
essa transita all’interno dei fasci tubieri degli scambiatori cedendo a loro volta il calore ad uno<br />
scambiatore ad acqua.<br />
Il sistema è così composto:<br />
• n. 1 vaso <strong>di</strong> espansione;<br />
• n. 2 pompe <strong>di</strong> circolazione (una in funzione, l’altra in stand-by);<br />
• n. 1 aerotermo per raffreddamento<br />
5.2.7.2 Sistema <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong>stribuzione acqua demi<br />
Il sistema consente <strong>di</strong> produrre e garantire un accumulo <strong>di</strong> acqua demineralizzata ed assicurare un<br />
reintegro continuo, del circuito vapore/condensato e altri ausiliari, con acqua <strong>di</strong> qualità adeguata alle<br />
necessità dei <strong>di</strong>versi sottosistemi. La centrale, infatti, presenta un consumo continuo <strong>di</strong> acqua<br />
demineralizzata dovuto alla necessità <strong>di</strong> compensare gli spurghi e le per<strong>di</strong>te del ciclo termico<br />
durante il regolare funzionamento; tali portate sono dovute essenzialmente ai seguenti consumi:<br />
• reintegro della portata <strong>di</strong> blow-down della caldaia a biomassa;<br />
• reintegro del vapore utilizzato per il soffiaggio in caldaia;<br />
• reintegro acqua per dosaggio con<strong>di</strong>zionamenti chimici;<br />
• reintegro acqua per <strong>di</strong>luizione urea<br />
• per<strong>di</strong>te spora<strong>di</strong>che <strong>di</strong> acqua o vapore per utilizzi minori.<br />
È quin<strong>di</strong> necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un’adeguata riserva <strong>di</strong> acqua demineralizzata per assicurare il<br />
riempimento delle apparecchiature del ciclo sia in fase <strong>di</strong> primo avviamento, sia in seguito a<br />
manutenzioni significative su apparecchiature che ne richiedano il drenaggio.<br />
5.2.7.3 Sistema <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong>stribuzione aria compressa<br />
Il sistema ha lo scopo <strong>di</strong> produrre aria compressa, per servizi e per strumenti, <strong>di</strong>stribuendola alle<br />
varie utenze della centrale alle con<strong>di</strong>zioni standard <strong>di</strong> 7 bar.<br />
Il sistema comprende due compressori ad elevata efficienza, uno in servizio ed uno <strong>di</strong> riserva,<br />
completi <strong>di</strong> filtri in aspirazione e <strong>di</strong> scambiatori raffreddati con l’acqua del sistema <strong>di</strong><br />
raffreddamento.<br />
L’aria strumenti subisce un ulteriore trattamento <strong>di</strong> essiccazione e <strong>di</strong> postfiltrazione prima <strong>di</strong> essere<br />
immagazzinata in un polmone <strong>di</strong> adeguate capacità.<br />
Agritre Pag. 29<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Il sistema è ubicato al chiuso in locale apposito.<br />
5.2.7.4 Sistema trattamento acque reflue<br />
Il sistema <strong>di</strong> trattamento delle acque reflue tratta le seguenti categorie <strong>di</strong> reflui:<br />
Acque meteoriche:<br />
le acque provenienti dalle precipitazioni atmosferiche vengono raccolte tramite l’apposita rete<br />
attraverso i tombini posizionati su tutta la superficie dell’<strong>impianto</strong>. Si presta particolare attenzione<br />
alle “acque <strong>di</strong> prima pioggia” (definite come le prime acque meteoriche che precipitano fino ad<br />
un’altezza <strong>di</strong> 5mm su tutta la superficie non drenante d’<strong>impianto</strong>, contenenti olio e possibili<br />
inquinanti), le quali raccolte separatamente subiscono un processo <strong>di</strong> <strong>di</strong>soleazione, quin<strong>di</strong> inviate<br />
alla vasca <strong>di</strong> neutralizzazione e successivamente nel recapito finale. Le “acque <strong>di</strong> seconda pioggia”<br />
possono essere inviate sia al sistema <strong>di</strong> filtrazione a sabbia e al recapito finale.<br />
Acque nere:<br />
le acque nere, provenienti dagli scarichi civili <strong>di</strong> uso sanitario sono convogliate nella rete interrata<br />
de<strong>di</strong>cata, e inviate ad un sistema <strong>di</strong> trattamento biologico con vasca tipo Imhof. L’acqua trattata<br />
viene successivamente inviata alla rete <strong>di</strong> sub irrigazione.<br />
Scarichi <strong>di</strong> processo:<br />
gli scarichi <strong>di</strong> processo derivanti da spurghi <strong>di</strong> apparecchiature e linee, drenaggi, condense e<br />
lavaggio o svuotamento <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> <strong>impianto</strong>, possono contenere ad<strong>di</strong>tivi chimici e avere pH non<br />
neutro. Raccolti attraverso tombini e ghiotte posizionate ove necessario, gli scarichi <strong>di</strong> processo<br />
sono inviati alla vasca <strong>di</strong> neutralizzazione e quin<strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentati. Le acque trattate sono<br />
successivamente inviate alla rete <strong>di</strong> sub irrigazione.<br />
Le caratteristiche delle acque trattate, avviate alla sub-irrigazione sono compatibili con quanto<br />
previsto dalla normativa (Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte 3 del D.Lgs. n.152 del 3/4/2006).<br />
5.2.8 Opere civili e infrastrutture <strong>di</strong> <strong>impianto</strong><br />
All’interno dell’area destinata ad ospitare la centrale sono previsti gli e<strong>di</strong>fici principali, costituiti<br />
dall’e<strong>di</strong>ficio stoccaggio e movimentazione della paglia, dall’e<strong>di</strong>ficio stoccaggio e movimentazione<br />
cippato, dalla sala macchine, dove trovano alloggio le apparecchiature e tutto quanto è a corredo del<br />
ciclo vapore, la sala <strong>di</strong> controllo e la sala quadri, dall’e<strong>di</strong>ficio servizi ausiliari, dall’e<strong>di</strong>ficio<br />
magazzino/officina /spogliatoi e dall’e<strong>di</strong>ficio produzione acqua calda.<br />
Gli e<strong>di</strong>fici sono previsti su fondazioni <strong>di</strong>rette. Sono previste fondazioni su palo per le<br />
apparecchiature principali quali la turbina, la caldaia, gli accessori caldaia, la linea trattamento fumi,<br />
il camino.<br />
Le opere civili da realizzare sono <strong>di</strong> seguito riepilogate:<br />
• Fabbricato scarico e stoccaggio biomassa;<br />
• Fondazioni caldaia, accessori caldaia e trattamento fumi;<br />
• Fondazioni camino;<br />
• Fabbricato controllo ed uffici: quadri elettrici;<br />
• Fabbricato officina e magazzino;<br />
Agritre Pag. 30<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• Fabbricato ausiliari <strong>di</strong> centrale (demi, compressori, locale pompe ed antincen<strong>di</strong>o);<br />
• Fabbricato impianti (turbina, condensatore e sistemi <strong>di</strong> centrale);<br />
• Fabbricato impianti produzione acqua calda;<br />
• Fondazioni apparecchiature sottostazione;<br />
• Fondazioni apparecchiature e serbatoi;<br />
• Vasche interrate;<br />
• Cunicoli, fognature, linee interrate e raccolta acque meteoriche;<br />
• Fabbricato portineria, mensa e spogliatoi ;<br />
• Cavidotto <strong>di</strong> collegamento;<br />
• Strade, piazzali, cigli, cordoli, marciapie<strong>di</strong>;<br />
• Recinzione;<br />
Di seguito si fornisce una breve descrizione degli e<strong>di</strong>fici<br />
5.2.8.1 E<strong>di</strong>ficio movimentazione biomassa<br />
L’e<strong>di</strong>ficio in oggetto è un fabbricato <strong>di</strong> tipo industriale <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni in pianta pari a 24.20 m x<br />
84.70 m. L’e<strong>di</strong>ficio è ad un unico piano con un’altezza massima <strong>di</strong> colmo pari a 11.75 m.<br />
La struttura costituente l’E<strong>di</strong>ficio movimentazione biomassa è realizzata in acciaio. Gli elementi<br />
verticali sono realizzati con profili tipo HEB600. Le vie <strong>di</strong> corsa per il carro ponte sono realizzati<br />
con i profili IPE500. Le travi <strong>di</strong> bordo sono realizzati con profili IPE600. Le travature principali, <strong>di</strong><br />
luce pari a 12.10 m, sono realizzati con profili HEB650. L’orizzontamento <strong>di</strong> copertura poggia sugli<br />
arcarecci posti ad interasse <strong>di</strong> 1.28 m. Gli arcarecci, realizzati con profili HEB240 <strong>di</strong> varia luce (8.00<br />
m, 7.20 m, 5.50 m), si appoggiano su un sistema <strong>di</strong> travature principali.<br />
La resistenza nei confronti delle azioni orizzontali è garantita attraverso la controventatura <strong>di</strong> parete<br />
realizzata con profili HEB200 e la controventatura <strong>di</strong> copertura costituita da profili angolari 80x10<br />
accoppiati e posti a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 2 cm.<br />
I tamponamenti e l’orizzontamento <strong>di</strong> copertura sono realizzati con pannelli in lamiera grecata<br />
coibentata.<br />
5.2.8.2 Sala macchina-quadri elettrici, sala controllo, uffici<br />
L’e<strong>di</strong>ficio in oggetto è un fabbricato <strong>di</strong> tipo industriale <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni in pianta pari a 24.20 m x<br />
37.50 m. Il corpo principale dell’e<strong>di</strong>ficio con la sala macchina (E<strong>di</strong>ficio N.6) è ad un unico piano<br />
con un’altezza massima <strong>di</strong> colmo pari a 12.30. Il corpo secondario che contiene sala controllo, sala<br />
quadri ed altri locali (E<strong>di</strong>ficio N.7) ha due piani e si sviluppa in altezza fino alla quota <strong>di</strong> 9.20 m.<br />
La struttura costituente l’E<strong>di</strong>ficio sala macchina è realizzata in acciaio. Gli elementi verticali della<br />
sala macchina sono realizzati con profili tipo HEB600. Gli elementi verticali del corpo contenente la<br />
sala controllo, la sala quadri sono invece realizzati con profili tipo HEB400. Le vie <strong>di</strong> corsa per il<br />
carro ponte sono realizzati con i profili IPE600. Le travature principali sopra la sala macchina, <strong>di</strong><br />
luce pari a 18.50 m, sono realizzati con profili HEB900x391. Le travature principali sopra la sala<br />
controllo, <strong>di</strong> luce pari a 8.50 m, sono realizzati con profili IPE450. Le travature principali sopra la<br />
sala quadri, <strong>di</strong> luce pari a 8.50 m, sono realizzati con profili IPE330. Gli arcarecci, realizzati con<br />
Agritre Pag. 31<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
profili HEB240 <strong>di</strong> varia luce (8.00 m, 7.00 m), si appoggiano con il passo pari a 1.28 m su un<br />
sistema <strong>di</strong> travature principali.<br />
La resistenza nei confronti delle azioni orizzontali è garantita attraverso la controventatura <strong>di</strong> parete<br />
realizzata con profili HEB200 e la controventatura <strong>di</strong> copertura costituita da profili angolari 80x10<br />
accoppiati e posti a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 2 cm.<br />
I tamponamenti e l’orizzontamento <strong>di</strong> copertura sono realizzati con pannelli in lamiera grecata<br />
coibentata.<br />
5.2.8.3 E<strong>di</strong>ficio– servizi ausiliari<br />
L’e<strong>di</strong>ficio in oggetto è un fabbricato <strong>di</strong> tipo industriale <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni in pianta pari a 15.00 m x<br />
19.50 m. L’e<strong>di</strong>ficio è ad un unico piano con un’altezza massima pari a 6.05 m.<br />
La struttura portante <strong>di</strong> questo e<strong>di</strong>ficio è realizzata in elementi in c.a. sia per quanto riguarda gli<br />
elementi verticali che per gli orizzontamenti. I solai sono realizzati con travi in c.a. e con la soletta<br />
in laterocemento. Gli elementi portanti verticali sono <strong>di</strong>sposti lungo la <strong>di</strong>rezione longitu<strong>di</strong>nale in<br />
quattro file con il passo 6.00 m (due campate) e 7.50 m (una campata) e lungo la <strong>di</strong>rezione<br />
trasversale in quattro file con il passo 5 m. Le travi principali a sostegno del solaio hanno forma<br />
rettangolare. Esse hanno altezza pari a 70 cm, larghezza pari a 50 cm. I pilastri hanno sezione<br />
quadrata 55 cm x 55 cm. La soletta in laterocemento ha spessore pari a 23 cm compresa la soletta <strong>di</strong><br />
spessore pari a 5 cm.<br />
5.2.8.4 E<strong>di</strong>ficio magazzino/officina/spogliatoi<br />
L’e<strong>di</strong>ficio in oggetto è un fabbricato <strong>di</strong> tipo industriale <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni in pianta pari a 14.40 m x<br />
26.10 m. Il corpo principale dell’e<strong>di</strong>ficio con l’officina è ad un unico piano con un’altezza massima<br />
<strong>di</strong> colmo pari a 9.50. Il corpo secondario che contiene magazzino, spogliatoi ed altri locali è<br />
anch’esso ad un unico piano e si sviluppa in altezza fino alla quota <strong>di</strong> 5.20 m.<br />
La struttura costituente l’E<strong>di</strong>ficio N.8 è realizzata in acciaio. Gli elementi verticali sono realizzati<br />
con profili tipo HEB550. Le vie <strong>di</strong> corsa per il carro ponte sono realizzati con i profili IPE600. Le<br />
travature reticolari principali, <strong>di</strong> luce pari a 14.4 m, hanno altezza pari ad 1.70 m ed i profili che la<br />
costituiscono sono dati da due profili angolari 100x100x12 accoppiati e posti a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 2 cm. Gli<br />
arcarecci, realizzati con profili IPE180 <strong>di</strong> luce pari a 5.50 m, si appoggiano con il passo pari a 1.20<br />
m su un sistema <strong>di</strong> travature principali.<br />
La resistenza nei confronti delle azioni orizzontali è garantita attraverso la controventatura <strong>di</strong> parete<br />
realizzata con profili HEB200 e la controventatura <strong>di</strong> copertura costituita da profili angolari 80x10<br />
accoppiati e posti a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 2 cm.<br />
I tamponamenti e l’orizzontamento <strong>di</strong> copertura sono realizzati con pannelli in lamiera grecata<br />
coibentata.<br />
5.2.8.5 E<strong>di</strong>ficio produzione acqua calda<br />
L’e<strong>di</strong>ficio in oggetto è un fabbricato <strong>di</strong> tipo industriale <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni in pianta pari a 7.50 m x 20.00<br />
m. L’e<strong>di</strong>ficio è ad un unico piano con un’altezza massima pari a 6.05 m.<br />
La struttura portante <strong>di</strong> questo e<strong>di</strong>ficio è realizzata in elementi in c.a. sia per quanto riguarda gli<br />
elementi verticali che per gli orizzontamenti. I solai sono realizzati con travi in c.a. e con la soletta<br />
in laterocemento. Gli elementi portanti verticali sono <strong>di</strong>sposti lungo la <strong>di</strong>rezione longitu<strong>di</strong>nale in<br />
Agritre Pag. 32<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
quattro file con il passo 5.00 m e lungo la <strong>di</strong>rezione trasversale in due file con il passo 7.50 m. Le<br />
travi principali a sostegno del solaio hanno forma rettangolare. Esse hanno altezza pari a 70 cm,<br />
larghezza pari a 50 cm. I pilastri hanno sezione quadrata 55 cm x 55 cm. La soletta in laterocemento<br />
ha spessore pari a 23 cm compresa la soletta <strong>di</strong> spessore pari a 5 cm.<br />
5.2.8.6 E<strong>di</strong>ficio stoccaggio cippato<br />
L’e<strong>di</strong>ficio in oggetto è un fabbricato <strong>di</strong> tipo industriale <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni in pianta pari a 15.00 m x<br />
21.00 m. L’e<strong>di</strong>ficio è ad un unico piano con un’altezza massima pari a 6.50 m.<br />
La struttura portante <strong>di</strong> questo e<strong>di</strong>ficio è realizzata in elementi prefabbricati in c.a. ed in c.a.p. La<br />
copertura è realizzata con i tegoli binervati TT <strong>di</strong> altezza pari a 60 cm, <strong>di</strong> larghezza pari a 149 cm,<br />
con la soletta superiore <strong>di</strong> spessore pari a 5 cm. I tegoli poggiano internamente sulle travi a “T”<br />
rovescio ed esternamente sulle travi a “L”. Le travi a “T” rovescio hanno l’anima alta 100 cm e lo<br />
spessore pari a 40 cm. La suola ha l’altezza pari a 28 cm e sporge <strong>di</strong> 20 cm. Le travi a “L” hanno<br />
l’anima alta 100 cm e lo spessore pari a 50 cm. La suola ha l’altezza pari a 28 cm e sporge <strong>di</strong> 20 cm.<br />
I pilastri hanno la sezione quadrata 55 x 55 cm.<br />
6 LA FILIERA AGRICOLA PER L’APPROVVIGIONAMENTO<br />
DELLE BIOMASSE<br />
6.1 CARATTERISTICHE DELLE PAGLIE AI FINI DELLA RACCOLTA E DEL<br />
LORO IMPIEGO ENERGETICO<br />
I residui colturali pagliosi rappresentano una fonte energetica <strong>di</strong> notevole entità nel nostro territorio<br />
e <strong>di</strong> facile accessibilità; occorre, però, considerare alcune specifiche criticità connesse al loro<br />
impiego ai fini energetici; in particolare:<br />
• la bassa produttività per unità <strong>di</strong> superficie;<br />
• il limitato periodo <strong>di</strong> tempo a <strong>di</strong>sposizione per la raccolta;<br />
• la sussistenza <strong>di</strong> consolidati impieghi alternativi d’utilizzo;<br />
• la peculiare composizione chimica del combustibile.<br />
Le quantità areiche <strong>di</strong> paglie, essendo relativamente modeste, possono causare notevole aggravio<br />
alle procedure <strong>di</strong> raccolta e comprometterne la convenienza economica; analogamente, il basso peso<br />
specifico del materiale (dunque il suo notevole ingombro) determinano una maggiore incidenza dei<br />
costi unitari <strong>di</strong> trasporto.<br />
La fase del trasporto è dunque fattore nevralgico dell’intera organizzazione logistica della filiera,<br />
unitamente alla razionale ed efficiente meccanizzazione del cantiere che sovraintende alla raccolta<br />
ed imballatura delle paglie.<br />
Agritre Pag. 33<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Per il complesso delle <strong>di</strong>fficoltà precedentemente enunciate (scarsa concentrazione territoriale ed<br />
elevati costi logistici connessi alla raccolta ed al trasporto della biomassa), unitamente alla necessità<br />
impiantistica <strong>di</strong> provvedere all’installazione delle più raffinate ed efficienti tecnologie <strong>di</strong> trattamento<br />
dei fumi e d’intercettazione <strong>di</strong> composti emissivi potenzialmente inquinanti, nonché in<br />
considerazione dell’esigenza <strong>di</strong> far valere l’effetto <strong>di</strong> rilevanti economie <strong>di</strong> scala (sia nella<br />
realizzazione dell’investimento che nella sua successiva gestione), è possibile affermare che la più<br />
efficiente filiera agro-energetica (sul fronte tecnico, ambientale ed economico) incentrata<br />
sull’impiego delle paglie è quella che ricorre ad impianti <strong>di</strong> potenza elettrica almeno superiore ai 20<br />
MW.<br />
6.2 QUANTITATIVI DI PAGLIA ED AMPIEZZA DEL BACINO DI<br />
APPROVVIGIONAMENTO<br />
Al fine <strong>di</strong> approvvigionare integralmente l’<strong>impianto</strong> in progetto è necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una quantità<br />
<strong>di</strong> paglie allo stato secco pari a 134 mila tonnellate all’anno, ciò che corrisponde ad un ammontare<br />
<strong>di</strong> paglie pari a circa 160 mila tonnellate all’anno, considerando un tenore in umi<strong>di</strong>tà pari al 15%.<br />
Con riferimento ai nostri ambienti cerealicoli meri<strong>di</strong>onali, il valore della <strong>di</strong>sponibilità areica <strong>di</strong><br />
paglie è pari a circa 1,22 t ha-1 a-1 <strong>di</strong> biomassa secca, corrispondente a circa 1,44 t ha-1 a-1 <strong>di</strong><br />
biomassa tal quale alla raccolta (15% <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà). Occorre riferire che il valore areico così<br />
determinato può ritenersi altamente conservativo e prudenziale; tale atteggiamento è dettato da<br />
ragioni sia agronomiche che ambientali; esse suggeriscono <strong>di</strong> adottare tassi <strong>di</strong> prelievo annui <strong>di</strong><br />
sostanza organica equilibrati e tecnicamente razionali. Dal punto <strong>di</strong> vista meramente<br />
impren<strong>di</strong>toriale, l’adozione <strong>di</strong> un criterio <strong>di</strong> prelievo delle risorse assai più vincolante costringe ad<br />
una più complessa organizzazione logistica e ad un aggravio dei costi. E’ però ferma convinzione<br />
del gruppo AGRITRE garantire modalità <strong>di</strong> prelievo ispirate alla massima compatibilità ambientale<br />
a garanzia della sostenibilità dell’impiego delle risorse.<br />
Ne consegue che, l’estensione complessiva della superficie coltivata a cereali sufficiente<br />
all’approvvigionamento dell’<strong>impianto</strong> è pari a circa 110.000 ettari.<br />
Un primo approccio finalizzato alla stima dell’estensione territoriale del bacino <strong>di</strong><br />
approvvigionamento considera: pari 0,80 l’incidenza della superficie agricola totale rispetto alla<br />
superficie territoriale; pari a 0,62 l’incidenza della superficie cerealicola rispetto alla superficie<br />
agricola totale; pari a 0,88 l’incidenza relativa all’accessibilità tecnica delle superfici cerealicole ai<br />
fini <strong>di</strong> un agevole espletamento delle procedure <strong>di</strong> raccolta e trasporto delle paglie. I coefficienti<br />
appena riferiti sono derivati sperimentalmente e debbono considerarsi come valore me<strong>di</strong>o<br />
territoriale. Da ciò consegue che la superficie complessiva del bacino <strong>di</strong> approvvigionamento può<br />
avere un’estensione minima <strong>di</strong> 2.500 e massima <strong>di</strong> 5.000 km quadrati; ciò corrisponde ad un raggio<br />
teorico territoriale della lunghezza compresa fra 28 e 40 km, in rapporto al grado <strong>di</strong> adesione<br />
all’accordo <strong>di</strong> filiera da parte degli agricoltori che gestiscono le superfici cerealicole (ipotizzato<br />
variabile dal 100 al 50%),<br />
Un secondo approccio <strong>di</strong> stima si è invece riferito ai dati del V Censimento dell’Agricoltura<br />
(ISTAT, 2000) ed identifica otto <strong>di</strong>versi ma limitrofi ambiti territoriali in rapporto ai quali<br />
determinare le <strong>di</strong>sponibilità reali <strong>di</strong> <strong>biomasse</strong> pagliose. Il territorio coinvolto nell’analisi è tutto<br />
Agritre Pag. 34<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
racchiuso entro una circonferenza <strong>di</strong> raggio ideale pari a 50 km, incentrata nel punto <strong>di</strong> teorica<br />
ubicazione dell’<strong>impianto</strong>.<br />
La <strong>di</strong>sponibilità potenziale complessiva <strong>di</strong> paglie è poco superiore alle 440 mila tonnellate annue,<br />
prelevate da una superficie cerealicola totale poco più estesa dei 362 mila ettari, questi ultimi<br />
<strong>di</strong>slocati nell’ambito <strong>di</strong> una superficie territoriale <strong>di</strong> circa 7.400 km quadrati.<br />
E’ possibile valutare che il territorio così considerato manifesta una <strong>di</strong>sponibilità potenziale <strong>di</strong><br />
paglie più che tripla e quasi tre volte e mezzo superiore a quella strettamente necessaria al<br />
rifornimento annuo dell’<strong>impianto</strong>. In particolare, la potenza elettrica teoricamente installabile è<br />
superiore agli 82 MW rispetto ai 25 MW lor<strong>di</strong> strettamente richiesti dall’<strong>impianto</strong>.<br />
Questa con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> eccedenza è ovviamente intenzionale in quanto deve tener conto del<br />
complesso dei fattori riduttivi o <strong>di</strong> decurtazione che attengono all’accessibilità delle superfici<br />
cerealicole oltre che al grado <strong>di</strong> adesione degli impren<strong>di</strong>tori agricoli all’accordo <strong>di</strong> filiera.<br />
Più nel dettaglio, con riferimento ai <strong>di</strong>versi <strong>di</strong>stretti geografico-territoriali, è possibile evidenziare<br />
quanto segue: l’area dei Monti Dauni meri<strong>di</strong>onali è quella che manifesta le <strong>di</strong>sponibilità potenziali<br />
più elevate <strong>di</strong> paglia (non a caso l’area in cui si colloca il comune <strong>di</strong> S. Agata <strong>di</strong> Puglia); si perviene,<br />
infatti, ad una potenza elettrica installabile <strong>di</strong> circa 18,8 MW. La densità energetica territoriale<br />
me<strong>di</strong>a è pari a 32,8 tep km-2. I comuni <strong>di</strong> Sant’Agata, Anzano <strong>di</strong> Puglia e Deliceto sono quelli che<br />
manifestano i valori più elevati <strong>di</strong> densità energetica (compresa fra 39,5 e 40,7 tep km-2); il<br />
Tavoliere centrale consentirebbe l’installazione <strong>di</strong> una potenza elettrica <strong>di</strong> ulteriori 15,7 MW.<br />
Foggia è il comune che su scala provinciale evidenzia la più alta produzione potenziale <strong>di</strong> paglia e,<br />
quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> energia (17 ktep all’anno); al gruppo dei comuni afferenti alla Provincia <strong>di</strong> Potenza (quelli<br />
più vicini all’<strong>impianto</strong>) ed al Tavoliere settentrionale, corrisponderebbero, rispettivamente, 11,9 ed<br />
11,5 MW <strong>di</strong> potenza elettrica installabile; il Tavoliere meri<strong>di</strong>onale ed i Monti Daini settentrionali<br />
manifestano valori pari rispettivamente a 8,4 e 7,8 MW <strong>di</strong> potenza elettrica teoricamente<br />
installabile; in coda alla graduatoria i <strong>di</strong>stretti della Provincia <strong>di</strong> Avellino e della Provincia B.A.T.,<br />
nei quali sarebbe possibile procedere, rispettivamente, all’installazione <strong>di</strong> 5,1 e 3,2 MW <strong>di</strong> potenza<br />
elettrica.<br />
Solo considerando l’area geografica dei Monti Dauni meri<strong>di</strong>onali, area in cui insiste il territorio del<br />
comune <strong>di</strong> S. Agata <strong>di</strong> Puglia, è possibile valutare una <strong>di</strong>sponibilità potenziale <strong>di</strong> paglie tale da<br />
sod<strong>di</strong>sfare fino al 75% il quantitativo <strong>di</strong> <strong>biomasse</strong> annualmente necessario per alimentare l’<strong>impianto</strong>.<br />
In alternativa, sempre con riferimento al medesimo bacino potenziale <strong>di</strong> approvvigionamento,<br />
volendo valutare il contributo in paglie ascrivibile esclusivamente alle aree pianeggianti, si perviene<br />
ad una potenza elettrica teoricamente installabile pari a circa 39 MW a raffronto dei 25 MW lor<strong>di</strong> in<br />
progetto. Quanto appena espresso vuole significare che le aziende cerealicole così identificate, ossia<br />
quelle logisticamente più idonee all’acquisizione delle paglie, sarebbero largamente sufficienti a<br />
garantire un adeguato approvvigionamento <strong>di</strong> <strong>biomasse</strong> all’<strong>impianto</strong>.<br />
Tale con<strong>di</strong>zione appare pertanto assai favorevole e pone l’organizzazione logistica in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
sicurezza e garanzia quantitativa <strong>di</strong> approvvigionamento, con ampi margini <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> ulteriori<br />
quantità <strong>di</strong> biomassa.<br />
A completamento delle valutazioni precedenti, si è proceduto ad espletare un terzo e più preciso<br />
approccio d’analisi il quale, impiegando carte <strong>di</strong>gitalizzate d’uso (o copertura) del suolo, adotta la<br />
tecnologia GIS (Geographical Information System). In questo modo si è potuto determinare il reale<br />
<strong>di</strong>mensionamento del bacino <strong>di</strong> approvvigionamento delle paglie e la sua effettiva <strong>di</strong>slocazione<br />
territoriale.<br />
Attraverso l’impiego <strong>di</strong> tale tecnologia è stato possibile valutare quanto segue:<br />
Agritre Pag. 35<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• Il territorio del comune <strong>di</strong> S. Agata (unitamente ai pochi comuni limitrofi) si colloca<br />
nell’area baricentrica più idonea all’approvvigionamento delle paglie, lì dove si registrano le<br />
più elevate densità territoriali del residuo colturale. Le ulteriori e limitate aree teoricamente<br />
idonee hanno, invece, una collocazione troppo periferica rispetto alla zona geografica <strong>di</strong><br />
riferimento, rappresentata dalla Capitanata.<br />
• A motivo della <strong>di</strong>ffusa coltivazione cerealicola, le densità territoriali <strong>di</strong> paglie risultano<br />
particolarmente elevate; pertanto, l’estensione complessiva del bacino <strong>di</strong> raccolta risulta<br />
relativamente contenuta, in rapporto alla potenza <strong>di</strong> generazione elettrica dell’<strong>impianto</strong>,<br />
comunque assai più ridotta rispetto al valore limite in<strong>di</strong>cato dalla normativa nazionale e<br />
regionale a riguardo (che stabilisce un raggio massimo pari a 70 km). Infatti, nel caso in cui<br />
si procedesse all’integrale acquisizione del quantitativo <strong>di</strong> paglie necessarie ad alimentare<br />
l’<strong>impianto</strong>, il raggio massimo dell’area effettiva <strong>di</strong> approvvigionamento sarebbe pari a poco<br />
meno <strong>di</strong> 36 km; tale raggio aumenterebbe a 43 e 51 km nella con<strong>di</strong>zione in cui,<br />
rispettivamente, solo il 70 od il 50% delle superfici cerealicole territoriali fossero <strong>di</strong> fatto<br />
impiegate ai fini dell’approvvigionamento.<br />
• E’ possibile affermare che il 40% delle <strong>biomasse</strong> necessarie all’esercizio dell’<strong>impianto</strong> può<br />
essere reperito entro una <strong>di</strong>stanza dal suo sito <strong>di</strong> localizzazione compresa fra i 25 ed i 32<br />
km, a seconda del grado <strong>di</strong> effettiva utilizzazione delle superfici cerealicole <strong>di</strong>sponibili.<br />
Da quanto fin qui espresso, consegue che l’approvvigionamento <strong>di</strong> <strong>biomasse</strong> necessarie ad<br />
alimentare l’<strong>impianto</strong>, integralmente o parzialmente, può essere sod<strong>di</strong>sfatto secondo modalità<br />
largamente conformi alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> “filiera corta”, ossia quella filiera che attinge le proprie<br />
necessità <strong>di</strong> combustibile in un ambito territoriale strettamente e rigorosamente locale, mai superiore<br />
ai 70 km <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza.<br />
6.3 DIFFERENTI IPOTESI DI APPROVVIGIONAMENTO INTEGRATIVO<br />
Alla favorevole con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> approvvigionamento appena riferita per le paglie, è possibile<br />
considerare l’aggiunta <strong>di</strong> ulteriori ed ampie <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> altre tipologie <strong>di</strong> <strong>biomasse</strong> (siano esse <strong>di</strong><br />
scarto o da colture de<strong>di</strong>cate), sempre <strong>di</strong> natura ligno-cellulosica e pertanto omogenee per qualità<br />
combustibili alle paglie.<br />
Con riferimento alle <strong>di</strong>sponibilità dei residui <strong>di</strong> potatura <strong>di</strong> alcune <strong>di</strong>ffuse coltivazioni arboree<br />
(oliveti e vigneti), è possibile procedere alle stime seguenti. Nell’area geografica del Tavoliere<br />
meri<strong>di</strong>onale, si renderebbero potenzialmente utilizzabili quantitativi <strong>di</strong> frasche e sarmenti tali da<br />
consentire l’istallazione <strong>di</strong> ulteriori 16 MWe; analogamente, con riferimento all’area del Tavoliere<br />
settentrionale, le <strong>biomasse</strong> residuali ottenute dagli scarti <strong>di</strong> potatura delle colture arboree<br />
consentirebbero <strong>di</strong> attivare, almeno in linea potenziale, potenze elettriche per ulteriori 11 MWe<br />
circa. Complessivamente, la provincia <strong>di</strong> Foggia, valutando la <strong>di</strong>sponibilità degli scarti <strong>di</strong> potatura <strong>di</strong><br />
vigneti ed oliveti, potrebbe consentire l’attivazione <strong>di</strong> impianti per circa 43 MWe.<br />
Sarebbe anche possibile, nonché auspicabile, orientarsi verso la coltivazione <strong>di</strong> specie agrarie<br />
espressamente destinate alla produzione <strong>di</strong> biomassa per l’energia (quali erbai autunno-vernini e<br />
colture estive come sorgo e girasole). Se questa innovazione colturale venisse anche accompagnata<br />
dall’adozione <strong>di</strong> alcune pratiche agronomiche a carattere “conservativo”, con particolare riferimento<br />
alla lavorazione del suolo, si avrebbe l’occasione <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre un “pacchetto” tecnologico<br />
completo, in grado <strong>di</strong> perseguire una pluralità <strong>di</strong> benefici obiettivi:<br />
Agritre Pag. 36<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• incrementare la fertilità dei suoli agrari attraverso l’inserimento <strong>di</strong> una coltura “da rinnovo”<br />
e l’adozione <strong>di</strong> una più razionale tecnica agronomica;<br />
• favorire un aumento del contenuto in sostanza organica ed il sequestro del carbonio nel<br />
suolo, al fine <strong>di</strong> contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico;<br />
• <strong>di</strong>versificare l’attività produttiva e rendere più <strong>di</strong>namica l’organizzazione aziendale;<br />
• aumentare in modo rilevante la produzione aziendale delle <strong>biomasse</strong>;<br />
• contribuire, tramite la produzione <strong>di</strong> energia da fonte rinnovabile, alla sostituzione <strong>di</strong><br />
energia <strong>di</strong> origine fossile;<br />
• favorire un incremento dei ricavi aziendali.<br />
L’applicazione <strong>di</strong> uno schema <strong>di</strong> avvicendamento colturale che veda l’inserimento <strong>di</strong> una coltura da<br />
rinnovo un anno su tre (triticale o sorgo, a solo titolo d’esempio) consentirebbe un drastico<br />
contenimento della superficie agricola asservita all’approvvigionamento dell’<strong>impianto</strong> a circa 31<br />
mila ettari (contrazione al 28,8 %) nel caso del triticale ed a soli 21 mila ettari nel caso del sorgo<br />
(contrazione al 19,1 %).<br />
6.4 LOGISTICA DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA E TRASPORTO<br />
DELLE PAGLIE E RELATIVI COSTI<br />
In previsione della raccolta, le paglie vengono lasciate in andane dalla mietitrebbiatrice e,<br />
successivamente, confezionate in balle. Il periodo utile per tale operazione è <strong>di</strong> 15-45 giorni dopo la<br />
raccolta della granella, in funzione del periodo <strong>di</strong> mieti-trebbiatura. Un efficiente utilizzo energetico<br />
<strong>di</strong> questi materiali residuali deve prevedere una sequenza <strong>di</strong> operazioni logistiche fondamentalmente<br />
identificabili in: raccolta, addensamento ed imballatura, trasporto e stoccaggio del prodotto<br />
combustibile così ottenuto fino alla suo finale impiego energetico.<br />
La modalità d’imballatura più idonea è quella che porta al confezionamento <strong>di</strong> grosse balle a forma<br />
<strong>di</strong> parallelepipedo (“balloni”), ad alta densità. Le <strong>di</strong>mensioni più frequentemente adottate nell’area<br />
oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sono: 0,85 x 1,20 x 2 m, per cui il volume è <strong>di</strong> circa 2 m3, il peso intorno ai 400<br />
kg, la densità approssimativamente pari a 200 kg m-3. Le balle parallelepipede giganti hanno,<br />
quin<strong>di</strong>, una elevata massa volumica e la loro forma si presta al trasporto ed allo stoccaggio.<br />
Per il trasporto su strada vengono normalmente utilizzati autotreni ed autoarticolati ed il costo<br />
unitario del trasporto è strettamente correlato alla <strong>di</strong>stanza da percorrere, al volume<br />
complessivamente <strong>di</strong>sponibile per il carico, alla massa volumica del materiale oggetto <strong>di</strong><br />
trasferimento nonché alla forma ed alle <strong>di</strong>mensioni in cui quest’ultimo viene confezionato. Nel<br />
presente stu<strong>di</strong>o si considera <strong>di</strong> destinare al trasporto delle paglie un autotreno con rimorchio<br />
ribassato avente un volume utile <strong>di</strong> carico pari a 122 m3. I 56 “balloni” complessivamente<br />
<strong>di</strong>slocabili sull’autorimorchio, avendo ciascuno un peso <strong>di</strong> 400 kg, consentono il trasporto <strong>di</strong> un<br />
peso totale <strong>di</strong> paglia pari a 22,4 t; è questo, pertanto, il quantitativo trasportabile ad ogni viaggio <strong>di</strong><br />
andata e ritorno.<br />
Il traffico <strong>di</strong> automezzi che contrad<strong>di</strong>stingue il regime <strong>di</strong> attività dell’<strong>impianto</strong> ai fini<br />
dell’approvvigionamento in paglie consiste nel passaggio <strong>di</strong> 2,5 automezzi l’ora (rispettivamente in<br />
entrata ed uscita) nell’arco del periodo d’esercizio annuo dell’<strong>impianto</strong> medesimo.<br />
La limitata “finestra temporale” a <strong>di</strong>sposizione per la raccolta delle paglie ed il numero troppo<br />
elevato <strong>di</strong> tali viaggi nell’unità <strong>di</strong> tempo che sarebbe necessario <strong>di</strong>sporre verso l’<strong>impianto</strong>, induce a<br />
Agritre Pag. 37<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
far ricorso ad una pluralità <strong>di</strong> centri <strong>di</strong> stoccaggio <strong>di</strong> tipo “satellite”, al fine <strong>di</strong> consentire un’or<strong>di</strong>nata<br />
fornitura delle paglie senza generare irrime<strong>di</strong>abili intasamenti presso un unico centro <strong>di</strong> stoccaggio<br />
presso l’<strong>impianto</strong>. Considerate le frequenze dei viaggi <strong>di</strong> trasporto, occorrerebbe pre<strong>di</strong>sporre circa 6<br />
<strong>di</strong>versi centri “satellite”; presso ogni centro satellite, quin<strong>di</strong>, viene stoccata una quantità <strong>di</strong> paglie<br />
pari a 26.400 tonnellate, utile a garantire un approvvigionamento per circa 55 giorni.<br />
Al fine <strong>di</strong> procedere allo stoccaggio delle paglie in ciascun centro <strong>di</strong> raccolta occorre <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una<br />
superficie effettiva <strong>di</strong> accatastamento delle paglie pari a circa 1,32 ettari. Per motivi <strong>di</strong> sicurezza e<br />
prevenzione incen<strong>di</strong>, è consigliabile ripartire l’intera massa combustibile in una pluralità <strong>di</strong> “isole”<br />
<strong>di</strong> stoccaggio, opportunamente <strong>di</strong>stanziate fra loro <strong>di</strong> almeno 12 metri; è inoltre opportuno<br />
considerare un corridoio laterale perimetrico anch’esso <strong>di</strong> ampiezza pari a 12 metri. Adottando una<br />
<strong>di</strong>sposizione geometricamente regolare, si vengono così ad occupare circa 3,2 ettari per ciascun<br />
centro <strong>di</strong> stoccaggio, per complessivi 19-20 ettari.<br />
Il costo <strong>di</strong> acquisto della paglia, realizzato <strong>di</strong>rettamente sul campo sul materiale semplicemente<br />
sfalciato e lasciato in superficie, si aggira, <strong>di</strong> norma, intorno ai 10 al massimo 15 €/ha, ciò che<br />
corrisponde a circa 10 € a tonnellata <strong>di</strong> paglia tal quale (al 15 % <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà).<br />
La somma complessiva dei costi (<strong>di</strong>retti ed in<strong>di</strong>retti) giornalieri relativi alle operazioni <strong>di</strong> raccolta è<br />
pari a circa 16 €/t <strong>di</strong> .<br />
Per quanto riguarda i costi <strong>di</strong> movimentazione delle paglie, essi possono essere scomposti in tre<br />
componenti: costi fissi <strong>di</strong> carico/scarico delle paglie, stimati pari a 5,0 €/ t <strong>di</strong> paglia; costi variabili in<br />
rapporto al tempo complessivamente impiegato, stimati pari a 4,3 €/t <strong>di</strong> paglia; costi variabili in<br />
rapporto alla <strong>di</strong>stanza percorsa durante il trasporto, pari a 4,0 €/t. Per il calcolo, si considera una<br />
<strong>di</strong>stanza me<strong>di</strong>a da percorrere pari a 35 km (considerando solo l’andata od il ritorno) ad una velocità<br />
<strong>di</strong> circa 60 km/h. Sommando le <strong>di</strong>verse spese sostenute durante la giornata lavorativa si perviene ad<br />
un costo complessivo <strong>di</strong> 2.358 €, ossia 39,3 €/t <strong>di</strong> paglie.<br />
Un ulteriore aspetto rilevante in merito al valore economico delle paglie consiste nella<br />
determinazione del costo relativo al suo equivalente fertilizzante, che tenga conto dei nutrienti<br />
minerali contenuti nelle paglie e che sono asportati dal suolo in caso <strong>di</strong> allontanamento delle paglie<br />
medesime. Sommando il valore economico relativo a ciascun elemento minerale presente nelle<br />
paglie è possibile risalire al valore economico complessivo dei residui colturali calcolato sulla scorta<br />
degli equivalenti fertilizzanti; in prima approssimazione, è possibile affermare che il valore<br />
nutrizionale delle paglie (al 15% <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà) corrisponde all’incirca a 10 € per tonnellata.<br />
6.5 GESTIONE AGRONOMICA OTTIMALE DELLE PAGLIE<br />
La strategia ritenuta più idonea alla gestione delle paglie rientra in un quadro più articolato <strong>di</strong> misure<br />
che mirano alla generale salvaguar<strong>di</strong>a della fertilità dei suoli agrari e che prevedono interventi<br />
innovativi che interagiscono su tre piani <strong>di</strong>stinti:<br />
1. misurato equilibrio fra asportazione ed incorporazione delle paglie;<br />
2. inserimento <strong>di</strong> una coltura da rinnovo (in particolare, un erbaio autunno-vernino) a<br />
destinazione energetica un anno su tre, con conseguente interruzione della monosuccessione<br />
cerealicola;<br />
3. introduzione <strong>di</strong> tecniche agronomiche “conservative”, più rispettose dell’integrità fisicofunzionale<br />
del suolo, con particolare riferimento alle lavorazioni principali.<br />
Agritre Pag. 38<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Con riferimento al prelievo delle paglie, una virtuosa soluzione <strong>di</strong> compromesso che tenga conto del<br />
complesso dei fattori favorevoli e contrari all’interramento dei residui colturali, è quella <strong>di</strong><br />
procedere ad una asportazione parziale. Questa con<strong>di</strong>zione può essere applicata regolando<br />
opportunamente l’altezza <strong>di</strong> taglio della barra falciante della mietitrebbia, in modo da ottenere il<br />
rapporto stoppie / paglie ritenuto più favorevole. Un valore dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> raccolta pari a 0,8 implica<br />
che le stoppie rappresentano il 20% dell’intero ammontare delle paglie in campo. Se l’efficienza <strong>di</strong><br />
raccolta è pari a 0,6 vuol <strong>di</strong>re che il 40% delle paglie inizialmente prelevate è poi andato perduto;<br />
2/3 <strong>di</strong> tale quantità è lasciato sul campo coltivato (durante le operazioni <strong>di</strong> raccolta del cereale), il<br />
rimanente 1/3 è invece perso al <strong>di</strong> fuori del campo (nel corso delle operazioni <strong>di</strong> trasporto e<br />
stoccaggio). Complessivamente è possibile affermare che poco più del 40% <strong>di</strong> tutta la biomassa<br />
pagliosa (fra stoppie e paglie vere e proprie) ritorna al suolo a costituire, nel tempo, una risorsa<br />
organica capace <strong>di</strong> preservare la qualità del suolo.<br />
6.6 CALCOLO DEL BILANCIO DELLE EMISSIONI CO2-EQUIVALENTI<br />
La capacità <strong>di</strong> ridurre le emissioni clima-alteranti è riconosciuta come uno dei criteri essenziali <strong>di</strong><br />
vantaggio delle fonti rinnovabili rispetto a quelle fossili. Occorre pertanto operare il calcolo del<br />
bilancio dei gas serra complessivamente emessi in atmosfera a fronte <strong>di</strong> quelli evitati. Questo<br />
calcolo andrebbe eseguito considerando non solo il funzionamento dell’<strong>impianto</strong> in sé ma<br />
estendendo l’analisi all’insieme della filiera agro-energetica (dalla fase <strong>di</strong> coltivazione fino<br />
all’utilizzo ed alla conversione energetica della biomassa).<br />
A tal fine è stata adottata la metodologia europea esposta nella recente Direttiva 2009/28/CE del<br />
Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 23 aprile 2009, ed inerente alla promozione ed uso<br />
dell’energia da fonti rinnovabili.<br />
Con il termine <strong>di</strong> “emissioni evitate” si intende riferirsi all’ammontare complessivo delle emissioni<br />
<strong>di</strong> CO2 (e gas equivalenti) che si sarebbero prodotte nel caso in cui l’<strong>impianto</strong> <strong>di</strong> produzione<br />
energetica, invece <strong>di</strong> essere <strong>alimentato</strong> con <strong>biomasse</strong> (fonte energetica rinnovabile) fosse rifornito a<br />
mezzo <strong>di</strong> un combustibile fossile. Le emissioni prodotte, invece, sono quelle ascrivibili: alle<br />
operazioni <strong>di</strong> raccolta e trasporto delle paglie; alla restituzione al suolo del complesso dei nutrienti<br />
minerali che sono stati sottratti con le paglie; alle costruzione dell’<strong>impianto</strong> ed alla sua <strong>di</strong>smissione,<br />
al termine del periodo complessivo d’esercizio. Non viene invece addebitato il costo emissivo <strong>di</strong><br />
coltivazione, poiché le paglie sono da considerarsi un residuo piuttosto che un sottoprodotto.<br />
E’ possibile affermare che l’attività dell’<strong>impianto</strong> e la conseguente produzione <strong>di</strong> energia elettrica da<br />
fonte rinnovabile consente <strong>di</strong> realizzare una sostituzione <strong>di</strong> fonti fossili a cui corrisponde un<br />
ammontare netto <strong>di</strong> risparmio emissivo (gas ad azione clima-alterante) compreso fra 68.600 e<br />
68.800 tonnellate equivalenti <strong>di</strong> CO2.<br />
Il risparmio emissivo conseguito (rispetto ad analoga produzione elettrica ma impiegando una fonte<br />
energetica fossile quale il metano) è, in termini relativi, pari all’89% (dato <strong>di</strong> gran lunga più elevato<br />
rispetto alla soglia minima fissata dalla UE, corrispondente al 35%).<br />
Volendo “convertire” questo considerevole ammontare <strong>di</strong> emissioni evitate in termini <strong>di</strong> risorse<br />
naturali, è possibile stimare la quantità equivalente <strong>di</strong> carbonio che verrebbe sequestrata<br />
annualmente da una superficie afforestata; essa è paria a circa 4.500 ha <strong>di</strong> superficie boscata; (ciò<br />
che corrisponde a circa 1 milione ed 800 mila piante).<br />
Agritre Pag. 39<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
6.7 RECUPERO DELLE CENERI<br />
Il processo <strong>di</strong> combustione delle paglie genera un residuo rappresentato dalle ceneri; tale residuo<br />
deve essere smaltito nel modo più corretto; in alternativa esso può essere valorizzato attraverso un<br />
impiego alternativo.<br />
Le ceneri derivanti da processi <strong>di</strong> combustione della biomassa sono classificate come “rifiuti<br />
speciali non pericolosi” ai sensi del D.lgs. 152/2006 (parte IV). E’ particolarmente opportuno<br />
qualificare le ceneri come “sottoprodotto” piuttosto che come materiale <strong>di</strong> “rifiuto”; questa<br />
<strong>di</strong>stinzione ha rilevanti ricadute in quanto esclude l’obbligo <strong>di</strong> avviare il materiale medesimo allo<br />
smaltimento ed offre nuove possibilità d’impiego. L’attuale normativa stabilisce <strong>di</strong>verse possibilità<br />
<strong>di</strong> recupero con procedure semplificate; in particolare è possibile considerare le seguenti<br />
destinazioni:<br />
produzione <strong>di</strong> conglomerati cementizi o industria <strong>di</strong> laterizi;<br />
produzione <strong>di</strong> compost;<br />
produzione <strong>di</strong> fertilizzanti;<br />
recupero ambientale, previo valutazioni con test <strong>di</strong> cessione del rifiuto.<br />
Particolare interesse si intende assegnare alla possibilità <strong>di</strong> procedere al recupero ed alla<br />
valorizzazione agronomica delle ceneri, consapevoli che la sottrazione minerale ai campi coltivati<br />
eseguita con l’asporto delle paglie potrebbe essere perfettamente riequilibrata attraverso l’apporto<br />
concimante delle ceneri, tal quali od opportunamente compostate. Dal punto <strong>di</strong> vista prettamente<br />
agronomico, le ceneri possono essere considerate:<br />
a) un concime, finalizzato ad apportare al suolo agrario elementi nutritivi utili<br />
all’accrescimento delle piante coltivate e, dunque, favorirne la produzione;<br />
b) un correttivo-ammendante, finalizzato ad innalzare la reazione del suolo (pH), in<br />
ragione della presenza <strong>di</strong> metalli alcalino-terrosi insolubili o poco solubili (quali Ca<br />
e Mg) nonché metalli alcalini solubili (quali Na e K) sotto forma <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong>, idrossi<strong>di</strong><br />
e carbonati.<br />
In particolare, le ceneri pesanti contengono la maggior parte degli elementi chimici d’interesse per<br />
un riutilizzo agronomico; <strong>di</strong>versamente, le ceneri fini sono la tipologia più apprezzata <strong>di</strong> ceneri ai<br />
fini dell’impiego nell’industria dei laterizi e dei conglomerati.<br />
Considerato che il contenuto in ceneri delle paglie è pari al 6-7% della loro sostanza secca,<br />
dall’<strong>impianto</strong> si ottengono, annualmente, 8.000 – 9.400 tonnellate <strong>di</strong> ceneri (da 1,0 ad 1,2 tonnellate<br />
<strong>di</strong> ceneri per ora <strong>di</strong> funzionamento dell’<strong>impianto</strong>). Me<strong>di</strong>amente, occorre procedere ad un carico <strong>di</strong><br />
trasporto ogni due giorni nell’arco del tempo annuo <strong>di</strong> esercizio dell’<strong>impianto</strong>. Si verrebbe a<br />
configurare un costo unitario totale pari a 86 € t-1 che, rapportato alla totalità delle ceneri ottenute<br />
dall’<strong>impianto</strong>, determina un’incidenza complessiva pari a 800-810 mila euro.<br />
6.8 ANALISI ECONOMICA DEL PROGETTO D’IMPIANTO IN RAPPORTO<br />
AL SUO DIMENSIONAMENTO<br />
Si è inteso procedere alla verifica <strong>di</strong> un parametro progettuale assolutamente cruciale: la “capacità”<br />
dell’<strong>impianto</strong> (ossia la sua “taglia” in termini <strong>di</strong> potenza <strong>di</strong> generazione elettrica) deve poter<br />
rispondere a precisi e ben definiti criteri <strong>di</strong> “ottimizzazione”.<br />
Agritre Pag. 40<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Il primo criterio è quello inerente la “massimizzazione” del ren<strong>di</strong>mento del capitale investito<br />
(misurato tramite il computo del VAN - Valore Attuale Netto) determinato come se esso fosse un<br />
capitale a carattere “pubblico” (piuttosto che privato); tale criterio, quin<strong>di</strong>, poggia su <strong>di</strong> un principio<br />
<strong>di</strong> pubblica utilità: si assume che l’<strong>impianto</strong> sia ben <strong>di</strong>mensionato allorché riesca a conseguire il<br />
livello <strong>di</strong> maggior convenienza possibile in termini <strong>di</strong> beneficio “pubblico”.<br />
Il secondo criterio è invece <strong>di</strong> tipo specificamente impren<strong>di</strong>toriale ed identifica il <strong>di</strong>mensionamento<br />
minimo che deve connotare l’<strong>impianto</strong> affinché il VAN dell’investimento (considerato, questa volta,<br />
come investimento a carattere privato) sia uguale od almeno superiore a zero. E’ questo un giu<strong>di</strong>zio<br />
<strong>di</strong> convenienza dell’investimento che esprime la con<strong>di</strong>zione minima ed essenziale per cui non deve<br />
verificarsi una per<strong>di</strong>ta finanziaria da parte dell’investitore ma, al contrario, l’acquisizione <strong>di</strong> un<br />
profitto.<br />
Con riferimento al primo criterio, occorre puntualizzare due importanti assunti su cui poggia<br />
l’analisi: non sono presi in considerazione gli incentivi tariffari rappresentati dai Certificati Ver<strong>di</strong><br />
(quin<strong>di</strong>, la valutazione economica riguardo la convenienza a realizzare un <strong>impianto</strong> a <strong>biomasse</strong> deve<br />
astrarsi dall’influenza esercitata dalle misure pubbliche d’intervento a sostegno delle energie<br />
rinnovabili ); non è considerata l’incidenza del carico fiscale tramite le imposte <strong>di</strong>rette (non ci si<br />
pone nell’ottica del singolo impren<strong>di</strong>tore quanto nella prospettiva del “policy maker” o del<br />
pianificatore; s’intende pertanto valutare il beneficio collettivo che scaturisce dall’investimento,<br />
senza riferimento alcuno alla figura impren<strong>di</strong>toriale specifica che lo realizza).<br />
Attraverso l’applicazione <strong>di</strong> un modello <strong>di</strong> simulazione economico, si perviene alla conclusione che<br />
l’ampiezza ottimale del bacino <strong>di</strong> approvvigionamento, a cui corrisponde un valore massimo del<br />
VAN pari a 13,25 M€, ha un raggio R pari a 40,70 km; ciò consente l’installazione <strong>di</strong> un <strong>impianto</strong><br />
della potenza elettrica Pw <strong>di</strong> 24,76 MW.<br />
Il secondo criterio che informa l’elaborazione dei prossimi scenari <strong>di</strong> simulazione, <strong>di</strong>versamente dal<br />
caso precedente, tiene conto della natura “privata” dell’investimento, operato da una società che<br />
punta alla realizzare <strong>di</strong> profitti. Perché possano maturarsi degli utili è necessario che il valore del<br />
VAN corrispondente all’investimento non sia negativo. Rispetto al caso precedente, si procede<br />
all’introduzione dell’effetto “economia <strong>di</strong> scala” (che rende l’investimento progressivamente più<br />
conveniente al crescere della sua “taglia”) nonché alla considerazione dell’incidenza della<br />
tassazione <strong>di</strong>retta. L’aliquota fiscale assunta a riferimento è pari al 40%.<br />
Attraverso l’applicazione del medesimo modello <strong>di</strong> simulazione economico, si perviene alla<br />
conclusione che l’investimento comincia a <strong>di</strong>venire economicamente vantaggioso (VAN > 0) solo<br />
per potenze elettriche superiori a 25 MW.<br />
Pertanto, è possibile affermare che il <strong>di</strong>mensionamento proposto, ossia i 25 MW <strong>di</strong> potenza elettrica<br />
lorda, è la “taglia” più appropriata anche con riferimento ad una valutazione <strong>di</strong> tipo economico.<br />
6.9 EFFETTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ED APPLICAZIONE DEL<br />
PREZZO “PLUS” DELLE BIOMASSE<br />
Operando nell’ambito del mercato nazionale dell’energia, in esso agiscono significative misure<br />
d’incentivazione; è quin<strong>di</strong> opportuno verificare l’influenza esercitata da parte del sostegno al prezzo<br />
<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dell’energia elettrica me<strong>di</strong>ante il sistema dei cosiddetti “certificati ver<strong>di</strong>”.<br />
Agritre Pag. 41<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Ancora una volta, tale influenza verrà valutata in termini d’incremento del VAN. Interpretando il<br />
requisito previsto dal Regolamento regionale sulle <strong>biomasse</strong>, occorrerà quantificare il cosiddetto<br />
prezzo plus che trasferisca almeno il 30% del maggior valore riveniente dall’incentivo.<br />
Si supponga (a titolo del tutto ipotetico) che l’incentivo tariffario ammonti a 0,14 € kWh-1; è<br />
possibile stimare che un prezzo “plus” <strong>di</strong> acquisto delle paglie fissato a 59 € per tonnellata consente<br />
<strong>di</strong> pervenire al valore “obiettivo” del VAN, in grado <strong>di</strong> trasferire almeno il 30% dei maggiori<br />
vantaggi economici legati al certificato verde dal settore “industriale” della filiera energetica a<br />
quello “agricolo” della medesima.<br />
Poiché non si è in grado <strong>di</strong> elaborare delle proiezioni atten<strong>di</strong>bili in merito al futuro regime <strong>di</strong><br />
sostegno ai prezzi dell’energia da fonte rinnovabile, è possibile affermare che, considerando valori<br />
crescenti dell’incentivo tariffario, da zero a 0,18 € kWh-1, il prezzo plus delle paglie dovrebbe<br />
crescere linearmente in risposta agli incentivi, fino a pervenire al valore <strong>di</strong> 72 € t -1.<br />
6.10 CONCLUSIONI<br />
L’ampia gamma delle valutazioni riferite nel piano <strong>di</strong> approvvigionamento, converge in modo<br />
univoco a confermare una con<strong>di</strong>zione, chiara e <strong>di</strong>fficilmente confutabile, <strong>di</strong> coerenza delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> approvvigionamento delle <strong>biomasse</strong> sia rispetto alla localizzazione dell’<strong>impianto</strong> che<br />
in rapporto alle <strong>di</strong>sponibilità locali delle risorse in paglia, frasche e sarmenti.<br />
Dagli stu<strong>di</strong> condotti, appare del tutto avvalorato il giu<strong>di</strong>zio che l’<strong>impianto</strong> in progetto risulti<br />
opportunamente <strong>di</strong>mensionato nei suoi parametri <strong>di</strong> potenza e commisurato alle effettive<br />
<strong>di</strong>sponibilità locali <strong>di</strong> <strong>biomasse</strong> cerealicole residuali.<br />
Si è avuto modo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare che l’<strong>impianto</strong> in progetto, con riferimento alle modalità <strong>di</strong><br />
approvvigionamento delle paglie, è in grado <strong>di</strong> rispettare criteri <strong>di</strong> sostenibilità ecologica e<br />
compatibilità ambientale, salvaguardando la conservazione della fertilità dei suoli, migliorando la<br />
gestione agronomica delle superfici agricole, incrementando significativamente la red<strong>di</strong>tività delle<br />
aziende (sia in presenza che in assenza del regime <strong>di</strong> sostegno alle tariffe energetiche).<br />
E’ stato inoltre identificato un “pacchetto” integrato <strong>di</strong> proposte tecnico-agronomiche utili a<br />
determinare benefiche ricadute ambientali ed aziendali in conseguenza <strong>di</strong> una virtuosa sintonia fra il<br />
settore industriale e quello agricolo della filiera energetica.<br />
Anche sul fronte prettamente economico-finanziario è stato evidenziato che la “taglia” impiantistica<br />
proposta è quella che meglio valorizza le risorse impiegate e la ricchezza generata, in termini <strong>di</strong><br />
massimizzazione del ritorno “pubblico” dell’investimento (senza cioè considerare l’effetto <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>storsione potenzialmente esercitato dagli incentivi tariffari). Allo stesso tempo vigono le<br />
con<strong>di</strong>zioni minime perché il medesimo investimento possa essere considerato profittevole da parte<br />
<strong>di</strong> un investitore privato.<br />
Agritre Pag. 42<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
7 TOPOGRAFIA, GEOLOGIA, IDROLOGIA, PAESAGGIO E<br />
AMBIENTE<br />
7.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROLOGICO DELL’AREA<br />
L’area in stu<strong>di</strong>o, compresa nel territorio del Subappennino Dauno, tra le quote <strong>di</strong> circa 320 e 330<br />
metri s.l.m.m. appare come un’area pianeggiante degradante dolcemente verso sud.<br />
Il territorio <strong>di</strong> competenza del Subappennino Dauno comprende una serie <strong>di</strong> affioramenti<br />
cronologicamente compresi fra il Cretaceo-Paleogene e l'Olocene, con varie formazioni ed una<br />
litologia estremamente varia. Al periodo più antico appartengono le formazioni riferibili, in base<br />
alla microfauna in esse contenuta, al Cretaceo-Paleogene e rappresentate dal complesso<br />
in<strong>di</strong>fferenziato, costituito prevalentemente da argille e marne a forte componente siltosa, grigie e<br />
vari colori, il cui strato <strong>di</strong> costipazione e scistosità varia notevolmente. Queste argille sono<br />
affiancate da complessi <strong>di</strong> strati calcarei, calcareo-marnosi e calcarenitici con intercalazioni <strong>di</strong><br />
brecce calcaree, arenarie, pud<strong>di</strong>nghe e, in misura minore, <strong>di</strong>aspri e scisti <strong>di</strong>asprigni.<br />
Il territorio <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è ricoperto prevalentemente da terreni sabbiosi <strong>di</strong> età Plio-Pleistocenica, solo a<br />
sud ovest affiorano rocce pre-plioceniche con facies <strong>di</strong> “flysch” specialmente nelle pen<strong>di</strong>ci dei<br />
rilievi della Daunia e <strong>di</strong> Melfi.<br />
I rilievi collinari della zona dei “Flysch” raggiungono quote intorno a 500 metri s.l.m..<br />
Poiché i se<strong>di</strong>menti danno origine a rilievi essenzialmente argillosi, la morfologia è dolce e i fianchi<br />
delle colline scendono con moderato pen<strong>di</strong>o.<br />
Solo la sommità <strong>di</strong> alcune alture si mostra aspra e scoscesa in corrispondenza <strong>di</strong> limitati<br />
affioramenti <strong>di</strong> calcari, brecce e arenarie me<strong>di</strong>amente compatte. Nei territorio ad Ovest <strong>di</strong><br />
Sant’agata la morfologia è quella propria <strong>di</strong> tutta la capitanata con vaste spianate inclinate<br />
debolmente verso il mare interrotte da valli ampie, solcate da torrenti e canali che con<strong>di</strong>zionano e<br />
rendono ripi<strong>di</strong> i versanti.<br />
Nell’area in esame si possono in<strong>di</strong>viduare due blocchi riferibili cronologicamente ad altrettanti<br />
perio<strong>di</strong>.<br />
Agritre Pag. 43<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Il primo, più antico, interessa la serie dei depositi prepliocenici, mentre il secondo è caratterizzato<br />
dalla presenza della serie plio-pleistocenica che ricopre gran parte dell’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Esso tra<br />
l’altro risulta essere il terreno fondale dell’intervento <strong>di</strong> progetto pertanto sarà descritto<br />
dettagliatamente. Si tratta complessivamente <strong>di</strong> una serie sabbiosa-argillosa con episo<strong>di</strong><br />
conglomeratici alla base ed alla sommità. Pertanto essa rappresenta un intero ed unico ciclo<br />
se<strong>di</strong>mentario anche se i termini più alti possono comprendere episo<strong>di</strong> secondari <strong>di</strong> variazioni<br />
eustatiche e <strong>di</strong> alluvionamento.<br />
La stratigrafia dell’area è così composta:<br />
• CONGLOMERATI POLIGENICI DI BASE, FORTEMENTE CEMENTATI ( Pp)<br />
• SABBIE DI COLORE GIALLO BRUNO CON LENTI CIOTTOLOSE, LOCALMENTE<br />
FOSSILIFERE (Ps)<br />
• ARGILLE E ARGILLE MARNOSE GRIGIO-AZZURROGNOLE, LOCALMENTE<br />
SABBIOSE (PQa)<br />
• SABBIE E SABBIE ARGILLOSE A VOLTE CON LIVELLI ARENACI GIALLASTRI<br />
E LENTI CIOTTOLOSE (PQs)<br />
• CONGLOMERATI POLIGENICI CON CIOTTOLI DI MEDIE E GRANDI<br />
DIMENSIONI: A VOLTE FORTEMENTE CEMENTATI E CON INTERCALAZIONI DI<br />
SABBIE E ARENARIE (QC1)<br />
• CIOTTOLAME INCOERENTE CON INTERCALAZIONI SABBIOSE (QC2)<br />
Agritre Pag. 44<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Stralcio carta geologica dell’area <strong>di</strong> intervento –Foglio 175<br />
Al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> tale unità che rappresenta il terreno che <strong>di</strong>rettamente interagirà con le strutture <strong>di</strong><br />
fondazione delle opere in progetto e fino alla profon<strong>di</strong>tà investigate (circa 15 metri), rinveniamo le<br />
Argille limose <strong>di</strong> colore grigio azzurro. Allo stato attuale, non si evidenziano fattori riconducibili a<br />
fenomeni <strong>di</strong> natura geostatica che implichino mo<strong>di</strong>fiche degli equilibri raggiunti.<br />
Il rilevamento geologico e geomorfologico <strong>di</strong> dettaglio, i dati bibliografici e l’analisi <strong>di</strong> indagini<br />
eseguite nell’area d’esame, hanno permesso la ricostruzione stratigrafica dalla quale si è evinto che<br />
la totalità dell’area è interessata dall’affioramento <strong>di</strong> terreno vegetale che ricopre limo argilloso e<br />
sabbioso intercalato da vari livelli <strong>di</strong> brecce calcaree fino ad una profon<strong>di</strong>tà me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 7.00 metri dal<br />
p.c..<br />
L’intervento da effettuare nell’area <strong>di</strong> indagine è compatibilmente confacente all’assetto<br />
morfostrutturale dell’area, alle caratteristiche fisico-meccaniche dei litotipi riconosciuti, alle<br />
con<strong>di</strong>zioni geologiche.<br />
Secondo la nuova classificazione sismica dei comuni italiani il territorio <strong>di</strong> Sant’Agata <strong>di</strong> Puglia,<br />
rientra nelle “Zone sismiche 1”. (Cfr. Carta Zone Sismiche)<br />
Agritre Pag. 45<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista idrogeologico l’area è caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> reticoli fluviali giovani<br />
(torrenti e valloni), caratterizzati da alvei in modellamento attivo, orientati in <strong>di</strong>rezione NW-SE con<br />
bacino idrografico in continua evoluzione morfo-strutturale.<br />
I principali torrenti sono:<br />
• T. Calaggio<br />
• T. Fugno.<br />
Il torrente Calaggio nasce nel Vallone della Toppa, presso il monte La Forma (m 864) e col torrente<br />
S. Gennaro forma il torrente Carapelle. Delimitando il confine con il territorio <strong>di</strong> Rocchetta<br />
Sant’Antonio, riceve, da sinistra, il suo principale affluente, il torrente Fugno.<br />
Il torrente Fugno nasce presso Anzano <strong>di</strong> Puglia sul versante opposto al torrente Fiumarella ed<br />
attraversa la zona centro-settentrionale del comune, a nord della città. Alimentato dalle acque della<br />
Valle <strong>di</strong> Fassa, dal Vallone del Salice e dalla Sorgente del Porcaro a destra e dalla Valle delle Coste<br />
e dal torrente Carpanito, a sinistra, il Frugno lambisce il confine <strong>di</strong> Acca<strong>di</strong>a, fino a riversarsi nel<br />
Calaggio, dopo Fontana il Piscilo.<br />
Il regime idraulico del corso d’acqua è torrentizio ed essenzialmente <strong>di</strong>pendente dalle fasi<br />
stagionali.<br />
Il sito in oggetto ricade in un’area che si colloca in corrispondenza <strong>di</strong> una blanda struttura<br />
anticlinalica delimitata a sud da una struttura valliva <strong>di</strong> probabile genesi fluviolacustre, che<br />
attualmente ospita del Canale Colotti, affluente del T.Carapelle, a Nord invece il F.so Viticone<br />
affluente del T.Carapelle.<br />
L’acquifero presente, pur essendo dotato <strong>di</strong> permeabilità <strong>di</strong>screte, non è localmente dotato <strong>di</strong><br />
importanti volumi delle riserve regolatrici limitando la portata dei pozzi presenti nell’area a 0,5-1,5<br />
lit./sec.; la quota piezometrica si attesta me<strong>di</strong>amente intorno ai 45-80 metri dal piano <strong>di</strong> campagna.<br />
Non sono visibili in sito morfosculture attive ad opera <strong>di</strong> acque selvagge né in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> movimenti<br />
plastici <strong>di</strong> massa ad opera della gravità (soliflusso, creep). In sito i processi attivi <strong>di</strong> evoluzione e<br />
rimodellamento morfologico (che si attuano essenzialmente ad opera degli agenti esogeni naturali e<br />
della gravità) si svolgono in forma marginale o ad<strong>di</strong>rittura nulla (per l’assenza <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>enti<br />
topografici ed idraulici significativi e scarsità <strong>di</strong> circolazioni attive delle acquemeteoriche).<br />
Gli interventi previsti negli elaborati progettuali, dal punto <strong>di</strong> vista geologico, sono pertanto fattibili.<br />
Agritre Pag. 46<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista morfologico generale l'area interessata dall'<strong>impianto</strong> è definibile come zona<br />
apicale delle alture costituente il paesaggio che nel complesso risulta essere <strong>di</strong> bassa collina, con<br />
topografia blandamente ondulata che si colloca, nello specifico, in un contesto morfologico generale<br />
<strong>di</strong> origine fluviolacustre. Le aree esaminate fungono in generale da spartiacque superficiali<br />
delineando le geometrie dei vari bacini idrografici che recapitano a fondovalle (negli impluvi<br />
naturali).<br />
La natura litologica, prevalentemente composta da elementi litoi<strong>di</strong> in matrice anidra talvolta<br />
cementata, dei terreni presenti ostacola, nelle aree <strong>di</strong> interesse, lo sviluppo <strong>di</strong> processi erosivi attivi;<br />
pertanto il risultato è che ci si trova <strong>di</strong> fronte ad una morfologia caratterizzata, in generale, da profili<br />
topografici arrotondati e regolari.<br />
Le aree esaminate si collocano in corrispondenza <strong>di</strong> spartiacque superficiali, con pendenze poco<br />
spinte, in cui la circolazione idrica superficiale ha caratteristiche idrauliche poco attive, basse<br />
velocità idrauliche, assenza <strong>di</strong> carico solido e scarsità <strong>di</strong> potere erosivo.<br />
Le acque corrive svolgono occasionalmente solo una certa azione <strong>di</strong> ruscellamento superficiale<br />
<strong>di</strong>ffuso <strong>di</strong> tipo essenzialmente laminare. La debole pendenza topografica presente in corrispondenza<br />
della maggior parte delle postazioni garantisce, nei riguar<strong>di</strong> delle erosioni lineari, spinte nulle o<br />
assenti con azioni erosive ascrivibili alle azioni delle acque meteoriche limitate alla reptazione. I<br />
singoli siti esaminati sono pertanto stabili.<br />
7.2 PAESAGGIO<br />
Il paesaggio può essere inteso come luogo <strong>di</strong> aggregazione del mondo fisico, formato da un<br />
complesso <strong>di</strong> beni ambientali e antropico-culturali e dalle relazioni che li correlano.<br />
L’analisi del paesaggio, è legata al rapporto tra oggetto (il territorio) e soggetto (l’osservatore); da<br />
questo rapporto, nasce il legame percettivo <strong>di</strong> cui è sfondo il paesaggio.<br />
Definire il paesaggio e le sue componenti è operazione complessa.<br />
Oggetto <strong>di</strong> molteplici stu<strong>di</strong>, interpretazioni, <strong>di</strong>scussioni, la definizione <strong>di</strong> paesaggio non può che<br />
essere "convenzionale”, correlata cioè al contesto “<strong>di</strong>sciplinare” (inteso come settore culturale e/o<br />
operativo) entro cui essa stessa si colloca.<br />
I <strong>di</strong>versi “tipi” <strong>di</strong> paesaggio sono definibili come:<br />
• paesaggio naturale: spazio inviolato dall’azione dell’uomo e con flora e fauna naturali<br />
sviluppate spontaneamente;<br />
Agritre Pag. 47<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• paesaggio seminaturale: spazio con flora e fauna naturali che, per azione antropica,<br />
<strong>di</strong>fferiscono dalle specie iniziali;<br />
• luogo culturale: spazio caratterizzato dall’attività dell’uomo (le <strong>di</strong>fferenze con la<br />
situazione naturale sono il risultato <strong>di</strong> azioni volute);<br />
• valore naturale: valore delle caratteristiche naturaIi <strong>di</strong> uno spazio che permangono dopo le<br />
attività trasformatrici dell’uomo (specie animali e <strong>vegetali</strong>, biotopi, geotopi);<br />
• valore culturale: valore delle caratteristiche <strong>di</strong> uno spazio dovute all'inse<strong>di</strong>amento umano<br />
(e<strong>di</strong>ficazione e infrastrutturazione, strutture storiche,reperti archeologici);<br />
• valore estetico: valore da correlarsi sua accezione sociale (psicologico/culturale).<br />
Nel quadro delle componenti fisiche che determinano il valore estetico <strong>di</strong> un paesaggio figurano: la<br />
sua configurazione, cioè il modo con il quale il paesaggio e i suoi elementi naturali e artificiali si<br />
manifestano all’osservatore; la struttura geomorfologica; il livello <strong>di</strong> silenzio ed i <strong>di</strong>versi<br />
suoni/rumori; i cromatismi.<br />
La definizione data della componente “paesaggio” nell’ambito del Piano Urbanistico Territoriale<br />
Tematico/Paesaggio della Regione Puglia (Piano Paesistico ai sensi della 431/85), è quella <strong>di</strong> “un<br />
insieme integrale concreto, un insieme geografico in<strong>di</strong>ssociabile che evolve in blocco sia sotto<br />
l’effetto delle interazioni tra gli elementi che lo costituiscono, sia sotto quello della <strong>di</strong>namica<br />
propria <strong>di</strong> ognuno degli elementi considerati separatamente”.<br />
L’analisi del paesaggio e quin<strong>di</strong> la sua definizione, non può essere elaborata in termini<br />
scientificamente corretti se non attraverso l’in<strong>di</strong>viduazione ed il riconoscimento analitico delle sue<br />
componenti intese quali elementi costitutivi principali.<br />
Il paesaggio può essere considerato l’aspetto visibile <strong>di</strong> un ambiente, in quanto rivela esteriormente<br />
i caratteri intrinseci delle singole componenti.<br />
Quin<strong>di</strong> una analisi del paesaggio, <strong>di</strong>viene lo specchio <strong>di</strong> una analisi dell’ambiente.<br />
Da quanto precedentemente enunciato, si ritiene non corretto relegare e limitare uno stu<strong>di</strong>o sul<br />
paesaggio ad una semplice verifica degli elementi percettivi o visivi del paesaggio.<br />
Oltre alla analisi delle visuali, dell’aspetto fisico e percettivo delle immagini e delle forme <strong>di</strong><br />
paesaggio, uno stu<strong>di</strong>o paesaggistico deve occuparsi anche <strong>di</strong> indagare tutte le componenti naturali e<br />
antropiche e ed i loro rapporti.<br />
Il territorio rurale è interessato da una moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> testimonianze storico-archeologicoarchitettoniche.<br />
Ne sono prova i villaggi rupestri, le necropoli, le chiese rupestri, i muretti a secco, i<br />
tratturi, le masserie fortificate.<br />
Agritre Pag. 48<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
L'articolazione tipologica, il numero e l’importanza documentaria e paesaggistica <strong>di</strong> tali presenze<br />
autorizza (specialmente per le masserie) a in<strong>di</strong>viduare sul territorio una serie <strong>di</strong> sistemi extraurbani<br />
(quello delle masserie, delle torri, etc.), da salvaguardare attraverso la “valorizzazione” dei beni che<br />
li costituiscono. Ma questi, quasi tutti <strong>di</strong> proprietà privata, esclusi da qualsiasi ciclo economico che<br />
ne giustifichi l’utilizzazione, sono in larghissima misura abbandonati e sottoposti a rapido degrado.<br />
In agro Sant’Agata <strong>di</strong> Puglia le masserie, originariamente circondate da un latifondo in cui si<br />
sviluppavano attività agricole reciprocamente complementari, oggi sono inserite in un ambiente<br />
privo <strong>di</strong> <strong>di</strong>more permanenti. Generalmente, sono del tipo a due piani con l’abitazione sovrapposta al<br />
rustico, con garitte pensili e ca<strong>di</strong>toie, oppure del tipo a ”torre” a due piani su base quadrata (usata<br />
come abitazione temporanea e legata alla conduzione degli oliveti e dei mandorleti), dotata <strong>di</strong><br />
ca<strong>di</strong>toie dal parapetto del terrazzo, con o senza recinto.<br />
All’interno della perimetrazione così come nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze, le forme <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione sono<br />
unicamente rappresentate da case sparse <strong>di</strong>ffuse nel territorio.<br />
Ricerche bibliografiche insieme a ricognizioni su campo sembrano escludere la presenza nell’area<br />
interessata dalla realizzazione dell’<strong>impianto</strong> <strong>di</strong> emergenze storiche o archeologiche <strong>di</strong> pregio tranne<br />
la presenza <strong>di</strong> masserie del XIX-XX secolo quali la Masseria Ciommarino a circa 750 m<br />
dall’<strong>impianto</strong> , Masseria Viticone a circa 600 m dall’<strong>impianto</strong>.<br />
In merito all’antropizzazione, prima considerata dal punto <strong>di</strong> vista dell’e<strong>di</strong>ficazione, la stessa deve<br />
essere considerata anche in riferimento alla vegetazione: la presenza, infatti, <strong>di</strong> aree a seminativo<br />
definisce queste come aree antropizzate poiché sottoposte a pratiche <strong>di</strong> <strong>di</strong>sserbo, aratura e,<br />
comunque, a tutto quanto necessario alla coltivazione. Queste sono quin<strong>di</strong> aree a bassa naturalità.<br />
Molto poco interessanti dal punto <strong>di</strong> vista vegetazionale oltre che paesaggistico, sono le aree a<br />
seminativo, che occupano la totalità della superficie all’interno dell’area in esame. La mancanza <strong>di</strong><br />
elementi paesaggistici <strong>di</strong> pregio viene avvalorata e confermata da quanto emerge dallo stu<strong>di</strong>o del<br />
PUTT/P, definendo un paesaggio prettamente agricolo.<br />
In relazione alle analisi condotte è possibile asserire che il paesaggio è in grado <strong>di</strong> accettare <strong>di</strong>versi<br />
tipi <strong>di</strong> intervento, purché si rispettino determinate linee <strong>di</strong> comportamento, che permettano <strong>di</strong> restare<br />
al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> verificabili limiti <strong>di</strong> impatto.<br />
Al fine <strong>di</strong> rendere ugualmente minimo l’impatto visivo delle varie strutture del progetto e perseguire<br />
la migliore integrazione dell’intero <strong>impianto</strong> nel paesaggio è necessario adottare delle misure che<br />
mitighino l’impatto sul territorio e nel tempo stesso sulla flora e sulla fauna.<br />
Le scelte progettuali da adottare consistono:<br />
Agritre Pag. 49<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
I colori delle facciate esterne dei fabbricati, compresi quelli destinati ad ospitare gli impianti,<br />
dovranno essere tenui e scelti tra le tipiche tonalità in uso per l’e<strong>di</strong>lizia rurale tra<strong>di</strong>zionale, al fine <strong>di</strong><br />
ridurne la visibilità<br />
sistemazione con piantumazioni nell’area perimetrale dell’<strong>impianto</strong> con essenze arbustive autoctone<br />
al fine <strong>di</strong> attenuare il più possibile la <strong>di</strong>scontinuità tra opere tecnologiche ed ambiente circostante;<br />
è preferibile utilizzare sistemi <strong>di</strong> recinzione <strong>vegetali</strong>, tipo siepi. Nel caso <strong>di</strong> recinzione artificiale,<br />
con reti metalliche o grigliati è preferibile l’utilizzo <strong>di</strong> strutture ad infissione anziché cordoli <strong>di</strong><br />
fondazione.<br />
le <strong>di</strong>rettrici dei cavidotti, interni ed esterni all’<strong>impianto</strong>, seguiranno i percorsi delle vie <strong>di</strong><br />
circolazione, al fine <strong>di</strong> ridurre gli scavi per la loro messa in opera;<br />
massimizzazione delle <strong>di</strong>stanze dell’<strong>impianto</strong> da unità abitative regolarmente censite e stabilmente<br />
abitate.<br />
8 ASPETTI ECONOMICI ED OCCUPAZIONALI<br />
Il progetto per l’<strong>impianto</strong> <strong>di</strong> Sant’Agata <strong>di</strong> Puglia prevede un investimento complessivo superiore a<br />
80 milioni <strong>di</strong> €.<br />
Questo investimento permetterà <strong>di</strong> realizzare un’opera importante dal punto <strong>di</strong> vista energetico che<br />
fornirà il suo contributo in un contesto nazionale che punta al raggiungimento dell’obiettivo <strong>di</strong> un<br />
parco <strong>di</strong> generazione elettrica più <strong>di</strong>versificato ed efficiente.<br />
Ma l’iniziativa appare, per il contesto in cui sarà inserita, anche una grande occasione <strong>di</strong> sviluppo<br />
tecnologico e professionale dalle importanti ricadute occupazionali e <strong>di</strong> crescita sociale ed<br />
economica del territorio.<br />
I lavori per la realizzazione dello stabilimento avranno una durata stimata <strong>di</strong> 28 mesi, periodo<br />
durante il quale verrà garantita un’occupazione me<strong>di</strong>a nell’or<strong>di</strong>ne delle 40-50 unità al giorno,<br />
coinvolgendo all’incirca 300 addetti, per la realizzazione delle opere civili e per il montaggio delle<br />
apparecchiature elettromeccaniche e degli impianti elettrici.<br />
Una volta entrata in esercizio, l’<strong>impianto</strong> creerà, a regime, almeno 35 nuovi posti <strong>di</strong> lavori stabili e<br />
<strong>di</strong>retti. Si tratta <strong>di</strong> tutte quelle persone, assunte e formate appositamente, cui sarà demandata la<br />
gestione ed il controllo dell’<strong>impianto</strong>.<br />
Il personale <strong>di</strong> cui avrà bisogno la centrale avrà competenze, qualifiche e mansioni, <strong>di</strong>versificate.<br />
Oltre alla figura <strong>di</strong> capo <strong>impianto</strong> e <strong>di</strong> un vice capo <strong>impianto</strong>, verranno impiegati turnisti addetti alle<br />
Agritre Pag. 50<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
varie fasi del ciclo <strong>di</strong> lavorazione, oltre a personale con funzioni <strong>di</strong> staff (segreteria,<br />
amministrazione, controlli ambientali e strumentali).<br />
I lavoratori saranno impegnati sia con orario <strong>di</strong> ufficio che su turni <strong>di</strong> lavoro tali da garantire<br />
l’operatività della centrale 24 ore al giorno.<br />
Agli occupati <strong>di</strong>rettamente assunti dalla società devono essere aggiunti un numero significativo <strong>di</strong><br />
persone – sempre impiegate su base continuativa - nell’indotto per le seguenti attività <strong>di</strong> servizio<br />
alla centrale:<br />
trasporto dei materiali in entrata ed uscita dalla centrale;<br />
attività <strong>di</strong> manutenzione e controllo;<br />
pulizia e guar<strong>di</strong>ania;<br />
mensa.<br />
Non è poi da sottovalutare il contributo, sia in termini occupazionali che <strong>di</strong> creazione <strong>di</strong> opportunità<br />
<strong>di</strong> sviluppo economico, che può dare la centrale con lo stimolo per l’organizzazione stabile e<br />
permanente della filiera locale delle <strong>biomasse</strong>.<br />
Da questo punto <strong>di</strong> vista si aprono, infatti, interessanti prospettive almeno su due fronti:<br />
organizzazione dei servizi <strong>di</strong> supporto per l’incontro fra la domanda <strong>di</strong> biomassa e l’offerta <strong>di</strong><br />
materiale presente nell’area;<br />
riconversioni culturali <strong>di</strong> terreni agricoli da destinare a seminativi energetici.<br />
Si ritiene infatti che ci sia ampio spazio per la costituzione <strong>di</strong> imprese e cooperative per<br />
l’organizzazione <strong>di</strong> attività impren<strong>di</strong>toriali permanenti sviluppate localmente e finalizzate a<br />
garantire un servizio efficiente e continuativo sul fronte dell’offerta <strong>di</strong> biomassa.<br />
8.1 ADDESTRAMENTO E SERVIZI TECNICI<br />
Prima dell’avviamento dell’<strong>impianto</strong> ciascun Fornitore dovrà provvedere all’addestramento<br />
complessivo del personale su tutto ciò che riguarda l'esercizio e la manutenzione dell’<strong>impianto</strong> e <strong>di</strong><br />
tutti i sistemi forniti.<br />
Il programma <strong>di</strong> addestramento sarà progettato ed eseguito per preparare il personale ad esercire la<br />
Centrale in sicurezza e affidabilità. In relazione a quanto sopra il programma <strong>di</strong> addestramento<br />
dovrà prevedere due <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> percorso formativo, volte a qualificare personale <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa<br />
professionalità:<br />
• Tipo A - Personale <strong>di</strong> Esercizio dell’<strong>impianto</strong><br />
Agritre Pag. 51<br />
Relazione Descrittiva Generale
Doc. No. SAG-00-P-016-2<br />
Rev. 2 – Giugno 2011<br />
• Tipo B - Personale <strong>di</strong> Manutenzione dell’<strong>impianto</strong><br />
L'addestramento dei due gruppi dovrà essere condotto con riguardo specifico alle <strong>di</strong>verse aree <strong>di</strong><br />
competenza <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi; per ciascun tipo <strong>di</strong> addestramento dovranno essere previste sessioni<br />
complete <strong>di</strong> formazione da tenersi in perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> tempo contigui, in date da concordare.<br />
Il programma <strong>di</strong> addestramento sarà strutturato in tre fasi separate:<br />
• addestramento teorico in sede, incluso la descrizione dell’<strong>impianto</strong>, suoi Componenti /<br />
Sistemi e suoi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> funzionamento;<br />
• addestramento sul campo con il supporto del personale <strong>di</strong> avviamento dei vari Fornitori,<br />
durante le fasi <strong>di</strong> avviamento e messa in servizio;<br />
• addestramento sul campo e precisamente nella sala controllo con il supporto del personale<br />
<strong>di</strong> avviamento del Fornitore durante le prove funzionali dell’<strong>impianto</strong> e per il periodo <strong>di</strong> esercizio<br />
precedente il Taking Over Tests.<br />
Il programma sarà elaborato in modo tale che la fase <strong>di</strong> teoria sia completata prima dell’inizio delle<br />
più importanti fasi <strong>di</strong> avviamento.<br />
Si fornirà 3 mesi prima della data <strong>di</strong> inizio dei corsi, una descrizione particolareggiata degli scopi<br />
dell’addestramento.<br />
Come parte dello scopo del Lavoro, il Fornitore preparerà i Manuali <strong>di</strong> addestramento che saranno<br />
consegnati in copie sufficienti per essere forniti a ciascun partecipante almeno 4 settimane prima<br />
dell’inizio del programma stesso. I Manuali <strong>di</strong> addestramento saranno strutturati per aumentare<br />
l'efficienza dell’addestramento; documenti <strong>di</strong> progetto possono essere inclusi come parte del<br />
Manuale, ma non è considerata accettabile la mera raccolta <strong>di</strong> documenti.<br />
I corsi saranno tenuti in lingua italiana, i manuali <strong>di</strong> addestramento saranno preparati in lingua<br />
italiana e saranno, inoltre, fornite tutte le facilities (proiettori, lavagne, TV, etc se necessario)<br />
necessarie per effettuare l’addestramento in sito.<br />
Verrà inoltre un corso <strong>di</strong> informazione / formazione rivolto al personale non tecnico dell’<strong>impianto</strong><br />
de<strong>di</strong>cato alla descrizione generale dell’<strong>impianto</strong> e dei suoi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> funzionamento con particolare<br />
riguardo ai criteri della sicurezza e della protezione ambientale. Per questa categoria <strong>di</strong> personale<br />
dovrà essere approntata una documentazione sintetica relativa agli argomenti trattati.<br />
Agritre Pag. 52<br />
Relazione Descrittiva Generale