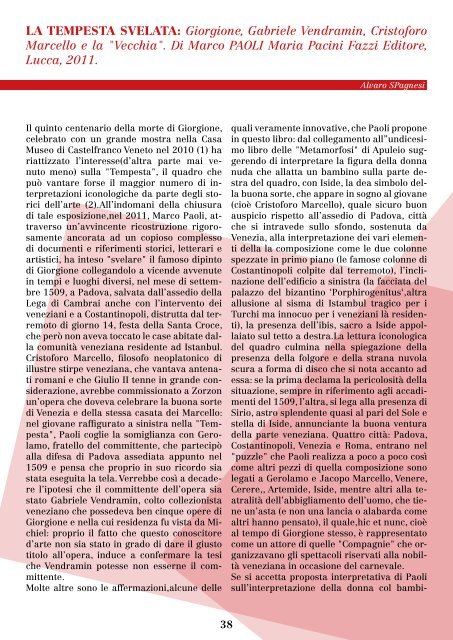ARCHEOMODERNITAS Rivista semestrale di Ineffabili fatti d'Arte nr.1
Il neologismo “ARCHEOMODERNITAS" che intitola la rivista, allude al processo che muove la ricerca artistica nell’ambito della tradizione creativa avvalendosi dell’esempio e dell’afflato del passato ma si connette funzionalmente e organicamente al patrimonio linguistico-espressivo del panorama contemporaneo all’epoca in cui tale processo si produce... www.exstudentiaccademiabellearti.org
Il neologismo “ARCHEOMODERNITAS" che intitola la rivista, allude al processo che muove la ricerca artistica nell’ambito della tradizione creativa avvalendosi dell’esempio e dell’afflato del passato ma si connette funzionalmente e organicamente al patrimonio linguistico-espressivo del panorama contemporaneo all’epoca in cui tale processo si produce... www.exstudentiaccademiabellearti.org
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LA TEMPESTA SVELATA: Giorgione, Gabriele Vendramin, Cristoforo<br />
Marcello e la "Vecchia". Di Marco PAOLI Maria Pacini Fazzi E<strong>di</strong>tore,<br />
Lucca, 2011.<br />
Il quinto centenario della morte <strong>di</strong> Giorgione,<br />
celebrato con un grande mostra nella Casa<br />
Museo <strong>di</strong> Castelfranco Veneto nel 2010 (1) ha<br />
riattizzato l’interesse(d’altra parte mai venuto<br />
meno) sulla "Tempesta", il quadro che<br />
può vantare forse il maggior numero <strong>di</strong> interpretazioni<br />
iconologiche da parte degli storici<br />
dell’arte (2).All’indomani della chiusura<br />
<strong>di</strong> tale esposizione,nel 2011, Marco Paoli, attraverso<br />
un’avvincente ricostruzione rigorosamente<br />
ancorata ad un copioso complesso<br />
<strong>di</strong> documenti e riferimenti storici, letterari e<br />
artistici, ha inteso "svelare" il famoso <strong>di</strong>pinto<br />
<strong>di</strong> Giorgione collegandolo a vicende avvenute<br />
in tempi e luoghi <strong>di</strong>versi, nel mese <strong>di</strong> settembre<br />
1509, a Padova, salvata dall’asse<strong>di</strong>o della<br />
Lega <strong>di</strong> Cambrai anche con l’intervento dei<br />
veneziani e a Costantinopoli, <strong>di</strong>strutta dal terremoto<br />
<strong>di</strong> giorno 14, festa della Santa Croce,<br />
che però non aveva toccato le case abitate dalla<br />
comunità veneziana residente ad Istanbul.<br />
Cristoforo Marcello, filosofo neoplatonico <strong>di</strong><br />
illustre stirpe veneziana, che vantava antenati<br />
romani e che Giulio II tenne in grande considerazione,<br />
avrebbe commissionato a Zorzon<br />
un’opera che doveva celebrare la buona sorte<br />
<strong>di</strong> Venezia e della stessa casata dei Marcello:<br />
nel giovane raffigurato a sinistra nella "Tempesta",<br />
Paoli coglie la somiglianza con Gerolamo,<br />
fratello del committente, che partecipò<br />
alla <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> Padova asse<strong>di</strong>ata appunto nel<br />
1509 e pensa che proprio in suo ricordo sia<br />
stata eseguita la tela. Verrebbe così a decadere<br />
l’ipotesi che il committente dell’opera sia<br />
stato Gabriele Vendramin, colto collezionista<br />
veneziano che possedeva ben cinque opere <strong>di</strong><br />
Giorgione e nella cui residenza fu vista da Michiel:<br />
proprio il fatto che questo conoscitore<br />
d’arte non sia stato in grado <strong>di</strong> dare il giusto<br />
titolo all’opera, induce a confermare la tesi<br />
che Vendramin potesse non esserne il committente.<br />
Molte altre sono le affermazioni,alcune delle<br />
Alvaro SPagnesi<br />
quali veramente innovative, che Paoli propone<br />
in questo libro: dal collegamento all’’un<strong>di</strong>cesimo<br />
libro delle "Metamorfosi" <strong>di</strong> Apuleio suggerendo<br />
<strong>di</strong> interpretare la figura della donna<br />
nuda che allatta un bambino sulla parte destra<br />
del quadro, con Iside, la dea simbolo della<br />
buona sorte, che appare in sogno al giovane<br />
(cioè Cristoforo Marcello), quale sicuro buon<br />
auspicio rispetto all’asse<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Padova, città<br />
che si intravede sullo sfondo, sostenuta da<br />
Venezia, alla interpretazione dei vari elementi<br />
della la composizione come le due colonne<br />
spezzate in primo piano (le famose colonne <strong>di</strong><br />
Costantinopoli colpite dal terremoto), l’inclinazione<br />
dell’e<strong>di</strong>ficio a sinistra (la facciata del<br />
palazzo del bizantino ‘Porphirogenitus‘,altra<br />
allusione al sisma <strong>di</strong> Istambul tragico per i<br />
Turchi ma innocuo per i veneziani là residenti),<br />
la presenza dell’ibis, sacro a Iside appollaiato<br />
sul tetto a destra.La lettura iconologica<br />
del quadro culmina nella spiegazione della<br />
presenza della folgore e della strana nuvola<br />
scura a forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>sco che si nota accanto ad<br />
essa: se la prima declama la pericolosità della<br />
situazione, sempre in riferimento agli acca<strong>di</strong>menti<br />
del 1509, l’altra, si lega alla presenza <strong>di</strong><br />
Sirio, astro splendente quasi al pari del Sole e<br />
stella <strong>di</strong> Iside, annunciante la buona ventura<br />
della parte veneziana. Quattro città: Padova,<br />
Costantinopoli, Venezia e Roma, entrano nel<br />
"puzzle" che Paoli realizza a poco a poco così<br />
come altri pezzi <strong>di</strong> quella composizione sono<br />
legati a Gerolamo e Jacopo Marcello, Venere,<br />
Cerere,, Artemide, Iside, mentre altri alla teatralità<br />
dell’abbigliamento dell’uomo, che tiene<br />
un’asta (e non una lancia o alabarda come<br />
altri hanno pensato), il quale,hic et nunc, cioè<br />
al tempo <strong>di</strong> Giorgione stesso, è rappresentato<br />
come un attore <strong>di</strong> quelle "Compagnie" che organizzavano<br />
gli spettacoli riservati alla nobiltà<br />
veneziana in occasione del carnevale.<br />
Se si accetta proposta interpretativa <strong>di</strong> Paoli<br />
sull’interpretazione della donna col bambino<br />
quale Iside che allatta, è possibile anche<br />
reinterpretare alcuni elementi che Paoli non<br />
prende in considerazione ma per altri avevano<br />
molto peso: Salvatore Settis, per confermare<br />
la sua ipotesi rispetto alle due figure umane<br />
della "Tempesta"(per lui Adamo ed Eva),<br />
enfatizza la presenza del "serpe" che entra<br />
in una tana in asse col calcagno della donna<br />
nuda, sopra <strong>di</strong> esso. Paoli liquida tale elemento<br />
del quadro con rapi<strong>di</strong>tà e nonchalanche:"si<br />
tratta, in realtà, della ra<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> un arbusto" e<br />
rimanda a due stu<strong>di</strong>osi che così lo classificano<br />
non ritenendo tale particolare degno <strong>di</strong> e forse<br />
vedendolo come un dato paesistico al pari<br />
dei sassolini chiari sparsi nei <strong>di</strong>ntorni (3).<br />
Ma in un contesto tanto articolato e complesso<br />
niente viene <strong>di</strong>pinto "a caso" e quin<strong>di</strong> anche<br />
un ra<strong>di</strong>ce sviluppata al <strong>di</strong> sopra del suolo, che<br />
sembra la coda <strong>di</strong> un serpente che penetra<br />
in un anfratto del terreno, specialmente se si<br />
impone così nettamente allo sguardo, deve essere<br />
esaminata con scrupolo prima <strong>di</strong> essere<br />
accantonata.Valutando l'ipotesi "serpente" in<br />
riferimento alla figura <strong>di</strong> Iside, la mente corre<br />
imme<strong>di</strong>atamente all’Uroborus della mitologia<br />
egizia che negli antichi misteri raffigura l’anello<br />
<strong>di</strong> congiunzione fra le quattro <strong>di</strong>vinità<br />
cosmiche: Sithis, Iside, Osiride e Horus.<br />
Il rettile effigiato in<strong>fatti</strong> "ad anello" mentre si<br />
<strong>di</strong>vora la coda, (oura "coda" e boros "<strong>di</strong>vorante"),<br />
sta a significare come la continuità sia<br />
conseguenza necessaria del movimento. Se un<br />
serpente dovesse esserci nel quadro dovrebbe<br />
essere rapportato a Iside (come l’ibis sul<br />
tetto) tra l’altro la dea è vista talvolta come<br />
cobra o comunque con serpenti sul corpo o<br />
sulla testa.(4)<br />
Ma il serpe, qui presente solo quale rettile<br />
strisciante <strong>di</strong> cui è possibile vedere esclusivamente<br />
la coda, perderebbe ogni connessione<br />
con la dea egizia e quin<strong>di</strong> dovrebbe essere<br />
stato inserito nella complessa figurazione<br />
giorgionesca soprattutto per le sue le caratteristiche<br />
legate al ciclo vitale <strong>di</strong> cui, una volta<br />
accettata questa ipotesi, potremmo vedere<br />
esito simbolico nei due arbusti che lo sovrastano:<br />
secco quello <strong>di</strong> sinistra,vivo e florido l’altro<br />
che peraltro interagisce con la figura<br />
della donna che allatta sovrapponendo i<br />
suoi rami fronzuti a quasi la metà inferiore<br />
del corpo nudo. In questo caso si giusti-<br />
ficherebbe l’ipotesi" ra<strong>di</strong>ce" dell’arbusto,<br />
secco (<strong>di</strong>co io).<br />
D’altra parte in un altro quadro della collezione<br />
Michiel, "I tre filosofi", Giorgione,<br />
aveva probabilmente evocato "facendolo<br />
paesaggio" secondo S.Settis "il tema<br />
dell’Albero secco e dell’Albero vivo:"L’Albero<br />
del Para<strong>di</strong>so che si è <strong>di</strong>sseccato<br />
dopo il peccato originale e l’Albero della<br />
Vita che annuncia rigoglioso la salvezza<br />
attraverso la Passione <strong>di</strong> Cristo"(5).<br />
Allora, con queste premesse, possono<br />
essere recuperati e fusi i valori simbolici<br />
della Madre Terra o Iside generatrice e<br />
del serpente che <strong>di</strong> continuo ringiovanisce,<br />
grazie alla muta della sua pelle, ne<br />
fa maggiormente un simbolo <strong>di</strong> rinnovamento<br />
e cambiamento?<br />
Colpisce anche la strana iconografia della<br />
donna che allatta il bambino non tenendolo<br />
in grembo come nella stragrande<br />
maggioranza delle versioni <strong>di</strong> Iside con<br />
il piccolo Horus o Madonne nelle immagini<br />
conosciute bensì tenendolo sul panno<br />
steso a terra sul quale essa stessa è<br />
seduta con le gambe piegate ad angolo<br />
e separate tra loro in posizione assai<br />
scomoda. Del florido puttino, seminascosto<br />
dalla coscia destra della sua nutrice,<br />
ve<strong>di</strong>amo solo la testa, un po'della spalla<br />
destra e <strong>di</strong> una gamba. Caino o Horus,<br />
Efrasto o chi altro questo lattante possa<br />
essere, certo non è figura esaltata da<br />
Giorgione: credo che il collegamento alla<br />
terra su cui si posa sia la ragione della<br />
scelta attuata dall’artista, e bambini collegati<br />
alla terra sono quelli della Saturnia<br />
Tellus nell’Ara Pacis <strong>di</strong> Roma.<br />
Dopo aver fatto, a mero titolo esemplificativo,<br />
le riflessioni suddette mi pare che<br />
ancora, implacabilmente, sussistano "ragionevoli<br />
dubbi" sul fatto che l’opera sia<br />
stata definitivamente "svelata".<br />
L’opera <strong>di</strong> Marco Paoli ha sicuramente il<br />
38 39