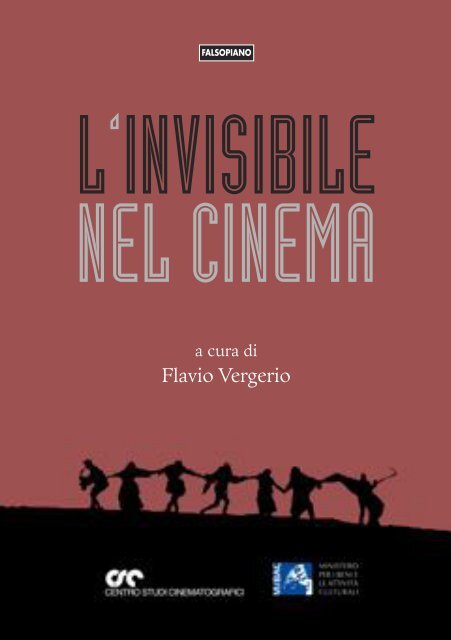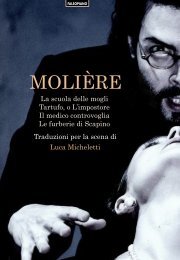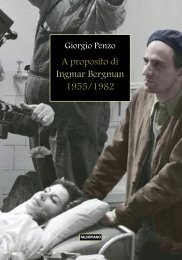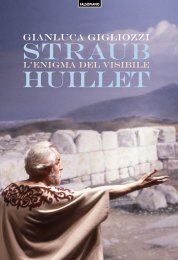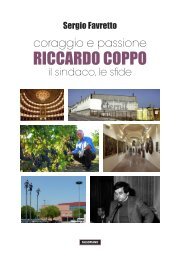Invisibile
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FALSOPIANO<br />
L’INVISIBILE<br />
NEL CINEMA<br />
a cura di<br />
Flavio Vergerio
FALSOPIANO<br />
CINEMA
EDIZIONI<br />
FALSOPIANO<br />
L’INVISIBILE<br />
NEL CINEMA<br />
a cura di<br />
Flavio Vergerio
Ringraziamenti<br />
Questo volume è stato realizzato grazie al contributo di CSC. Centro Studi<br />
Cinematografici e del MIBACT - Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del<br />
Turismo.<br />
© Edizioni Falsopiano - 2017<br />
via Bobbio, 14<br />
15121 - ALESSANDRIA<br />
http://www.falsopiano.com<br />
Progetto grafico e impaginazione: Daniele Allegri<br />
Prima edizione - Marzo 2017<br />
ISBN 9788893040655
INDICE<br />
Introduzione<br />
Da Stanlio e Ollio a Ozu<br />
Flavio Vergerio p. 11<br />
Secrets Beyond the Door.<br />
Lubitsch, il Codice e il film invisibile<br />
Paolo Vecchi p. 27<br />
Il suo silenzio non ti parla?<br />
(Ingmar Bergman, Il settimo sigillo)<br />
Carlo Tagliabue p. 43<br />
Così bella così dolce<br />
(Une femme douce, Robert Bresson, 1969)<br />
Elio Zenobi p. 66
Muriel, l’impossibile ritorno<br />
Flavio Vergerio p. 81<br />
Amo il cinema, perché<br />
è un’arte indiretta,<br />
inconfessata, nasconde tanto<br />
quanto mostra (François Truffaut)<br />
Giulio Fedeli p. 97<br />
Chris Marker.<br />
La Jetée, la metropolitana di Sans Soleil<br />
Tullio Masoni p. 113<br />
Alfred Hitchcock: playing behind screens<br />
Carlo Caspani p. 121<br />
L’opera e i giorni<br />
Adriano Piccardi p. 138<br />
Tra l’invisibilità e il mistero:<br />
il Decalogo di Krzysztof Kieślowski<br />
Giancarlo Zappoli<br />
Laura Negretti p. 151
The Act of Killing (Joshua Oppenheimer)<br />
Caterina Doni p. 172<br />
L’ipervisibile.<br />
Dalla didattica alla dialettica visibile/invisibile in Peter Greenaway<br />
Elio Girlanda p. 188
Germania anno zero (1948)<br />
10
INTRODUZIONE<br />
Da Stanlio e Ollio a Ozu<br />
Flavio Vergerio<br />
Questo libro raccoglie una serie di saggi che cercano di individuare<br />
l’origine misteriosa della produzione di senso nel cinema. Secondo la mia<br />
ipotesi questo mistero costituirebbe la negazione della mera rappresentazione<br />
della realtà (o supposta tale) soggetta alle regole manipolatrici della<br />
trasparenza. Il cinema che produce pensiero non è quello che “mostra”,<br />
ma quello che occulta, che suggerisce, che interpella sull’“oltre” dell’immagine.<br />
Il cinema che invita a “vedere” fra gli interstizi della narrazione per<br />
immagini, nelle ellissi, nei falsi raccordi di montaggio, nel fuori campo,<br />
nella sospensione del racconto.<br />
Credo che per ogni giovane spettatore, ancora curioso e disponibile ad<br />
accogliere le mille invenzioni possibili del cinema, non ancora cioè reso<br />
cieco e sordo dalla omologazione linguistica mediatica, le prime esperienze<br />
di visione abbiano costituito un’immersione nella meraviglia del fantastico<br />
e del misterioso. Il senso di quanto abbiamo visto al cinema da bambini era<br />
avvolto nell’involucro affascinante e ambiguo del mistero e dell’insondabile.<br />
Questo fascino morbido ha modellato la nostra visione del cinema e<br />
del mondo in esso rappresentato. Per quanto mi riguarda (ma credo che la<br />
cosa sia valida per tutti) le mie prime visioni cinematografiche mi hanno segnato<br />
profondamente perché contenevano in sé una rappresentazione del<br />
mondo distorta, surreale, fantastica, in qualche modo sovversiva. E ciò avveniva<br />
in film apparentemente pacificati e giocosi.<br />
Pescando nel rimosso della mia memoria (visto che in età matura mi sono<br />
dedicato al cinema “serio” e rigoroso di Bergman, Bresson e Dreyer), i film<br />
11
che ricordo come prime esperienze fondative sono alcune comiche di Stanlio<br />
e Ollio e Aquila nera di Riccardo Freda (1946), visti con mio padre nel<br />
primo dopoguerra in un cinema oggi scomparso (forse si chiamava Excelsior)<br />
dalle parti di Piazzale Corvetto a Mestre. Il fascino della visione era addirittura<br />
resa elettrizzante dalla cortina di fumo azzurrino e dalla<br />
partecipazione emotiva degli spettatori accalcati (io e papà finivamo sempre<br />
in galleria).<br />
In particolare di Stanlio e Ollio ricordo una comica (forse si tratta di Laughin’<br />
Gravy, tradotto in italiano come Non c’è niente da ridere, del 1931)<br />
in cui i due cercano di dormire in una stanza d’albergo nascondendo un cagnolino<br />
non gradito al proprietario. I due dormivano in un letto matrimoniale<br />
disturbandosi a vicenda e giungendo a ficcarsi i piedi in bocca. Una<br />
situazione simile viene proposta in altri film successivi. In Pardon Us (Muraglie,<br />
1931) i due dividono a fatica lo spazio esiguo di una branda in un<br />
carcere; in A Chump at Oxford (Noi siamo le colonne, 1940) si aggrovigliano<br />
in una cuccetta di un treno notturno… Al di là della comicità esilarante<br />
delle gag (che trascinava gli spettatori in reazioni telluriche) la<br />
situazione rappresentata mi comunicava un indefinibile disagio per la promiscuità<br />
cui i due personaggi erano costretti. Non avevo ancora visto la comica<br />
quasi coeva (Liberty, 1929) in cui il possibile rapporto omosessuale<br />
fra i due è adombrato in modo più esplicito. In questo film Laurel e Hardy<br />
evadono dal carcere e si vestono con abiti civili arraffati in un negozio, ma<br />
sbagliano misure (troppo larghi per Stan, troppo stretti per Ollie). Tutte le<br />
volte che i due tentano di scambiarsi in disparte i pantaloni, rimanendo in<br />
mutande, vengono colti sul fatto dai passanti e sanzionati secondo il comune<br />
senso del pudore…<br />
Il mistero insito nel film (e il vero motivo della sua fascinazione su di<br />
me) e che dovevo scoprire solo molto più tardi stava appunto nella latente<br />
omosessualità che era la molla profonda del loro perenne gioco delle parti<br />
(tronfia e ottusa mascolinità da parte di Ollie, maliziosa e surreale femminilità<br />
da parte di Stan).<br />
Per quanto riguarda Aquila nera, si trattava di un complicato film di<br />
cappa e spada tratto da Puskin (e sceneggiato oltre che da Freda anche da<br />
Monicelli e da Steno), con sullo sfondo le prime lotte contadine contro i latifondisti.<br />
Ciò che ricordo del film è una lunga galoppata notturna di Rossano<br />
Brazzi (con cui il l’ufficiale zarista Dubrowskij, divenuto capo di una<br />
12
anda di ribelli, si slancia al duello finale con il principe Sergio che sta per<br />
impalmare contro la sua volontà l’amata Masha e alla vendetta nei confronti<br />
del latifondista Kirila Petrovic che gli ha umiliato e ucciso il padre).<br />
Della trama, piena di risvolti narrativi e di cambiamenti di scena, al tempo<br />
avevo capito ben poco, così come dello scenario sociale, premonitore della<br />
futura Rivoluzione d’Ottobre. La galoppata si svolgeva in un cupo paesaggio<br />
notturno, nel fitto di una foresta a stento illuminata dalla luna. La sequenza<br />
evocava in me paure ancestrali, costiduendosi come ambiguo<br />
oggetto transizionale (cfr. il “gioco del rocchetto” freudiano) di una confusa<br />
ricerca d’identità, strumento favolistico di elaborazione di quelle stesse<br />
paure.<br />
Tutti i teorici e gli storici del cinema fanno risalire alla produzione dei<br />
fratelli Lumière, con le loro fredde e immobili prises de vues, il cinema<br />
della realtà, mentre attribuiscono alle pantomime piene di trucchi e di invenzioni<br />
immaginifiche di Georges Méliès l’origine del cinema fantastico.<br />
A parte il fatto che non credo che il confine fra i due tipi di cinema sia così<br />
netto (i Lumière manipolavano la realtà prima delle riprese, Méliès rivelava<br />
giocosamente l’origine meccanica dei suoi trucchi), è significativo il fatto<br />
che i due film cui attribuisco la formazione infantile del mio immaginario<br />
cinematografico appartengano più al versante del cinema popolare-fantastico<br />
più che a quello rigoroso e astratto dei Bergman, Dreyer e Bresson.<br />
Il tema della funzione dal cinema fantastico come proiezione dell’invisibile<br />
è stato illustrato da Bruno Fornara in una bella introduzione alla sezione<br />
Filmare l’invisibile nel catalogo dell’Infinity Festival (Alba, 2005).<br />
Mentre i Lumière fondano il fascino del cinema nella sua capacità di registrare<br />
e fissare il visibile, Méliès vuole filmare l’invisibile: “Non registra il<br />
mondo: filma un palcoscenico. Filma spettacoli, ama i prestigiatori, si serve<br />
di eleganti illusionisti (…) Stacca la testa dai corpi, fa apparire e sparire<br />
belle ragazze (…) Méliès, inventore i tutti gli effetti speciali, non si cura del<br />
reale, lo vuole reinventare, vuole giocare con corpi, oggetti e storie, vuole<br />
essere un mago (…) Dunque, nel fantastico, per la prima volta, l’invisibile<br />
diventa grazie alla tecnica e ai suoi trucchi, registrabile e visibile”.<br />
Successivamente il cinema moderno si pone il problema di come si<br />
possa interpellare e cogliere il segreto del mondo rappresentato sullo<br />
schermo con elementi oggettivi e realistici, senza ricorrere a trucchi e manipolazioni.<br />
Si chiede ancora Fornara: “come può la macchina da presa<br />
13
guardare azioni e corpi in modo tale per cui, sulla pellicola, restino le tracce<br />
di qualcos’altro, di qualcosa che gli occhi non avevano visto”. La prima e<br />
fondamentale invenzione del cinema moderno rispetto al cinema dei Lumière<br />
e dei Méliès sta nel cambiamento di funzione della cornice dell’inquadratura.<br />
Nel cinema delle origini l’essenza del mondo rappresentato<br />
stava tutto all’interno di una cornice statica e conchiusa in sé. Successivamente<br />
i movimenti sempre più audaci della macchina da presa, il rinvio<br />
problematico all’inquadratura successiva, prodotto da un montaggio sempre<br />
più creativo, inducono lo spettatore a immaginare ciò che non si vede,<br />
oltre il confine dell’inquadratura. Poco alla volta questa porzione di spazio<br />
che non appare si imporrà all’attenzione del fruitore come il vero motore<br />
della storia e origine del senso di quanto appare, che spesso si manifesta<br />
come illusoria e fuorviante. Il fuoricampo è forse la principale manifestazione<br />
di quell’invisibile che problematizza tutto il cinema della modernità.<br />
Ma, oltre al fuoricampo “esterno” esiste anche un “fuori campo interiore”.<br />
Il cinema osserva e riproduce la superficie delle cose e delle persone.<br />
Ma cosa c’è oltre questa superficie, nella vera e profonda (e spesso oscura<br />
e inconfessabile) identità dei corpi e delle persone rappresentate? Il cambiamento<br />
di prospettiva è radicale: non si tratta più di filmare l’apparenza<br />
e la materialità dei personaggi, ma loro essenza, chi essi siano. Il teorico del<br />
cinema Jacques Rancière nel suo La fable cinématografique (Seuil, 2001),<br />
citato da Fornara, rintraccia le origini di questa ricerca in quei momenti<br />
della rappresentazione liberi dai codici statici e puramente riproduttivi della<br />
stessa. Quando l’artista creatore “Fa apparire il gesto della pittura e dell’avventura<br />
della materia sotto i soggetti della raffigurazione. Fa brillare,<br />
dietro i conflitti delle volontà drammatiche o romanzesche, il fulgore dell’epifania,<br />
lo splendore puro dell’essere senza ragione. Svuota o inasprisce<br />
la gestualità dei corpi espressivi, frena o accelera la velocità dei concatenamenti<br />
narrativi, sospende o sovraccarica i significati. L’arte dell’era estetica<br />
vuole identificare il suo potere incondizionato con il suo contrario: la<br />
passività dell’essere senza ragione, la polvere delle particelle elementari, lo<br />
sbocciare originario delle cose”.<br />
Gli esempi e le modalità diverse di questa ricerca dell’invisibile sono naturalmente<br />
infiniti e comunque ne cito alcuni per individuare alcune direzioni<br />
espressive ed estetiche. Il maggiore regista concettuale vivente,<br />
Jean-Luc Godard, nel suo ultimo film Adieu au langage (2014) affida al-<br />
14
l’occhio di un cane l’osservazione di una vicenda slabbrata di conflitti amorosi<br />
applicando l’aforisma di Claude Monet citato da Marcel Proust “Non<br />
bisogna dipingere ciò che si vede, visto che non vediamo niente, ma dipingere<br />
ciò che non si vede”. Ovvero bisogna tentare di rappresentarle idee,<br />
non ciò che si crede di vedere, una realtà illusoria e fallace.<br />
Roberto Rossellini in Germania anno zero (1947) nella lunga spettrale<br />
sequenza finale attraverso Berlino pone il suo giovane protagonista prima<br />
del suicidio di fronte agli incontri mancati della sua vita: la comunità dei<br />
suoi pari (un gruppo di ragazzini gioca a palla fra le macerie), la dimensione<br />
fideistica (da una chiesa gotica arriva un suono d’organo), una famiglia e<br />
l’assenza di un padre (la sorella lo chiama quando è troppo tardi). L’apparente<br />
realismo dello sguardo si carica delle emozioni e della disperazione<br />
del protagonista, senza cadere nel didascalismo di vieti simbolismi.<br />
A proposito del suo La sapienza (2014) Eugène Green fa coincidere<br />
l’aspirazione alla riconquista dell’armonia di coppia con la ricerca dell’ascesi<br />
verso l’infinito delle forme barocche del Borromini nella cupola<br />
di Ivo alla Sapienza. Il regista afferma di prendere nei suoi film la materia<br />
bruta del cinema e di andare verso ciò che non si vede, l’ invisibile appunto,<br />
evitando la razionalità e i simboli. Preferire i segni.<br />
Michelangelo Antonioni conduce un implacabile lavoro di “reificazione”<br />
dei suoi personaggi, messi a confronto con una realtà sociale e ambientale<br />
fredda e distante. Le sue storie si concludono sempre sulla sospensione di<br />
senso e sull’apertura dolorosa verso un futuro incerto. Ne L’avventura<br />
(1959) la scomparsa di Anna svela la precarietà dei nuovi rapporti amorosi<br />
che ne vengono determinati e l’incomunicabilità di coppia. L’assenza della<br />
donna diviene progressivamente la metafora dell’incertezza esistenziale con<br />
cui i personaggi non vogliono e non possono fare i conti.<br />
Eric Rohmer non filma i fatti, ma lo sguardo mentale dei suoi personaggi.<br />
La nevrotica protagonista de Il raggio verde (1986) crede di vedere in un fenomeno<br />
di rifrazione solare al tramonto sul mare la conferma della giustezza<br />
di un suo nascente rapporto amoroso e forse della presenza del divino.<br />
Robert Bresson riesce a scoprire l’anima profonda dei suoi inespressivi<br />
attori non professionisti attraverso l’impiego di rigorose inquadrature fisse<br />
e di un tempo narrativo sacrale. In ragione del suo giansenismo ascetico, la<br />
parabola verso la solitudine sacrificale della protagonista di Mouchette<br />
(1967) acquista il suo nascosto significato religioso attraverso il solo se-<br />
15
gnale di uno velo bianco e delle note lancinanti di Monteverdi.<br />
Carl Th. Dreyer in Ordet (1955) attribuisce allo sguardo di una bambina<br />
la Verità della drammatica resurrezione della madre, richiamata alla<br />
vita dalla Follia fideistica di uno studente di teologia, critico nei confronti<br />
del “tradimento” della Chiesa ufficiale.<br />
Alain Resnais affida a un complesso lavoro sulle strutture narrative e sul<br />
montaggio l’occultamento di ricordi dolorosi e dell’angoscia di morte negli<br />
spazi di una memoria selettiva.<br />
François Truffaut affermava che nella preparazione di un film non faceva<br />
mai molti sopralluoghi per le riprese, preferendo affidarsi alla loro<br />
rappresentazione in altri film, fotografie o romanzi. Il suo rapporto con la<br />
realtà diventava di conseguenza il riflesso di un riflesso.<br />
Se vogliamo tuttavia rintracciare una forma espressiva privilegiata nella<br />
manifestazione dell’<strong>Invisibile</strong> nel cinema si può ipotizzare che essa consista<br />
nell’origine e nella potenza dello sguardo dei suoi personaggi generatore<br />
di storie e di analisi della realtà.<br />
L’invisibile e il segreto<br />
Nel suo aureo libretto Segreti e no (Bompiani, 2014) Claudio Magris<br />
analizza in funzione sociale, politica, psicologica e narrativa l’origine e la<br />
funzione strutturante e simbolica fondamentale del segreto. Coprire, velare<br />
il segreto all’interno di una vita o di un racconto significa ipotizzarne la<br />
ricchezza e la complessità. Non c’è storia senza segreto, ovvero è impossibile<br />
scoprire la verità profonda di una storia o di un personaggio. Svelare<br />
si intreccia con l’atto del ri-velare, coprire-scoprire la verità, rendersi conto<br />
che c’è un sempre in essa un ulteriore aspetto nascosto. La verità di un fatto,<br />
di un’esistenza, di un personaggio consiste nel suo aspetto segreto.<br />
Si veda l’esempio fulminante del corto di Jean-Gabriel Périot Eût-elle<br />
été criminelle… (Se anche fosse stata criminale..., 2006, visibile su You<br />
Tube): la Marsigliese sembra glorificare scene di giubilo della popolazione<br />
francese il giorno della Liberazione. La macchina da presa inquadra in<br />
campi stretti volti gioiosi di cittadini in festa. Ma poi il campo si allarga e<br />
vediamo che essi stanno partecipando all’umiliazione pubblica di donne<br />
francesi collaborazioniste o sospette di collusione col nemico (rasate a zero,<br />
16
segnate dalla svastica nazista, schiaffeggiate, offerte in pasto al pubblico ludibrio).<br />
Quelli che ci sembravano sorrisi ed espressioni di gioia ci appaiono<br />
ora come ghigni ottusi e satanici di chi si accanisce contro donne<br />
inermi e vittime di un situazione storica più grande di loro. Anche l’inno<br />
francese cambia di segno e diventa gonfia manifestazione di retorica occultante<br />
la complessità e la contradditorietà di un avvenimento che la storiografia<br />
ufficiale vuole lineare e univoco.<br />
E quando si crede di aver scoperto il segreto di una vicenda umana, il narratore<br />
spesso ne rilancia l’occultamento con ulteriori spostamenti narrativi.<br />
Orson Welles non risolve il segreto esistenziale di Charles Foster Kane, il tycoon<br />
protagonista di Citizen Kane (Quarto potere, 1941), mostrandoci il falò<br />
in cui brucia la slitta Rosebud, simbolo dell’infanzia negata al personaggio.<br />
Dal camino della grande villa in cui era morto Kane esce un denso fumo<br />
nero, segnale di dissoluzione di tanti altri segreti inconoscibili e sul cancello<br />
riappare la scritta No Tresspassing (Vietato entrare) con cui era iniziato il<br />
film. Non esiste un’unica verità dell’uomo Kane.<br />
Magris cita significativamente lo scrittore Javier Marìas: “Raccontare<br />
deforma i fatti e li altera e quasi li nega, tutto ciò che si racconta diventa irreale<br />
e approssimativo benché veritiero, la verità non dipende dal fatto che<br />
le cose siano o succedano, ma dal fatto che rimangano nascoste e non si conoscano<br />
e non si raccontino; appena si raccontano o si manifestano o si<br />
mostrano, anche in ciò che appare più reale, in televisione o sul giornale,<br />
in ciò che si chiama la realtà o la vita o addirittura la vita reale, passano a<br />
formare parte dell’analogia o del simbolo, e dunque non sono più fatti, ma<br />
si trasformano in riconoscimento. La verità non riluce, come si dice, perché<br />
l’unica verità è quella che non si conosce e non si trasmette, quella che<br />
non si traduce con parole né con immagini, quella celata e non controllata.<br />
Forse per questo si racconta tanto o si racconta tutto, perché niente sia mai<br />
accaduto, una volta raccontato”.<br />
Da parte sua Magris chiarisce così ulteriormente il concetto: “Svelare il<br />
segreto, portarlo alla luce, significa sempre anche deformarlo, già solo per<br />
il fatto di immetterlo in un contesto diverso, così come nel principio di indeterminazione<br />
di Heisenberg osservare un fenomeno significa già modificarlo,<br />
per cui si viene a conoscere già il preteso (inesistente?) fenomeno<br />
in sé, bensì il fenomeno conosciuto e osservato. La scrittura (e ciò vale<br />
anche per il cinema, ndr) è sempre uno scavare alla ricerca di qualcosa che<br />
17
si rivela - quando e se si rivela - soltanto durante questa ricerca e che in<br />
quanto si tratta di qualcosa di non conosciuto, è un segreto. In ciò consiste<br />
la verità ma anche il suo potenziale devastante, perché costringe a sapere”.<br />
Straordinaria la ricerca sul “non detto” (ovvero sull’ellissi e l’omissione)<br />
in campo letterario condotta da Nicola Gandini nel suo denso saggio<br />
Lacuna (Bompiani, 2014). Nel capitolo fondativo del saggio Gandini<br />
afferma che “Non c’è omissione testuale che non rimandi a una pienezza<br />
extratestuale, e questa sta come l’ombra al corpo. Riconoscere il valore dell’omissione<br />
significa rimettere la parzialità della scrittura nella totalità del<br />
mondo. Significa cercare il senso (…) Non dire tutto, se di fatto è una necessità,<br />
letterariamente è una libertà: l’imperfetto sovrabbonda di potenza”.<br />
Tutti i lettori de I promessi sposi ricordano il fulminante proverbiale<br />
“La sventurata rispose” con cui Manzoni lascia intravvedere l’abisso di<br />
perdizione in cui Gertrude si getterà rispondendo ai richiami amorosi di<br />
Egidio. L’orrore per le conseguenze del rapporto amoroso (gli infanticidi,<br />
la condanna a morte della suora, murata viva) è moltiplicato dall’allusione,<br />
più dalla descrizione puntuale del seguito della vicenda. Più curioso ai nostri<br />
fini il fatto che uno dei primi esempi di “lacuna”, ovvero di ellissi narrativa,<br />
proposto da Gandini sia quel La marchesa von O… di Kleist, da cui<br />
Rohmer ha tratto il film omonimo (1976). Una nobildonna vedova e madre<br />
di due figlie durante l’assedio al castello del padre governatore in una cittadina<br />
del Nord Italia viene salvata dalla soldataglia russa da un ufficiale nemico.<br />
La donna si addormenta sotto il benefico influsso di una tisana,<br />
vegliata dall’ufficiale. Tempo dopo la donna si scopre incinta e solo dopo<br />
molte insistenze accetta un matrimonio riparatore offertole dall’ufficiale<br />
che a sua insaputa l’ha posseduta. La misteriosa ellissi nasconde il conflitto<br />
intimo fra le pulsioni erotiche dei due protagonisti e l’ordine esteriore di una<br />
società moralista. Commenta Gandini: “La lacuna (…), di fatto già contenuta<br />
nel nome della protagonista (quella O che è uno zero o uno spazio<br />
tutto da riempire, come il suo grembo), determina un cambiamento psicologico<br />
significativo nel personaggio della marchesa e nella società di cui è<br />
parte; un vero e proprio scompiglio, che distrugge e ridisegna tutti i ruoli<br />
famigliari. Riempire la lacuna porterà al ristabilimento dell’ordine, dando<br />
una nuova coscienza e dignità sia nello stupratore che nella stuprata”.<br />
Credo che la produttività delle invenzioni della messa in scena cinematografica<br />
per ottenere l’apertura verso l’invisibile e l’assoluto consista<br />
18
nella sua indeterminatezza e polisemia, aperta cioè alla percezione e all’interpretazione<br />
dello spettatore più diverse. Un esempio celebre di questa<br />
produttività, è la sequenza del vaso, frequentatissima da teorici e critici, in<br />
Tarda primavera (1949), film fondativo e seminale della produzione ultima<br />
di Jazujiro Ozu. L’esile trama propone una struttura che si ripeterà in<br />
alcuni film successivi con sottili ma significative varianti. Un vecchio professore<br />
universitario rimasto vedovo viene accudito dalla figlia, ormai matura,<br />
che non vuole abbandonarlo per amore filiale e senso del dovere.<br />
L’uomo, per lasciarla libera e convincerla a sposarsi, simula l’intenzione di<br />
risposarsi. La figlia cede a malincuore a un matrimonio combinato e il padre<br />
rimarrà solo. Prima del matrimonio padre e figlia fanno un ultimo viaggio<br />
a Kyoto, ove ammirano gli antichi templi, i giardini zen e assistono a uno<br />
spettacolo di teatro tradizionale Nō. I due trascorrono la notte assieme, stesi<br />
accanto, con il volto rivolto al soffitto ove si disegnano le ombre del giardino<br />
esterno. La donna si scusa con il padre per averlo criticato per la sua<br />
intenzione di risposarsi, ma questi si è già addormentato. A due primi piani<br />
della donna, prima sorridente, poi in lacrime, si intercalano e poi seguono<br />
due lunghe inquadrature di un grande vaso a forma di anfora posato per<br />
terra, mentre sulla finestra di fondo si disegna la sagoma di un albero. Secondo<br />
Paul Schrader (Il trascendente nel cinema, Donzelli 2002, pp. 42-43)<br />
il cinema di Ozu rappresenta il percorso zen dell’uomo verso l’aware, il<br />
mondo ideale, la pacificazione spirituale e l’estasi. “La stasi completa, ossia<br />
la paralisi di ogni movimento, è il marchio di fabbrica dell’arte religiosa in<br />
ogni cultura (…) Il vaso è la stasi, una forma che può assorbire un’emozione<br />
profonda, contradditoria, e trasformarla in un’espressione di qualcosa<br />
di unificato, permanente, trascendente.<br />
L’evento decisivo - il miracolo delle lacrime - ha poco significato in sé,<br />
ma serve a verificare la consistenza della forma. Lo stile trascendentale,<br />
come il vaso, è una forma che esprime qualcosa di più profondo di ciò che<br />
è visibile, e cioè l’intima unità di tutte le cose”.<br />
Per Donald Ritchie (in Ozu, The Regent of University of California,<br />
1974, tr. fr. ed. Lettre du Blanc, 1980, pp. 169-170) il vaso produce un complesso<br />
rapporto di identificazione fra il personaggio della la donna e lo spettatore.<br />
“È dal silenzio che segue il dialogo, che il dialogo prende senso; è<br />
dal vuoto che segue l’azione, che l’azione prende senso. È allo spettatore<br />
che compete questo lavoro del senso (…) Posto di fronte al vuoto, deve<br />
19
sperimentare la scena vuota. L’effetto di questa esperienza è la stasi, una<br />
immobilità letterale attraverso la quale lo spettatore deve egli stesso muoversi.<br />
È precisamente in questo senso che le ‘nature morte’, e altre scene<br />
vuote del cinema di Ozu, assolvono alla funzione di ricettacolo di emozioni.<br />
L’immagine del vaso nella stanza buia serve non solo di transizione<br />
fra la donna prima serena e poi in lacrime, ma contiene egualmente le nostre<br />
stesse emozioni nello stesso tempo che esso le suscita. Qui non è in<br />
gioco alcuna identificazione. La proiezione immaginaria delle nostra stessa<br />
coscienza sul personaggio, fenomeno di cui non possiamo negare l’esistenza,<br />
diviene secondaria, ovvero parassitaria. L’esperienza primordiale,<br />
che ci offre la scena vuota salvo di mu (il ‘nulla’ della filosofia zen), è l’intuizione<br />
improvvisa con la quale noi ‘cogliamo’ il senso del film (…) In sé<br />
il vaso non significa nulla ma la sua presenza è uno spazio nel quale si manifesta<br />
la nostra emozione”.<br />
Gilles Deleuze ne L’immagine-tempo (Ubulibri 1989, pag. 28) identifica<br />
nel vaso “un’immagine-tempo diretta, che attribuisce a ciò che cambia la<br />
forma immutabile nella quale si produce il cambiamento (…). La natura<br />
morta è il tempo, poiché tutto ciò che cambia è nel tempo, ma il tempo non<br />
cambia se stesso, non potrebbe cambiare che in un altro tempo all’infinito<br />
(…) Le nature morte di Ozu durano, hanno una durata, i dieci secondi del<br />
vaso è precisamente la rappresentazione di ciò che permane, attraverso la<br />
successione di stati mutevoli”.<br />
David Bordwell in Ozu and the Poetics of Cinema (Priceton University<br />
Press, 1988), secondo la sintesi che ne fa Dario Tomasi nella sua monografia<br />
su Ozu (Il Castoro Cinema, 1991), sottolinea il carattere “comportamentale”<br />
della narrazione che rende difficile stabilire quali siano la cause<br />
del mutamento d’espressione di Noriko (la figlia), “sottolineando come in<br />
ogni caso il vaso non rappresenti una soggettiva della donna e, cosa di maggior<br />
interesse, come esso non sia probabilmente neanche il centro focale di<br />
quell’immagine, costruita piuttosto su un disegno di ombre e di luci, dove<br />
ciò che è in evidenza sono gli shoji (le porte scorrevoli) illuminati e le<br />
ombre dei rami che vi si riflettono”.<br />
Da parte sua Dario Tomasi insiste, come in altri passaggi del suo studio,<br />
sul concetto di sguardo altrove attribuibile ai due inserti dal vaso, dalle moteplici<br />
funzioni: “coprire un’ellisse attraverso cui si realizza il mutamento<br />
dello stato d’animo di un personaggio, relativizzare la drammaticità di un<br />
20
sentimento umano e, nel contempo, indurre lo spettatore, mediante una<br />
pausa, a cogliere il carattere universale di quel sentimento di dolore che<br />
ogni distacco porta con sé” (pag. 103).<br />
Ma c’è di più. Ancora Bruno Fornara nel suo Geografia del cinema<br />
(Scuola Holden, BUR, 2001) rintraccia un vaso negli scritti di Lao-Tzu, fondatore<br />
del taoismo, la filosofia cinese fondata sul concetto di continuo divenire<br />
e di rapporto armonico fra gli opposti. In un passaggio sapienziale del<br />
Libro della Via e della Virtù Lao-tzu afferma: “Si ha un bel lavorare l’argilla<br />
per fare vasellame, l’utilità del vasellame dipende da ciò che non è”. Chiosa<br />
Fornara: “È vero che ci vuole l’argilla per fare un vaso ma è lo spazio vuoto<br />
all’interno del vaso a renderlo utile. Utilità del mu, il vuoto produttivo”.<br />
Si parla di vasi anche nella filosofia occidentale. Nota Giuseppe Ardrizzo,<br />
teorico della conoscenza, che oggi abbiamo il “vizio” cognitivo partorito<br />
troppo sbrigativamente dalla modernità di andare troppo velocemente<br />
sugli oggetti, siano essi oggetti mentali come i concetti, siano oggetti materiali,<br />
gli stessi che passano sotto il nome di cose. E questo nostro andare<br />
troppo velocemente sugli oggetti (“contro” gli oggetti) implica il nostro<br />
non vederne l’essenza, nell’abituale presunzione di sapere di primo acchito<br />
che cosa essi siano.<br />
Heidegger, nel suo saggio su La questione della cosa si domanda “Che<br />
cos’è una cosa?”. Per rispondere, H. prende in considerazione una “cosa”<br />
comunemente conosciuta come brocca. Ne ricava che la cosalità della<br />
brocca non consiste tanto nella sua superficie-involucro - quell’immediatamente<br />
visibile inviluppo esternale -, bensì nel suo essere recipiente. Recipere<br />
significa ricevere, accogliere, accettare. Nello riempimento della<br />
brocca, noi facciamo fluire il fluido nella brocca, che è vuota e che ora riceve,<br />
accoglie, accetta. “Il vuoto, questo nulla della brocca, è ciò che la<br />
brocca è come recipiente che contiene”.<br />
Emerge così la cosalità della brocca che “non consiste affatto nel materiale<br />
di cui esso consiste, ma nel Vuoto, che contiene”. L’approccio scientifico<br />
ci dice che la brocca non è vuota: è piena di aria. Ma la riflessione<br />
scientifica ci porta a oscurare l’essenza stessa della cosa, cioè in che cosa<br />
consiste l’esser-brocca della brocca. Nell’abbandonarci al percorso scientifico,<br />
insomma, “non abbiamo lasciato che il vuoto della brocca fosse davvero<br />
il suo vuoto”. In questa direzione non percepiamo che l’esser-brocca della<br />
brocca trovi una propria consistenza nell’offrire: “L’essenza del vuoto con-<br />
21
tenente è raccolta nell’offrire”. Dall’offerta il vuoto stesso della brocca riceve<br />
la sua essenza. L’offerta del versare, insegna H., significa dare da bere<br />
ai mortali e trova il suo senso sacrale in un offrire rivolto agli dei immortali.<br />
Siamo apparentemente un po’ lontani, sulle strade dell’invisibile al cinema,<br />
da Stanlio e Ollio, ma sono convinto che tutto il cinema costituisca<br />
il riflesso, anche suo malgrado, di un pulviscolo di indicibile e di infinito.<br />
Note di lettura<br />
Nel chiedere i contributi a questo libro collettaneo abbiamo lasciato liberi<br />
i diversi saggisti di scegliere autonomamente, secondo le proprie predilezioni,<br />
i registi e i film che a loro giudizio erano più funzionali a illustrare<br />
il concetto di “invisibile” nel cinema. Ne è derivata una mappatura della<br />
storia del cinema e delle sue prospettive future che, pur procedendo da approcci<br />
metodologici diversi, costituisce una corposa risposta al problema<br />
posto nell’introduzione e uno stimolo a indagini successive.<br />
In assenza di un’unica prospettiva teorica l’ordine dei saggi ubbidisce<br />
a una logica cronologica, in riferimento alle opere analizzate.<br />
Diamo conto di questa varietà di approcci facendo riferimento ad alcuni<br />
testi.<br />
Paolo Vecchi, nella sua acuta e divertita analisi dell’opera di Ernst Lubitsch,<br />
fa derivare dal censorio codice Hays (1930) rilevanti conseguenze<br />
sulle forme della rappresentazione e del racconto hollywoodiani. La “regola”<br />
censoria produsse infinite forme di trasgressione, nei modi sottili e<br />
sfrontati dell’allusione e del doppio senso, rasentando spesso l’irrisione e<br />
la spregiudicatezza. Obiettivo dichiarato di questo cinema furono i “corretti”<br />
rapporti di coppia e una rigida concezione dell’identità sessuale. Maestro<br />
in queste strategie di aggiramento delle “regole” si rivela Lubitsch che,<br />
paradossalmente, si inventò la “proibizione” come ostacolo da superare.<br />
Nello specifico, Lubitsch ha inventato il procedimento delle porte che,<br />
aprendosi e chiudendosi, nascondono, alludono, introducono all’azione. Di<br />
questo meccanismo Vecchi cita la felice definizione di B. Améngual: “Strizzatine<br />
d’occhio complici, le porte sono le occhiate che ci indirizzano non i<br />
personaggi, ma il film. È poco dire che scandiscono la storia, esse ne sono<br />
la sostanza e il principio”. Le porte che si aprono e che si chiudono realiz-<br />
22
zano una vera strategia del desiderio, così che le porte che dovrebbero nascondere,<br />
in effetti finiscono per rivelare: “Andando in direzione contraria<br />
rispetto alla scopofilia dello spettatore, stimolano il suo voyeurismo, come<br />
se stesse guardando dal buco della serratura”.<br />
Tullio Masoni nel suo saggio su Chris Marker, utilizzando il pensiero di<br />
Merleau-Ponty, a proposito de La Jetée ne analizza la particolare concezione<br />
del tempo (un uomo rivive il proprio passato che coincide con la sua<br />
morte). Il film è eccezionale perché il regista vi rappresenta “il dilemma di<br />
chi opera con le immagini senza cedere alla pura negazione (il cinema come<br />
morte al lavoro, secondo Jean Cocteau) (...) perché cammina sul filo strappando<br />
alla fatalità ogni pur precaria chance di resistenza”. Nella successiva<br />
analisi di Sans soleil (che mostra i complessi rapporti fra la cultura e<br />
l’immaginario africano e quello giapponese, Masoni nota come Marker<br />
“mostra un film che non si vede o, meglio, che lui stesso fa nascere per<br />
frammenti in un’eclettica mescolanza mediatico-figurale: animazione filmico-televisiva,<br />
videogioco...”. Marker è il regista della dialettica fra visibile<br />
e invisibile, fra immagine e parola.<br />
Carlo Tagliabue, in un testo pensoso scritto poco prima del suo improvviso<br />
decesso e che a mio avviso può essere considerato una sorta di lascito<br />
testamentario, procede da Totò a Ricciotto Canudo per affermare che<br />
“il cinema è arte totale perché forma espressiva che si presta meglio di altre<br />
a stimolare lo spettatore a un itinerario interpretativo volto a svelare ciò<br />
che è occultato per spingerci a cogliere il senso più profondo dell’opera<br />
proposta”.<br />
A proposito del sonoro Tagliabue cita Bresson e Benedetto XVI che elogiano<br />
il silenzio come strumento essenziale per riflettere e analizzare i messaggi<br />
assordanti del sistema dei mass-media. Tagliabue propone un<br />
significativo elenco di autori, fra i quali Antonioni, Rossellini, Visconti,<br />
Fellini, Leone, che hanno utilizzato il silenzio quale strumento tematicoespressivo.<br />
Fra questi basti ricordare il Dillinger è morto di Marco Ferreri,<br />
che descrive la crisi e il suicidio di un uomo immerso nel vuoto della propria<br />
esistenza, rumorosa, ma inessenziale.<br />
Tagliabue nota poi come molti registi si siano confrontati con l’assoluto<br />
e il silenzio di Dio. L’apporto più pregnante in questo ambito è stato offerto<br />
da Ingmar Bergman, a partire dal famoso dialogo fra il Cavaliere e la<br />
Morte ne Il settimo sigillo.<br />
23
Kim Ki-duk, Stanley Kubrick, Pier Paolo Pasolini, Saverio Costanzo,<br />
Xavier Beauvois e molti altri affidano al “vuoto” narrativo/espressivo il<br />
senso della loro ricerca d’assoluto. Forse l’autore più significativo in questa<br />
direzione appare Andrej Tarkovskij che ha sviluppato all’interno di una<br />
vera “estetica del silenzio” il tentativo inane di “vedere” l’immagine di Dio,<br />
per comprendere il significato profondo del Verbo.<br />
Elio Zenobi scandaglia accanitamente la diegesi di Une femme douce di<br />
Robert Bresson in cui scopre l’insanabile duplicità della condizione umana,<br />
“l’inafferrabile dispiegarsi del caso o del destino, un fondamentale pessimismo<br />
sul senso delle vita, ma anche una chiara attenzione alla trascendenza”,<br />
svelando il simbolismo che si cela dietro la fredda narrazione realista. Il film<br />
è costruito su una serie di tempi vuoti, che il fruitore è indotto a caricare di<br />
senso. Nella sua analisi Zenobi invita a rifuggire da letture “selettive e riduttive”,<br />
volte a “slanci idealizzanti”, insistendo piuttosto sulle contraddizioni e<br />
il mistero di un’anima. Il cinema di Bresson si fonda sull’occultamento delle<br />
idee, svolto in modo tale che alla fine esse si rivelino.<br />
A proposito de Il sole della mela cotogna di Victor Erice, Adriano Piccardi<br />
individua nel tempo (non filmabile) una delle basi su cui il cinema<br />
fonda la sua testualità. Essa si costruisce nel suo rapporto con lo spettatore<br />
che avverte nella visione del film il mutamento dei processi di metamorfosi<br />
che avvengono all’interno dell’immagine. Il regista mostra l’invisibile (il<br />
concetto, la categoria) attraverso la registrazione delle modificazioni che il<br />
visibile ci mostra. Piccardi applica il pensiero del fisico Heisenberg affermando<br />
che il film e l’opera pittorica misurano l’impossibilità di “cogliere<br />
con precisione assoluta la posizione nella traiettoria che questi (il neutrone,<br />
come le cotogne) non cessano di percorrere”, con una sola immagine. Il<br />
film rappresenta “la sfida tra la fissità dell’immagine pittorica definitiva<br />
(lo spazio) e la volontà di misurarsi con le modificazioni introdotte dal fattore<br />
cronologico”.<br />
Giancarlo Zappoli e Laura Negretti, nell’affrontare un’ardua lettura del<br />
Decalogo di Krzysztof Kieślowski, prendono avvio da una dichiarazione<br />
del regista che indicava come oggetto della propria ricerca estetica il “giusto<br />
equilibrio fra l’ovvio e il misterioso”. Il cinema polacco negli anni ’60-<br />
’70 per evitare gli interventi della censura comunista aveva elaborato una<br />
sorta di codice segreto (ma ben comprensibile agli spettatori) fondato su<br />
messaggi impliciti. Kieślowski va oltre: in quella che rimane la sua opera<br />
24
maggiore “lavora costantemente sull’invisibilità, su quanto vuole che resti<br />
dietro a quanto appare in superficie, su un superamento dell’immagine e<br />
della parola”. Il progetto visivo della serie dei Comandamenti prevedeva<br />
che l’azione venisse osservata da una persona misteriosa che osservava dietro<br />
una finestra di un grande condominio... Dice il regista “Il suo sguardo<br />
intenso rivolto a loro (i personaggi dei singoli episodi) li spinge a porsi<br />
delle domande su se stessi”. L’invisibile in Kieślowski, da progetto politico<br />
si fa interpellazione metafisica, meditazione problematica del rapporto fra<br />
l’umano e il divino.<br />
La raccolta di saggi si conclude con l’intervento di Elio Girlanda sull’attuale<br />
prospettiva dei mass-media verso le forme dell’ipervisibile. Per<br />
illustrare questa tendenza si serve dell’opera di Peter Greenaway, maestro<br />
della “rappresentazione paradossale dell’invisibile attraverso l’ipervisibile<br />
e l’iperfetazione di immagini e segni”. Servendosi dei testi teorici di Moholy-Nagy,<br />
Jean Epstein e Michel Foucault, Girlanda esplora il rapporto<br />
fra rappresentazione e soggettività, che trova nel regista inglese una manifestazione<br />
straordinaria. L’artista multimediale opera con “rappresentazioni<br />
ipervisibili, tese da una parte a moltiplicare la mise en abîme e, dall’altra,<br />
a ricomprendere il ruolo produttivo dello spettatore con cui portare alla luce<br />
fenomeni inaccessibili all’occhio umano, resi ancora più (in)visibili dal regime<br />
scopico digitale e virtuale, iperrreale e ipermediale”.<br />
Greenaway di fronte all’invasione delle nuove tecnologie cerca nuove<br />
forme di narratività e di rappresentazione. Afferma Girlanda: “il cinema è<br />
morto, il futuro è nel digitale, in un processo sottrattivo, classificatorio, enciclopedico,<br />
se non addirittura combinatorio, espanso e pre-digitale”.<br />
Con una serrata riflessione teorica, Girlanda arriva a definire l’ipervisibile<br />
una sorta di risarcimento per la censura che industria, mercato, chiese<br />
e saperi costituiti hanno imposto al visuale, limitandone tutte le potenzialità<br />
e capacità reali.<br />
25
To Be or Not to Be (1942)<br />
26