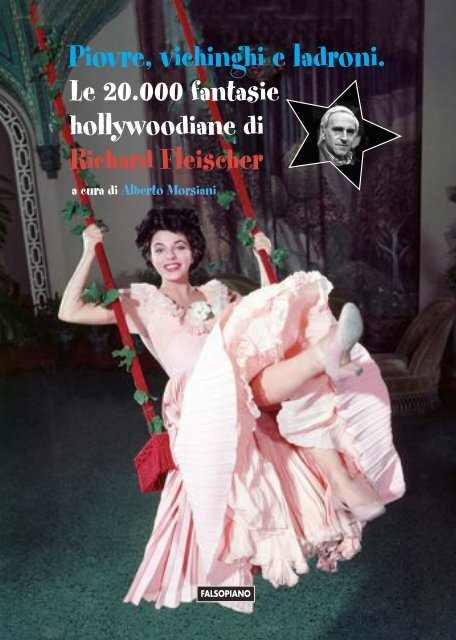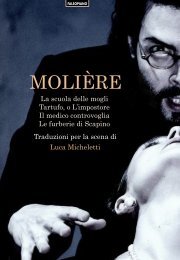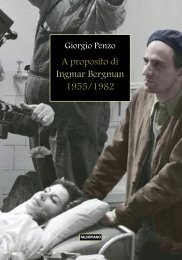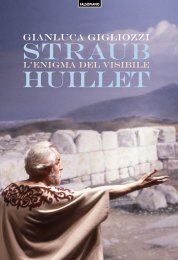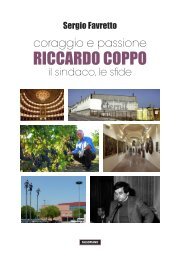Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Piovre, vichinghi e ladroni.<br />
Le 20.000 fantasie<br />
hollywoodiane di<br />
Richard <strong>Fleischer</strong><br />
a cura di Alberto Morsiani<br />
FALSOPIANO
FALSOPIANO<br />
CINEMA
Dedico questo libro a tutti i veri cinefili<br />
(tra cui le mie figlie), gli unici che possono<br />
davvero capire e godere dei film eccitanti<br />
e fantasiosi di Richard <strong>Fleischer</strong>, e alla<br />
Hollywood che non c’è più.
EDIZIONI<br />
FALSOPIANO<br />
a cura di Alberto Morsiani<br />
Piovre, vichinghi e ladroni.<br />
Le 20.000 fantasie<br />
hollywoodiane di<br />
Richard <strong>Fleischer</strong>
Questo volume è stato realizzato in collaborazione con il Circolo del cinema “Adelio<br />
Ferrero” in occasione delle Giornate del Premio di critica cinematografica,<br />
Alessandria, 20-22 ottobre 2016.<br />
In copertina: Joan Collins in L’altalena di velluto rosso (The Girl in the Red Velvet<br />
Swing) (1955).<br />
In quarta di copertina: Raquel Welch in Viaggio allucinante (Fantastic Voyage) (1966).<br />
© Edizioni Falsopiano - 2016<br />
via Bobbio, 14<br />
15121 - ALESSANDRIA<br />
http://www.falsopiano.com<br />
Progetto grafico e impaginazione: Daniele Allegri<br />
Prima edizione - Dicembre 2016
INDICE<br />
Il più grande regista sconosciuto del mondo<br />
di Alberto Morsiani p. 11<br />
L’impermeabile, il cappotto e la sordida sirena.<br />
Due gioielli di sintesi: Sterminate la gang! e<br />
Le jene di Chicago<br />
di Alberto Morsiani p. 37<br />
L’utopia anrchica di Nemo. 20.000 leghe sotto i mari<br />
di Roberto Chiesi p. 47<br />
Bandido<br />
di Massimo Lastrucci p. 57<br />
Il feticcio della sala segreta. L’altalena di velluto rosso<br />
di Roberto Chiesi p. 63
Sabato tragico<br />
di Leonardo Gandini p. 71<br />
Hollywood sul Tamigi e sul Tevere.<br />
I vichinghi e Barabba<br />
di Paolo Vecchi p. 79<br />
Compulsion/Compassion.<br />
Frenesia del delitto<br />
di Alberto Morsiani p. 89<br />
Viaggi allucinanti.<br />
L’ottica fantascientifica di <strong>Fleischer</strong><br />
di Fabio Zanello p. 95<br />
Lo strangolatore di Boston<br />
di Emanuela Martini p.103<br />
L’opacità del male.<br />
L’assassino di Rillington Place n. 10<br />
di Roberto Chiesi p. 109<br />
I nuovi centurioni, Un anti-kolossal<br />
di Mario Gerosa p. 116<br />
La banda di Harry Spikes<br />
di Massimo Lastrucci p. 127
Incontro con Richard <strong>Fleischer</strong><br />
a cura di Bertrand Tavernier p. 131<br />
Sono sempre stato attratto da ciò che è nuovo e insolito.<br />
Intervista con Richard <strong>Fleischer</strong><br />
a cura di Michel Ciment e Lorenzo Codelli p. 135<br />
Cenni biografici p. 149<br />
Filmografia p. 150<br />
Bibliografia selezionata p. 169
10
IL PIÙ GRANDE REGISTA SCONOSCIUTO DEL MONDO<br />
Alberto Morsiani<br />
A Richard <strong>Fleischer</strong> siamo grati debitori di alcuni dei maggiori divertimenti<br />
della nostra infanzia e giovinezza: come dimenticare, tra i tanti momenti<br />
eccitanti o spassosi dei suoi film, la lotta con la piovra gigante e gli<br />
interni vittoriani del sottomarino di 20.000 leghe sotto i mari, la protervia<br />
di Kirk Douglas guercio da un occhio in I vichinghi, Anthony Quinn ottuso<br />
ladrone redento in Barabba, l’amabile dottor Dolittle, il corpo umano come<br />
pianeta alieno in Viaggio allucinante, il colosso nero Ken Norton sessualmente<br />
eccitato dalla piccola venere bionda Susan George in Mandingo…<br />
In particolare i film di <strong>Fleischer</strong> diretti nel periodo alla Fox, a partire dalla<br />
metà degli anni Cinquanta fino al termine dei Sessanta, sono autentiche<br />
fantasie hollywoodiane, avventure scintillanti e rutilanti di colore; rappresentano<br />
fonti di costante divertimento, anche quelli meno riusciti. Il senso<br />
del meraviglioso vi è sempre presente. Dipende forse dal fatto che Richard<br />
è figlio e nipote di due tra i più inventivi creatori hollywoodiani, quei fratelli<br />
Max e Dave <strong>Fleischer</strong> fondatori negli anni Venti di una casa d’animazione<br />
che rivaleggiò a lungo con la potentissima Disney. Dave è stato il<br />
creatore di personaggi come Betty Boop, la cui immagine morbida e sexy<br />
sconvolse al suo apparire gli ambienti conservatori. Sta di fatto che molto<br />
raramente un film di Richard rischia di annoiare lo spettatore. Quale sia il<br />
genere cinematografico in cui si cimenta al momento, il suo interesse maggiore<br />
appare quello di stupire, di sorprendere, di meravigliare. Solo in tempi<br />
relativamente più recenti, abbiamo recuperato e scoperto i suoi primi film<br />
in bianco e nero, soprattutto i magnetici gioiellini noir degli anni Quaranta<br />
e Cinquanta, piccole produzioni in maggioranza RKO, che in alcuni casi lo<br />
11
avvicinano al livello di un Anthony Mann, suo sodale nello studio.<br />
Scrivere di Richard <strong>Fleischer</strong> significa, dunque, gettare finalmente un<br />
po’ di luce su uno dei tanti bravi professionisti che hanno lavorato a Hollywood<br />
negli anni del suo massimo splendore, talenti oscurati dai Grandi<br />
Nomi e abbastanza trascurati dagli studiosi e dagli storici del cinema. Richard<br />
<strong>Fleischer</strong> potrebbe infatti apparire la vera epitome del regista sottostimato.<br />
Baciato dal successo di pubblico e dunque liquidato dalla critica<br />
come regista commerciale. Anche se non vogliamo resuscitare a tutti i costi<br />
la figura dell’Autore, tanto cara alla critica di alcuni decenni fa, è comunque<br />
interessante capire il ruolo del regista nel dare forma a un film. Bisogna<br />
dunque porre l’accento sull’abilità tecnica e sulla competenza mostrata<br />
da registi come <strong>Fleischer</strong>, che hanno diretto dozzine di film in ogni tipo e<br />
genere nell’arco di quasi mezzo secolo. Alla fine della loro carriera, sono<br />
rientrati in quel cono d’ombra critico da cui erano emersi solo in sporadiche<br />
occasioni. Eppure, i loro film sono un patrimonio della visione di milioni<br />
di spettatori, prima nella sala cinematografica e poi in televisione e<br />
sull’home video.<br />
<strong>Fleischer</strong>, figlio d’arte, come tanti altri artigiani più o meno grandi di<br />
Hollywood (Robert Aldrich, Edward Dmytryk, Budd Boetticher, Don Siegel,<br />
Samuel Fuller, Anthony Mann, Robert Wise, Nicholas Ray, Joseph<br />
Lewis eccetera), ha iniziato a lavorare nell’immediato secondo dopoguerra,<br />
quando l’industria cinematografica americana ha cercato con successo di<br />
rinnovare e rinfrescare i propri ranghi in ogni settore professionale. <strong>Fleischer</strong><br />
ha diretto tutti i generi di film: noir, thriller, melodrammi, documentari,<br />
polizieschi, commedie, film in costume, fantasy, epici, catastrofici,<br />
film di montaggio, war movie, western, film di fantascienza, horror, biopic,<br />
musical, film sportivi… Nulla è sfuggito all’obiettivo della sua cinepresa,<br />
da nulla si è tirato indietro (neppure da una biografia di Che Guevara). Ritenuto<br />
di massima affidabilità, spesso è stato scelto dall’industria per sperimentare<br />
nuove strade tecniche, inaugurare filoni di tendenza, consolidare<br />
carriere divistiche, proseguire o replicare in sicurezza film o serie di successo.<br />
La sua sterminata filmografia (quasi cinquanta titoli) lo dimostra<br />
ampiamente.<br />
Né autore consacrato né “piccolo maestro” snobbato dal pubblico ma<br />
adorato da certa critica, come scrive Michel Ciment, <strong>Fleischer</strong> ha sempre<br />
goduto di uno statuto ambiguo. I cinefili degli anni Cinquanta e Sessanta,<br />
12
soprattutto francesi, dal canto loro, non hanno mai smesso di rivendicarne<br />
il grande talento. Un punto di vista minoritario, certo, ma che ha saputo talvolta<br />
imporre la rivalutazione quando non la stessa scoperta di parecchi registi<br />
hollywoodiani considerati in patria, al massimo, dei buoni artigiani. La<br />
sola monografia pubblicata sul regista è naturalmente di uno studioso francese,<br />
Stéphane Bourgoin. Le riviste cinematografiche che hanno dedicato<br />
costante attenzione ai film del regista americano sono anch’esse francesi,<br />
“Positif”e, soprattutto, i “Cahiers du Cinéma”, su cui, a proposito di <strong>Fleischer</strong>,<br />
hanno scritto critici poi divenuti registi come François Truffaut, Bertrand<br />
Tavernier, Jacques Doniol-Valcroze. Truffaut, in una recensione del<br />
1953 di Le jene di Chicago, scrive: “Si ritrova in questo film il treno di The<br />
Lady Vanishes, una variante sul tema dello scambio di omicidi di Strangers<br />
on a Train, l’assassino obeso e il fonografo di Journey into Fear”. Hitchcock<br />
e Welles, dunque: gli idoli di Truffaut giovane critico<br />
cinematografico, chiamati in causa per legittimare un regista “minore”.<br />
Truffaut cerca in <strong>Fleischer</strong> la conferma dei suoi amori, parla di “fascinazione”<br />
e di “humour sentimentale”. Il grande critico Serge Daney, recensendo<br />
nel 1967 sui “Cahiers” Fantastic Voyage, si entusiasma per la<br />
bellezza e il senso di inquietudine trasmessi dai primi piani dell’aereo che<br />
si posa nella notte. Un bel dossier curato da Ciment e dal nostro Lorenzo<br />
Codelli è apparso su “Positif” subito dopo la scomparsa di <strong>Fleischer</strong>.<br />
In Italia <strong>Fleischer</strong> è stato quasi sempre trattato dalla critica alla stregua<br />
di un anonimo regista commerciale. La riscoperta è molto più recente rispetto<br />
ai francesi: in questo senso, occorre, almeno, segnalare l’omaggio<br />
(dieci film) dedicato al regista americano dal Torino Film Festival nel 2004<br />
e il bel saggio di Giuseppe Turroni del 1971 su “Filmcritica” opportunamente<br />
ripubblicato nel catalogo. Nel suo scritto, che prende spunto dall’uscita<br />
di L’assassino di Rillington Place n.10 per allargarsi con parole<br />
fiorite a una valutazione più generale del regista, Turroni parla del “torvo<br />
fuoco moralistico di <strong>Fleischer</strong>. I suoi cupi bagliori. La perfezione di una<br />
forma e di un linguaggio che deve per forza trovare nella purezza metallica<br />
di un cinema esaltante ed esaltato la spinta morale, l’incentivo a una rarefatta<br />
estasi”. E, più avanti: “L’audacia di <strong>Fleischer</strong> sta appunto nei modi, nei<br />
segni di un linguaggio che si rifà alla matrice espressionista, depurandola<br />
di tutte le scorie intellettualistiche, delle metafore concettose o sterilmente<br />
fantasiose, stringendo il discorso sintattico in una morsa moralistica che è<br />
13
in effetti la sublimazione del suo grande disprezzo per un cinema non cinematografico,<br />
che vede ad esempio il male e il delitto come fatto spettacolare”.<br />
I film di <strong>Fleischer</strong> comunicano, spesso, un’impressione ambigua. In un<br />
certo senso, li si ama presi uno a uno ma non li si considera molto presi nel<br />
loro insieme. In altre parole, si stenta ad attribuire al regista uno statuto autoriale.<br />
Rimane una via di mezzo tra l’artigianato hollywoodiano e l’ authorship<br />
di scuola europea. Scoperto e dimenticato a intervalli regolari. In<br />
verità, per non essere un autore, <strong>Fleischer</strong> parla sempre delle stesse cose.<br />
Ad esempio: i giochi della giustizia, la ripartizione delle ricompense e delle<br />
punizioni, o ancora il potere dell’intelligenza. Casi di coscienza, testimonianze<br />
contraddittorie, motivazioni bizzarre. Guardando i suoi film, si impara<br />
che ogni giudizio è temerario, perché, come si dice, tutti hanno le loro<br />
ragioni. Recensirli non è facile. Ci si arma di pazienza, ma occorre spesso<br />
sospendere il giudizio. I più bei film di <strong>Fleischer</strong>, come L’altalena di velluto<br />
rosso o I diavoli del Pacifico, sono anche quelli la cui visione è più<br />
ardua, per non dire deludente. Si parte per giudicare i personaggi, per decidere<br />
chi ha ragione e chi ha torto, e, nel corso del film, il problema perde<br />
la sua urgenza, quasi scompare. Ci si sorprende a seguire il movimento (tesi<br />
e antitesi) di un pensiero impersonale, imparziale e un po’ cinico, desideroso<br />
di spegare, di giustificare, e tutto ciò per niente (o per il semplice piacere<br />
dell’esaltazione intellettuale). Ecco, dunque, i poteri dell’intelligenza,<br />
e i suoi limiti: non illumina se non retrospettivamente.<br />
I film di <strong>Fleischer</strong> sembrano non concludersi mai davvero su una posizione<br />
precisa; progrediscono distruggendo se stessi. Vale a dire che non portano<br />
da nessuna parte, affastellano idee in preferenza contraddittorie. Mettono<br />
tutto sullo stesso piano. È lo spettatore che è chiamato a decidere, a scegliere,<br />
in totale libertà. Uno spettatore che dunque, in qualche caso, rischia di rimanere<br />
vuoto, deluso, abbandonando la bella ragazza sulla sua altalena di velluto<br />
rosso e il regista nel suo purgatorio, o nel suo limbo: né artigiano né<br />
autore, appunto. In effetti, le orge dell’intelligenza, a volte, generano solo un<br />
lieve senso di amarezza.<br />
Purtroppo, più che un regista sottovalutato o dallo status ambiguo,<br />
<strong>Fleischer</strong>, in realtà, è ridiventato col tempo quasi un regista sconosciuto.<br />
Parafrasando una definizione affibbiata molti anni fa a un fantastico e sfortunato<br />
guitar hero del rock-blues, Roy Buchanan, lo si potrebbe definire “il<br />
14
più grande regista cinematografico sconosciuto del mondo”. In parte per<br />
colpa anche sua: sicuramente, l’ultima parte della carriera è stata contraddistinta<br />
da film non certo eccelsi. Si potrebbe affermare che l’ultimo film<br />
del tutto riuscito di <strong>Fleischer</strong> sia Mandingo, che risale al 1975. Ad esso<br />
sono seguiti altri nove lungometraggi abbastanza dimenticabili, spesso riprese<br />
di film o serie passate, oppure tratti da script di basso livello. Sempre,<br />
però, anche nei casi più difficili, la regia di <strong>Fleischer</strong>, specialmente<br />
nelle sequenze d’azione, si è dimostrata all’altezza della situazione. In precedenza,<br />
nel suo periodo d’oro, la sua opera era stata di quasi costante eccellenza,<br />
molto curata a tutti i livelli, per merito anche delle case di<br />
produzione che via via lo assumevano. <strong>Fleischer</strong> è stato, infatti, a suo massimo<br />
agio quando era ancora in piedi il cosiddetto studio system, ovvero<br />
quando era inserito all’interno di case produttrici strutturate, che si facevano<br />
carico dei loro autori, li sostenevano e li proteggevano. <strong>Fleischer</strong> ha diretto<br />
nove film per la RKO compresi tra il 1947 e il 1951, ben dodici per la Fox,<br />
nel periodo che va dal 1955 al 1970, con un breve intervallo in mezzo. Venuto<br />
meno, agli inizi degli anni Settanta, lo studio system, <strong>Fleischer</strong> si è<br />
trovato improvvisamente allo scoperto, senza più un ancoraggio preciso,<br />
lui, abituato fin dagli esordi a lavorare con un team di riferimento.<br />
Se leggiamo il suo libro di memorie, divertente e istruttivo, intitolato<br />
“Just Tell Me When to Cry”, possiamo seguire in modo molto dettagliato,<br />
attraverso decine di ritratti e aneddoti, l’intero suo percorso nel sistema hollywoodiano,<br />
e i contatti e i rapporti di forza con i diversi moghul che<br />
l’hanno avuto di volta in volta alle loro dipendenze: Howard Hughes, Darryl<br />
Zanuck, Stanley Kramer, Dino De Laurentiis e perfino Kirk Douglas,<br />
l’intrattabile produttore di I vichinghi. Michel Ciment ha scritto bene: “Conosceva<br />
tutti i segreti di un sistema di cui aveva salito tutte le scale, e soprattutto<br />
il potere delle star che gli davano fiducia. Restituito alla sua<br />
libertà, non ha saputo adattarsi alle novità produttive della New Hollywood,<br />
e, come è successo a molti altri registi della sua generazione, ha visto la<br />
sua vita professionale oscurarsi improvvisamente”.<br />
Il cono d’ombra critico in cui <strong>Fleischer</strong> è sprofondato a un certo punto<br />
si spiega, anche, con quello che potrebbe pure apparire un pregio, vale a<br />
dire la grande varietà ed eclettismo dei suoi film. <strong>Fleischer</strong> è oscillato tra<br />
piccoli film quasi d’autore e grandi blockbuster creati per il successo del<br />
botteghino, e sappiamo quanto critici e cinefili siano diffidenti verso le car-<br />
15
iere non troppo coerenti. In realtà, questa era la norma nella Hollywood di<br />
un tempo: se uno dimostrava di saperci fare con i piccoli budget, ecco che<br />
veniva automaticamente promosso a produzioni più impegnative, che indubbiamente<br />
legavano le mani a chi le realizzava. È questo il nostro caso:<br />
<strong>Fleischer</strong> si è dimostrato in grado di passare con facilità da un genere all’altro<br />
del sistema hollywoodiano. È facile, allora, prestarsi alla superficiale<br />
accusa di scarsa personalità: ecco dunque apparire la losca figura del<br />
regista disposto a tutto, del mestierante per tutte le stagioni schiavo dei voleri<br />
dell’industria che lo paga. Nulla di più falso nel caso di <strong>Fleischer</strong>: certo<br />
regista affidabile e degno della fiducia dei vari produttori, ma nel contempo<br />
dotato di un sicuro segno personale. Scrive ancora Michel Ciment: “<strong>Fleischer</strong><br />
si incolla a un genere senza volontà di sovvertirlo, ma introducendovi<br />
sottili variazioni. È un lavoro meno spettacolare, ma che è legato a un<br />
costante lavoro formale”. Sappiamo infatti che, nel genere cinematografico,<br />
non è tanto il soggetto a contare, vincolato com’è a codici e convenzioni<br />
molto precisi, quanto il modo in cui viene di volta in volta trattato dal<br />
singolo autore. Fin da bambino, a contatto diretto con il geniale cinema<br />
d’animazione creato dal padre e dallo zio, <strong>Fleischer</strong> ha certamente subito<br />
l’influenza di un’arte che mette assieme ricerca tecnica e invenzione formale.<br />
Il lavoro sul colore (da L’altalena di velluto rosso a Barabba), le audacie<br />
visive (dal travelling finale di I diavoli del Pacifico allo split screen<br />
di Lo strangolatore di Boston), la predilezione per il formato cinemascope<br />
utilizzato alla Fox negli anni Cinquanta, che peraltro condivide con altri<br />
registi provenienti dal teatro come Elia Kazan, Otto Preminger, Douglas<br />
Sirk e Nicholas Ray, sono la prova della volontà di apertura del regista alla<br />
sperimentazione e all’ innovazione formale e tecnica.<br />
L’opera di <strong>Fleischer</strong> è percorsa, nei momenti migliori, da una “tensione<br />
feconda”, come la definisce Ciment. Il meticoloso lavoro preparatorio<br />
che conduce per i suoi film di intrigo poliziesco, a partire già da Le jene<br />
di Chicago, il gusto realistico della ricostruzione d’epoca (ad esempio per<br />
Frenesia di un delitto e I vichinghi), non impediscono che, spesso, i film di<br />
<strong>Fleischer</strong> sfiorino la categoria del fantastico. Del resto, la dimensione dell’immaginazione<br />
e dell’irrazionale scaturiscono proprio dall’osservazione<br />
del dato reale. Lo scrupolo nell’osservazione dei dettagli realistici e la propensione,<br />
solo in apparenza contraddittoria, al particolare strano o bizzarro,<br />
permettono spesso a <strong>Fleischer</strong> di volgere uno sguardo acuto a una società,<br />
16
passata (Barabba, L’altalena di velluto rosso, Mandingo, Frenesia del delitto),<br />
presente (Le jene di Chicago, Sabato tragico, Lo strangolatore di<br />
Boston, I nuovi centurioni), ed anche futura (Viaggio allucinante, 2022 i sopravvissuti),<br />
di cui individua e sottolinea in modo chiaro difetti, mediocrità,<br />
potenziale di minaccia e di decomposizione.<br />
Con l’eccezione di Welles, nessun regista hollywoodiano ha avuto<br />
come lui la cura di una ricerca permanente della tensione e dell’invenzione<br />
all’interno dell’inquadratura. <strong>Fleischer</strong> non cede mai alla tentazione di una<br />
pura decorazione priva di necessità drammatica: le composizioni più spettacolari,<br />
le inquadrature più inattese dei suoi film non si allontanano mai dal<br />
nerbo e dalla sostanza del racconto. L’irrequietezza è senza dubbio la caratteristica<br />
più evidente dello stile di <strong>Fleischer</strong>: a cominciare da quella dei<br />
corpi, dei volti, dei personaggi in tensione perenne, ai quali il regista non<br />
concede il minimo rilassamento -. come non lo concede a se stesso.<br />
Lungi, dunque, dal rivelarsi opere di pura routine e di asservimento alla<br />
logica conformista dell’industria, i suoi film, o almeno parecchi di essi, rivelano<br />
oggi una sensibilità e una intelligenza critica che accomunano <strong>Fleischer</strong>,<br />
la cui famiglia è di origine austriaca, ad altri registi più o meno<br />
contemporanei che, come lui, provengono dalla “vecchia Europa”. Qualche<br />
nome fra i tanti? Otto Preminger, Anthony Mann, Billy Wilder, Fritz Lang,<br />
Stanley Kubrick, Edgar Ulmer, Robert Siodmak. Unisce questi autori, che<br />
per decenni hanno fatto grande Hollywood, una regia sobria, mai sopra le<br />
righe; l’attenzione al dato sociale e morale, che non scade mai nel messaggio<br />
aperto e ruffiano; il costante rispetto per l’intelligenza dello spettatore;<br />
la capacità di una diagnosi sovente spietata sulle malattie della civiltà<br />
contemporanea e, insieme, sui” comportamenti patologici dell’individuo<br />
singolo, un essere abbandonato alla solitudine e inadeguato alla società che<br />
lo circonda” (Ciment). Colpa del singolo o del contesto? Questo è un interrogativo<br />
che ricorre spesso nei film di <strong>Fleischer</strong>, zeppi di individui malati<br />
o frustrati, che reagiscono alle loro debolezze con l’aggressività.<br />
La carriera<br />
Nato a Brooklyn, New York, l’ 8 dicembre 1916, <strong>Fleischer</strong> ha compiuto<br />
studi prima di medicina e poi di teatro, frequentando la Yale School of<br />
17
Drama dove ha pure fondato una sua compagnia teatrale, gli Arena Players.<br />
Un talent-scout della RKO lo invita a Hollywood per collaborare ai<br />
cinegiornali della Pathé. Durante gli anni di guerra, <strong>Fleischer</strong> cura alcuni<br />
film di propaganda per l’esercito, collaborando alle serie documentarie This<br />
Is America e Flicker Flashbacks. Quest’ultima era costituita da rimontaggi<br />
di film dell’epoca muta. Subito dopo la guerra, nel 1946, la RKO gli offre<br />
di esordire nel lungometraggio con Child of Divorce, il primo film lowbudget<br />
firmato da <strong>Fleischer</strong>. È subito una bella prova di regia, che ruota attorno<br />
alla difficile reazione di una bambina al divorzio dei suoi genitori.<br />
Lo script di Lillie Hayward, basato sul lavoro teatrale “Wednesday’s Child”<br />
di Leopold L. Atlas, evita infatti tutte le possibili trappole di un facile pietismo.<br />
Entrambi i genitori (interpretati da Regis Toomey e Madge Meredith)<br />
sembrano volere solo ciò che è meglio per la figlia; i nuovi partner della<br />
coppia paiono sinceri nel loro desiderio di diventare suoi amici; ma la<br />
bimba, in parte a causa delle innocenti prese in giro che subisce dai compagni<br />
a scuola, in parte perché proprio non riesce a capire, rimane ostinatamente<br />
non riconciliata. La sola soluzione, dunque, è quella di iscriverla<br />
a un collegio: non un qualche antro orrorifico alla Dickens, peraltro, ma un<br />
gradevole, ampio luogo in campagna che contempla ogni divertimento che<br />
una bambina possa desiderare. Qui, in una sequenza finale cruda e commovente<br />
insieme, la bimba impara, sotto la simpatica tutela di una nuova<br />
amichetta che ha conosciuto in un mulino, cosa può attendersi d’ora in<br />
avanti: un’età in cui le arrivano regali sempre più frequenti e voluminosi;<br />
un’età però in cui le visite dei genitori avvengono sempre più raramente; e<br />
poi, soltanto la lunga, lunghissima attesa di crescere e diventare adulta.<br />
<strong>Fleischer</strong> non sbaglia un colpo, e gli attori-bambini (Sharyn Moffett è la<br />
bimbetta infelice, Ann Carter la sua amichetta) sono straordinari.<br />
Il successivo Banjo (Piccolo cuore), del 1947, è basato su uno script<br />
simile di Lillie Hayward. Sharyn Moffett interpreta nuovamente una bambina<br />
di nove anni, che rimane orfana e va a vivere in città con una ricca e<br />
giovane zia (Jacqueline White), che però non le permette di tenere con sé<br />
il cagnolino Banjo. La bestiola si fa male e la bimba la fa curare da un giovane<br />
medico (Walter Reed), che è anche l’ex-fidanzato della zia: con l’aiuto<br />
del cane avverrà dunque la riconciliazione tra i due. Molto più importante<br />
il mediometraggio successivo, Design For Death (1947), che vincerà quell’anno<br />
il premio Oscar per la categoria del documentario. Il film mostra i<br />
18
preparativi giapponesi per l’attacco a Pearl Harbor, ma poi risale settecento<br />
anni indietro nella storia nipponica per descrivere il sistema feudale delle<br />
caste, una rivolta contadina soffocata dopo che i samurai hanno ucciso più<br />
di quarantamila persone, l’apertura al commercio internazionale a cui il<br />
Giappone fu costretto dall’ammiraglio americano Perry, la follia perversa<br />
di trasformare la religione scintoista di adorazione della natura in un credo<br />
fanatico secondo il quale i giapponesi sarebbero una razza padrona e il loro<br />
imperatore una sorta di Dio Sole a cui si deve obbedire ciecamente, e poi,<br />
nuovamente, come sbocco quasi necessario di tutto ciò, l’attacco proditorio<br />
a Pearl Harbor. Le voci narranti appartengono ad attori piuttosto noti,<br />
come Kent Smith e Hans Conreid.<br />
Del 1948 è la prima incursione del regista nel filone thriller con Bodyguard<br />
(Squadra mobile). A ventitre anni, Robert Altman ottiene il suo<br />
primo credit a Hollywood come co-autore del soggetto del film, insieme a<br />
un certo George W. George. Il film è il classico B-movie nella ben nota<br />
linea RKO di quegli anni. Lawrence Tierney interpreta un poliziotto poco<br />
affidabile che si fa assumere come guardia del corpo del padrone di una<br />
fabbrica di confezioni di carne che si trova sotto tiro dei criminali. Naturalmente,<br />
nel film ci sono molti più trabocchetti e astuzie di quanto ci si potrebbe<br />
attendere da un plot così elementare. <strong>Fleischer</strong> indugia in alcuni abili<br />
passaggi e sforna almeno una sequenza elettrizzante, quella in cui la partner<br />
femminile di Tierney, Priscilla Lane, usa una cabina di registrazione per<br />
archiviare su vinile una prova chiave.<br />
<strong>Fleischer</strong> torna alla commedia con So This Is New York (Due sorelle a<br />
New York, 1948), basato su “The Big Town”, un romanzo del 1925 di Ring<br />
Lardner, sceneggiato da Carl Foreman e prodotto dall’esordiente Stanley<br />
Kramer. Un ometto che vive in una smalltown (l’attore è la star radiofonica<br />
Henry Morgan) eredita una fortuna e porta la famiglia a vivere a New<br />
York. Lo shock per la cultura urbana che ne consegue assume bizzarre<br />
forme e si incarna in strani personaggi. Il primo, vero successo del regista<br />
è però dell’anno successivo: il thriller Follow Me Quietly (Seguimi in silenzio,<br />
1949), prodotto ancora dalla RKO. Il grande Anthony Mann è tra i<br />
soggettisti di questo piccolo gioiello noir, uno dei primi a mettere al centro<br />
del plot la figura di un serial killer. Un omicida seriale con velleità moralizzatrici<br />
preannuncia i propri delitti spedendo lettere minacciose in cui<br />
scrive di voler punire i peccatori. Si firma “il giudice” e strangola le sue vit-<br />
19
time solo quando sta piovendo. L’agente Harry Grant (William Lundigan),<br />
che si occupa del caso, fa costruire un manichino con le sembianze dell’assassino,<br />
sulla base dell’identikit fornito da una delle vittime prima di tirare<br />
le cuoia. C’è anche una giornalista spigliata, Ann Gorman (Dorothy<br />
Patrick), che fornisce un contributo decisivo per risolvere il caso e che naturalmente<br />
si innamora del protagonista. Il colpevole è un individuo onesto<br />
e gentile, il classico “insospettabile”. Il film resta nella memoria,<br />
soprattutto, per la lunga sequenza finale, di chiara matrice espressionista<br />
(alla M, per intenderci) che ha luogo in una fabbrica.<br />
Di normale routine il film che segue, Mike Mine Laugh (1949), che è<br />
un pastiche, il secondo di tre film composti da numeri musicali e sketch<br />
comici tratti da precedenti film della RKO. Ci sono ventriloqui, ballerine,<br />
mimi, e, tra i film saccheggiati, ritroviamo anche Bamboo Blonde di Anthony<br />
Mann, in una suggestiva sequenza del quale Frances Langford canta<br />
languidamente il brano “Moonlight Over the Islands”. Ci sono anche spezzoni<br />
già utilizzati per la serie documentaria di montaggio Flicker Flashbacks<br />
a cui <strong>Fleischer</strong> aveva lavorato alcuni anni prima.<br />
Si entra ormai nell’epoca d’oro del noir, cui <strong>Fleischer</strong>, sempre di stanza<br />
alla RKO, fornisce un notevole contributo dirigendo, uno dopo l’altro, quattro<br />
film di ottimo livello (soprattutto gli ultimi due). Nuovamente sceneggiato<br />
da Carl Foreman, The Clay Pigeon (Bersaglio umano), del 1949, vede<br />
lo statico Bill Williams nei panni di un ex-prigioniero di guerra che soffre<br />
di amnesia (un vero topos classico del noir postbellico) e che lotta per ristabilire<br />
la propria innocenza, dato che è stato accusato di tradimento e di<br />
essere il responsabile della morte di un amico in un campo di concentramento<br />
giapponese. Il film è diretto da <strong>Fleischer</strong> con nitida energia, nonostante<br />
uno script poco plausibile e performance attoriali modeste (c’è anche<br />
Barbara Hale, futura segretaria del Perry Mason televisivo, che interpreta<br />
la vedova dell’amico, all’inizio ostile e ben presto innamorata del protagonista)<br />
ne ridimensionino un po’ la qualità. Trapped (1949), gemello del<br />
manniano T-Men contro i fuorilegge di due anni precedente, appartiene, invece,<br />
al fortunato filone documentarista/realista del noir postbellico. All’inizio,<br />
l’austera, familiare voce di un commentatore fuori campo esalta<br />
infatti l’onnipotenza del mitico Dipartimento del Tesoro americano. Il film,<br />
una volta proclamato il suo credo “politico”, passa a trattare del caso all’ordine<br />
del giorno, che è quello di un piccolo delinquente, sciatto e ag-<br />
20
gressivo, interpretato da Lloyd Bridges, che esce di prigione e si mette alla<br />
ricerca delle matrici con cui falsificare le banconote, senza sapere che gli<br />
uomini del Dipartimento stanno pedinando ogni suo movimento. Seguono<br />
svolte narrative e rovesciamenti di sorte piacevolmente imprevedibili, con<br />
gli affascinanti motivi visivi tipici del genere noir: complotti tramati in appartamenti<br />
dalla luce fioca, tizi con cappelli flosci che salgono i gradini di<br />
scale sinistre, dosi generose di violenza coreografata in modo pittoresco, soprattutto<br />
nell’ottimo climax della sequenza con la sparatoria nella rimessa<br />
degli autobus. Per l’unica volta nella sua carriera, forse, John Hoyt, che in<br />
genere recita nella parte di un “cattivo” minore, ha la parte dell’eroe protagonista.<br />
Anche nello strepitoso Armored Car Robbery (Sterminate la gang!,<br />
1950) compaiono in ruoli da protagonisti attori fantastici che normalmente<br />
nei film hanno soltanto piccole parti: William Talman (più noto come televisivo<br />
procuratore distrettuale sempre perdente di fronte a Perry Mason) e<br />
Charles McGraw, uno dei “volti” del noir col suo profilo aquilino da “duro”<br />
alla Dick Tracy, utilizzato spesso anche da Anthony Mann. Il “film di rapina”<br />
ha dovuto soccombere nel tempo alla ripetitività e a inutili rielaborazioni,<br />
ma questo autentico gioiello – che apre la strada a film ben più noti<br />
ma non certo migliori come Giungla d’asfalto di John Huston e Rapina a<br />
mano armata di Stanley Kubrick – è di una razza a parte. Quasi documentaristico<br />
nel racconto di una rapina che finisce male e delle successive difficili<br />
indagini della polizia, il film fa un eccellente uso di varie location di<br />
Los Angeles e si affida a un profondo contrasto luministico per “modellare”<br />
superbamente la realtà, nello stile caratteristico del noir. Le caratterizzazioni<br />
sono indimenticabili: Talman è la sordida mente criminale, Adele<br />
Jergens una spogliarellista viziosa e doppiogiochista, McGraw il poliziotto<br />
granitico che vuole a ogni costo vendicare la morte del suo partner.<br />
Charles McGraw è l’inaspettato protagonista del successivo The Narrow<br />
Margin (Le jene di Chicago, 1952), uno dei capolavori di <strong>Fleischer</strong>, e<br />
il suo “casting” nel ruolo del poliziotto regala molta ambiguità al film. Infatti,<br />
McGraw, normalmente, impersona il “cattivo” della storia, e qui deve<br />
dibattersi nel dilemma se contravvenire al suo dovere cedendo alle lusinghe<br />
dei criminali che gli offrono del denaro per chiudere un occhio, oppure<br />
tener duro e proteggere la donna che sta scortando a un processo. Nel film,<br />
c’è infatti la più classica delle premesse pulp: il poliziotto, che ha visto mo-<br />
21
ire un suo collega subito all’inizio del film, deve scortare la vedova di un<br />
criminale davanti al Gran Giurì per farla testimoniare contro un boss. Il<br />
problema è che c’è un bel mucchio di killer sguinzagliati dietro di lei col<br />
preciso compito di farla fuori. Le facce sono indimenticabili, nel più puro<br />
casting da B-movie: oltre al magnificamente ambiguo McGraw c’è la sordida<br />
sirena Marie Windsor, in una parte che anticipa quella in Rapina a<br />
mano armata. Il setting è ugualmente classico nella sua concentrazione<br />
claustrofobica: un treno espresso transcontinentale in cui ogni passeggero<br />
e ogni fermata possono rappresentare una minaccia mortale. Il ritmo è incalzante,<br />
frenetico. Brulicante di piccoli e grandi incidenti, il film è infatti<br />
costruito con una velocità che toglie il fiato. In una parola, un gioiello a<br />
basso budget e ad alta suspense.<br />
Di tutt’altro genere è The Happy Time (Tempo felice, 1952). Basato<br />
sul romanzo del 1945 di Robert Fontaine, segue la crescita a Ottawa, in<br />
Ontario, del giovane Robert Bibi Bonnard , interpretato da Bobby Driscoll,<br />
coccolato dai genitori Jacques (Charles Boyer), musicista in un teatro di<br />
vaudeville, e Susan (Marsha Hunt). Ci sono anche uno zio ubriacone e un<br />
altro zio, Desmonde (Louis Jourdan), commesso viaggiatore sciupafemmine.<br />
Desmonde contende le attenzioni della giovanissima Mignonette<br />
(Linda Christian) proprio a Bibi, che poi dirotterà il suo interesse verso la<br />
vicina di casa e compagna di scuola Peggy (Marlene Cameron). Co-prodotto<br />
da Stanley Kramer, è una commedia di formazione sul coming up of<br />
age di un adolescente circondato da una famiglia dai forti vincoli affettivi,<br />
amabile e con un bel cast (c’è anche Jeanette Nolan nella parte della sfortunata<br />
moglie dello zio ubriacone).<br />
<strong>Fleischer</strong> dimostra di saper dirigere qualsiasi produzione gli sia commissionata:<br />
è affidabile e competente. Lo scelgono anche per uno dei primi<br />
esperimenti di 3-D, Arena (id, 1953). Per alcuni mesi, nel corso dell’estate<br />
del 1953, parve infatti che il 3-D potesse prendere il sopravvento nell’industria.<br />
Ma gli occhialini – la logistica del doverli procurare, la scomodità<br />
del doverli indossare – portarono rapidamente alla scomparsa (provvisoria,<br />
visto il recente revival…) di questa tecnologia, che nel film di <strong>Fleischer</strong>,<br />
visibile ormai solo in 2-D e dunque appiattito, è ancora riconoscibile<br />
negli aggiustamenti dei piani dentro l’inquadratura, in una certa confusione<br />
dell’immagine, e negli improvvisi movimenti verso la macchina da presa<br />
degli oggetti, ad esempio una scarpa durante una rissa. Come suggerisce il<br />
22
titolo, Arena è un film sul rodeo, girato in stile documentaristico e in tempo<br />
quasi reale, in cui troviamo, immancabili, i tre stereotipi del filone: il campione<br />
dimenticato (Henry Morgan), il novellino arrogante (Robert Horton)<br />
e il veterano stanco (Gig Young).<br />
Il film successivo di <strong>Fleischer</strong>, 20,000 Leagues Under the Sea (20.000<br />
leghe sotto i mari, 1954), oltre a essere il suo primo girato a colori, è anche<br />
uno dei suoi migliori. Prodotto dalla Disney (la rivale acerrima della ditta<br />
di famiglia…), rimane uno dei suoi adattamenti live action più ambiziosi.<br />
Il film volgarizza solo marginalmente l’originale di Jules Verne e impressiona<br />
per la forza selvaggia di alcune sequenze (la battaglia con la piovra<br />
gigante in primis) e per l’inventiva delle scenografie, soprattutto dei lussuosi<br />
interni in stile vittoriano dell’indimenticabile sommergibile Nautilus.<br />
È stato anche il primo film prodotto dalla Disney a utilizzare le grandi star:<br />
James Mason fornisce un’accattivante interpretazione del tormentato capitan<br />
Nemo, e Peter Lorre è fantastico nei panni di uno dei suoi seguaci. Il<br />
tempo non è stato altrettanto clemente con il ruolo di Kirk Douglas, l’avido<br />
arpioniere con la maglietta a righe: sembra quasi che sia stato inserito nel<br />
cast soltanto per rassicurare lo spettatore americano sconcertato da quello<br />
che poteva anche sembrare un plot fortemente anti-colonialista. Il film rimane,<br />
comunque, una delle grandi avventure dello schermo, e merita del<br />
tutto la sua “canonizzazione” nel parco di divertimenti di Disneyworld,<br />
dove un’elaborata corsa subacquea tenta, riuscendovi solo in parte, di evocare<br />
alcuni dei momenti di maggior suspense della pellicola.<br />
<strong>Fleischer</strong> torna al prediletto thriller inaugurando il suo duraturo sodalizio<br />
con la Fox grazie a Violent Saturday (Sabato tragico, 1955), un ottimo<br />
film su di una rapina a una banca girato nella luce accecante, esaltata<br />
dalla fotografia in cinemascope e Deluxe color, del sole di mezzogiorno<br />
del Midwest, senza che ci sia un’ombra in vista. Ogni film che schieri, tutti<br />
in una volta, attori come Victor Mature, Ernest Borgnine e Lee Marvin si<br />
annuncia come un manuale di spietata violenza cinematografica; ma, in realtà,<br />
Borgnine interpreta qui un contadino fondamentalista religioso, e Mature,<br />
l’eroe buono, viene ben presto relegato ai margini quando deve<br />
vedersela con la performance diabolicamente minimalista di Marvin nei<br />
panni di un killer dalla parlantina sciolta e dal perpetuo raffreddore. Marvin<br />
va in giro borbottando: “le donne e i bambini mi rendono nervoso”, e<br />
riesce a rendere perverso perfino il gesto di inalarsi continuamente benze-<br />
23
drina nel naso! Dietro l’aspetto amabile, il personaggio è capace di estrema<br />
violenza: schiaccia le dita a un ragazzino che gli aveva strappato dalle mani<br />
lo spray nasale. Alla lunga, <strong>Fleischer</strong> sottrae un po’ di spazio all’azione<br />
concentrandosi sulla battaglia morale in corso alla fattoria, con il contadino<br />
buono Borgnine che, alla fine, pianta il suo forcone nella schiena di<br />
Marvin.<br />
Fiammeggiante melò in costume, The Girl in the Red Velvet Swing<br />
(L’altalena di velluto rosso, 1955) è giustamente celebrato come uno dei<br />
vertici della carriera di <strong>Fleischer</strong>. È anche il primo di una serie di film che<br />
il regista, evidentemente un fan della materia, ha tratto da celebri casi di<br />
cronaca nera. Ai primi dell’Ottocento, ci fu infatti uno scandalo nella società<br />
bene di New York: il milionario Harry Thaw uccise per gelosia l’architetto<br />
Stanford White, l’amante della moglie, la procace ballerina Evelyn<br />
Nesbit. Il melodramma a forti tinte e a colori saturi di <strong>Fleischer</strong> ricostruisce<br />
la vicenda, analizzando con notevole finezza la relazione perversa che<br />
si instaura tra tre personaggi dalle ambigue pulsioni, interpretati, rispettivamente,<br />
da Farley Granger, Ray Milland e Joan Collins. Girato anch’esso<br />
col procedimento Deluxe color, in origine era ricco di un cromatismo sfavillante<br />
che, nelle copie in pellicola più recenti, è andato in parte perduto,<br />
soprattutto nelle sequenze in cui compare l’altalena rossa del titolo, all’interno<br />
di un giardino segreto luogo di seduzione della ballerina da parte del<br />
maturo e ricco spasimante.<br />
L’esordio nel western di <strong>Fleischer</strong> avviene relativamente tardi, con<br />
Bandido (Bandido, 1956). Il regista dimostra subito, però, di saper maneggiare<br />
da par suo anche questo genere, dirigendo con solido mestiere Robert<br />
Mitchum nella parte di un avventuriero yankee che, nel Messico del 1916,<br />
gioca su due sponde, promettendo armi all’esercito regolare ma vendendole<br />
poi all’armata rivoluzionaria. Per complicarsi ulteriormente la vita, il<br />
protagonista si innamora della moglie del losco fornitore. Subito dopo il<br />
debutto nel western, c’è quello nell’altro genere “maschile” per eccellenza<br />
di Hollywood, il film bellico, con Between Heaven and Hell (I diavoli del<br />
Pacifico, 1956), in cui <strong>Fleischer</strong> torna al bianco e nero dopo alcuni film girati<br />
a colori. Un altezzoso gentiluomo sudista (Robert Wagner) è costretto<br />
ad abbassare notevolmente la cresta quando viene spedito sul fronte del Pacifico<br />
nella seconda guerra mondiale e si trova intruppato nel plotone “suicida”<br />
comandato da un autentico psicotico (un grande Broderick Crawford).<br />
24
Non c’è neanche bisogno di dirlo: il nostro snob si redime e manda a memoria<br />
ogni possibile lezione a proposito di umiltà e umanità in tempi difficili.<br />
Anche <strong>Fleischer</strong> mostra umiltà di regia, tiene bene insieme l’azione,<br />
e non lascia che retorica e buoni sentimenti saturino il film.<br />
Il regista torna all’epica, e al colore, con la strepitosa saga nordica di<br />
The Vikings (I vichinghi, 1957), in cui i due fratellastri vichinghi Kirk Douglas<br />
e Tony Curtis combattono tra loro per il trono di Northumbria. Un film<br />
straripante di saccheggi, lanci di scuri, boccali di birra, assalti di castelli,<br />
eroici salti in fosse di lupi, e tante chiacchiere sulla gloria di entrare nel<br />
Walhalla con lo spadone in mano. Splendidamente fotografata da Jack Cardiff,<br />
e diretta con verve e muscoli da <strong>Fleischer</strong>, questa epica storica continua<br />
a divertire lo spettatore anche dopo decine di visioni. These Thousands<br />
Hills (Il re della prateria), del 1959, è il secondo western diretto da <strong>Fleischer</strong>,<br />
che non pare troppo interessato ai canoni classici del genere. In effetti,<br />
più che un western il film è un melodramma: un cacciatore (Don<br />
Murray, moscio) si fa aiutare da una puttana (Lee Remick, radiosa) nella<br />
sua scalata sociale a ranchero disposto a tutto per i soldi e il potere, ma poi<br />
la lascia per strada. Salvo pentirsene anni dopo, quando ormai è troppo tardi<br />
per rimediare ai danni.<br />
<strong>Fleischer</strong> riscopre un altro caso celebre di cronaca nera nel successivo<br />
Compulsion (Frenesia del delitto, 1959), versione cinematografica del romanzo<br />
di Meyer Levin basato sul caso Leopold-Loeb, in cui due studenti<br />
di legge omosessuali uccisero un ragazzo per dimostrare la loro superiorità<br />
intellettuale (il fatto aveva già ispirato nel 1948 Nodo alla gola di Alfred<br />
Hitchcock). Molto riuscito finché rimane fedele al formato del thriller, è<br />
altrettanto efficace nell’ambientazione storica (la Chicago del 1924). Resta<br />
impressa, soprattutto, la lunghissima, commovente, arringa finale dell’avvocato<br />
della difesa, interpretato da Orson Welles, che, muovendo a fatica<br />
il suo corpaccione, chiede e ottiene per i suoi assistiti l’attenuante dell’infermità<br />
mentale. Ottimi, oltre a Welles, il tremebondo Dean Stockwell e il<br />
cinico Bradford Dillman che interpretano i due studenti assassini. Meno<br />
riuscito il thriller in bianco e nero Crack in the Mirror (Dramma nello specchio,<br />
1960), che si compone di due storie parallele di triangoli sessuali, un<br />
po’ meccaniche, interpretate dagli stessi attori. Nella prima, la moglie (Juliette<br />
Gréco) di un marito ubriacone (Orson Welles), decide di uccidere il<br />
coniuge con l’aiuto dell’amante (Bradford Dillman), ma i due assassini<br />
25
sono scoperti e condannati; nella seconda, la Gréco vorrebbe sposare un<br />
giovane (Dillman), ma la notizia scatena una crisi cardiaca nel vecchio<br />
amante di lei (Welles) e i due giovani decidono di lasciarsi.<br />
Una vera bizzarria il film successivo, The Big Gamble (Il grosso rischio,<br />
1961), scritto da Irvin Shaw. Una coppia di irlandesi parte su un camion<br />
insieme a un cugino alla volta della Costa d’Avorio per intraprendervi<br />
un’attività commerciale. Sdoganato il veicolo, si dirigono all’interno dove<br />
li attendono mille difficoltà. Curioso film, in bilico tra avventure e commedia<br />
drammatica, diretto a quattro mani da <strong>Fleischer</strong> e Elmo Williams,<br />
un produttore della Fox. Man mano che si dipana, la vicenda ricorda sempre<br />
più Vite vendute (1953), il classico di Henri-Georges Clouzot.<br />
<strong>Fleischer</strong> batte poi un gran colpo con Barabbas (Barabba, 1961). Il regista<br />
si mette nelle mani di Dino De Laurentiis e dirige uno dei film epici<br />
più stilizzati e di successo emersi nel glorioso periodo della cosiddetta<br />
“Hollywood sul Tevere”. Anthony Quinn impersona il leggendario ladrone,<br />
il cui viaggio spirituale e fisico inizia al momento della crocefissione del<br />
Cristo e termina nell’arena di Roma, dopo un periodo di permanenza nelle<br />
miniere di zolfo. La qualità, per certi versi sorprendente, del film deve parecchio<br />
ai dialoghi sofisticati e letterari scritti da Christopher Fry, ma, certamente,<br />
almeno altrettanto alla notevole abilità di <strong>Fleischer</strong> come regista<br />
delle scene d’azione.<br />
Il buon momento del regista è confermato dal film successivo, Fantastic<br />
Voyage (Viaggio allucinante, 1965), che è anche la sua prima incursione<br />
nel genere fantascientifico (con molti tratti del thriller, a dire il vero).<br />
La stupefacente premessa del film è che, quando uno scienziato di fama<br />
mondiale che ha scelto l’Occidente libero soffre di una lesione cerebrale durante<br />
il tentativo di assassinarlo da parte di agenti comunisti, la soluzione<br />
del problema è quella di miniaturizzare ed iniettare nel suo sistema sanguigno<br />
un sottomarino e una intera equipe medica per riparare il danno. Il<br />
viaggio attraverso i fantastici paesaggi dell’interno di un corpo umano è<br />
reso con una brillante capacità immaginativa. Ci imbattiamo, via via, in un<br />
cuore che sembra l’antro di una cripta, in ondate di marea che sconvolgono<br />
i canali interni dell’orecchio (prodotte quando una infermiera lascia cadere<br />
uno strumento in sala operatoria), in venti ciclonici che spazzano il sottomarino<br />
allorché vengono raggiunti i polmoni (la causa è il respiro del paziente).<br />
Lo script mostra una notevole inventiva, alternando una lettura<br />
26
medica e scientifica alla crescente suspense su chi sia il misterioso sabotatore<br />
che si nasconde a bordo del sottomarino (va detto che il suo aspetto<br />
equivoco e sudaticcio non lascia molto spazio al mistero…).<br />
Doctor Dolittle (Il favoloso dottor Dolittle, 1967) è la lussuosa versione<br />
musicale prodotta dalla Fox degli amatissimi racconti di Hugh Lofting.<br />
Un flop non annunciato, che quasi mandò in bancarotta lo studio dato<br />
che gli spettatori si guardarono bene dall’affollare le sale cinematografiche.<br />
Con il senno di poi, non è difficile capire il perché. Le pagliacciate del<br />
gentile veterinario interpretato da Rex Harrison, che ha imparato quattrocentonovantotto<br />
linguaggi animali, non riescono a trovare, per tutta la lunghissima<br />
durata del film, una forma interessante dal punto di vista<br />
drammatico; il non irresistibile braccio destro di Dolittle (Anthony Newley)<br />
e il suo vago interesse sentimentale (Samantha Eggar) non offrono un<br />
grande aiuto. È vero, però, che le canzoni di Leslie Bricusse (tra cui “If I<br />
Could Talk to the Animals”) posseggono un loro fascino, e lo spettacolo<br />
pre-computer grafica di millecinquecento animali vivi tutti assieme ha una<br />
sua indiscutibile magia che funziona con gli spettatori più giovani (mentre<br />
quelli più smaliziati, piuttosto, pensano con simpatia e spirito di solidarietà<br />
agli indubbi tormenti di <strong>Fleischer</strong> e della sua troupe: la sequenza deve davvero<br />
essere stata un incubo da girare, specialmente quando uno dei pappagalli<br />
deve imparare a mimare il “Cut!” del regista…).<br />
<strong>Fleischer</strong> ritorna sul prediletto terreno del thriller e dei casi celebri con<br />
The Boston Strangler (Lo strangolatore di Boston, 1968). Ci troviamo, qui,<br />
alle prese con uno sgradevole caso di schizofrenia multipla. Sempre attento<br />
alla sperimentazione di nuove tecniche, <strong>Fleischer</strong> impiega per la prima volta<br />
la frammentazione delle immagini sullo schermo (il cosiddetto splitscreen),<br />
che, come il 3-D, godrà di un breve momento di gloria. Il personaggio<br />
reale di Albert DeSalvo, uno dei primi e più famosi serial killer della<br />
storia, perpetratore confesso di undici strangolamenti, viene risolto nello<br />
script in un evidente caso di personalità multipla, al punto che lo spettatore<br />
è quasi autorizzato a provare simpatia per un felice marito e padre di famiglia<br />
costretto, gradualmente, a confrontarsi con i crimini commessi dal<br />
suo oscuro alter ego, che sembra agire a sua totale insaputa... Tony Curtis<br />
regala una performance attenta a ogni sfumatura, e si sforza di immettere<br />
vita nel cliché del killer seriale. La città di Boston vive in uno stato di panico<br />
non proprio esasperato (grazie allo split-screen, vediamo, nello stesso<br />
27
momento, in un lato della strada alcune anziane signore che fanno gossip,<br />
e, nell’altro, un cadavere che attende di essere esaminato dalla polizia scientifica).<br />
Le sequenze degli interrogatori sono tirate un po’ troppo per le lunghe.<br />
Ci sono però dei momenti piuttosto riusciti, ad esempio quando le<br />
meticolose indagini della polizia alla ricerca del serial killer svelano, in<br />
corso d’opera, un po’ di spazzatura umana acquattata negli anfratti bui della<br />
città, una vera e propria variegata collezione di pervertiti pallidi e vergognosi.<br />
Un altro celebre personaggio della cronaca recente, Che Guevara, interpretato<br />
da Omar Sharif, è il soggetto del film successivo, il biopic Che!<br />
(Che, 1969). Si tratta di uno dei più bizzarri film usciti dal breve periodo<br />
in cui Hollywood ha flirtato con la rivoluzione durante gli anni Sessanta,<br />
un lavoro peraltro abbastanza neutro, ma, qui e là, piuttosto divertente, soprattutto<br />
grazie all’eccentrica scelta della star brutta e cattiva per eccellenza,<br />
Jack Palance, come interprete di un Fidel Castro scoppiato di<br />
anfetamine. Nel 1970 esce il kolossal Tora! Tora! Tora! (id), secondo e ultimo<br />
war movie di <strong>Fleischer</strong>. Questo interminabile polpettone bellico è, in<br />
realtà, più un prototipo del filone catastrofico (il cosiddetto “disaster<br />
movie”) che sta per inaugurare la sua epoca d’oro, a riprova delle doti di<br />
sperimentatore del regista, o almeno della fiducia che Hollywood è disposta<br />
a concedergli quando si tratta di intraprendere vie nuove. Il film ricostruisce<br />
con dovizia di particolari l’attacco proditorio a Pearl Harbor (si<br />
riallaccia, dunque, al lontano documentario premio Oscar del regista) ed è<br />
costato venticinque milioni di dollari: uno dei più cari film americani fino<br />
ad allora. Un cast di tutto rispetto (svetta Toshiro Mifune) va un po’ perduto<br />
nell’alluvione di effetti speciali; e le sequenze dirette da Toshio Masuda e<br />
Kinji Fukasaku, che intendono mostrare il punto di vista dei giapponesi<br />
sulla vicenda, fanno capire che la produzione, mescolando un po’ le carte,<br />
è stata ben attenta a non urtare le suscettibilità e le sensibilità delle due nazioni<br />
in conflitto. Il climax, però, si risolve in qualcosa di più di una semplice<br />
sequenza di battaglie navali, e l’intelligente regia di <strong>Fleischer</strong> riesce<br />
a generare una vera sensazione di caos e apocalisse.<br />
Si torna al thriller e ai casi celebri di cronaca nera con 10 Rillington<br />
Place (L’assassino di Rillington Place n. 10, 1970). Per essere un regista<br />
il cui lavoro rivela una strana ed evidente fascinazione per la ricostruzione<br />
di crimini realmente accaduti, <strong>Fleischer</strong>, questa volta, sembra però un po’a<br />
28
disagio alle prese con il celebre caso Christie/Evans. Anche se tutti i dettagli<br />
d’epoca (gli anni Quaranta) sono corretti (lo script di Clive Exton è basato<br />
su di un libro di Ludovic Kennedy), abbastanza poco<br />
dell’ambientazione nella Gran Bretagna del dopoguerra viene colto sullo<br />
schermo. Inoltre, concentrandosi in maniera ossessiva sui personaggi di<br />
Christie (Richard Attenborough) e dell’isterico Evans (John Hurt), <strong>Fleischer</strong><br />
si lascia un po’ prendere la mano dagli eccessi gigioneschi della recitazione<br />
“all’inglese” dei due attori. Il risultato finale è più un<br />
melodramma che non il lucido esame di una patologia criminale.<br />
In seguito <strong>Fleischer</strong> gira l’ennesimo thriller, See No Evil (Terrore cieco,<br />
1971). Mia Farrow impersona Sarah, una ragazza cieca ospite degli zii.<br />
Una sera, tornata a casa, trova la famiglia massacrata: l’omicida è ancora<br />
nell’appartamento. Riesce miracolosamente a fuggire, ma non sa più di chi<br />
fidarsi. Thriller progettato nella evidente scia del successo dell’assai simile<br />
Gli occhi della notte (1967) di Terence Fisher, in cui era Audrey Hepburn<br />
a impersonare la vittima non vedente. La sequenza-clou del film è quella<br />
in cui la Farrow si aggira per la casa senza poter vedere i cadaveri dei parenti<br />
disseminati attorno a lei. Per aumentare la suspense (anche noi spettatori<br />
non dobbiamo vederlo!), dell’assassino vengono inquadrati soltanto<br />
gli stivali. In The Last Run (L’ultima fuga, 1971), George C. Scott interpreta<br />
un anziano gangster di Chicago, un tempo asso del volante al servizio del<br />
Sindacato del crimine, che, con moglie fuggita e figlio defunto, riemerge<br />
dal suo tetro ritiro in Portogallo per portare a termine un ultimo lavoro e<br />
provare a se stesso che è ancora un uomo in gamba. Sia John Huston che<br />
John Boorman rifiutarono la regia del film, e la cosa non sorprende perché<br />
lo script è decisamente sopra le righe, pretenzioso, si dilunga a spiegare<br />
cose che lo spettatore ha già capito da sé in un secondo. Come ormai sappiamo,<br />
<strong>Fleischer</strong>, invece, non rifiuta nulla, è in grado di portare a termine<br />
ogni lavoro con professionalità. Infatti, il film non è per niente male: le sequenze<br />
di azione, al solito, sono girate benissimo, Scott è perfetto, e la fotografia<br />
di Sven Nykvist è straordinaria.<br />
Molto interessante, e a suo modo anch’esso progenitore di un nuovo<br />
filone (la polizia che guarda se stessa), il film successivo, The New Centurions<br />
(I nuovi centurioni, 1972), adattamento piuttosto libero del romanzo<br />
di Joseph Wambaugh. Ogni sintomo del malessere sociale di un periodo<br />
turbolento è colto al volo e usato con spregiudicata crudezza per allestire<br />
29
una serie di episodi che si svolgono durante un’ordinaria giornata di lavoro<br />
in una normale stazione di polizia: infanti maltrattati, estorsioni, liti coniugali,<br />
retate di travestiti, c’è un po’ di tutto. La cosa che colpisce è che più<br />
il film si dà da fare perché lo spettatore simpatizzi con i poliziotti, più simpatia<br />
quello prova invece per le loro vittime! Il tutto è tenuto assieme con<br />
bravura dal tema dell’iniziazione, svolto però in modo stranamente macabro:<br />
un poliziotto anziano insegna a quello giovane tutto ciò che sa prima<br />
di farsi esplodere il cranio.<br />
<strong>Fleischer</strong>, dopo alcuni anni, torna per la seconda volta alla fantascienza<br />
con il riuscito Soylent Green (2022: i sopravvissuti, 1973). È un film distopico,<br />
adattato dal romanzo “Make Room! Make Room!” di Harry Harrison,<br />
che può avere i suoi difetti (il sentimentalismo, la propensione a<br />
lanciar messaggi, un finale non così sorprendente come avrebbe potuto essere),<br />
ma certamente di gran lunga superiore al cinema di fantascienza che<br />
stava per imporsi, al giovanilismo un po’ stupido che sarà epitomizzato in<br />
film come Guerre stellari (1977) di George Lucas e ET l’extra-terrestre<br />
(1982) di Steven Spielberg. Il film di <strong>Fleischer</strong> anticipa piuttosto, per alcuni<br />
aspetti, la complessità di Blade Runner (1982) di Ridley Scott. Descrive, infatti,<br />
un futuro prossimo tormentato dalla sovrappopolazione, dall’inquinamento<br />
e dai cambiamenti climatici, e una New York divenuta ormai una<br />
babele brulicante di quaranta milioni di abitanti. Charlton Heston interpreta<br />
il poliziotto che sta indagando sull’omicidio di un dirigente della multinazionale<br />
che produce il cibo sintetico del titolo originale, da cui tutti ormai<br />
dipendono per la loro sopravvivenza; Edward G. Robinson, fantastico nell’ultimo<br />
ruolo della sua carriera, impersona il suo sodale, che, mentre si<br />
avvicina alla morte, assapora le memorie dei bei tempi andati. Roba solida<br />
e di qualità, assemblata in modo tanto brillante da apparire del tutto persuasiva.<br />
Per niente male anche il successivo The Don Is Dead (Il boss è morto,<br />
1973), un film di mafia che, evidentemente, cerca di lucrare un po’sul successo<br />
mondiale de Il Padrino (1972) di Francis Ford Coppola. Una volta di<br />
più, per mansioni di questo tipo, l’industria si rivolge volentieri al buon<br />
<strong>Fleischer</strong>, che offre assoluta garanzia di professionalità nell’eseguire un<br />
compito ben preciso. Il film è un convincente racconto di mafiosi, che<br />
prima si spartiscono Las Vegas, poi si tradiscono a vicenda per mettere le<br />
mani su di una fetta più grande della torta (Martin Scorsese lo avrà certa-<br />
30
mente studiato prima di girare, nel 1995, il suo Casinò). Anthony Quinn indossa<br />
in modo sorprendentemente sommesso ed efficiente i panni del<br />
grande boss, Frederic Forrest funziona bene come giovane membro che<br />
vuole uscire dalla Famiglia, e <strong>Fleischer</strong> maneggia il tutto con energia e<br />
competenza.<br />
Terzo e ultimo western diretto da <strong>Fleischer</strong>, The Spikes Gang (La<br />
banda di Harry Spikes, 1974) è un film abbastanza appassionante, tratto<br />
dal romanzo “The Bank Robber” di Giles Tippette e costruito un po’ come<br />
il sequel di Cattive compagnie (1972) di Robert Benton., ma che ricorda<br />
molto anche il famigerato I Cowboys (1972) di Mark Rydell, in cui il vecchio<br />
John Wayne ammaestrava una banda di ragazzini prima di morire ammazzato<br />
da Bruce Dern. Lee Marvin è un pistolero ferito che viene soccorso<br />
da tre ragazzi, e più tardi (dopo che loro sono fuggiti di casa in caccia della<br />
vita eccitante e facile evocata dai suoi racconti) diventa il loro tutore guidandoli<br />
per un sentiero molto pericoloso. Territorio forse familiare (il pistolero<br />
che invecchia stritolato tra frontiere che inesorabilmente si chiudono<br />
e scelte crudeli che non si possono più rimandare), ma ben recitato, scritto<br />
in modo intelligente e a tratti molto divertente, soprattutto quando, verso il<br />
finale, si trasforma in una amara lezione sulle disillusioni della vita. Certamente,<br />
uno dei migliori <strong>Fleischer</strong> del decennio.<br />
Di routine ma ben diretto il film seguente, Mr. Majestyk (A muso duro,<br />
1974), che contribuì parecchio a creare il mito di Charles Bronson star violenta<br />
e giustizialista (nello stesso anno uscì Il giustiziere della notte di Michael<br />
Winner). Bronson, gli occhi ridotti a fessure, attraversa il film ad ampie<br />
falcate nelle vesti di un paternalistico coltivatore di meloni del Colorado,<br />
antirazzista, tollerante con i sindacati (a ragion veduta: alla fine si prende<br />
proprio la bella ragazza del sindacato; ma come fa Linda Cristal a mantenere<br />
i suoi capelli così neri e lucenti dopo tutto il sudore sparso a raccogliere meloni?),<br />
che naturalmente si scontra con i cattivoni locali. Il coltivatore di meloni<br />
sconfigge da solo il racket del lavoro, e la polizia ci fa una pessima<br />
figura. Farsi giustizia da soli pare l’unica soluzione. <strong>Fleischer</strong> è alle prese<br />
con uno script a dir poco mediocre e con attori che, nella maggior parte,<br />
sembrano incapaci perfino di maneggiare un melone, ma, una volta ancora,<br />
se la cava al meglio, eccellendo in bravura nei momenti di tensione e negli<br />
inseguimenti d’auto, e sforna un altro bel prodotto d’evasione.<br />
Una competenza registica confermata ed anzi esaltata in Mandingo<br />
31
(id, 1975), da annoverare tra i suoi film migliori. Il noioso, lugubre stereotipo<br />
del Deep South a metà Ottocento, con gli schiavi di colore stoici nella<br />
loro sofferenza e le ritrose bellezze sudiste, viene qui portato all’eccesso e<br />
fatto esplodere. <strong>Fleischer</strong> svela l’autentica sessualità e violenza che si cela<br />
dietro il mondo dello schiavismo e allestisce un affascinante pezzo di American<br />
Gothic, analizzando, in modi disinvoltamente piccanti, le magagne e<br />
le contorsioni di una società schizofrenica. Il plot, tratto da un romanzo di<br />
Kyle Onstott, racconta gli anni del declino di una famiglia di allevatori di<br />
schiavi, che vengono trattati, se non proprio come animali, come umanoidi.<br />
La loro intimità fisica con la razza padrona è totale. Alla fine, è la pura e<br />
semplice assurdità e incongruità del ruolo delle donne in questo bislacco sistema<br />
a mandare in pezzi un edificio ormai decrepito. Di base, è puro melodramma<br />
vittoriano al suo meglio, con più di una eco dei romanzi delle<br />
sorelle Brontë, diretto e recitato (soprattutto da Perry King) con enorme<br />
buon gusto. L’atmosfera lussuosa e decadente della grande dimora di Falconhurst<br />
è resa magnificamente dalla fotografia molto pittorica di Richard<br />
Klein. Più in generale, è bello vedere <strong>Fleischer</strong> tornare al genere di thriller<br />
psico-patologico che riesce a maneggiare così bene.<br />
Di gran lunga inferiore, purtroppo, è il successivo The Incredible Sarah<br />
(Sarah Bernhardt – La più grande attrice di tutti i tempi, 1976). <strong>Fleischer</strong><br />
non è nuovo al genere biopic, ma qui sembra che si annoi lui per primo<br />
(coinvolgendo nel processo anche lo spettatore) a mettere in fila alcune scene<br />
tratte dalla vita vera della grande attrice teatrale Sarah Bernhardt, dal rifiuto<br />
subito agli esordi al trionfo finale passando attraverso l’ostracismo sociale.<br />
Lo script, a dire il vero, compie uno sforzo o due per legare la tendenza della<br />
diva a teatralizzare di continuo la propria vita quotidiana con il magnetismo<br />
delle sue apparizioni sul palcoscenico, ma il tutto rimane abbastanza in superficie.<br />
È un “Reader’s Digest” più che un film, con la firma dei suoi sponsor<br />
ben in evidenza in ogni inquadratura . Glenda Jackson emoziona<br />
abbastanza recitando una serie di pezzi di repertorio tratti dai classici, ma<br />
può fare ben poco per rimediare a tutto ciò che le sta attorno.<br />
Prodotto sotto la stessa bandiera di comodo che i Salkinds avevano<br />
utilizzato per i due precedenti film di Richard Lester tratti da “ I tre Moschettieri”<br />
di Dumas, The Prince and the Pauper (Il principe e il povero,<br />
1977) è un ridondante remake del classico Warner del 1937 con Errol<br />
Flynn. Negli Stati Uniti è uscito con un titolo diverso, Crossed Swords. La<br />
32
egia stavolta anonima di <strong>Fleischer</strong> e la mediocre (a dir poco) capacità recitativa<br />
di Mark Lester nel doppio ruolo dei due sosia del titolo finiscono<br />
per trasformare la vicenda di identità confuse dell’originale romanzo di<br />
Mark Twain in una serie interminabile di ingombranti cammei divistici:<br />
Charlton Heston impersona Enrico VIII, George C. Scott un cattivo “cockney”,<br />
e così via. Scenografie di prim’ordine, ma poca ironia e immaginazione<br />
zero. Anche Ashanti (id, 1979) è un prodotto di routine. Nell’ultima<br />
parte della sua carriera, da Mandingo in poi, <strong>Fleischer</strong> fa sempre più fatica<br />
a districarsi fra le produzioni anonime e commerciali in cui viene coinvolto.<br />
Messo di fronte a uno script, terribile, sul rapimento di una dottoressa<br />
afro-americana aggregata a una carovana di schiavi nell’Africa<br />
sub-sahariana, <strong>Fleischer</strong> opta, in questo caso, per un funzionale anonimato.<br />
Il cast fa la stessa scelta: tutti gli attori paiono determinati ad auto-parodiarsi,<br />
in un contesto altrimenti privo di umorismo. Peter Ustinov interpreta<br />
uno schiavo arabo macchiettistico ai confini del ridicolo; Michael Caine,<br />
che impersona il marito della dottoressa rapita, sembra del tutto disinteressato<br />
alla faccenda. Il suo recalcitrante cammello resta nella memoria<br />
come perfetta icona umoristica di un primitivo e decrepito star vehicle.<br />
The Jazz Singer (Il cantante di jazz/La febbre del successo, 1980) è il<br />
tipico film nato per lucrare su un musicista di fama mondiale, in questo<br />
caso Neil Diamond, che interpreta il figlio del cantore della sinagoga di<br />
New York, disponibile a cambiare il suo yarmulke con il luccichio del jazz<br />
business di Los Angeles. Il debutto della superstar del soft-rock pare quanto<br />
mai prudente. In ogni istante, il film si premura di confermare la riconoscibilità<br />
e l’indubbio talento del divo. Ma, come talvolta accade, anche se<br />
tutto è predisposto per non compromettere la sua immagine di divo per famiglie,<br />
nondimeno il personaggio che scaturisce dal film è, curiosamente,<br />
sconsiderato e irresponsabile. Dal canto suo, Diamond non azzarda mai<br />
nulla di più difficile che non sia masticare un chewing- gum e camminare<br />
nello stesso tempo. Leggermente più interessante Tough Enough (Il duro<br />
più duro, 1983). Un cantante country di scarso successo (Dennis Quaid) si<br />
dà al pugilato e tenta la fortuna sul ring. È, chiaramente, un tentativo di rifare<br />
il successo della serie Rocky con Sylvester Stallone, ma, al solito, è<br />
ben girato da <strong>Fleischer</strong> e c’è la giusta dose di autoironia.<br />
<strong>Fleischer</strong> dirige nel 1983 quello che è il suo primo e unico vero film<br />
horror, Amityville 3-D (Amityville 3D) e, nell’occasione, compie il suo se-<br />
33
condo esperimento con il 3-D dopo Arena. Terzo episodio della saga sulla<br />
casa maledetta, iniziata nel 1979 da Stuart Rosenberg e proseguita nel 1982<br />
dal nostro Damiano Damiani (ci sarà un quarto e ultimo – per ora – episodio<br />
nel 2005), è decisamente il migliore di tutti, grazie proprio alla regia<br />
senza fronzoli di <strong>Fleischer</strong> e a effetti speciali curati. Dopo aver comprato<br />
la proprietà meno attraente che esista, almeno dai tempi in cui il Bates<br />
Motel di Psycho è rimasto privo di clienti, uno scettico di professione (Tony<br />
Roberts) spende la restante ora del film a valutare vari eventi sinistri da B-<br />
movie come semplici, bizzarri incidenti domestici, finché è costretto ad<br />
ammettere che, sotto la cantina, esiste nientemeno che un passaggio per<br />
l’inferno. Un tizio vestito come il Mostro della Laguna Nera compare sulla<br />
porta agitando le pinne e la casa crolla a pezzi. Il film ci tiene all’erta costante:<br />
un ascensore che precipita, sedute spiritiche, una sequenza di autocombustione<br />
spontanea e fotografie che profetizzano sventura. Per<br />
aggiungere suspense i personaggi fanno continui riferimenti ai precedenti<br />
film della serie, mentre, al fine di esaltare il 3-D, vespe, mobili e personaggi<br />
minori vengono proiettati a intervalli regolari in direzione dello spettatore.<br />
C’è anche una irriverente comparsata di una giovanissima Meg<br />
Ryan, al debutto.<br />
<strong>Fleischer</strong> si cimenta poi nel fantasy epico-mitologico con un altro sequel,<br />
questa volta da Conan il barbaro (1982), che John Milius aveva tratto<br />
dal romanzo di Robert Howard e dalle illustrazioni di Frank Frazetta e John<br />
Buscema. Il film è Conan the Destroyer (Conan il distruttore, 1984), prodotto<br />
da De Laurentiis, e riprende la saga del guerriero cimmero alle prese<br />
con un mondo di sangue, acciaio e magie. Liberato dalle pretese intellettuali<br />
e dalla ideologia superomista (e dal sesso gratuito) del predecessore, il sequel<br />
di <strong>Fleischer</strong> si avvicina molto di più all’originale ispirazione del personaggio<br />
(per dirla con una battuta: piccole menti in grandi corpi – una<br />
formula che Arnold Schwarzenegger soddisfa pienamente). Il plot, basato<br />
sulla ricerca di un corno fornito di poteri magici, è largamente prevedibile<br />
e gli effetti speciali non sono granché, ma la regia di <strong>Fleischer</strong> e il suo talento<br />
per l’azione donano una gran verve al tutto.<br />
Meno riuscito il successivo e assai simile Red Sonja (Yado, 1985), avventura<br />
fumettistica di nuovo nello stile di Conan e produzione De Laurentiis.<br />
Spiccano alcune giunoniche bellezze preistoriche, tra cui Brigitte<br />
Nielsen, che vaga alla ricerca di una vendetta sulla principessa malvagia<br />
34
(Sandahl Bergman), che si è impadronita di un potente talismano e vuole<br />
distruggere il mondo (almeno il mondo come lo hanno immaginato i non<br />
eccelsi scenografi del film…). Arnold Schwarzenegger, ancora lui, flette i<br />
possenti muscoli ma non i talenti recitativi. La Nielsen pronuncia le sue<br />
battute al ritmo di due parole al minuto, e il povero Ronald Lacey è costretto<br />
a riprendere il suo ruolo di nazista cattivo di I predatori dell’arca<br />
perduta (1981) di Steven Spielberg indossando abiti e copricapi al limite del<br />
ridicolo e oltre. Ancor peggio, c’è un giovane principe privo di fascino che<br />
prende Sonja sotto la sua protezione. D’altro canto, il film, girato a Cinecittà,<br />
si vale della fotografia di Giuseppe Rotunno, dei costumi di Danilo<br />
Donati, della musica di Ennio Morricone…<br />
Million Dollar Mystery (Il mistero da 4 milioni di dollari, 1987) inizia in<br />
un ristorante isolato nel deserto dell’Arizona. Un gruppo di viaggiatori sta<br />
pranzando quando uno di loro cade improvvisamente a terra. Prima di spirare,<br />
rivela agli altri di aver nascosto diversi milioni di dollari in quattro località<br />
diverse e dà loro le chiavi per scoprirle. Inizia così una vera e propria caccia<br />
al tesoro, evidentemente ispirata a quella di Questo pazzo pazzo pazzo pazzo<br />
mondo (1963) di Stanley Kramer. Ancora una volta, dunque, <strong>Fleischer</strong> è chiamato<br />
a riprendere un film di successo: un nome una garanzia. La caccia al tesoro<br />
del film venne sfruttata anche in termini promozionali dalla produzione<br />
che mise in palio un milione di dollari per chi scopriva il nascondiglio seguendo<br />
le indicazioni contenute nelle confezioni Glad, sponsor del film. Il<br />
film, prodotto come i precedenti da Dino De Laurentiis, fu un fiasco clamoroso,<br />
nonostante la presenza nel cast di Tom Bosley, la star di Happy Days.<br />
L’ultimo film di <strong>Fleischer</strong> è un breve filmetto di fantascienza pieno di ironia,<br />
Call From the Space (1989), inedito in Italia. La trama è davvero bislacca. Un<br />
regista cinematografico e il suo eccentrico nipote con l’hobby delle invenzioni<br />
stanno girando uno sci-fi movie a basso budget. La faccenda diventa interessante<br />
quando la macchina del tempo progettata dal giovane comincia a<br />
portare visitatori da altre epoche, inclusi Napoleone, Archimede, persone dal<br />
futuro e cavernicoli dal passato. Mentre zio e nipote stanno girando quello che<br />
pensano sarà il più grande film di fantascienza di tutti i tempi, la macchina<br />
spedisce sul set del film un visitatore alieno (la voce è quella di Charlton Heston).<br />
C’è anche un cammeo di James Coburn nel ruolo di un infuriato dirigente<br />
dello studio.<br />
35
Sterminate la gang! (1950)<br />
36
L’impermeabile, il cappotto e la sordida sirena.<br />
Due gioielli di sintesi: Sterminate la gang! (1950) e Le jene di Chicago<br />
(1952)<br />
Alberto Morsiani<br />
Scommettiamo che Michael Mann, prima di girare il suo Heat nel 1996,<br />
ha dato più di una occhiatina al dimenticato, magnetico thriller Sterminate<br />
la gang! (Armored Car Robbery) che <strong>Fleischer</strong> diresse nel 1950? Le analogie<br />
nella trama infatti sono sorprendenti, soprattutto in due sequenze<br />
chiave. La prima è quella dell’assalto al furgone blindato, portato a termine<br />
con modalità assai simili. La seconda è la scena del climax, che in entrambi<br />
i casi si svolge sulla pista di un aeroporto con un apparecchio in arrivo che<br />
decide il risultato dello scontro. Sull’asfalto del terminal rimane ucciso il<br />
capo della gang, Robert DeNiro nel film di Mann, William Talman in quello<br />
di <strong>Fleischer</strong>. Per quanto riguarda lo stile, i due film invece divergono:<br />
quanto Heat è prolisso, zeppo di sottostorie familiari e sentimentali, qua e<br />
là retorico, tipico del barocchismo manniano, tanto Sterminate la gang! è<br />
breve (sessantaquattro minuti), secco, essenziale, crudele. Si svolge nell’arco<br />
di pochissimi giorni, e segue i preparativi di un hold-up, l’esecuzione<br />
dell’assalto, la caccia tragica ai quattro membri della gang. Non c’è<br />
nulla di troppo o di ridondante, c’è solo quanto serve per illuminare la storia<br />
e i personaggi tratteggiandoli con precisione anche psicologica. Da una<br />
parte il tenente Jim Cordell (Charles McGraw, con il suo profilo aquilino<br />
da duro alla Dick Tracy), mosso dal desiderio di vendicare il collega ucciso<br />
nello scontro a fuoco con i banditi, dall’altro lo spietato Dave Purvis (William<br />
Talman, memorabile cattivo nei film di quegli anni, poi transitato –<br />
forse per contrappasso – sul piccolo schermo a farsi regolarmente ridicolizzare<br />
da Raymond Burr nei panni del procuratore distrettuale umiliato<br />
dall’avvocatone Perry Mason). Il regolamento di conti tra i due si conclude,<br />
come detto, sulla pista dell’aeroporto di Los Angeles: il secondo spara al<br />
primo, che, ferito ma ancora minaccioso, viene travolto da un velivolo che<br />
sta atterrando. I soldi della rapina si spargono sulla pista, in una immagine<br />
icastica del “delitto non paga” ripresa da allora innumerevoli volte. Non si<br />
tratta però dell’ultima scena del film, che si conclude subito dopo con una<br />
37
evissima sequenza in cui Cordell va a trovare all’ospedale un giovane<br />
collega, il detective Cuyler (Don Haggerty), ferito da Purvis, la cui abnegazione<br />
ha permesso l’eliminazione del gangster. Questa sequenza finale è<br />
necessaria, e si pone in parallelo con quella precedente e analoga in cui<br />
Cordell si reca all’ospedale per consolare la vedova (Anne Nagel) del suo<br />
collega e amico, il tenente Phillips (James Flavin), ucciso da Purvis. Quest’ultima<br />
è una scena di sobria asciuttezza, che rende bene il mood sintetico<br />
del film: Cordell entra nella stanza in cui è seduta la vedova, inquadrata in<br />
primo piano mentre piange in silenzio rivolta verso lo spettatore. Cordell<br />
non sa letteralmente cosa dire, come comportarsi: si toglie il cappello, pronuncia<br />
solo due brevissime frasi: “Conta su di me”, “Si diventa una cosa<br />
sola”. La sobrietà e umiltà di Cordell si contrappone, nel film, all’aspetto<br />
e all’atteggiamento flamboyant e sopra le righe di Purvis, un gangster che<br />
veste elegante e mostra in pari misura crudeltà e spacconeria (“Ci vuole un<br />
grosso cervello”, si dice da solo). Freddo e sicuro di sé, anticipa, anche nell’uso<br />
del sarcasmo, quello che sarà il personaggio tipico di Lee Marvin nei<br />
thriller anni Cinquanta. Il costoso cappotto di cammello indossato da Purvis<br />
fa da esatto contraltare, nel film, all’impermeabile spiegazzato del poliziotto.<br />
A sua volta, la compostezza della vedova Phillips si contrappone<br />
all’aspetto sguaiato ed esuberante della biondona Yvonne LeDoux (Adele<br />
Jergens), una sirena sordida, ballerina e spogliarellista provocante in un<br />
teatro di second’ordine, amante fedifraga di Purvis per il quale tradisce l’ingenuo<br />
piccolo malavitoso Benny McBride (Douglas Fowley) che per lei si<br />
rovina. Non a caso, è proprio il vistoso rossetto teatrale usato da Yvonne a<br />
fornire la traccia decisiva, alla fine, per rintracciare Purvis. Come dire, il<br />
vizio non paga. Se c’è un altro film che può aver tratto ispirazione dal piccolo<br />
gioiello di <strong>Fleischer</strong>, è Rapina a mano armata (The Killing) diretto<br />
nel 1956 da Stanley Kubrick: in entrambi i film, una rapina finisce male e<br />
i partecipanti vengono eliminati o si eliminano tra loro fino all’ultimo uomo<br />
(il personaggio della sirena sordida e traditrice è ripreso in Kubrick dalla<br />
spettacolare Marie Windsor). A fianco dei protagonisti, si aggira una fauna<br />
umana tipica del noir di quel periodo ma resa con eccezionale vividezza e<br />
spessore psicologico, nonostante il poco spazio concesso a ciascuno, come<br />
accade per i due gangster amici di Benny e fregati da Purvis, Al Mapes e<br />
William ‘Ace’ Foster, interpretati da altri due volti ben familiari della Hollywood<br />
del B-movie, Steve Brodie e Gene Evans, e per l’assicuratore Bron-<br />
38
son (Max Mellinger), squallidamente preoccupato per il rimborso dovuto<br />
dalla sua compagnia, che Cordell liquida seccamente intimandogli di togliersi<br />
dai piedi. Al pari dei personaggi, protagonista è la città, una Los Angeles<br />
di enorme icasticità, introdotta all’inizio dalle immagini documentarie<br />
dall’alto tipiche del periodo, e in seguito colta negli ambienti più diversi e<br />
insieme tipici della “banalità” americana: la stazione di polizia, l’ospedale,<br />
il bar, gli appartamenti di Benny e Purvis, il teatro, lo stadio di baseball, il<br />
motel, il vicolo, il garage, l’area dei docks portuali, l’aeroporto… Tutti questi<br />
luoghi vengono fotografati on location e sono perfettamente integrati<br />
alla storia e funzionali ad essa, pur nella loro sinteticità. Si pensi alla sequenza<br />
suggestiva in cui Cordell e i suoi uomini penetrano nell’hangar ai<br />
cantieri navali dove stanno acquattati nell’ombra Purvis e i suoi. Tutta la sequenza<br />
si svolge in un silenzio irreale, con i poliziotti e i gangster che cercano<br />
di non fare il più piccolo rumore (anche a questo momento può avere<br />
guardato Michael Mann per Heat, nella sequenza della rapina scoperta e<br />
sorvegliata dalla polizia e poi lasciata a metà da DeNiro e compagni). Il silenzio<br />
è improvvisamente interrotto dal rumore provocato da Foster che<br />
inciampa, e a questo punto i banditi fuggono precipitosamente dopo uno<br />
scambio a fuoco. Di grande forza anche l’immagine dell’auto dei banditi<br />
che si inoltra, dopo la rapina e il posto di blocco, in un paesaggio urbano<br />
di trivelle e pozzi petroliferi, che introduce alla zona dei cantieri navali.<br />
Così come il gioco a nascondino tra Cordell e Purvis, quando il primo arriva<br />
all’improvviso al Valley Motor Court, il motel dove si cela il secondo.<br />
Cordell si fa accompagnare dal gestore fino alla stanza di Purvis, e quest’ultimo<br />
scappa dalla finestra sul retro e si nasconde nel garage, spiando<br />
il poliziotto da dietro un’auto. Subito all’inizio, c’è un’altra bella sequenza,<br />
come al solito sintetica, in cui Purvis cronometra il tempo di arrivo della polizia<br />
sul luogo della rapina che sta progettando. La sequenza si apre con<br />
l’inquadratura della torre dello stadio di baseball, il Ringley Field, sullo<br />
sfondo, come colonna sonora il vociare della folla di tifosi; all’improvviso,<br />
entra in campo in primo piano il volto di Purvis, inquadrato dal basso in alto<br />
per conferirgli, insieme, un senso di potenza e minaccia. Purvis si allontana<br />
dalla macchina da presa, finge di seguire la partita alla radio di un carretto<br />
di gelati, controlla l’orologio. Ecco arrivare sul posto l’auto della<br />
polizia, attirata dalla falsa notizia di una rapina in corso. Purvis misura il<br />
tempo e sogghigna. La misurazione del tempo della rapina, e l’ambienta-<br />
39
zione in uno stadio sportivo, riporta di nuovo al film di Kubrick. Capiamo<br />
subito che non sarà facile sbarazzarsi di Purvis: è un tipo che sa il fatto suo,<br />
è maniacalmente attento ai dettagli, non vuole lasciare nessuna traccia dietro<br />
di sé (toglie perfino le etichette alle sue camicie per non farsi identificare),<br />
elimina tutti quelli che possono intralciarlo. È un uomo-fantasma,<br />
l’epitome del Male che si nasconde nella moderna metropoli, ma è anche<br />
una persona in carne ed ossa, con i suoi vizi e virtù: a Yvonne dice che per<br />
lui “è un capriccio”. Anche la sequenza della rapina è risolta con grande<br />
forza e sinteticità: il furgone blindato col denaro accosta al marciapiede di<br />
fronte allo stadio, e di fianco c’è posteggiata l’automobile dei banditi, alla<br />
guida Foster. Purvis e Mapes indossano divise da imbianchini. L’attacco è<br />
preceduto dal lancio di gas lacrimogeni, e i banditi portano maschere antigas,<br />
proprio come in Heat. Ma Cordell arriva prima del tempo, nasce una<br />
sparatoria. Benny è ferito, la Sedan nera dei gangster si dà alla fuga per le<br />
strade di LA. Una sequenza brevissima, senza fronzoli, più efficace di<br />
quella lunghissima del film di Michael Mann. Semmai affine allo stile registico<br />
di un altro Mann, il migliore, Anthony, anch’egli arruolato in quegli<br />
anni dalla RKO per girarvi piccoli noir a basso costo.<br />
Charles McGraw impersona un poliziotto anche nel successivo gioiellino<br />
noir di <strong>Fleischer</strong>, Le jene di Chicago (The Narrow Margin, 1952), settantuno<br />
minuti al cardiopalma che giustificarono anche un remake firmato<br />
nel 1990 da Peter Hyams e intitolato in italiano Rischio totale (non malaccio,<br />
tutto sommato). Va detto che il casting di McGraw nel ruolo del poliziotto<br />
reca con sé un po’ di salutare ambiguità. L’attore, infatti, appare in<br />
realtà assai più spesso nel ruolo del cattivo della storia. Soprattutto, è un<br />
ideale heavy per Anthony Mann, per il quale ha recitato in T-Men (T-Men<br />
contro i fuorilegge, 1947), Reign of Terror (Il regno del terrore, 1949), Border<br />
Incident (Mercanti di uomini, 1949) e Cimarron (id, 1960). McGraw,<br />
peraltro, è apparso anche in The Birds (Gli uccelli, 1963) di Alfred Hitchcock,<br />
dove interpreta un arcigno pescatore, e in Spartacus (id, 1960) di<br />
Stanley Kubrick, nei panni dello spietato allenatore dei gladiatori. Molta<br />
della suspense di Le jene di Chicago nasce proprio dal fatto che, dato il tipico<br />
casting di McGraw, ci potremmo attendere che, ad ogni momento, egli<br />
ceda alle lusinghe della banda di killer e baratti la donna che sta scortando<br />
a testimoniare con un bel po’ di bigliettoni. La sordida sirena, in questo<br />
caso, è il top del genere, Marie Windsor, che impersona in modo indimen-<br />
40
ticabile la vedova che deve testimoniare davanti al Gran Giurì di Los Angeles.<br />
In realtà, è anch’essa una poliziotta della Divisione Affari Interni, e<br />
finisce per funzionare da specchietto delle allodole per i killer (la vera vedova<br />
è una bionda slavata e tremebonda). Il film si giova moltissimo di<br />
questi slittamenti ed equivoci (c’è anche un viaggiatore obeso, impiccione<br />
ed equivoco, che sembra far parte della gang ma in realtà è un poliziotto ferroviario),<br />
e procede a mille all’ora, teso ed avvincente, proprio come il<br />
treno direttissimo sul quale per la massima parte si svolge. Il film inizia<br />
proprio con l’inquadratura di un treno che sfreccia nella notte, e fa una sosta<br />
a Chicago. Ne scendono due poliziotti, Brown (McGraw) e il più anziano<br />
Forbes (Don Beddoe). Devono prelevare la vedova di un gangster, la signora<br />
Neal, e scortarla con lo stesso treno fino a Los Angeles, dove deve<br />
testimoniare contro la gang dell’ex marito. Mentre vanno in taxi fino all’abitazione<br />
della donna, i due scommettono cinque dollari su quale deve<br />
essere l’aspetto della donna. Brown si attende “un tipo volgare a buon mercato”,<br />
e in effetti vince la scommessa (che non incasserà). Quando entrano<br />
nell’appartamento dove viene tenuta nascosta, appare loro infatti una vera<br />
pupa del gangster, con vistosa collana e orecchini, avvolta dal fumo di una<br />
sigaretta, introdotta dalle note di un vizioso be-bop in linea col personaggio.<br />
La donna tratta sgarbatamente i due poliziotti, li sfotte perché, venendo<br />
da LA, non hanno la tintarella. <strong>Fleischer</strong> è sopraffino nella cura dei dettagli:<br />
Forbes si accende di continuo il sigaro che si spegne sempre, ed è questo<br />
particolare che lo farà uccidere di lì a pochi minuti. Sull’uscio<br />
dell’appartamento, alla donna si spezza la collana, e alcuni grani cadono di<br />
sotto, nell’androne, e rotolando svelano i piedi di un uomo, un sicario, che<br />
se ne sta acquattato nell’ombra (la sequenza ricorda quella della prima apparizione<br />
di Orson Welles/Harry Lime in Il terzo uomo). È una sequenza<br />
stupendamente montata, tanto sintetica quanto elettrizzante. L’agguato mortale<br />
riesce a metà: Forbes viene ucciso, ma Brown e la donna si salvano. Replicando<br />
la gentilezza mostrata da Cordell in Sterminate la gang!, Brown<br />
si china sul corpo del collega spazzandogli via la cenere dal bavero del cappotto,<br />
mentre accorre la gente e un tappeto prende fuoco a causa del sigaro<br />
rimasto finalmente acceso, quando ormai è troppo tardi. Questo sì che è cinema<br />
di prim’ordine, senza parole, con gesti ridotti all’essenziale e sempre<br />
pieni di significato, nessun orpello o patetismo! Quando è a questi livelli,<br />
<strong>Fleischer</strong> si mostra non inferiore a giganti come Mann o Fuller. Il sicario<br />
41
ha lasciato dietro di sé un soprabito con il bavero di pelo scuro: come Purvis<br />
in Sterminate la gang!, anche qui il cattivo è raffigurato come un tipo<br />
che ci tiene a vestir bene. Poco dopo, il laconico commento di Brown sulla<br />
sorte del collega morto non è indegno del John Wayne/John Chance dell’<br />
hawksiano Un dollaro d’onore: “Stava diventando vecchio, aveva perso<br />
l’agilità”. Proprio come in Sterminate la gang!, Brown ha dunque perso il<br />
collega all’inizio del film, deve vedersela da solo contro una banda di killer<br />
bene intenzionata a comprarlo o a ucciderlo assieme alla donna che sta<br />
scortando, e pure con quest’ultima, una pericolosa sirena tentatrice (lui non<br />
lo sa, ma la poliziotta lo sta testando per vedere se è corruttibile). Questo<br />
groviglio di ansie, paure e stoicismo spinto al limite del sacrificio si amplia<br />
a dismisura non appena i personaggi salgono sul treno, da cui in pratica il<br />
film non si staccherà se non per pochissimi minuti (e rarissime inquadrature<br />
d’esterni). Qui davvero il gioco si fa sottile, e il film diventa una lezione<br />
di regia in interni. <strong>Fleischer</strong> è straordinario nel filmare in spazi<br />
ristretti, compresso tra scompartimenti soffocanti, corridoi angusti in cui<br />
le persone fanno fatica a passare. È come se la geografia dei luoghi replicasse<br />
lo scarso spazio a disposizione di Brown per scampare al pericolo. Un<br />
pericolo che si raddoppia ogni volta che il treno si ferma e sale a bordo un<br />
personaggio che può rappresentare una nuova minaccia. I personaggi non<br />
sono mai quello che appaiono, e questo porta a una partita a scacchi la cui<br />
posta è la sopravvivenza. Il tutto, si badi bene, alla velocità della luce, senza<br />
cali di tensione o rallentamenti. La macchina da presa sforna inquadrature<br />
claustrofobiche degli spazi del treno, usando focali lunghe e fissando spesso<br />
l’immagine dal basso in alto: anche i soffitti devono fare la loro parte! I personaggi<br />
entrano ed escono dagli scompartimenti o dalla carrozza-ristorante,<br />
i luoghi vengono ispezionati dalla gang ma l’obiettivo è sempre da qualche<br />
altra parte, come in un gioco illusionistico. Una sosta di dodici minuti del<br />
treno a La Junta in Colorado consente a Brown di pronunciare una battuta<br />
formidabile: “Quando il treno si muove è tutto confuso, quando è fermo<br />
tutto appare chiaro”. È proprio così: il movimento del treno sembra destabilizzare<br />
i personaggi, far loro perdere equilibrio, farli vacillare, aumentare<br />
slittamenti e insicurezze. In questo gioco del gatto con un topo che non si<br />
fa acchiappare facilmente le posizioni si scambiano, le situazioni di vantaggio<br />
si ribaltano ad ogni istante, il tourbillon aumenta; la focale del film<br />
resta però, sempre, il volto di McGraw/Brown, zigomi sporgenti, naso aqui-<br />
42
Le jene di Chicago (1952)<br />
43
lino e occhi di ghiaccio. Per questo è necessario, nei piani degli altri personaggi,<br />
farlo crollare, fargli perdere il centro (per Ralph Waldo Emerson,<br />
eroe è “colui che è posto al centro”). In una brillante sequenza, mentre uno<br />
dei sicari sta tentando Brown offrendogli fino a trentamila dollari per fargli<br />
chiudere un occhio sulla faccenda, la macchina da presa inquadra in primissimo<br />
piano il volto della vedova Neal incollato alla parete divisoria dello<br />
scompartimento accanto, mentre si sforza di origliare. Noi pensiamo che<br />
stia temendo per la propria vita se Brown dovesse “venderla”, in realtà sta<br />
cercando di scoprire se il poliziotto è un corrotto. Lei stessa si dà da fare<br />
come sirena tentatrice. Liscia il pelo a Brown: “Fatti furbo, questo treno va<br />
al cimitero, ma c’è in arrivo quello dei soldi!”. In pratica, gli propone di accettare<br />
i soldi che gli offrono. In questa scena, la macchina da presa si avvicina<br />
fino a un primissimo piano della limetta con cui la donna si sta<br />
lisciando le unghie, in quella che è una vera propria offerta di seduzione:<br />
l’immagine slitta direttamente dalla limetta che oscilla avanti e indietro alle<br />
ruote sferraglianti del treno. Tutto si muove, nel film e sul treno, ma tutto<br />
finisce anche per arenarsi su Brown, l’incorruttibile tutto d’un pezzo, su<br />
questo volto da duro, che funziona da catalizzatore e spegnitore delle tensioni<br />
emotive del film. Sottoposto a tante pressioni (le offerte della gang e<br />
quelle della finta vedova), Brown vacilla ma regge. Quando salta fuori che<br />
la vera vedova è in realtà la signora Sinclair (Jacqueline White), una tranquilla<br />
biondina borghese con figlio rompiscatole appresso, che sta viaggiando<br />
in incognito nello scompartimento accanto, ecco che questa giravolta<br />
dell’intrigo introduce un altro elemento di preoccupazione per Brown ma gli<br />
offre anche una nuova opportunità. Bilanciata dall’arrivo sul treno del sicario<br />
di Chicago, Densel (Peter Virgo). Le cose qui si complicano, perché<br />
Densel non va tanto per il sottile come i suoi compari e ha la pistola facile.<br />
È lui ad ammazzare la falsa vedova Neal. Intanto, un’automobile con altri<br />
sicari a bordo corre parallela al treno, scrutata con preoccupazione dal poliziotto.<br />
Il ballo si fa decisamente duro, e i duri cominciano a ballare. Brown<br />
si sbarazza di uno dei killer dopo una lunga, violenta scazzottata compressa<br />
all’interno di un minuscolo scompartimento e magnificamente ripresa. Densel<br />
però prende in ostaggio la vera vedova. Il climax avviene, ancora, sfruttando<br />
benissimo la geografia del luogo. Brown, che è nello scompartimento<br />
confinante a quello in cui stanno Densel e il suo ostaggio, vede le immagini<br />
della coppia riflesse sul vetro del finestrino di un treno che si è fermato ac-<br />
44
canto al loro. Individua così la posizione esatta del sicario e lo uccide sparando<br />
attraverso la porta. L’ennesima perla registica di un film che ne annovera<br />
parecchie. La scena finale è quella del poliziotto che prende<br />
sottobraccio la vedova e la accompagna a piedi a testimoniare. In questa<br />
placida scenetta borghese, la suspense infine si scioglie. Con una ulteriore<br />
nota ironica: in realtà, il taccuino in possesso della donna, con tutte le preziose<br />
informazioni sulle attività della gang, era già stato spedito da tempo<br />
al procuratore distrettuale. Dunque, tutto ciò che è successo, uccisioni comprese,<br />
è stato completamente inutile, gratuito. È giustificato soltanto in<br />
quanto cinema allo stato puro.<br />
45
20.000 leghe sotto i mari (1954)<br />
46