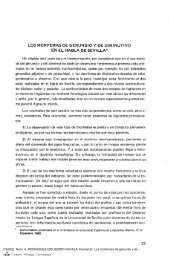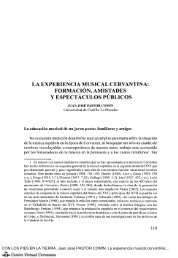La riscrittura della favola pastorale da Sannazaro a Lope de Vega
La riscrittura della favola pastorale da Sannazaro a Lope de Vega
La riscrittura della favola pastorale da Sannazaro a Lope de Vega
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ANGELA CARACCIOLO ARICÓ<br />
Università di Venezia<br />
<strong>La</strong> <strong>riscrittura</strong> <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>favola</strong> <strong>pastorale</strong><br />
<strong>da</strong> <strong>Sannazaro</strong> a <strong>Lope</strong> <strong>de</strong> <strong>Vega</strong><br />
Quando nel 1483 Jacopo <strong>Sannazaro</strong> comincia il primo nucleo di<br />
Edoghe, che <strong>da</strong>ranno vita ali' Arcadia, il genere <strong>pastorale</strong> aveva percorso<br />
un lungo cammino '.<br />
1 Sulla lenta gestazione <strong>de</strong>ll'Arcadia, che si sviluppa <strong>da</strong> un primo nucleo di<br />
ecloghe si ve<strong>da</strong>no gli studi di E. CARRARA, Sulla composizione <strong>de</strong>ll' "Arcadia", in<br />
"Bollettino <strong><strong>de</strong>lla</strong> società filologica romanza" VHI(1906), pp.27-48; A. MAURO, Le<br />
prime edizioni <strong>de</strong>ll' "Arcadia" <strong>de</strong>l <strong>Sannazaro</strong>, in "Giornale italiano di Filologia"<br />
11(1949), pp. 341-51; G.F. FOLENA, <strong>La</strong> crisi linguistica <strong>de</strong>l Quattrocento e ¡'"Arcadia"<br />
di I. <strong>Sannazaro</strong>, Firenze, Leo S. Olschki, 1952, pp.10-4; M. CORTI, Le tre re<strong>da</strong>zioni<br />
<strong><strong>de</strong>lla</strong> "Pastorale" di P.J. <strong>de</strong> Jennaro con un excursus sulle tre re<strong>da</strong>zioni <strong>de</strong>ll""Arcadia", in<br />
"Giornale storico <strong><strong>de</strong>lla</strong> letteratura italiana", 131,fasc. 3,(1954), pp. 305-51: 342-51;<br />
MAURO, Nota sul testo, in I. SANNAZARO, Opere volgari, a cura di A. MAURO,<br />
Bari, Giuseppe <strong>La</strong>terza & figli, 1961, pp.413-35; P.V. MENGALDO, Contributo ai<br />
problemi testuali <strong>de</strong>l <strong>Sannazaro</strong> volgare, in "Giornale storico <strong><strong>de</strong>lla</strong> letteratura italiana",<br />
139 (1962), pp.219-45: 237-45; M. CORTI, L'impasto linguistico <strong>de</strong>ll' "Arcadia"alla<br />
luce <strong><strong>de</strong>lla</strong> tradizione manoscritta, in "Studi di filologia italiana", XXII(1964)),pp. 587-<br />
619, ora in EAD., Storia <strong><strong>de</strong>lla</strong> lingua e storia <strong>de</strong>i testi, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi<br />
ed., 1989, pp.243-71; M. CORTI,// codice bucolico e l'"Arcadia"di Jacobo <strong>Sannazaro</strong><br />
in Metodi e fantasmi, Milano 1961, pp. 281-304; EAD., Rivoluzione e creazione<br />
stilistica nel <strong>Sannazaro</strong>, in Linguistica e Filologia — Omaggio a Benvenuto Terracini,<br />
Milano, II Saggiatore, 1968, pp.97-118, poi in Metodi e fantasmi, cit., pp. 307-23; F.<br />
TATEO, <strong>La</strong> crisi culturale <strong>de</strong>l <strong>Sannazaro</strong>, in Tradizione e realtà nell' Umanesimo italiano,<br />
Bari, De<strong>da</strong>lo, 1967, pp. 11-109; M. SANTAGATA, L'alternativa 'arcadica'<strong>de</strong>l<br />
<strong>Sannazaro</strong>, in <strong>La</strong> lirica aragonese. Studi sulla poesia napoletana <strong>de</strong>l secondo Quattrocento,<br />
Padova, Antenore, 1979, pp.342-74; G. VELLI, <strong>Sannazaro</strong> e le "Partheniae Mirycae":<br />
forma e significato <strong>de</strong>ll' "Arcadia" , in Tra lettura e creazione. <strong>Sannazaro</strong> — Alfieri —<br />
Foseólo, Padova, Editrice Antenore, 1983, pp. 1-56: 14-56; G. VILLANI, Per l'edizione<br />
<strong>de</strong>ll' "Arcadia" <strong>de</strong>l <strong>Sannazaro</strong>, Roma, Salerno Editrice, 1989, pp. 9-36.<br />
Per una visione generale <strong><strong>de</strong>lla</strong> bibliografia sull' Arcadia ed il genere <strong>pastorale</strong> si<br />
ve<strong>da</strong> G. VILLANI, "Arcadia" di Iacobo <strong>Sannazaro</strong>, in Letteratura Italiana. Le opere, I,
200<br />
Provenendo <strong>da</strong>i lontani furori di Teocrito, aveva attraversato le<br />
malinconiche, incantate plaghe <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>pastorale</strong> virgiliana, per poi per<strong>de</strong>rsi<br />
nei rivoli sotterranei <strong><strong>de</strong>lla</strong> bucolica medievale, <strong>de</strong>nsa di allegorie, di<br />
tensioni politiche, di messaggi filosofici 2 .<br />
VAmeto di Boccaccio, in questo lento percorso ha segnato un<br />
punto di svolta, perché 1' impianto ancora allegorico-moralistico <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />
vicen<strong>da</strong> di Ameto che si migliora attraverso l'incontro di sette fanciulle<br />
e per 1' amore di Lia, è riscattato <strong>da</strong>l disteso gusto <strong><strong>de</strong>lla</strong> narrazione in<br />
prosa, in cui si manifesta tutta 1' elegante eloquenza <strong><strong>de</strong>lla</strong> cultura romanza<br />
di Boccaccio. 3<br />
II "saevus amor" (Ec. Vili, 47), il "cru<strong>de</strong>lis amor"(Ec. X, 29), 1'<br />
"insanus amor" (Ec. X,44) che ha agitato la poesia virgiliana non ha più<br />
voce.<br />
<strong>La</strong> visione cristiana, entrata nella forma <strong><strong>de</strong>lla</strong> bucolica antica, 1' ha<br />
fatta lievitare secondo una valenza diversa, di carattere escatologico e religioso<br />
4 .<br />
Torino, Einaudi, 1992, pp. 869-887: 884-887. e la Nota bibliografica di F. ER-<br />
SPARMER preposta all'edizione <strong>de</strong>ll' Arcadia <strong>da</strong> lui curata per Mursia ed., 1990, pp.<br />
35-37. 2 Sui percorsi <strong>de</strong>l genere <strong>pastorale</strong> si ve<strong>da</strong>no 1' ancor oggi valido E. CAR-<br />
RARA, <strong>La</strong> poesia <strong>pastorale</strong>, Milano, Francesco Vallardi [1909]; e M. GERHARDT, <strong>La</strong><br />
Pastorale. Essai a" analyse litteraire, Assen, 1950; D. DE ROBERTIS, Aspects <strong>de</strong> laformation<br />
du gerire pastoral en Italie au XVe siècle, in Le gerire pastoral en Europe du XVe au<br />
XVIIe siècle, Saint-Etienne 1980, pp.7-14; G. PONTE, Perspectives <strong>de</strong> la litérature <strong>de</strong><br />
sujetpastoral au XVe siècle en Italie, in op. cit., pp. 15-23. Per la <strong>pastorale</strong> spagnola J.B.<br />
AVALLE-ARCE, <strong>La</strong> novela pastoril española, Madrid, Istmo, 1974.<br />
3 <strong>La</strong> Commedia <strong>de</strong>lle Ninfe, a cura di E. Quaglio, Firenze 1963.<br />
4 Si ve<strong>da</strong> la produzione bucolica di Dante e Boccaccio, tutta impostata su un<br />
cripto-messaggio allegorico, cfr. V. ZABUGHIN, Vergilio nel Rinascimento italiano <strong>da</strong><br />
Dante a Torquato Tasso. Fortuna. Studi. Imitazioni. Traduzioni. Parodie. Iconografia,<br />
Bologna, Nicola Zanichelli editore, 1921 — 23, 2 voli. : I-, // Trecento ed il Quattrocento,<br />
pp. 7-32 sulla produzione bucolica medievale in rapporto al mo<strong>de</strong>llo virgiliano;<br />
F. PETRARCA, // Bucolicum Carmen e i suoi commenti inediti, a cura di A. Avena,<br />
MEDIVM AEWM, Padova 1906, rist. anastatica Bologna, Forni, 1969, e la Presentazione<br />
di L. PAOLETTI, ivi. G. BOCCACCIO, // "Buccolicum Carmen" trascritto di<br />
su l' autografo riccardiano e illustrato per cura di G. Lidonnici, Città di Castello, S.<br />
<strong>La</strong>pi, 1914.
Quando <strong>Sannazaro</strong> rianno<strong>da</strong> i fili <strong><strong>de</strong>lla</strong> bucolica a quelli <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>pastorale</strong><br />
classica, sciogliendosi <strong>da</strong>gli impacci <strong>de</strong>ll' allegoricismo medievale,<br />
ricrea un mondo arcadico <strong>de</strong>l tutto personale, con ca<strong>de</strong>nze solo in<br />
apparenza simili al mo<strong>de</strong>llo antico.<br />
Cambia innanzitutto la struttura, perché <strong>Sannazaro</strong>, ricorre al prosimetro,<br />
forma inaugurata nel Medioevo <strong>da</strong> Dante nella Vita nuova e ripresa<br />
<strong>da</strong>l Boccaccio proprio nella <strong>favola</strong> <strong>pastorale</strong> d' Ameto.<br />
Ma soprattutto cambiano la visione <strong>de</strong>ll' amore, l'i<strong>de</strong>a di Arcadia,<br />
e la funzione <strong>de</strong>ll' opera letteraria.<br />
L' amore che in Virgilio è dramma, insania, passione, naturale appetito<br />
— non importa se etero od omosessuale -— maledizione, persuasore<br />
di morte, forza panica irresistibile <strong>da</strong> cui si è vinti, (cfr. Ec. X, . 69:<br />
"omnia vincit Amor, et nos ce<strong>da</strong>mus Amori") senza averne felicità, è<br />
profon<strong>da</strong>mente mutato.<br />
Neh" Arcadia <strong>de</strong>l <strong>Sannazaro</strong> 1' amore si presenta come forza alienante,<br />
come straniamento <strong>da</strong> sé e <strong>da</strong>i ritmi consueti di vita:<br />
201<br />
"Ergasto solo, senza alcuna cosa dire o fare, appiè di un albero, dimenticato<br />
di sé e <strong>de</strong>' suoi greggi, giaceva, non altrimente che se una pietra o un<br />
tronco stato fusse"( Arcadia, pr. I, 8)<br />
ma soprattutto è melanconia, rimpianto per un bene perduto.<br />
È un sentimento in assenza <strong><strong>de</strong>lla</strong> donna oggetto d' amore, è amore<br />
negato, non per un rifiuto, ma per la mancanza <strong>de</strong>ll' amata. È dunque<br />
manifestazione di vita rapita, di gioia perduta.<br />
Se è vero che uno <strong>de</strong>i grandi motivi <strong><strong>de</strong>lla</strong> letteratura italiana, <strong>da</strong><br />
Dante a Petrarca a Tasso è il tema <strong>de</strong>ll' amore, che si intreccia con la<br />
morte, va <strong>de</strong>tto che nell' Arcadia di <strong>Sannazaro</strong> questo è un topos che si<br />
complica con un complesso edipico di cui Jacopo non riesce a liberarsi.<br />
Talché il pianto per il bene perduto può avere i contorni <strong>de</strong>l pianto per<br />
la morte di Masella Santomango, madre di Jacopo 5 , esplicitamente ci-<br />
5 Si ve<strong>da</strong> la lettura in chiave psicanalitica che <strong>de</strong>ll' Arcadia <strong>da</strong> V. GAJETTI,<br />
Edipo in Arcadia. Miti e simboli nell' "Arcadia" <strong>de</strong>l Sanazaro, Napoli, Gui<strong>da</strong> 1977, pp.<br />
59-73
202<br />
tata nel racconto <strong>de</strong>i giochi funebri in onore di Massilia, ma crípticamente<br />
evocata in più punti, e subliminalmente disvelata nella vicen<strong>da</strong> di<br />
Carino, che dopo un avvio drammatico, si conclu<strong>de</strong> con il perdono <strong>de</strong>l<br />
pastore accolto <strong>da</strong>lla sua donna, come fa "la pietosa madre" con il suo<br />
unico figlio (Pr. Vili, 56).<br />
J. <strong>Sannazaro</strong> intreccia due magisteri: quello latino <strong>de</strong>i classici, e la<br />
lezione <strong>de</strong>i toscani Boccaccio, <strong>da</strong>ll'Ameto, al Filocolo, ali' Elegia di Madonna<br />
Fiammetta ai toscani <strong>de</strong>ll'antologia <strong>de</strong>lle Bucoliche elegantissime,<br />
edite a Firenze <strong>da</strong> Miscomini nel 1482.<br />
Forse anche per questo 1' Arcadia sannazariana è una realtà ambivalente,<br />
<strong>da</strong> una parte fuga <strong>da</strong>lla realtà nei paradisi bucolici, in cui la natura<br />
è neoplatonicamente presente e partecipe <strong>de</strong>i casi e <strong>de</strong>i sentimenti<br />
<strong>de</strong>i pastori; <strong>da</strong>ll' altra, in particolare nella secon<strong>da</strong> parte <strong>de</strong>ll' opera, è<br />
volontà di riscatto <strong>da</strong> quei confini, <strong>de</strong>si<strong>de</strong>rio di superamento, verso una<br />
realtà "altra", più intima e cupamente malinconica, è una dimensione<br />
splenetica di una serenità per sempre perduta, è <strong>de</strong>si<strong>de</strong>rio di annientamento<br />
totale come fine ultimo <strong>de</strong>ll' esperienza letteraria e di vita.<br />
L' argomento umile, il tono apparentemente disimpegnato non<br />
riescono a celare la realtà culturale <strong>de</strong>ll' Arcadia, che è quella di una<br />
scrittura estremamente colta, preziosa, frutto di sistematiche in<strong>da</strong>gini<br />
lessicali e stilistiche. <strong>Sannazaro</strong> <strong>da</strong> vero "poeta philologus", conduce una<br />
accurata disamina ali' interno <strong>de</strong>gli "exquisiti suoni" 6 , di Virgilio, Lucrezio,<br />
Orazio, Ovidio on<strong>de</strong> arricchire il suo codice linguistico che,<br />
prima <strong><strong>de</strong>lla</strong> normalizzazione bembiana, può valersi <strong>de</strong>l latino al pari <strong>de</strong>l<br />
volgare toscano.<br />
Il Prologo pren<strong>de</strong> avvio con la dichiarata predilezione per una natura<br />
incolta e libera, di contro agli artficiosi parametri <strong>de</strong>l vivere civile<br />
— antitesi città-campagna che affon<strong>da</strong> le sue radici nella bucolica di<br />
Teocrito - e si conclu<strong>de</strong> con il ricordo di Marsia, quale invito ali' umiltà<br />
e appello alla mediocritas <strong>de</strong>l canto, nel vagheggiamento <strong>de</strong>l mondo<br />
<strong><strong>de</strong>lla</strong> natura arcadica, più felice di quello <strong><strong>de</strong>lla</strong> cultura perché più armonioso<br />
e sereno.<br />
Mondo incantato dunque, rifugio in una realtà i<strong>de</strong>alizzata e lontana.<br />
Ma <strong>da</strong>lla prosa VII si assiste ad un brusco mutamento. Jacopo, ab-<br />
Cfr. Arcadia, Congedo "A la Sampogna", 13.
andonato 1' infingimento <strong>pastorale</strong> dietro cui si celava con i nomi di<br />
Ergasto e Sincero, parla in prima persona e si dice esule in Arcadia (Pr.<br />
VII, 16-18). <strong>La</strong> finzione bucolica non è più una libera scelta felice, ma<br />
costrizione, situazione subita, non amata.<br />
Il tono è cambiato, così lo stato d' animo. L' i<strong>de</strong>ale arcadico<br />
sembra non esistere più:<br />
203<br />
"ora mi posso giustamente sovra ogni altro chiamare infelicissimo, trovandomi<br />
per tanta distanza di paese absenté <strong>da</strong> lei [...] Máximamente ricor<strong>da</strong>ndomi<br />
in questa fervi<strong>da</strong> adolescenzia <strong>de</strong>' piaceri <strong>de</strong> la <strong>de</strong>liciosa patria<br />
tra queste solitudini di Arcadia, ove, con vostra pace il dirò, non che i gioveni<br />
ne le nobili città nudriti, ma appena mi si lascia cre<strong>de</strong>re che le selvatiche<br />
bestie vi possano con diletto dimorare" (Pr. VII, 17-8)<br />
L' Aracadia è ormai sentita come con<strong>da</strong>nna, tedio, fallimento. È<br />
Napoli la "<strong>de</strong>liciosa patria" (Ec. VII, 18), non il paese <strong>de</strong>gli Arcadi.<br />
Ritorna ed insiste sul me<strong>de</strong>simo tema anche nell' Ec. X, 4-9, e 41-<br />
42 in cui si manifesta la piena crisi <strong>de</strong>l mondo arcadico, espressa come<br />
crisi <strong><strong>de</strong>lla</strong> poesia:<br />
"<strong>La</strong>sso chi può sperar più gloria o vanto?<br />
Morta è la fé, morto è '1 giudicio fido.<br />
Ricominciate, o Muse, il vostro pianto" (Ec. X, 41-42)<br />
Versi che suonano come <strong>de</strong>nuncia <strong>de</strong>ll' i<strong>de</strong>ntità tradita tra attività<br />
poetica e virtù morale.<br />
<strong>La</strong> secon<strong>da</strong> parte <strong>de</strong>ll' Arcadia adombra la realtà <strong><strong>de</strong>lla</strong> corte in un<br />
periodo di profon<strong>da</strong> crisi politica.<br />
L'illusione di un governo stabile, si incrina pericolosamente; i rassicuranti<br />
ritmi di vita e gli ozi letterari <strong>de</strong>ll' Acca<strong>de</strong>mia Pontaniana sono<br />
stravolti <strong>da</strong> un esiziale incalzare di avvenimenti che velocemente vengono<br />
assommandosi, in una spirale che porta il regno di Napoli ad una<br />
tragica situazione di non ritorno, impensabile solo un ventennio prima.<br />
Iniziano i Turchi, nel 1480, con lo sbarco a Otranto; cui si aggiunge nel<br />
1485-86 la congiura <strong>de</strong>i baroni che radica fin <strong>de</strong>ntro al cuore <strong><strong>de</strong>lla</strong> città<br />
odi e rancori. <strong>La</strong> fatale conclusione si ha nel 1494-96 con 1' arrivo di<br />
Carlo Vili, e la buona accoglienza che gli viene riservata <strong>da</strong> parte di
204<br />
quei baroni che Ferdinando aveva voluto tradire, mortificare e distruggere<br />
con il bagno di sangue <strong>de</strong>l Maschio Angioino 7 .<br />
Dunque nella secon<strong>da</strong> Arcadia vive un mondo instabile, un presagio<br />
di fine imminente<br />
L' atmosfera serena, anche se malinconica, <strong>de</strong>gli inizi è an<strong>da</strong>ta corro<strong>de</strong>ndosi.<br />
Ne abbiamo piena conferma nella tragicità <strong><strong>de</strong>lla</strong> X<br />
écloga:<br />
"Mutata è la stagione e '1 tempo è duro<br />
e già s' attuffa Arcturo in mezzo a 1' on<strong>de</strong>,<br />
e '1 sol, eh' a noi s ascon<strong>de</strong> ha i raggi spenti,<br />
e van per 1' aria i venti mormorando,<br />
né so pur come o quando tome estate" (Ec. X, 85-8).<br />
<strong>La</strong> stessa natura ha perduto la sua felicità. Il turbamenbto è cosmico:<br />
"secche son le viole in ogni piaggia"<br />
(Ec. X, 104)<br />
muore la natura, e con essa il mondo bucolico-<strong>pastorale</strong>:<br />
"E già Pan furioso con la sanna,<br />
spezzò 1' amata canna".<br />
(Ec. X, 124-6)<br />
Pan spezza la canna e con questo gesto distrugge se stesso ed il suo<br />
motivo di vita: il canto bucolico.<br />
Significativamente ritorna l'immagine di Marsia che nella conclusione<br />
<strong>de</strong>l Prologo suonava come appello ali' umiltà <strong>de</strong>l canto; qui è potente<br />
figura <strong><strong>de</strong>lla</strong> sconfitta <strong>de</strong>ll' uomo nel rapporto con gli <strong>de</strong>i:<br />
"Marsia senza pelle ha guasto il bosso<br />
per cui la carne e 1' osso or porta ignudo"<br />
(Ec. X.135-7).<br />
pp. 85-7.<br />
7 Cfr. B. CROCE, Storia <strong>de</strong>l regno di Napoli, Bari, G. Làterza e figli, 1945,
II canto non ha più ragione d' essere. E continua:<br />
"<strong>La</strong> donna e la bilancia è gita al cielo [...] dormasi fuor <strong>da</strong>l bosco" (Ec. X,<br />
156, 160).<br />
Utilizzando i materiali <strong><strong>de</strong>lla</strong> IV Ec. di Virgilio, <strong>Sannazaro</strong> offre<br />
una soluzione opposta e tragica. Non 1' età <strong>de</strong>ll' oro ha preso il campo,<br />
ma il male, in una realtà di totale catastrofe.<br />
L' universo arcadico è <strong>de</strong>finitivamente tramontato nel Congedo "A<br />
la Sampogna", aggiunto probabilmente entro il 1501, anno <strong><strong>de</strong>lla</strong> <strong>de</strong>finitiva<br />
caduta <strong>de</strong>gli Aragonesi di Napoli. In quell' anno re Fe<strong>de</strong>rico parte<br />
per 1' esilio in Francia, e <strong>Sannazaro</strong> lo segue come estremo omaggio di<br />
fe<strong>de</strong>ltà e amicizia.<br />
Nel Congedo, dunque, il tema <strong>de</strong>l pianto diviene come un leitmotiv,<br />
quasi tema musicale, <strong>da</strong> melodramma monteverdiano:<br />
205<br />
"Dunque sventurata piagni; piagni, che ne hai ben ragione. Piagni, misera<br />
vedova; piagni, infelice e <strong>de</strong>nigrata sampogna [•••] Né restar mai di piagnere<br />
e di lagnarti <strong>de</strong> le tue cru<strong>de</strong>lissime disventure mentre di te rimanga<br />
calamo in queste selve [...]"<br />
(Congedo, 7)<br />
Vive, in questa pagina, la dichiarazione di un' infelicità esistenziale<br />
assoluta.<br />
"Attristati dunque, infelicissima; e quanto più puoi, <strong>de</strong> la avara morte, <strong>de</strong>l<br />
sordo cielo, <strong>de</strong> le cru<strong>de</strong> stelle e <strong>de</strong>' tuoi fati iniquissimi ti lamenta" (Congedo,<br />
12)<br />
Siamo giunti al grado zero <strong><strong>de</strong>lla</strong> vicen<strong>da</strong> personale e storica. Jacopo<br />
si arren<strong>de</strong>, ce<strong>de</strong> le armi, appen<strong>de</strong> la zampogna. Esperienza di confine<br />
neh" arte e nella vita, ed assieme passaggio <strong>da</strong> una prova personale ali'<br />
esperienza collettiva:<br />
"Le nostre Muse sono extinte, secchi sono i nostri lauri, ruinato il nostro<br />
Parnaso, le selve son tutte mutole, le valli e i monti per doglia son divenuti<br />
sordi" (Congedo, 10)<br />
II plurale ha la doppia valenza <strong>de</strong>l plurale maiestatis per la solennità<br />
<strong>de</strong>l momento, irrevocabile; ed assieme 1' immagine <strong>de</strong>l "Parnaso rui-
206<br />
nato", è simbolo <strong><strong>de</strong>lla</strong> cerchia di poeti <strong><strong>de</strong>lla</strong> corte aragonese che hanno<br />
perduto il loro ubi consistam. Il plurale dilata il discorso e lo colora di<br />
un connotato tragico. Mentre il bosco di Arcadia, già abitato <strong>da</strong> driadi,<br />
amadriadi, fauni e ninfe, torna ad essere un insieme di "duri e insensati<br />
alberi" (Congedo, 11).<br />
<strong>La</strong> rovina è cosmica, parte <strong>da</strong>lla situazione <strong>de</strong>l poeta e si allarga alla<br />
natura tutta. Tutto è rovinato, perduto per sempre.<br />
Il canto <strong><strong>de</strong>lla</strong> zampogna si è convcrtito in urlo:<br />
"E se tra questi rami il vento per aventura movendoti ti donasse spirito, non<br />
far mai altro che gri<strong>da</strong>re, mentre quel fiato ti basta" (Cong., 12)<br />
<strong>La</strong> poesia si è tramutata in grido contro la vita, ormai intollerabile.<br />
Il codice bucolico è consunto, sfinito, <strong>de</strong>finitivamente superato.<br />
Vanno dunque ridimensionati quei giudizi che vedono nella poesia<br />
<strong>pastorale</strong> di Jacopo <strong>Sannazaro</strong> un proposito evasivo verso i lidi felici di<br />
una vita elementare e secondo natura. Per Rogelio Reyes Cano, 8 nell'<br />
Arcadia quello che conta è 1' estetica, nella Diana di Montemayor la<br />
vita '. Così Menén<strong>de</strong>z Pelayo <strong>da</strong> cui <strong>de</strong>riva questo giudizio 10 ; ed ancora<br />
Reyes Cano afferma che "la <strong>pastorale</strong> di Jacopo <strong>Sannazaro</strong> è <strong>de</strong>tta archeologica,<br />
quella di Montemayor mo<strong>de</strong>rna" ". Per F. Yndurain <strong>Sannazaro</strong><br />
ha la fred<strong>de</strong>zza <strong>de</strong>ll' imitatore, <strong>de</strong>ll' intellettuale che copia, pren<strong>de</strong> i<br />
mo<strong>de</strong>lli classici e li traduce in volgare, il tema <strong>pastorale</strong> è per Jacopo<br />
<strong>Sannazaro</strong> solo un tema di cultura, mentre per Cervantes un anelito vi-<br />
8 Cfr. R. REYES CANO, <strong>La</strong> Arcadia <strong>de</strong> <strong>Sannazaro</strong> en España, Anales <strong>de</strong> la<br />
Universi<strong>da</strong>d Hispalense. Serie Filosofia y Letras, n. 16, Sevilla, 1973.<br />
9 Cfr. op. cit., p. 22: "<strong>La</strong> palabra <strong>de</strong>finitoria <strong>de</strong> la Arcadia podría ser la palabra<br />
Estética: la materia novelesca está someti<strong>da</strong> a una distribución estética en la que el pastor<br />
como tal no es más que un elemento que presta realce al conjunto. En la Diana,<br />
en cambio, lo que cuenta es la Vi<strong>da</strong>'<br />
10 Cfr. M. MENENDEZ PELAYO, Orígenes <strong>de</strong> la novela, Ed. Nacional, II,<br />
Santan<strong>de</strong>r, 1948, secondo cui la prosa <strong><strong>de</strong>lla</strong> Diana "es mucho más novelesca que la<br />
prosa poética y archilatiniza<strong>da</strong> <strong>de</strong> <strong>Sannazaro</strong>" pp. 270-1<br />
11 Cfr. R. REYES CANO, in op.cit., 1' interessante capitolo su "<strong>La</strong> Diana <strong>de</strong><br />
Montemayor", pp. 20-26.
tale; il mondo di <strong>Sannazaro</strong> è chiuso nei propri limiti, lontano <strong>da</strong><br />
preoccupazioni diverse <strong>da</strong> quelle <strong>de</strong>l paradiso arcadico 12 . Anche in anni<br />
più recenti ritorna una valutazionee riduttiva <strong>de</strong>ll' Arcadia di <strong>Sannazaro</strong>,<br />
A. Prieto, sottolinea che "Nace la prosa <strong>de</strong> la Arcadia corno marco<br />
que arrope la poesía", attribuendo un valore preminentemente letterario<br />
e non poetico ali' opera sannazariana 13<br />
Giudizi questi che vanno rimeditati al di là <strong>de</strong>le schematizzazioni<br />
che hanno inquadrato 1' Arcadia di Jacopo <strong>Sannazaro</strong> entro un paesaggio<br />
tanto letterariamente sereno, quanto insulsamente lontano <strong>da</strong>lla<br />
realtà.<br />
Nel 1547 esce la traduzione spagnola <strong>de</strong>ll' Arcadia <strong>de</strong>l <strong>Sannazaro</strong> e<br />
1' opera comincia a navigare entro i vasti confini <strong><strong>de</strong>lla</strong> cultura iberica e<br />
ibero-americana, fino ali' approdo con 1' omonima Arcadia di <strong>Lope</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Vega</strong>.<br />
Va ricor<strong>da</strong>to che Garcilaso già negli anni '30 <strong>de</strong>l Cinquecento, con<br />
molto anticipo dunque sulla traduzione spagnola, era venuto a contatto<br />
con la poesia <strong>de</strong>l <strong>Sannazaro</strong>, durante il suo soggiorno a Napoli. Pertanto<br />
anticipa i tempi, ed, in particolare, nella II Ec. compone una diretta<br />
imitazione <strong>de</strong>ll' Arcadia, però con una novità di singolare rilievo:<br />
1' introduzione di una donna a co-protagonista <strong><strong>de</strong>lla</strong> vicen<strong>da</strong>: Camilla,<br />
di cui Albanio è innamorato.<br />
Questo procedimento è <strong>de</strong>l tutto nuovo rispetto alla tradizione bucolica.<br />
Da Teocrito, a Virgilio, alla bucolica medievale, ali' edizione<br />
Miscomini M , al <strong>Sannazaro</strong> stesso, in nessun testo è presente una donna<br />
come soggetto <strong>de</strong>ll'azione ".<br />
12<br />
cfr. F. YNDURAIN, Reelección <strong>de</strong> "<strong>La</strong> Galatea", in "Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> "Insula"<br />
I, pp. 105-116: 114.<br />
13<br />
A. PRIETO, Morfologia <strong>de</strong> la novela, Barcelona, Planeta, p. 338.<br />
14<br />
Bucoliche elegantissimamente composte <strong>da</strong> Bernardo Pulci fiorentino et <strong>da</strong> Francesco<br />
<strong>de</strong> Arsochi senese et <strong>da</strong> Hieronymo Benivieni fiorentino et <strong>da</strong> Jacopo Fiorino <strong>de</strong> Buoninsegni<br />
senese edite a Firenze nel 1482 presso Antonio Miscomini, su cui cfr. Francesca<br />
BATTERÀ, L ' edizione <strong>de</strong>lle Bucoliche elegantissimamente composte, "Studi e problemi<br />
di critica testuale", 40, aprile 1990, pp. 149-185.<br />
15<br />
Va tuttavia registrato l'inquieto mondo <strong>de</strong>lle presenze femminili in Ameto,<br />
su cui mi permetto di rinviare al mio Arcadia fuor di Parnaso, Roma, Bulzoni ed., in<br />
corso di stampa.<br />
207
208<br />
Nella bucolica prece<strong>de</strong>nte la donna è oggetto d' amore, non soggetto,<br />
in Garcilaso è soggetto.<br />
È questa un' innovazione che lascia traccia nel livello <strong><strong>de</strong>lla</strong> scrittura,<br />
che si fa più corsivo. Nella II Ec. di Garcilaso il canto malinconico<br />
<strong>de</strong>l pastore — che si foggia sull' Vili prosa <strong>de</strong>ll' Arcadia di <strong>Sannazaro</strong>,<br />
ce<strong>de</strong> il passo al dialogo tra Albanio e Camilla. L' intreccio dialogato<br />
pren<strong>de</strong> il posto <strong>de</strong>l canto lirico. Un registro più basso, legato alla quotidianità,<br />
fatto di battute a botta e risposta, subentra a portare il sapore<br />
<strong>de</strong>l dramma <strong>pastorale</strong>.<br />
<strong>La</strong> composizione si apre verso la forma teatrale, ad un tono medio,<br />
colloquiale, che prelu<strong>de</strong> ali' Aminta <strong>de</strong>l Tasso e ali' Arcadia di<br />
<strong>Lope</strong>.<br />
Un <strong>da</strong>to nuovo rispetto alla turbata fissità <strong>de</strong>ll' Arcadia sannazariana<br />
entra nella sensibilità <strong>de</strong>gli scrittori <strong>de</strong>gli anni trenta: il movimento,<br />
la fuga, il rincorrersi, il non potersi incontrare, un' ansia esistenziale<br />
che si esprime attraverso i segni di un' inquietudine e di un' accelerazione<br />
mai placati.<br />
L' Arcadia di <strong>Lope</strong> <strong>de</strong> <strong>Vega</strong> è tutta giocata su questo versante, romanzesco,<br />
di pieno coinvolgimento con la vita. ""<br />
In <strong>Lope</strong>, tema iniziale è quello <strong><strong>de</strong>lla</strong> fuga <strong>da</strong> una realtà penosa; tuttavia<br />
il dramma di Belardo, in cui si riflette il poeta, si risolve nell' intreccio,<br />
nelle situazioni, negli inganni, non nella meditazione su questi.<br />
Ogni pastore porta il peso <strong>de</strong>lle sue vicen<strong>de</strong> personali, che non sono trasfigurate,<br />
ma semplicemente travestite in un codice <strong>pastorale</strong> fittizio; il<br />
paesaggio mentale ed esterno è chiaramente connotato, i pastori-cortigiani<br />
passano il tempo in discussioni filosofiche, in sottili disquisizioni<br />
d'amore, mo<strong>de</strong>, vestiti e sentimenti. Sono queruli e per niente poetici.<br />
<strong>La</strong> geografia <strong>de</strong>ll' Arcadia sannazariana è invece un paesaggio<br />
i<strong>de</strong>ale, <strong>da</strong>i contorni sfumati, in cui il profilo di Napoli rimane sullo<br />
sfondo come una patria lontana e perduta, è un paesaggio d' anima, in<br />
16 M RICCIARDELLI in un saggio <strong>de</strong>l 1966 L'"Arcadia"diJ. <strong>Sannazaro</strong> e di<br />
<strong>Lope</strong> <strong>de</strong> <strong>Vega</strong>, Napoli, Fausto Fiorentino, ha affrontato la lettura in parallelo fra le due<br />
opere, mantenendosi tuttavia su di un piano di lettura discorsivo e scarsamente critico.
cui i pastori-amici si rifugiano. Il loro codice linguistico e di comportamento<br />
è separato, diverso, trasfigura le urgenze <strong><strong>de</strong>lla</strong> realtà quotidiana, e<br />
sconfina negli ampi domini <strong><strong>de</strong>lla</strong> poesia.<br />
In Spagna il mo<strong>de</strong>llo i<strong>de</strong>ale espresso <strong>da</strong>lla cultura italiana <strong>de</strong>l Rinascimento<br />
si colora di tinte più forti e sanguigne, dunque 1' Arcadia di<br />
<strong>Lope</strong> è il luogo <strong>de</strong>lle passioni non sublimate, di scontri e gelosie violentemente<br />
vissute.<br />
<strong>Lope</strong> storicizza, inserendo personaggi <strong>de</strong>l mondo reale, anche <strong>de</strong>l<br />
passato ( introduce Romolo, Alessandro, i capitani di Spagna, el Cid, la<br />
regina Isabella ecc.) con un intento encomiastico e cortigiano che in<br />
<strong>Sannazaro</strong> è sconosciuto.<br />
L' atteggiamento <strong>de</strong>i pastori di <strong>Lope</strong> è letterario, secondo 1' esempio<br />
<strong><strong>de</strong>lla</strong> Diana di Montemayor 17 , ma tutti sono facilmente i<strong>de</strong>ntificabili.<br />
Belardo è <strong>Lope</strong>; Brasi<strong>da</strong> è Juan Blas musico; Anfriso è il duca d'Alba;<br />
che sa e conosce le gelosie, le ripicche le invidie <strong><strong>de</strong>lla</strong> corte. Il tutto condito<br />
<strong>da</strong>lla malinconia di <strong>Lope</strong> esiliato <strong>da</strong>lla corte di Madrid, sua patria.<br />
L'Arcadia lopiana esce nel 1598. L'Aminta <strong>de</strong>l Tasso è rappresentata<br />
nel 1573.<br />
In entrambe le composizioni i pastori sono ormai solo <strong>de</strong>i cortigiani<br />
travestiti; in entrambe — come già nelle ecloghe di Garcilaso — la presenza<br />
femminile è coprotagonista, uno <strong>de</strong>gli elementi attivi e vivi nel<br />
dramma.<br />
<strong>La</strong> donna in <strong>Lope</strong> non è un termine lontano che <strong>da</strong> occasione di<br />
poesia, di canto e di vagheggiamento, è invece presente, puntigliosa, umorale.<br />
I primi versi <strong>de</strong>ll'Arcadia spagnola non riportano il lamento malinconico<br />
<strong>de</strong>l pastore — tipico <strong><strong>de</strong>lla</strong> tradizione bucolica —, ma il lamento<br />
Belisar<strong>da</strong>.<br />
<strong>La</strong> donna per <strong>Lope</strong> ha cuore instabile, 1' animo femminile, non è<br />
meditativo, ma capriccioso, traditore, di poco affi<strong>da</strong>mento.<br />
Dunque 1' amore nel!' Arcadia <strong>de</strong>llo spagnolo sa di bisticcio, di gioco,<br />
17 J. <strong>de</strong> MONTEMAYOR, <strong>La</strong> Diana, edición <strong>de</strong> Asunción Rallo, Madrid, Cathedra,<br />
Letras Hispánicas, 1991. Per uno studio comparativo tra Arcadia e Diana, cfr.<br />
B. DAMIANI, <strong>Sannazaro</strong> and Montemayor. Toward a comparative study of "Arcadia"<br />
and "Diana", in Studies in honour of Elias Rivers, Scripta humanistica.ed. 1989, pp.<br />
59-75.<br />
209
210<br />
e di ripicca, di vita insomma, ma non di i<strong>de</strong>alizzazione d' amore. Questa<br />
forma di amore a dispetto, senza nessuna volontà di trasferire le vicen<strong>de</strong> in<br />
un piano emblematico, cifrato, che si possa prestare a diverse interpretazioni,<br />
non è polisemia, ma specchio <strong><strong>de</strong>lla</strong> realtà, in cui il travestimento è<br />
leggero, e non opera il trasferimento in un mondo diverso e poetico. L'<br />
amore non è la chiave interpretativa <strong>de</strong>l mondo, come per Jacopo <strong>Sannazaro</strong>,<br />
ma vicen<strong>da</strong> personale con <strong>da</strong>ti ed un intreccio ben preciso.<br />
Le teorie bembiane sull' amor platonico non hanno lasciato il<br />
segno neir Arcadia spagnola.<br />
Anzi 1' Arcadia lopiana inizia con un chiaro disegno, quello <strong><strong>de</strong>lla</strong><br />
peregrinazione al tempio <strong>de</strong>l disinganno, cammino virtuoso seguendo la<br />
splen<strong>de</strong>nte virtù che allontana 1' animo <strong>de</strong>ll' uomo <strong>da</strong>lla tentazione <strong>de</strong>i<br />
piaceri. Il Disinganno è liberazione, è dichiarare che l'amore è stato una<br />
schiavitù, è volersi allontanare <strong>da</strong> questo come forza malefica.<br />
Gli austeri parametri <strong><strong>de</strong>lla</strong> Controriforma hanno <strong>da</strong>to il loro<br />
frutto.<br />
L' Arcadia si conclu<strong>de</strong> con il ringraziamento per essersi liberato <strong>da</strong>ll'Amore<br />
"Mas ya que el fiero yugo<br />
que me cerviz domaba<br />
<strong>de</strong>sata el <strong>de</strong>sengaño con tu afrenta,<br />
y al mismo sol enjugo<br />
que un tiempo me abrasaba,<br />
la ropa que saqué <strong>de</strong> la tormenta;<br />
con voz libre y esenta<br />
al <strong>de</strong>sengaño santo<br />
consagro altares y alabanzas canto." 1S<br />
mentre 1' opera si conclu<strong>de</strong> con l'augurio di Celia a Belardo:<br />
"óigate el mundo a ti, y amor castigue" "<br />
Siamo di fronte ad una virata in senso tassiano e controriformistico.<br />
Prevale nel V libro la volontà morale di insegnare. Posizione<br />
LOPE DE VEGA, op. cit., p. 450.<br />
ID., op. cit., p. 452.
molto diversa <strong>da</strong> quella di Jacopo <strong>Sannazaro</strong>, che non si propone alcun<br />
fine di utilità pratica o morale, ma vicina a quella <strong>de</strong>l Proemio <strong><strong>de</strong>lla</strong> Gerusalemme<br />
liberata <strong>de</strong>l Tasso:<br />
0 Musa, che di caduchi allori<br />
non circondi la fronte in Elicona,<br />
ma su nel cielo infra i beati cori<br />
hai di stelle immortali aurea corona,<br />
tu spira al petto mio celesti ardori,<br />
tu rischiara il mio canto , e tu perdona<br />
s' intesso fregi al ver, s' adorno in parte<br />
d' altri diletti, che <strong>de</strong>' tuoi, la carte.<br />
Sai che là corre il mondo ove più versi<br />
di sue dolcezze il lusinghier Parnaso,<br />
e che '1 vero condito in molli versi,<br />
1 più schivi allettando ha persuaso.<br />
Così a 1' egro fanciul porgiamo aspersi<br />
di soavi licor gli orli <strong>de</strong>l vaso:<br />
succhi amari ingannato intanto ei beve,<br />
e <strong>da</strong> 1' inganno suo vita riceve (I, 2, 3)<br />
<strong>La</strong> distanza tra il mondo di Jacopo e quello di <strong>Lope</strong> si è fatta abissale.<br />
Ne troviamo ulteriore conferma nel Commiato A la Sampogna che,<br />
ad imitazione di <strong>Sannazaro</strong>, conclu<strong>de</strong> anche 1' Arcadia di <strong>Lope</strong> con il<br />
congedo di Belardo a la Zampona. Ma questo è solo una cornice esteriore,<br />
il contenuto è molto più mo<strong>de</strong>sto e limitato, perché, come abbiamo<br />
visto, in Jacopo <strong>Sannazaro</strong> assume il significato universale di<br />
morte <strong>de</strong>i valori umani e poetici, in <strong>Lope</strong> è semplicemente la conclusione<br />
<strong><strong>de</strong>lla</strong> sua Arcadia, con riferim <strong>de</strong>l tutto personali.<br />
<strong>Lope</strong> riduce il messaggio di Jacopo ad una funzione retorica, in cui<br />
si innesta 1' accenno alla propria condizione di letterato che vaga <strong>da</strong> una<br />
corte ali' altra.<br />
Ma lo spirito di profon<strong>da</strong> disperazione <strong>de</strong>l tempo presente, di<br />
punto fermo oltre cui non si può an<strong>da</strong>re, il valore esistenziale, totalmente<br />
negativo, <strong>de</strong>l congedo <strong>de</strong>l <strong>Sannazaro</strong>, qui è assente.<br />
Quello di <strong>Lope</strong> è un mondo diverso, in cui le consonanze che possono<br />
riscontrarsi nel titolo, nella situazione malinconica di lamento,<br />
nel!' arredo bucolico, costituiscono solo una parentela esteriore.<br />
211
212<br />
II mondo rappresentato <strong>da</strong> <strong>Lope</strong> è, manieristicamente, un intreccio<br />
di azioni, in continuo dialogo tra la vita, il sogno, la morte. Il movimento<br />
entra nei canoni <strong><strong>de</strong>lla</strong> realtà, e segna situazioni e sentimenti (affermare,<br />
negare, cercare, fuggire).<br />
Ma 1' inquieta malinconia sannazariana, la dimensione neoplatonica<br />
<strong>de</strong>l mondo, che ha in sé la cifra <strong>de</strong>ll' assoluto, sono <strong>de</strong>finitivamente<br />
perdute.