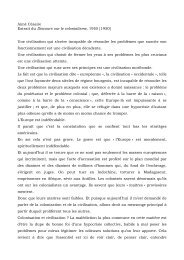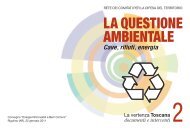Modello semiotico-informazionale
Modello semiotico-informazionale
Modello semiotico-informazionale
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TEORIE E TECNICHE DELLE<br />
COMUNICAZIONI DI MASSA<br />
Prof. Geraldina Roberti<br />
Anno Accademico 2004-2005<br />
2004 2005<br />
Prof.ssa Geraldina Roberti<br />
Università di Siena
Slide lezioni<br />
4° parte
I cultural studies
I Cultural Studies<br />
�� La cultura non è una pratica, né semplicemente<br />
la descrizione della somma delle abitudini e dei<br />
costumi della società. Essa passa attraverso<br />
tutte le pratiche sociali ed è il risultato delle loro<br />
interrelazioni.<br />
�� Cultura come significati e valori, ma anche come<br />
pratiche.
I Cultural Studies<br />
Le radici storiche si fanno risalire a:<br />
1) la rappresentazione, targata primi anni Cinquanta, di una<br />
“nuova” Inghilterra caratterizzata da: la ripresa della<br />
produzione industriale, l’affermazione del Welfare State,<br />
l’unità dell’Occidente contro l’Unione Sovietica, la predizione<br />
della scomparsa della classe operaia e la individuazione<br />
della modernità nella americanizzazione della cultura<br />
popolare;
I Cultural Studies<br />
2) la ripresa, all’interno delle scienze sociali, di un interesse interesse<br />
per<br />
la natura sia della cultura che delle comunità operaie;<br />
3) l’attività dell’Institute<br />
dell’ Institute of Contemporary Arts (ICA) di Londra;<br />
4) la tradizione di ricerca Culture and Civilisation, Civilisation,<br />
intellettualmente attratta dallo sviluppo della cultura<br />
popolare;<br />
5) l’attività di insegnamento per adulti che aveva coinvolto negli negli<br />
anni Trenta e Quaranta sia Richard Hoggart che Raymon<br />
Williams.
Caratteristiche dei<br />
Cultural Studies<br />
� Individuazione della famiglia quale unità di consumo<br />
televisivo.<br />
� Collocazione del consumo televisivo all’interno di un<br />
processo che ha inizio nella fase dell’ideazione del<br />
programma.<br />
� Inserimento della ricerca specifica sul consumo televisivo in<br />
un progetto che contempli, sul medesimo oggetto di analisi,<br />
studi a diversi livelli.
Le origini<br />
�� Richard Hoggart Hoggart: : The The Uses Uses of of Literacy Literacy (1958) (1958)<br />
�� Raymond Williams Williams: : Culture Culture and and Society Society (1958), (1958), The The Long Long<br />
Revolution Revolution (1961), (1961), Communications (1961), (1961), Television: Television:<br />
Technology Technology and and Cultural Cultural Form Form (1974) (1974) Marxism Marxism and and<br />
Literature Literature (1977) (1977)<br />
�� E. P. Thompson: Thompson The The Making Making of of the the English English Working Working Class Class<br />
(1963)<br />
(1963)
Principi di base<br />
� Riscoperta della funzione dell’ideologia.<br />
� Revisione dei modelli comunicativi.<br />
� Analisi del testo e del contesto di consumo,<br />
nell’orizzonte di una grande attenzione al processo<br />
di significazione nella vita quotidiana.
L’ideologia<br />
�� Per i cultural studies, studies,<br />
l’ideologia è<br />
l’espressione attraverso la quale gli individui<br />
vivono le loro relazioni con le condizioni reali<br />
dell’esistenza: un insieme di idee e credenze<br />
da un lato, e pratiche materiali dall’altro.<br />
�� “L’ideologia concerne dunque il rapporto<br />
vissuto dagli uomini con il loro mondo”.<br />
(Althusser, 1965).
Il concetto di egemonia<br />
Fonte: McQuail, 1994<br />
�� Per egemonia si intende un insieme di idee<br />
dominanti che permeano una società, ma in<br />
modo tale da far sembrare sensato, pacifico e<br />
naturale l’assetto vigente di potere.<br />
�� Un’ideologia dominante non è imposta, ma<br />
sembra esistere in virtù di un consenso<br />
indiscusso.<br />
�� L’egemonia tende a liquidare l’opposizione allo<br />
status quo come dissidenza o devianza.
Il concetto di egemonia<br />
�� L’egemonia presuppone che “il dominio di<br />
certe formazioni sia assicurato non da<br />
costrizioni ideologiche, ma da una<br />
leadership culturale […] e che sia<br />
realizzato principalmente attraverso mezzi<br />
in grado di vincere il consenso attivo dei<br />
gruppi e delle classi subordinate […]” (S.<br />
Hall 1982).
Il concetto di egemonia<br />
�� Il concetto di egemonia, nell’accezione di<br />
ideologia dominante (Gramsci ( Gramsci 1977), appare<br />
in grado di spiegare come la cultura mediale<br />
concorra a perpetuare la società classista<br />
(dominata da una classe).<br />
�� I mass media non definiscono di per sé la<br />
realtà, ma danno spazio alle definizioni dei<br />
detentori del potere.
Gli effetti dell’ideologia<br />
�� Secondo Hall, l’attività ideologica si<br />
presenta come la possibilità dei mass<br />
media di definire la linea di demarcazione<br />
“tra spiegazioni preferite ed escluse, tra<br />
comportamenti ammessi e devianti, tra ‘ciò<br />
che è privo di senso’ e ‘ciò che è pieno di<br />
senso’ tra pratiche, significati e valori<br />
integrati e di opposizione” (Hall 1979).
<strong>Modello</strong> comunicativo<br />
<strong>semiotico</strong>-<strong>informazionale</strong><br />
� Il modello si basa sulla struttura del precedente<br />
MODELLO MATEMATICO-INFORMAZIONALE,<br />
cui viene aggiunto il problema della significazione.<br />
Centrali in tale modello sono i fattori relativi a:<br />
Codice Significante<br />
Sottocodice Significato<br />
Decodifica Decodifica aberrante
Fonte<br />
emittente<br />
codice<br />
sottocodici<br />
<strong>Modello</strong><br />
<strong>semiotico</strong>-<strong>informazionale</strong><br />
(Eco-Fabbri e altri, 1965)<br />
Messaggio emesso<br />
come significante<br />
che veicola un<br />
certo significato<br />
canale<br />
Messaggio<br />
ricevuto come<br />
significante<br />
Destinatario<br />
codice<br />
sottocodici<br />
Messaggio<br />
ricevuto come<br />
significato
<strong>Modello</strong><br />
<strong>semiotico</strong>-<strong>informazionale</strong><br />
<strong>semiotico</strong> <strong>informazionale</strong><br />
(Eco-Fabbri (Eco Fabbri e altri, 1965)<br />
�� La comunicazione è concepita non come trasferimento di<br />
informazione, informazione,<br />
ma come trasformazione da un sistema ad un<br />
altro. Il codice garantisce la possibilità di tale trasformazione.<br />
trasformazione.<br />
�� Si innesta nel processo comunicativo il problema della<br />
significazione.<br />
significazione<br />
�� Il modello mette in evidenza il fatto che tra il messaggio<br />
codificato alla fonte e il messaggio ricevuto come significato dal dal<br />
destinatario possono intercorrere elementi di difformità<br />
(competenze linguistiche, enciclopediche e comunicative).<br />
�� La comunicazione rivela la sua intrinseca natura di processo<br />
negoziale in cui conta da un lato l’articolazione dei codici,<br />
dall’altro il contesto comunicativo.
<strong>Modello</strong><br />
<strong>semiotico</strong>-<strong>informazionale</strong><br />
<strong>semiotico</strong> <strong>informazionale</strong><br />
(Eco-Fabbri (Eco Fabbri e altri, 1965)<br />
�� In questo modo è definitivamente accantonata l’idea<br />
del ricevente come soggetto passivo.<br />
�� La comprensione è strutturalmente problematica,<br />
cioè non è identificabile aprioristicamente con le<br />
intenzioni comunicative dell’emittente.<br />
�� I processi di comunicazione implicano il tentativo di<br />
controllo dell’emittente sul livello di decodifica del<br />
messaggio, che permette l’attivazione di una<br />
“decodifica anticipatoria”.<br />
anticipatoria”.
La decodifica aberrante<br />
�� Incomprensione o rifiuto del messaggio per<br />
assenza di codice (il messaggio è segnale fisico<br />
non decodificato o “rumore”).<br />
Per es.<br />
�� Incomprensione per disparità dei codici<br />
(il codice dell’emittente non è ben compreso dal<br />
destinatario).<br />
Per es. «Abbiamo Abbiamo ricevuto il certificato di allibramento di lire<br />
74.400 relativo al verbale n. 3028 del 16/05/00».<br />
16/05/00
La decodifica aberrante<br />
�� Incomprensione del messaggio per<br />
interferenze circostanziali (il codice<br />
dell’emittente è compreso dal destinatario, ma il<br />
messaggio è modellato sul proprio “orizzonte di<br />
attesa”).<br />
�� Rifiuto del messaggio per delegittimazione<br />
dell’emittente (il codice dell’emittente è compreso<br />
dal destinatario, ma il senso viene stravolto per<br />
motivi ideologici).
link<br />
Il significante<br />
Il significante è<br />
una immagine acustica<br />
portatrice di un certo significato<br />
che viene negoziato dal ricevente.<br />
Ad esempio, il termine AIUTO può avere una<br />
valenza diversa a seconda che sia pronunciato:<br />
- da una persona vittima di un’aggressione<br />
- da una persona che sta scherzando con un<br />
amico.
- link<br />
Il codice<br />
�� Il codice è un sistema convenzionale e culturale<br />
(un prodotto sociale) che contiene un alfabeto<br />
di simboli e una grammatica di regole.<br />
�� Rende possibile un legame tra i partecipanti<br />
all’atto comunicativo, assicurando<br />
comunicazione e reciprocità.
Il modello <strong>semiotico</strong>-testuale<br />
(Eco-Fabbri (Eco Fabbri 1978)<br />
�� I destinatari non ricevono messaggi singoli<br />
riconoscibili, ma insiemi testuali.<br />
�� I destinatari non commisurano i messaggi a<br />
codici riconoscibili come tali, ma a insiemi di<br />
pratiche testuali.<br />
�� I destinatari ricevono sempre molti messaggi,<br />
sia in senso sincronico che diacronico.
�� Morley<br />
Il consumo televisivo<br />
Morley, , Nationwide Nationwide (1980): la soggettività è<br />
discontinua e instabile: uno stesso spettatore<br />
potrebbe “leggere” in modi differenti, anche<br />
contraddittori, diversi segmenti di Nationwide,<br />
Nationwide,<br />
riproponendo le tre diverse possibili posizioni di<br />
lettura ipotizzate da Stuart Hall: dominante, di<br />
opposizione o negoziata.
Il consumo televisivo<br />
�� Dorothy Hobson: Hobson:<br />
oggetto della ricerca è la soap<br />
opera britannica Crossroads Crossroads<br />
�� All’interno del rapporto testo-lettore testo lettore l’autrice<br />
ipotizzò la presenza attiva di una sorta di<br />
potere-diritto potere diritto dell’audience sul testo, arrivando<br />
alla conclusione che “non c’è, nel lavoro, un<br />
messaggio o un significato intrinseco globale,<br />
ma questo viene in vita e comunica quando il<br />
telespettatore aggiunge la propria<br />
interpretazione del programma”.
Il modello <strong>semiotico</strong>-enunciazionale<br />
(Proiezione e riconoscimento dei simulacri)<br />
E/tore E/tario<br />
TESTO<br />
unciatore empirico E/tore E/tario<br />
(Produzione di simulacri testuali)<br />
Enunciatario empirico
<strong>Modello</strong> <strong>semiotico</strong>-enunciazionale<br />
“Nella strategia militare lo stratega si disegna un<br />
modello dell’avversario. Se io faccio questa mossa<br />
azzardava Napoleone, Wellington dovrebbe reagire<br />
così. Se io faccio questa mossa, argomentava<br />
Wellington, Napoleone dovrebbe reagire così.<br />
…Wellington si è costruito un Napoleone-modello che<br />
assomigliava al Napoleone concreto più di quanto il<br />
Wellington-modello, immaginato da Napoleone,<br />
assomigliasse al Wellington concreto.”<br />
(U.Eco, Lector in fabula, 1979)
l modello <strong>semiotico</strong>-enunciazionale<br />
<strong>semiotico</strong> enunciazionale<br />
�� Il livello dell’enunciazione<br />
dell’ enunciazione, , cioè del rapporto<br />
comunicativo diretto nell’hic nell’ hic et nunc di una<br />
interazione faccia a faccia, è definitivamente<br />
assente nella comunicazione massmediatica.<br />
massmediatica<br />
�� Le immagini testuali sono profondamente<br />
disgiunte da quelle empiriche, fenomeno che<br />
nell’ambito della semiotica di ispirazione<br />
greimasiana viene definito come débrayage.<br />
débrayage
<strong>Modello</strong> <strong>semiotico</strong>-enunciazionale<br />
<strong>semiotico</strong> enunciazionale<br />
�Concetti fondamentali:<br />
�Cooperazione interpretativa<br />
�Debrayage:<br />
momento in cui si istituisce il testo e<br />
questo si distacca da colui che lo enuncia,<br />
acquistando la sua autonomia (testo come<br />
unità compiuta e manifesta).<br />
�Simulacro
Il modello <strong>semiotico</strong>-enunciazionale<br />
<strong>semiotico</strong> enunciazionale: :<br />
un esempio di applicazione<br />
�� Il network non dialoga istituzionalmente con le proprie<br />
audience empiriche.<br />
�� Semmai è l’audience che conversa con i testi (proiettandosi<br />
nei simulacri) e interagisce con l’arena collettiva (entrando<br />
negli studi televisivi).<br />
�� Il network, invece, si rivolge a simulacri di audience, o<br />
settori di audience, che appaiono come aggregati statistici<br />
rispetto ai quali si muove seguendo un calcolo razionale di<br />
pianificazione di mercato.<br />
�� Il network, dunque, si trova a verificare la rispondenza tra il<br />
simulacro del lettore modello con le audience empiriche<br />
(domanda domanda) ) studiate statisticamente rispetto alla<br />
costruzione dei programmi (offerta ( offerta). ).
Il rapporto testo-lettore<br />
��Il Il lettore modello costituisce una strategia<br />
testuale che simula il comportamento<br />
interpretativo dell’enunciatario<br />
dell’ enunciatario.<br />
��L’ L’autore autore modello si presenta come il<br />
soggetto della strategia testuale di<br />
produzione del testo.
La ricerca etnografica<br />
sull’audience televisiva<br />
La ricerca etnografica è definibile come:<br />
�� “un’attività interpretativa in cui il ricercatore,<br />
attraverso l’osservazione, il colloquio in<br />
profondità e vari tipi di interviste, tenta di<br />
afferrare il significato della comunicazione<br />
analizzando le percezioni, gli assunti condivisi e<br />
le attività degli attori sociali analizzati” (Lull ( Lull<br />
1990).
Fasi di ricerca<br />
Lull , 1990<br />
�� Campionatura<br />
�� Tecniche d’osservazione<br />
�� Raccolta dei dati<br />
�� Organizzazione e presentazione
Problemi metodologici<br />
�� Definizione del campione: problemi riguardanti le<br />
modalità attraverso le quali raggiungere famiglie<br />
che cooperino alla ricerca.<br />
�� Tecniche di osservazione: devono permettere al<br />
ricercatore di raccogliere informazioni senza<br />
alterare con la sua presenza il comportamento<br />
dei membri della famiglia.
Problemi metodologici<br />
�� Raccolta dei dati: temporizzazione non rigida ma<br />
sufficientemente codificata dall’esperienza<br />
(periodo medio di osservazione: una<br />
settimana).Verifica di validità e attendibilità dei<br />
dati raccolti.<br />
�� La critica principale fa comunque riferimento<br />
alla presenza dell’osservatore nell’ambiente<br />
naturale.
�� Lull<br />
Gli usi sociali della televisione<br />
Lull distingue tra usi strutturali e usi relazionali:<br />
relazionali<br />
�� Usi strutturali: uso strutturale<br />
ambientale →rumore →rumore<br />
di fondo e uso strutturale<br />
regolativo →scansione scansione dei momenti della giornata<br />
�� Usi relazionali: facilitazione della comunicazione,<br />
appartenenza/esclusione, mezzo di apprendimento<br />
sociale, competenza/dominio
Le subculture<br />
�� Studio del modo in cui le mappe di significato si<br />
compongono sia del senso dato dal gruppo<br />
subculturale stesso alle pratiche, alle istituzioni e<br />
agli oggetti, fino a trasformare la subcultura.
Stuart Hall<br />
�� Direttore del Center of Contemporary Cultural<br />
Studies (CCCS) famoso come “Scuola di<br />
Birmingham”<br />
�� Lancia la rivista Working Working Papers Papers in in Cultural Cultural<br />
Studies Studies (1972)<br />
�� Teorico del modello Encoding/Decoding<br />
Encoding Decoding (1973) in<br />
cui si ribadisce il concetto di negoziazione del<br />
significato e si inaugura la ricerca sulle dinamiche<br />
di fruizione mediatica da parte del pubblico.
Encoding/Decoding<br />
Encoding Decoding Model<br />
�� 1980 - Stuart Hall sanziona la rottura definitiva<br />
con i modelli comunicativi della tradizione<br />
statunitense.<br />
�� Tenta di rendere conto della dinamica<br />
all’interno della quale il significato viene creato<br />
nel processo di produzione e ricezione dei<br />
media.<br />
�� Il processo di significazione diventa un<br />
processo attivo, una relazione bilaterale.
Encoding/Decoding<br />
Encoding Decoding Model<br />
�� “La La produzione dei media di massa ricopre […] la<br />
funzione di provvedere al mantenimento<br />
dell’ordine sociale egemonico, legittimando le<br />
definizioni sociali esistenti […] attraverso un<br />
processo di codifica che investe i prodotti<br />
massmediatici di una lettura preferita”. Il punto di<br />
vista egemonico è caratterizzato:<br />
- “dal definire nei propri termini l’intero universo<br />
dei significati che una cultura o una società<br />
possono esprimere;<br />
- dal non avere bisogno di alcuna legittimazione”.
Encoding/Decoding<br />
Encoding Decoding Model<br />
Tre ipotetiche posizioni di lettura che determinano tre<br />
differenti modalità di decodifica :<br />
�� la posizione dominante egemonica (lettura preferita)<br />
�� la posizione negoziata<br />
�� la posizione “di opposizione”<br />
Le ipotesi sono formulate a partire dal fatto che non<br />
esistendo una “corrispondenza corrispondenza necessaria” necessaria occorre<br />
costruire una teoria della “comunicazione<br />
comunicazione<br />
sistematicamente distorta”.<br />
distorta
Encoding/Decoding<br />
Encoding Decoding Model<br />
Fonte S. Hall (1980)<br />
�� Si attua una lettura “preferita” quando il telespettatore<br />
“prende il significato connotato da, diciamo, un<br />
telegiornale o una rubrica di attualità direttamente e nella<br />
sua interezza e decodifica il messaggio nei termini del<br />
codice attraverso il quale è stato codificato”.
Encoding/Decoding<br />
Encoding Decoding Model<br />
Fonte S. Hall (1980)<br />
�� L’uso del codice negoziato sottende un<br />
atteggiamento duplice:<br />
“accordare la posizione privilegiata alle definizioni<br />
dominanti degli eventi, pur riservando il diritto di<br />
attuarne un uso più negoziato legato a condizioni<br />
locali”.
Encoding/Decoding<br />
Encoding Decoding Model<br />
Fonte S. Hall (1980)<br />
�� Nella posizione di opposizione il telespettatore<br />
comprende la lettura preferita costruita e<br />
proposta, ma ridefinisce “il messaggio all’interno<br />
di una qualche cornice di riferimento alternativa”.<br />
�� Nel caso precedente avevamo fenomeni di<br />
distorsione della comunicazione, mentre qui non<br />
si crea distorsione, ma si attiva la volontà di porre<br />
in rilievo le contraddizioni che una lettura contro le<br />
regole del codice egemonico comporta.