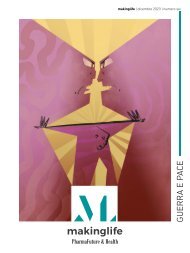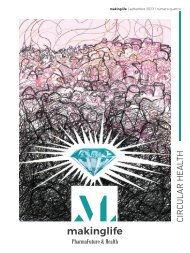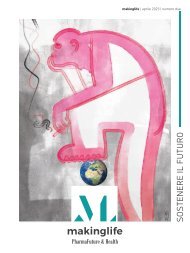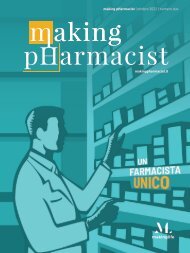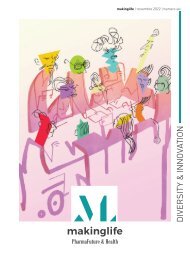Making Life numero zero_ web_FINALE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MAKING LIFE | Novembre 2020
COVID-19 E INDUSTRIA
FARMACEUTICA,
OPPORTUNITÀ E SFIDE
Gabriele Costantino
L’emersione del beta coronavirus denominato
SAR-CoV2 e l’emergenza indotta dalla diffusione
dell’infezione e della malattia sistemica a essa
associata hanno, in tempi rapidissimi, modificato le
priorità e le riflessioni di larghi strati della società.
Per diverse generazioni, soprattutto le più giovani,
l’idea di una malattia trasmissibile da uomo a uomo,
per via respiratoria, è stato qualcosa di assolutamente
inatteso. E forse ancora più inatteso, soprattutto
per le generazioni cui appartiene chi scrive, il fatto
che improvvisamente ci siamo trovati di fronte alla
constatazione che non esistono farmaci per trattare una
condizione estremamente diffusa e diffondibile!
Queste riflessioni portano a una serie di
questioni che sono molto dibattute in questi
giorni e che riguardano non solo i rapporti
tra individui ma anche i rapporti che a
livello di società abbiamo con i farmaci.
L’industria farmaceutica rappresenta
una componente importante - e sovente
anticiclica - per le economie dei Paesi
sviluppati, ma anche un driver insostituibile
di progresso e di innovazione. Da
questo punto di vista, è indispensabile
un’operazione culturale che faccia
sedimentare il più possibile nell’opinione
pubblica l’idea che il farmaco (e chi, dalle
università all’industria, mette energia e
rischio di impresa nella sua ideazione
e sviluppo) non è un bene di largo
consumo ma una vera e propria opera di
ingegno e di inventività. Detto questo, le
vicissitudini (iniziali?) di questa pandemia
hanno fatto emergere anche dinamiche
che dovrebbero esser attentamente
considerate nell’ottica di un aumento della
reputazione, sociale ed economica, della
filiera del farmaceutico.
Due aspetti sono particolarmente
significativi, da questo punto di vista.
Il primo riguarda il fatto – ovvio per gli
addetti ai lavori ma forse meno per
l’opinione pubblica – che i nuovi farmaci
di oggi derivano da ricerche e, soprattutto,
investimenti di 10-15 anni fa. La capacità
di prevedere scenari (e mercati, e bisogni)
a tale distanza è indice di enorme
lungimiranza, e non è possibile quindi
biasimare nessuno se ci troviamo oggi
in una grave carenza di farmaci contro
malattie infettive e trasmissibili. Questo
vale per le infezioni virali, ma lo stesso
discorso può esser fatto per le resistenze
batteriche, le infezioni fungine sistemiche,
le malattie parassitarie. Oggi sappiamo
che la crescita demografica, le migrazioni,
la sempre maggiore contiguità tra uomo
e animali da allevamento renderanno
sempre più probabile l’emersione di
nuove malattie zoonotiche, trasmissibili
e favoriranno sempre più la selezione di
geni di resistenza a farmaci. L’industria
farmaceutica ha iniziato oggi un percorso
di ricerca e di sviluppo (basato su approcci
di systems biology, knowledge-based,
riposizionamento, screening) che forse
non servirà ad avere un nuovo farmaco
per il Covid-19 prima del vaccino o di
altri interventi non farmacologici, ma che
sicuramente fornirà la base di conoscenza
e di materiale con cui affrontare le
inevitabili crisi dei prossimi decenni,
esattamente come l’industria e il mondo
della ricerca si sono trovati pronti negli
scorsi anni ad affrontare le malattie
oncologiche e non trasmissibili.
Il public engagement è fondamentale nello
stabilire se questa sfida sarà coronata o
meno dal successo, ma non v’è dubbio
che ci dovrà esser supporto a livello
governativo – nazionale e sovranazionale
– nel finanziare e nel dirigere anche
con interventi top-down la ricerca e lo
sviluppo in aree terapeutiche sinora
trascurate. Ma allo stesso modo l’industria
farmaceutica dovrà mettere in gioco la
sua reputazione come attività a forte
ruolo sociale e di progresso, non avendo
timore di investire in aree e progetti a forte
rischio e, apparentemente, a minor ritorno
economico.
La saldatura tra mondo farmaceutico
(industria, università, enti di ricerca) e
società civile dovrà avvenire su questi temi
e dovrà accadere alla svelta per riuscire ad
aver impatto per i prossimi decenni.
L’epidemia da SARS-Cov2 ha però messo
in luce anche un altro aspetto su cui
vale la pena riflettere, di ordine diverso
(e apparentemente meno significativo)
rispetto a quello precedente, ma
probabilmente di analoga se non peggiore
conseguenza. Sin dall’inizio della pandemia
- che evidentemente è stata ed è fenomeno
globale - si è osservato il fenomeno dello
shortage di farmaci, neppure direttamente
coinvolti nella gestione della pandemia
stessa. Questa è una dinamica oramai ben
conosciuta in economia, relativamente
all’impatto di crisi sistemiche (come
possiamo a ben diritto definire Covid-19)
sulle filiere di produzione e distribuzione di
prodotti sia di largo consumo che a elevato
valore aggiunto. Nel caso dei farmaci e
delle materie prime per la loro produzione,
le dinamiche produttive e di distribuzione
sono fortemente globalizzate (o, per dirla
dalla nostra prospettiva, delocalizzate) e i
volumi vengono stimati con largo anticipo.
Qualora venga richiesta, improvvisamente
e su larga scala, una riconversione della
produzione verso determinati principi
attivi o formulazioni, si possono generare
interruzioni sulla catena, con ripercussioni
importanti sulla disponibilità al banco.
Un esempio di ciò è facilmente desumibile
osservando i report di AIFA che, nel
primo semestre 2020, ha evidenziato
la carenza di numerosi principi attivi,
sia per blocco di approvvigionamento o
fabbricazione, sia per eccessiva domanda
(il lettore potrà trovare informazioni su
come l’Agenzia italiana ha affrontato la
crisi all’indirizzo: https://www.aifa.gov.
it/web/guest/-/carenze-di-farmacied-emergenza-covid-19).
L’esperienza
accumulata in questi mesi suggerisce
quindi la necessità che gli Stati sovrani,
attraverso le proprie agenzie di regolazione
e di controllo, esercitino non solo azione
di vigilanza e allerta, ma anche di
programmazione a lungo termine delle
disponibilità. A tale riguardo potrebbe
essere utile osservare che per gran
parte delle malattie non trasmissibili (ad
esempio malattie del metabolismo, tumori,
malattie cardiovascolari) è estremamente
improbabile assistere a una improvvisa
e massiva richiesta di una particolare
classe di farmaci, in quanto le dinamiche
di cambio di prevalenza su scala geotemporale
medio-alta richiedono tempi
molto lunghi. Viceversa, e l’esperienza
Covid19 è qui a insegnarcelo, le malattie
trasmissibili possono causare impennate
improvvise nella richiesta di particolari
farmaci, che dovrebbero sempre esser
disponibili. Ad esempio, il fatto che un
certo antibiotico abbia una domanda
costantemente bassa, non vuol dire che
non ce ne possa essere improvvisamente
un bisogno insostenibile su scala mondiale.
Il lettore potrà ricordare ad esempio il caso
dell’uso terroristico dell’antrace, che ha
causato uno shortage improvviso di un
normale antibatterico, appartenente alla
classe dei fluorochinoloni.
È necessario quindi che le aziende
produttrici, ma anche le agenzie nazionali,
riprendano un ruolo non solo burocratico
ma di analisi e previsione scientifica,
identificando con anticipo possibili
evoluzioni pandemiche che, soprattutto
di origine zoonotica, saranno sempre più
frequenti.
6 7