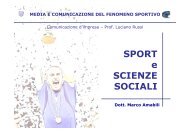La prospettiva socio- costruzionista e culturalista/1 La prospettiva ...
La prospettiva socio- costruzionista e culturalista/1 La prospettiva ...
La prospettiva socio- costruzionista e culturalista/1 La prospettiva ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> <strong>prospettiva</strong> <strong>socio</strong><strong>costruzionista</strong><br />
e <strong>culturalista</strong>/1<br />
• Viviamo in un mondo psicologicamente rappresentato<br />
• <strong>La</strong> costruzione delle rappresentazioni avviene nelle<br />
interazioni; negoziazione dei punti di vista<br />
• Il ruolo del linguaggio: strumento del pensiero; strumento<br />
di costruzione sociale; strumento di interazione e<br />
negoziazione; la “svolta linguistica”<br />
• <strong>La</strong> natura <strong>socio</strong>-culturale della mente<br />
• <strong>La</strong> narrazione come forma di conoscenza; la doppia<br />
natura del cervello.<br />
<strong>La</strong> <strong>prospettiva</strong> <strong>socio</strong><strong>costruzionista</strong><br />
e <strong>culturalista</strong>/2<br />
• L’approccio dialogico; la vita, il pensiero, il sé come dialogo<br />
aperto e costante<br />
• <strong>La</strong> dimensione dilemmatico-argomentativa del pensiero;<br />
l’approccio retorico alla mente; alla persuasione<br />
• Il discorso come territorio di definizione consensuale del<br />
mondo; di scambio di punti di vista; di negoziazione della<br />
posizione<br />
• <strong>La</strong> cultura come sedimentazione dei processi di costruzione<br />
collettiva; di artefatti materiali e ideali; di pratiche operative<br />
• Gli atteggiamenti come artefatti; come risorse interpretative;<br />
come pratiche situate; come negoziazione di senso; come<br />
espressione di una controversia sociale.<br />
L’influenza sociale<br />
• Antiche tradizioni di studio in nuovi contesti; in nuove condizioni<br />
sociali; con nuove tecnologie; la pluralità dei media<br />
• Interpersonale vs allargata, diffusa; principi e processi simili vs<br />
differenziati; quale “modello” di comunicazione<br />
• Le ragioni di una forza potente: biologia, vantaggio del gruppo,<br />
sottomissione all’autorità vs incertezza interpretativa, fascino<br />
dell’argomentazione, sguardo congiunto sul mondo<br />
• Il filone della “psicologia della folla”; Le Bon, Freud, Tarde; la “folla<br />
virtuale”?<br />
• Il filone della persuasione; ingannare vs convincere; dalla retorica<br />
antica agli strumenti moderni; aspetti cognitivi vs emozionali; le “leve”<br />
della persuasione<br />
• Dalla manipolazione, al modellamento, alla co-costruzione<br />
dell’ambiente simbolico in cui si vive.<br />
1
<strong>La</strong> “Communication research”<br />
• Oggetto interdisciplinare; <strong>socio</strong>logia vs psicologia; cdm e<br />
società di massa; la ricaduta delle diverse teorie sul<br />
comportamento; “apocalittici e integrati”<br />
• <strong>La</strong> ricerca sugli effetti: dai media onnipotenti agli effetti limitati e<br />
ritorno<br />
• Hovland e la scuola di Yale; l’atteggiamento come variabile<br />
interveniente; le condizioni di una comunicazione ‘persuasiva’<br />
• Flusso di comunicazione a due fasi; i leader d’opinione; le<br />
interazioni di gruppo<br />
• <strong>La</strong> ricerca sui pubblici; le caratteristiche degli utenti; le<br />
segmentazioni psicografiche; gli “audience studies”.<br />
Processi cognitivi<br />
e comunicazione di massa/1<br />
• Processi cognitivi nella communication research; la comunicazione<br />
nella psicologia cognitiva<br />
• W.Lippmann: la necessità di semplificare il mondo; le immagini nella<br />
mente; gli “stereotipi”<br />
• Cognizione sociale e comunicazione; l’influenza di contesti, pratiche<br />
interattive, norme e valori, dinamiche emozionali; legame bidirezionale<br />
• Comunicazione interpersonale vs di massa; similarità vs specificità dei<br />
processi<br />
• I diversi media: similarità vs specificità dei processi.<br />
Processi cognitivi<br />
e comunicazione di massa/2<br />
• Mutamento di <strong>prospettiva</strong>:<br />
– dai comportamenti alla rappresentazione del mondo<br />
– dai contenuti del pensiero ai processi di elaborazione<br />
– l’individuo da recettore passivo a soggetto attivo<br />
– dalle caratteristiche stabili del soggetto all’interazione sistemica<br />
• Processi implicati:<br />
– selezione: salienza; focalizzazione; discriminazione; familiarizzazione;<br />
assuefazione<br />
– organizzazione: categorizzazione, schematizzazione<br />
– memorizzazione: codifica, recupero, accessibilità; rete semantica<br />
– presa di decisione; inferenze; bias; interferenze emozionali<br />
• In definitiva: si amplifica il serbatoio di informazioni; i problemi di selezione e<br />
inferenza.<br />
2
<strong>La</strong> base psicologica<br />
delle teorie CMM<br />
• Flusso a due fasi: cmm e comunicazione interpersonale; gruppi;<br />
leadership; co-costruzione<br />
• Agenda setting: selezione, valorizzazione, narrazione; una mappa<br />
delle priorità<br />
• Coltivazione: socializzazione; omogeneizzazione culturale;<br />
“mainstreaming”<br />
• Usi e gratificazioni: cosa le persone fanno con i media; le persone<br />
fruiscono attivamente; scopi, bisogni, differenze individuali,<br />
consapevolezza<br />
• Spirale del silenzio: espressione delle opinioni e ‘forza’ sociale; una<br />
stima delle opinioni della maggioranza; un problema di identità<br />
sociale.<br />
I media nella <strong>prospettiva</strong><br />
<strong>costruzionista</strong> e discorsivista<br />
• Ampliamento e trasformazione dell’Altro significativo; delle occasioni<br />
di co-costruzione del mondo; dell’esperienza del mondo; dell’universo<br />
simbolico di cui viviamo<br />
• <strong>La</strong> formazione del “senso comune”; credenze condivise;<br />
rappresentazioni sociali; ideologia; le credenze di senso comune sui<br />
media..<br />
• Dinamiche dell’interazione mediata: intenzioni e scopi; processi<br />
cognitivi; dinamiche emozionali<br />
• Pluralità dei generi discorsivi; informazione, inchiesta, dibattito,<br />
evasione, pubblicità, narrazione, fiction, reality; fusioni,<br />
contaminazioni, mistificazioni..<br />
• Pluralità dei mezzi; specificità vs comunanze.<br />
Il cervello doppio<br />
SINISTRO DESTRO<br />
verbale, parole non verbale, immagini<br />
analitico, elementistico sintetico, globale<br />
sequenza temporale atemporalità<br />
linearità,<br />
spazialità,<br />
bidimensionalità tridimensionalità<br />
logica, inferenza, analogia, somiglianza,<br />
sillogismo<br />
metafora<br />
razionale, conscio non razionale,<br />
inconscio, emozioni<br />
computazione,<br />
algoritmo<br />
intuizione, insight<br />
3
Modello informazionale<br />
emittente codifica canale decodifica ricevente<br />
• informazioni sullo stato del mondo<br />
• con un inizio e una fine<br />
• alla fine del processo il ricevente possiede la stessa<br />
quantità di informazioni; o una quantità proporzionale<br />
all’efficacia del canale; e dei processi di<br />
codifica/decodifica<br />
• alla fine del processo i ruoli si invertono; l’emittente<br />
diventa ricevente e viceversa; il feedback<br />
• prevalenza del codice verbale; il non-verbale come<br />
supporto.<br />
Modello relazionale<br />
emittente codifica canale decodifica ricevente<br />
• informazioni sullo stato del mondo + informazioni<br />
sull’identità e sulla relazione<br />
• permanente: “non si può non comunicare”<br />
• con feedback costantemente reciproco<br />
• con prevalenza della comunicazione non verbale<br />
• con costante dinamica di posizione; asimmetria<br />
up/down; contesa di potere; di sguardo sul mondo<br />
<strong>La</strong> <strong>prospettiva</strong> retoricoargomentativa/1<br />
• M. Billig, 1987, 1991, 1997<br />
• il pensiero come flusso di argomentazioni a sostegno delle<br />
diverse opinioni; come articolazione dilemmatica<br />
• come prodotto <strong>socio</strong>-culturale; il senso comune; correlato a<br />
strutture sociali e forme di potere<br />
• due tradizioni di studio:<br />
– la retorica come arte della persuasione<br />
– l’ideologia come forma di potere sociale<br />
• la persuasione come elemento cruciale del pensiero, della<br />
relazione sociale, della struttura di potere di una società<br />
• fiducia vs paura nei confronti della persuasione; elemento di<br />
democrazia vs di totalitarismo<br />
4
Una nuova <strong>prospettiva</strong><br />
in psicologia sociale<br />
• una psicologia veramente sociale; una critica del maistream<br />
individualista, cognitivo, essenzialista, sperimentale;<br />
• con oggetto non gli stati e processi interni ma le interazioni sociali;<br />
Bachtin: la psicologia sociale come studio dei generi di discorso<br />
• in stretto contatto con altre discipline sociali: antropologia, linguistica,<br />
<strong>socio</strong>logia, semiotica; più che con la psicologia<br />
• metodologia interpretativa, partecipativa, etnografica; analisi del<br />
discorso<br />
• tutti i temi classici della psicologia individuale e cognitivista<br />
riformulabili in termini di discorso e di scambio sociale; percezione,<br />
memoria, schemi, inferenze, categorizzazioni.<br />
Gli atteggiamenti<br />
in <strong>prospettiva</strong> retorico-discorsiva<br />
• gli atteggiamenti non come stati interni, ma come espressione di<br />
opinioni; giustificazione di punti di vista<br />
• prese di posizione in <strong>prospettiva</strong> retorica; argomentazioni a sostegno<br />
di uno dei corni di un dilemma; con scopi pragmatici<br />
• acquistano senso nel contesto conversazionale;<br />
• emergono in una situazione di contesa; non emergono su questioni<br />
non controverse; segnalano la disponibilità ad impegnarsi nella<br />
contesa<br />
• data la loro natura conversazionale e contestuale hanno molteplici<br />
modalità di espressione; sempre nuovi in relazione al contesto; alla<br />
specificità delle contro-argomentazioni<br />
• ciò vale anche per il pensiero inviduale; conversazione interna con se<br />
stessi.<br />
I temi della retorica<br />
• Magna Grecia, V sec. a.C.; Gorgia, Protagora, Isocrate; Platone,<br />
Aristotele; Cicerone, Quintiliano<br />
• l’arte della persuasione; convincere tramite argomentazioni; del falso?<br />
di ogni cosa? l’eredità della sofistica<br />
• la conoscenza come scoperta del vero vs conoscenza come accordo;<br />
relativismo, scetticismo e capacità critica; il problema dei ‘valori’<br />
• la forza del linguaggio; l’encomio di Elena…<br />
• la forza della dialettica; le regole del gioco; la funzione sociale: si entra<br />
in contatto per mezzo delle opinioni<br />
• un catalogo di strumenti e tecniche; il “sistema retorico”: inventio,<br />
dispositio, elocutio, actio; la memoria<br />
• l’emozione; l’estetica, il ritmo, l’immagine;la parte destra del cervello; il<br />
ruolo delle metafore.<br />
5
I dilemmi<br />
nel pensiero e nella vita/1<br />
• il pensiero come argomentazione dilemmatica; nelle scelte quotidiane;<br />
le decisioni come sequenza di scelte dicotomiche; il dialogo muto con<br />
se stessi; la ‘voce della coscienza’<br />
• i modelli; la rappresentazione della conoscenza; i “piani fattoriali”; le<br />
“tabelle a doppia entrata”..<br />
• es.: conoscenza oggettiva vs soggettiva; le due parti del cervello;<br />
ragione vs sentimento; metodi quantitativi vs qualitativi; informazione<br />
vs relazione…<br />
• chiusura vs apertura; protezione e sicurezza vs esplorazione e<br />
avventura; generalizzazione e categorizzazione vs particolarizzazione<br />
e individuazione<br />
I dilemmi<br />
nel pensiero e nella vita/2<br />
• i dilemmi del senso comune; i proverbi;<br />
• i valori<br />
• es.: giustizia vs clemenza; coraggio vs prudenza; obbedienza vs<br />
originalità; tradizione innovazione<br />
• la politica<br />
• es.: destra vs sinistra; libertà vs sicurezza; i referendum..<br />
• la pubblicità<br />
• es.: tradizione vs innovazione; forte vs tenero; raffinato vs sobrio;<br />
specializzato vs universale; lento vs veloce; distinguersi vs adeguarsi<br />
• individuo vs società; in-group vs outgroup; buoni vs cattivi; nella<br />
visione del mondo; nella narrazione<br />
• nella comunicazione di massa; nelle trasmissioni televisive; nella<br />
costruzione di un articolo di giornale.<br />
<strong>La</strong> “svolta linguistica”<br />
• Frege: tra denotazione e senso<br />
• Russell: l’atomismo logico; il mondo costituito da fatti elementari che il<br />
linguaggio rappresenta in forme complesse<br />
• Wittgenstein: il linguaggio come raffigurazione dei fatti del mondo; il<br />
linguaggio come forma di vita; i “giochi linguistici”<br />
• <strong>La</strong> filosofia del linguaggio ordinario; gli atti linguistici (Austin, Grice,<br />
Searle)<br />
• Il filone pragmatico: Peirce, Dewey, Quine, Davidson, Rorty; i contesti<br />
d’uso come base della comunicazione<br />
• Il filone ermeneutico: Vico, Heidegger, Gadamer; Derrida, Foucalut; il<br />
mondo come testo che va interpretato; la verità come verità dialogica.<br />
6
L.S.Vygotskji (1896-1934)<br />
e la scuola storico-culturale<br />
• <strong>La</strong> natura sociale della coscienza nel materialismo storico; “è la vita<br />
che determina la coscienza”; quale rapporto fra struttura e<br />
sovrastruttura<br />
• Una psicologia su basi materialistiche; quale materialismo? la<br />
“<strong>socio</strong>genesi dei processi mentali superiori”<br />
• Gli oggetti del mondo come “segni” in relazione ad una rete di rapporti<br />
sociali; alle attività materiali dell’esistenza<br />
• Gli “strumenti” come elementi di mediazione nelle relazioni<br />
interpersonali; di raggiungimento di obiettivi concreti<br />
• <strong>La</strong> “funzione strumentale del segno”; i processi mentali strutturati da<br />
artefatti culturali<br />
• Pensiero e linguaggio (1934); introiezione di funzione sociale; portare<br />
di un mondo di senso; di motivazioni; testi e sottotesti.<br />
M.Bachtin (1895-1975)<br />
e il “dialogismo”<br />
• Il “Circolo” di Bachtin; la questione dell’autore (Bachtin vs<br />
Volosinov, Medvedev); filosofia del linguaggio e critica letteraria<br />
• il linguaggio come portatore di senso; continuamente negoziato e<br />
modificato<br />
• la natura intersoggettiva della coscienza; la vita come dialogo<br />
continuo; con sé e con gli altri; confronto di punti di vista, di<br />
interpretazioni, di senso; il sé dialogico e polifonico<br />
• la polifonia delle voci; la verità come esito della polifonia; come<br />
sintesi mediata dei punti di vista; la verità ‘dialogica’<br />
• l’ “immaginazione dialogica”; la “eteroglossia”; la “intertestualità”; i<br />
generi del discorso<br />
• teoria e critica dell’ideologia; carattere ideologico del linguaggio;<br />
monoglossia vs eteroglossia<br />
• nella tradizione ermeneutica; specie Gadamer; influenze su<br />
Cultural Studies; sulla critica postmoderna.<br />
Vita materiale e coscienza<br />
individuale nel materialismo<br />
storico<br />
"non è la coscienza che determina la vita, ma<br />
la vita che determina la coscienza” (Marx,<br />
Engels, L’ideologia tedesca, 1845-46)<br />
"Le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale<br />
degli uomini appaiono .... come emanazione diretta del loro<br />
comportamento materiale. Ciò vale allo stesso modo per la<br />
produzione spirituale, quale essa si manifesta nel<br />
linguaggio della politica, delle leggi, della morale, della<br />
religione, della metafisica, ecc. di un popolo" (ibidem)<br />
7
Quale rapporto fra struttura e<br />
sovrastruttura<br />
• <strong>La</strong> “relativa autonomia” della sovrastruttura; la possibilità di<br />
“retroazione” sulla struttura<br />
• L’enfasi sulla struttura come necessità argomentativa<br />
• A. Gramsci<br />
– contro la “superstizione economistica”; la “reciprocità necessaria”;<br />
egemonia e ideologia<br />
– la prassi come strumento conoscitivo<br />
– il linguaggio come elaborazione e condivisione di una specifica<br />
visione del mondo<br />
• <strong>La</strong> “Scuola di Francoforte”;<br />
– l’industria culturale e la manipolazione delle coscienze; il ‘carattere<br />
sociale’ (Fromm)<br />
– linguaggio e definizione intersoggettiva dei modelli di<br />
interpretazione della realtà (Habermas).<br />
L’enfasi sulla struttura come<br />
necessità argomentativa<br />
"Che i giovani diano talvolta al lato economico un peso<br />
maggiore di quanto non gli spetti, lo si deve in parte a<br />
Marx e a me. Di fronte agli avversari, noi avevamo il<br />
dovere di mettere in risalto il principio fondamentale da<br />
essi negato, e non sempre v'era tempo, luogo od occasione<br />
per assegnare il posto dovuto agli altri fattori coinvolti<br />
nell'azione e reazione reciproca" (Engels 1890/1982, p. 26).<br />
Visione “dilemmatica” dei media<br />
• Positiva:<br />
– masse che emergono alla storia<br />
– consapevolezza e democrazia<br />
– abbassamento vs elevamento culturale<br />
– mm come elemento di integrazione sociale<br />
• Negativa:<br />
– destra: paura delle masse; incultura;<br />
violenza<br />
– sinistra: mercificazione della cultura;<br />
sviluppo del capitalismo<br />
– omogeneizzazione pensiero; conformismo<br />
e conservatorismo; fabbrica del consenso.<br />
8
Bias di favoritismo integruppi<br />
• Distorsione dei processi cognitivi<br />
• Distorsione dei processi attribuzionali<br />
• Bias linguistico intergruppi<br />
• Stereotipi verso ingroup e outgroup.<br />
Modello delle categorie<br />
linguistiche<br />
• DAV (descr. (Semin action verbs): & descrizione Fiedler oggettiva 89) di un evento<br />
osservabile; es. colpisce<br />
• IAV (interpret. action verbs): descrizione di una classe di azioni;<br />
es. danneggia, ferisce<br />
• SV (state verbs): stato psicologico permanente, ma ancora<br />
riferito ad un oggetto specifico; es: odia<br />
• Disposizione: caratteristica personale che si generalizza al di là<br />
di situazioni, comporamenti, persone implicate; es. è aggressivo.<br />
Noi<br />
Appartenenza<br />
Loro<br />
Bias attribuzionale e<br />
Tipo di azione<br />
linguistico<br />
Positive<br />
Cause personali<br />
Termini astratti<br />
Cause esterne<br />
Termini concreti<br />
Negative<br />
Cause esterne<br />
Termini concreti<br />
Cause personali<br />
Termini astratti<br />
10



![(Microsoft PowerPoint - Lezione 8b.ppt [modalit\340 compatibilit\340])](https://img.yumpu.com/15217439/1/190x135/microsoft-powerpoint-lezione-8bppt-modalit340-compatibilit340.jpg?quality=85)