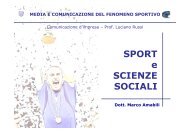Pensare la pace - Facoltà di Scienze della Comunicazione - Sapienza
Pensare la pace - Facoltà di Scienze della Comunicazione - Sapienza
Pensare la pace - Facoltà di Scienze della Comunicazione - Sapienza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Luciano Russi<br />
<strong>Pensare</strong> <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
A cura <strong>di</strong> F<strong>la</strong>vio Silvestrini<br />
Gennaio 2008<br />
«Ma l’imperatore ha fatto tante guerre<br />
che confonde sempre l’una con l’altra<br />
e non ricorda bene neanche qual è<br />
che sta combattendo ora.»<br />
(Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, 1959)<br />
Appunti ad uso degli studenti <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> del<strong>la</strong> comunicazione dell’Università “La <strong>Sapienza</strong>” per il corso <strong>di</strong> Storia delle idee politiche<br />
e sociali.
Introduzione<br />
Premessa<br />
1. L’autonomia concettuale<br />
2. L’elogio antibellicista<br />
3. Diritto delle genti e psicologia politica<br />
4. I progetti settecenteschi<br />
5. Le analisi ottocentesche<br />
6. Al tempo delle guerre mon<strong>di</strong>ali<br />
7. Nel<strong>la</strong> stagione del<strong>la</strong> “guerra fredda”<br />
Antologia<br />
I <strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> Irene<br />
In<strong>di</strong>ce dei nomi e dei luoghi
Premessa<br />
Introduzione<br />
Queste pagine, peraltro sollecitate dagli studenti romani <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> del<strong>la</strong> comunicazione,<br />
non intendono condurre una nuova storia dell’irenismo o del<strong>la</strong> non-violenza, ovvero dei movimenti<br />
per <strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Sul pacifismo, sia quello borghese, che quello cristiano, che quello socialista<br />
esiste già un’ampia bibliografia 1 . Così come sull’aggettivazione del pacifismo. 2<br />
Secondo alcuni, in 3400 anni <strong>di</strong> storia, l’umanità avrebbe avuto solo poco più <strong>di</strong> duecento<br />
anni <strong>di</strong> <strong>pace</strong>, intesa come assenza <strong>di</strong> conflitti armati. Ma <strong>la</strong> sua frequenza non legittima <strong>la</strong><br />
guerra. Altrimenti si dovrebbe dare ragione a chi ha affermato che “<strong>la</strong> guerra è l’anima<br />
dell’Occidente” 3 o a chi ha affermato che, se si volesse scrivere <strong>la</strong> storia del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, essa si ridurrebbe<br />
a nient’altro che al<strong>la</strong> storia del<strong>la</strong> guerra 4 . Sul tema del<strong>la</strong> guerra Machiavelli romaneggia:<br />
per lui sono ancora valide le proverbiali parole dello scrittore <strong>di</strong> arte militare 5 : si vis<br />
<strong>pace</strong>m para bellum. Sull’ineluttabilità del<strong>la</strong> guerra e sul suo fascino (da Machiavelli a C<strong>la</strong>usewitz,<br />
da Eraclito a Schmitt) abbiamo una <strong>la</strong>rga letteratura. A cominciare dai suoi dei e dal<strong>la</strong><br />
sua etimologia. 6<br />
1<br />
Giustamente A. D’ORSI, Introduzione al pacifismo, in “Trimestre”, X (1977), nn. 1-2, pp. 114-6 critica <strong>la</strong> tendenza<br />
a non <strong>di</strong>stinguere il pacifismo da posizioni simili ma <strong>di</strong>verse come l’antimilitarismo, <strong>la</strong> non violenza,<br />
l’internazionalismo, il federalismo.<br />
2<br />
. Sul “pacifismo attivo” artico<strong>la</strong>to in tre forme: “il primo strumentale, ovvero <strong>la</strong> <strong>pace</strong> attraverso il <strong>di</strong>sarmo e <strong>la</strong><br />
nonviolenza, il secondo istituzionale, ovvero <strong>la</strong> <strong>pace</strong> attraverso il <strong>di</strong>ritto, il terzo etico, e finalistico, ovvero <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
attraverso l’educazione morale” (N. BOBBIO, Pacifismo, in Dizionario del<strong>la</strong> politica, Mi<strong>la</strong>no, TEA, 1994, pp.<br />
745-7). Sul pacifismo “ideologico” sorto nel XIX secolo, <strong>di</strong>stinto da quello nazionalistico e da quello fideistico<br />
dei secoli precedenti, cfr. V. FROSINI, Pacifismo, in “Nuovissimo Digesto Italiano”, Torino, Utet, 1965, pp. 304.<br />
3<br />
E. SEVERINO, La guerra, Mi<strong>la</strong>no, Rizzoli, 1992, p. 91.<br />
4<br />
Cfr. M. FOUCAULT, Il faut défendre <strong>la</strong> société. Cours au Collège de France, 1975-1976, Paris, Gallimard, 1997,<br />
tr. it. Torino, Einau<strong>di</strong>, 2002, p. 6.<br />
5<br />
VEGEZIO, Epitoma rei militaris, libro III: «igitur qui desiderat <strong>pace</strong>m, praeparet bellum».<br />
6<br />
L’italiano guerra (come l’omofono termine castigliano, portoghese e cata<strong>la</strong>no e l’omologo francese guerre)<br />
deriverebbe dall’antico tedesco werra. Il termine avrebbe sostituito il <strong>la</strong>tino c<strong>la</strong>ssico bellum in primo luogo per il<br />
significato. Con bellum si intendeva il modo romano <strong>di</strong> combattere, organizzato e <strong>di</strong>sciplinato secondo le strategie<br />
dei comandanti. L’avvento del modo germanico <strong>di</strong> dare battaglia, <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato e caotico, avrebbe definitivamente<br />
sostituito il modo <strong>di</strong> intendere <strong>la</strong> guerra. Ecco perché le lingue romanze, al posto <strong>di</strong> bellum, presentano<br />
tutte un’evoluzione del termine werra, letteralmente “mischia, turba”. La per<strong>di</strong>ta panromanza <strong>di</strong> bellum sarebbe<br />
dovuta anche al conflitto omofonico con bellus: derivato da bonus (bello, grazioso) questo termine avrebbe già<br />
al<strong>la</strong> fine del I secolo d.C. sostituito nel par<strong>la</strong>to l’antico pulcher.<br />
2
Queste pagine non intendono però neppure sfuggire all’analisi dell’en<strong>di</strong>a<strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zionale:<br />
guerra /<strong>pace</strong>. Intendono solo sfuggire al<strong>la</strong> definizione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> tramite il suo opposto, al<strong>la</strong><br />
contrapposizione tra un significato forte (guerra) e un termine debole (<strong>pace</strong>), al nesso genera-<br />
tore guerra/<strong>pace</strong> o degeneratore <strong>pace</strong>/guerra. Mentre <strong>la</strong> guerra è stata sempre vista come mez<br />
zo <strong>di</strong> azione politica (dal<strong>la</strong> tribù alle superpotenze), <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è stata in<strong>di</strong>viduata come un bene<br />
da conseguire, un fine, un approdo. Si è così <strong>di</strong>segnata una <strong>di</strong>alettica guerra – <strong>pace</strong> come mez<br />
zo – fine.<br />
La <strong>pace</strong>, considerata generalmente inenarrabile, è stata ritenuta residuale o antitetica. Il<br />
carattere negativo (o sospensivo) ha accompagnato da sempre l’identificazione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> 7 .<br />
Ciò che si è inteso fare è <strong>di</strong> dare un’autonomia, per quanto possibile analitica, al<strong>la</strong> defini<br />
zione teorica e al<strong>la</strong> <strong>di</strong>fesa filosofico-politica del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. E’ singo<strong>la</strong>re che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> sia tra<strong>di</strong>zio<br />
nalmente trattata all’interno del<strong>la</strong> polemologia 8 . Del resto perché <strong>la</strong> violenza e <strong>la</strong> guerra sono<br />
state considerate sno<strong>di</strong> fondamentali del<strong>la</strong> riflessione politica 9 mentre <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> non aggres<br />
sività sono sempre state marginalizzate dall’analisi storica? 10 O al massimo confinate nel ge<br />
nere dell’utopia o del<strong>la</strong> profezia o dell’ottimismo sociale 11 . La stessa paro<strong>la</strong> in<strong>di</strong>ca il concetto,<br />
definito imme<strong>di</strong>atamente dal suo semantema 12 , <strong>di</strong> composizione <strong>di</strong> interessi contrapposti.<br />
La <strong>pace</strong> non riesce a proporsi come situazione a se stante, con caratteri sganciati dal<strong>la</strong><br />
contingenza e dal<strong>la</strong> sua interconnessione con <strong>la</strong> guerra. Ciò che non evidenzia è <strong>la</strong> sua costitu<br />
zione, <strong>la</strong> sua costituente, <strong>la</strong> sua idealità, <strong>la</strong> sua realtà, <strong>la</strong> sua moralità, <strong>la</strong> sua politicità. Non<br />
ogni posizione contraria ad una guerra è affermazione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> non belligeranza<br />
in un luogo sono contemporanei a conflitti armati condotti in altre parti. Dal<strong>la</strong> <strong>pace</strong> “negativa”<br />
(assenza <strong>di</strong> guerra) deve essere preliminarmente <strong>di</strong>stinta <strong>la</strong> <strong>pace</strong> “positiva” (stato giuri<strong>di</strong>ca<br />
mente rego<strong>la</strong>to e con una certa stabilità).<br />
7<br />
Cfr. F. CARDINI, Quell’antica festa crudele. Guerra e cultura del<strong>la</strong> guerra dall’età feudale al<strong>la</strong> grande rivoluzione,<br />
Firenze, Sansoni, 1982.<br />
8<br />
G. BOUTHOUL, La paix, Paris 1974, p. 5.<br />
9<br />
Si veda per tutti C. SCHMITT, Le categorie del politico, Bologna, Il Mulino, 1972.<br />
10<br />
Ultimo esempio gli Annali (XVIII) del<strong>la</strong> Storia d’Italia, de<strong>di</strong>cati a Guerra e <strong>pace</strong>, a c. <strong>di</strong> W. Barberis, Torino,<br />
Einau<strong>di</strong>, 2002.<br />
11<br />
Cfr. J. MOLTMANN, Le spade <strong>di</strong>verranno vomeri, «Rinascita», n. 21, maggio 1983, p. 24.<br />
12<br />
Pace, dal <strong>la</strong>tino pax, termine collegato con pacisci, significa “concludere un patto”, sta a prevedere una composizione<br />
<strong>di</strong> interessi contrapposti. Allo stesso modo <strong>di</strong> eirène, termine collegato ad ararisco, che significa<br />
“congiungere”, “or<strong>di</strong>nare”.<br />
Il termine pax deriverebbe da due ra<strong>di</strong>ci: <strong>la</strong> ra<strong>di</strong>ce *PAG-/P G-, che ha significato <strong>di</strong> “piantare”, “conficcare”, da<br />
cui “costituire”; <strong>la</strong> ra<strong>di</strong>ce *PAK-/P K-, un cui significato è “unire”, “legare”, “congiungere”. I. LANA (a c. <strong>di</strong>), Le<br />
concezioni del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> a Roma, Torino 1987, p. 208. Già Ulpiano, giurista romano del III secolo d.C., coglieva<br />
nel termine pax un collegamento con patio e quin<strong>di</strong> con pactum, che in<strong>di</strong>ca l’atto <strong>di</strong> concludere un accordo. Il<br />
termine <strong>la</strong>tino pax significa “il presupposto e <strong>la</strong> premessa <strong>di</strong> un contenuto”, al contrario del greco eiréne che invece<br />
in<strong>di</strong>ca “il contenuto e frutti del tempo <strong>di</strong> <strong>pace</strong>” (I. LANA, L’idea <strong>di</strong> <strong>pace</strong> nell’antichità, ECP, S.Domenico <strong>di</strong><br />
Fiesole 1991, p. 56).<br />
3
La <strong>pace</strong> è problema, non solo pratico ma anche teorico, del<strong>la</strong> politica. Essa, come problema,<br />
non sorge so<strong>la</strong>mente in rapporto al<strong>la</strong> guerra. Non può essere pensata ancora e solo come<br />
un valore derivato o un’esigenza solo psicologica 13 o un’aspirazione etica.<br />
Dal p.d.v. socio-politico <strong>la</strong> <strong>pace</strong> si identifica con un’azione <strong>di</strong>namica e continua (quoti<strong>di</strong>ana,<br />
in<strong>di</strong>viduale, collettiva) volta a <strong>di</strong>sinnescare, a depotenziare le ragioni del<strong>la</strong> violenza, le<br />
cause dei conflitti. Questi ultimi non sono realtà inevitabili ma degenerazioni dovute<br />
all’incapacità del<strong>la</strong> politica. L’idea <strong>di</strong> <strong>pace</strong> deve contenere l’idea del mutamento, del cambiamento<br />
e del<strong>la</strong> sua processualità. Quin<strong>di</strong>, non una <strong>pace</strong> come approdo obbligato, unica strada<br />
del<strong>la</strong> civiltà, figlia del<strong>la</strong> paura del<strong>la</strong> morte, ma frutto del<strong>la</strong> <strong>di</strong>namica politica, figlia del<strong>la</strong> realtà<br />
politica, ricerca incessante <strong>di</strong> un equilibrio. Un facere continuo, un processo incessante pieno<br />
<strong>di</strong> avanzate ma anche <strong>di</strong> stalli e <strong>di</strong> arretramenti.<br />
Ambizione <strong>di</strong> queste pagine è dunque quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> dare al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> “problema” per il<br />
pensiero politico. Se <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è un processo pieno <strong>di</strong> luci e ombre, <strong>di</strong> progressi e <strong>di</strong> regressioni,<br />
essa appartiene al<strong>la</strong> realtà storica e non al<strong>la</strong> prospettiva utopica. Non si tratta <strong>di</strong> continuare a<br />
confrontare le ragioni <strong>di</strong> Antigone con quelle <strong>di</strong> Creonte o <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>segnare nuovi aut-aut tra bene<br />
e male, ma, <strong>di</strong>saureo<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> guerra e <strong>di</strong>ssipatone il fascino, artico<strong>la</strong>re e approfon<strong>di</strong>re <strong>la</strong> politicità<br />
del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. La questione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> ha bisogno <strong>di</strong> recuperare un carattere precipuamente<br />
politico (basato sull’equilibrio) e non solo religioso (basato sul “non uccidere”), etico (basato<br />
sul<strong>la</strong> giustizia) o giuri<strong>di</strong>co (<strong>di</strong>chiarazioni universali del <strong>di</strong>ritto) o pedagogico (educare al<strong>la</strong> non<br />
aggressività).<br />
Su un tema come quello del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, non sconnesso ma non <strong>di</strong>pendente dal<strong>la</strong> guerra,<br />
l’esercizio storiografico acquista un significato non solo per <strong>la</strong> comprensione del “già pensato”<br />
ma anche per <strong>la</strong> definizione del “pensare” presente. Ecco perché forse è utile fare una storia<br />
<strong>di</strong> come gli autori politici l’hanno pensata nel corso dei secoli 14 .<br />
13 «Per guadagnare definitivamente <strong>la</strong> <strong>pace</strong> – ragiona Aron nel saggio al cui titolo ci siamo ispirati – bisogna far<br />
<strong>di</strong>ventare <strong>la</strong> guerra un tabù come l’incesto» (R. ARON, Penser <strong>la</strong> guerre, Paris, C<strong>la</strong>usewitz, 1976).<br />
14 Come d’altronde avevano cominciato a fare alcuni pionieri: A. RAVÀ, Il problema del<strong>la</strong> guerra e del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
Lezioni <strong>di</strong> Storia delle dottrine politiche e scienza politica generale raccolte da Tito Ravà, Padova, Cedam,<br />
1932. G. DEL VECCHIO, Stu<strong>di</strong> su <strong>la</strong> guerra e <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, Mi<strong>la</strong>no, Giuffrè, 1959. Del Vecchio c<strong>la</strong>ssifica nel suo saggio<br />
del 1910 (R.I.F.D.) quattro specie <strong>di</strong> teorie sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong>: <strong>la</strong> concezione ascetica, basata sul<strong>la</strong> legge etica<br />
dell’amore e del<strong>la</strong> fraternità umana, comprendente i Padri del<strong>la</strong> Chiesa, alcune correnti come i Mennoniti, i<br />
Quaccheri, Tolstoj; <strong>la</strong> concezione imperialistica o assolutistica, basata sul<strong>la</strong> capacità <strong>di</strong> una dominazione <strong>di</strong> governare<br />
il mondo (<strong>la</strong> pax romana, <strong>la</strong> monarchia universale <strong>di</strong> Dante); <strong>la</strong> concezione empirico-politica, basata su<br />
una serie <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> tra <strong>di</strong>versi stati o governi, <strong>di</strong>ffusa nei secoli XVII e XVIII; <strong>la</strong> concezione giuri<strong>di</strong>ca, basata su<br />
fondamenti razionali e storici (Rousseau e Kant), pp. 42-43.<br />
4
1. L’autonomia concettuale: Dante e Marsilio<br />
Il tema del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, ed in partico<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> politica, è un passaggio assolutamente cen<br />
trale del<strong>la</strong> letteratura tra Duecento e Trecento. La sua centralità è conseguenza anche dei con<br />
trasti seco<strong>la</strong>ri tra poteri <strong>di</strong>fferenti e contrapposti, dopo che <strong>la</strong> (con)fusione tra politico e spiri<br />
tuale, operata dal<strong>la</strong> Chiesa, ha mostrato i suoi limiti storici.<br />
Rispetto all’età c<strong>la</strong>ssica (greca) dove <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, quando c’è, è (secondo Esiodo) una con<strong>di</strong><br />
zione naturale 15 , essa <strong>di</strong>venta una realtà da conquistare a scapito del<strong>la</strong> continuità delle guerre.<br />
Al<strong>la</strong> <strong>di</strong>cotomia <strong>pace</strong>/guerra si affianca quel<strong>la</strong> più politica <strong>pace</strong>/<strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a civile. La rifles<br />
sione si sviluppa in più <strong>di</strong>rezioni: verso l’uomo, come <strong>pace</strong> filosofica, e il cristiano, come<br />
quiete dell’anima; verso <strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione interumana o interpersonale che porta a quel<strong>la</strong> civile e<br />
politica.<br />
Il processo <strong>di</strong> ridefinizione concettuale del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, che vedrà in Dante e Marsilio due au<br />
tentici protagonisti, annovera molti autori: da Egi<strong>di</strong>o Romano, per cui <strong>pace</strong> civile e or<strong>di</strong>ne del-<br />
<strong>la</strong> legge <strong>di</strong>vina ancora «corrispondono» 16 , a Tommaso d’Aquino, che <strong>di</strong>stingue <strong>la</strong> <strong>pace</strong> «per<br />
fetta» (quel<strong>la</strong> <strong>di</strong>vina) da quel<strong>la</strong> «imperfetta» (quel<strong>la</strong> umana) 17 ; da Remigio de’ Giro<strong>la</strong>mi, che<br />
cerca <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>care <strong>la</strong> <strong>pace</strong> su schemi politici ancora in equilibrio tra citta<strong>di</strong>ni, comunità e teleo<br />
logia del bene 18 , a Guglielmo d’Ockham, per il quale <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è già in<strong>di</strong>pendente dalle ingeren<br />
ze ecclesiastiche 19 .<br />
Rispetto a questi autori, come agli altri sostenitori me<strong>di</strong>evali dell’ideale irenico, il Fioren<br />
tino e il Padovano cercano <strong>di</strong> uscire dall’impasse in cui si era soliti rimanere imbrigliati: il<br />
cleavage tra papato e impero. D’altra parte, le nuove forme <strong>di</strong> comunità politica stanno ren<br />
dendo anacronistiche le tra<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong>atribe tra sostenitori del<strong>la</strong> soluzione imperiale e quelli<br />
dell’opzione ecclesiastica.<br />
Dallo stesso crinale storico in cui <strong>la</strong> società me<strong>di</strong>evale si apriva al<strong>la</strong> emergenza del<strong>la</strong> mo<br />
dernità politica attraverso l’esperienza comunale, Dante e Marsilio giungono ad e<strong>la</strong>borare<br />
progetti politici <strong>di</strong>fferenti.<br />
15 G. ZAMPAGLIONE, L’idea <strong>di</strong> <strong>pace</strong> nel mondo antico, Torino, ERI, 1967.<br />
16 EGIDIO ROMANO, De regimine principum (1285), Firenze, Le Monnier, 1858.<br />
17 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae (1268), Bologna, ESD, 1996.<br />
18 REMIGIO DE’ GIROLAMI, De bono pacis (1304), in E. PANELLA, Dal bene comune al bene del Comune. I trattati<br />
politici <strong>di</strong> Remigio dei Giro<strong>la</strong>mi nel<strong>la</strong> Firenze dei bianchi-neri, “Memorie domenicane”, 16, 1985, pp. 169-83.<br />
19 GUGLIELMO D’OCKHAM, De potestate papae et imperatoris (1334-1342), Torino, Bottega d'Erasmo, 1966.<br />
5
In segno <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità sia con <strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione agostiniana 20 che con quel<strong>la</strong> tomistica 21 ,<br />
Dante non ha dubbi a eleggere <strong>la</strong> <strong>pace</strong> come il “bene migliore” per <strong>la</strong> felicità del<strong>la</strong> collettività.<br />
Rispetto al De civitate Dei e al<strong>la</strong> Summa Theologiae <strong>la</strong> Monarchia dantesca non s’attarda sul<br />
<strong>la</strong> teorizzazione <strong>di</strong> “guerra giusta” 22 , che per lungo tempo ha stemperato il conflitto tra papato<br />
e impero.<br />
Se è vero che il creato porta impressa <strong>la</strong> traccia <strong>di</strong>vina, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> – il cui compito egli attri<br />
buisce all’imperatore – è il vettore politico del fine <strong>di</strong>vino. Il sillogismo dantesco comporta<br />
che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è il mezzo che si interpone tra <strong>la</strong> vita terrena degli or<strong>di</strong>namenti politici e <strong>la</strong> sua<br />
tensione verso <strong>la</strong> perfezione dell’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>vino.<br />
La prima intenzione del<strong>la</strong> Monarchia 23 è quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> autonomizzare <strong>la</strong> sfera politica (com<br />
prendente <strong>la</strong> <strong>pace</strong> civile) dal<strong>la</strong> fenomenologia ecclesiastica. Questa autonomia del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> poli<br />
tica non fonda però, come accadrà in Marsilio, il fine politico del<strong>la</strong> comunità ma è il termine<br />
me<strong>di</strong>o tra <strong>la</strong> politica e il ruolo del monarca universale. Il monarca universale è l’unico 24 che<br />
possa amministrare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> tra i suoi sud<strong>di</strong>ti, perché in grado <strong>di</strong> agire da giu<strong>di</strong>ce imparziale,<br />
dotato com’è <strong>di</strong> sapienza e immune com’è dal<strong>la</strong> cupi<strong>di</strong>gia 25 , vero nemico del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
Se con Dante si emancipa dai vincoli ecclesiastici, con Marsilio il concetto <strong>di</strong> <strong>pace</strong> si se<br />
co<strong>la</strong>rizza. La <strong>pace</strong> o civilis tranquillitas si svinco<strong>la</strong> completamente dal<strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione che<br />
l’aveva caricata <strong>di</strong> valore etico, religioso e teologico.<br />
Marsilio chiarisce subito <strong>la</strong> <strong>di</strong>retta connessione tra <strong>la</strong> <strong>pace</strong> (terrena) e <strong>la</strong> politica. A co<br />
minciare dal fatto che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è risultato dell’opera <strong>di</strong> tutti, e non <strong>di</strong> qualcuno.<br />
20<br />
Secondo Agostino ci sono due tipi <strong>di</strong> <strong>pace</strong>: <strong>la</strong> Pax Babylonis e <strong>la</strong> pax Christi; <strong>la</strong> prima provvisoria e mai definitiva,<br />
<strong>la</strong> seconda vera e duratura. Sia per <strong>la</strong> prima che per <strong>la</strong> seconda il cristiano opera e prega. Ma mentre <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
terrena è un mezzo, quel<strong>la</strong> celeste è un fine. In ambedue i casi <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è più sollievo dall’infelicità che go<strong>di</strong>mento<br />
del<strong>la</strong> felicità. Cfr., tra gli altri, A. PORTOLANO, L’etica del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> nei primi secoli del cristianesimo, Napoli,<br />
Federico & Ar<strong>di</strong>a, 1974.<br />
21<br />
Nel<strong>la</strong> questione XXIX, Tommaso s’attarda sul concetto <strong>di</strong> <strong>pace</strong>, che non s’identifica con <strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a, e che si<br />
può definire “quiete nell’or<strong>di</strong>ne, effetto del<strong>la</strong> carità”.<br />
22<br />
Nel suo scritto Agostino considera giusta <strong>la</strong> guerra che ven<strong>di</strong>ca i soprusi, che punisce i crimini, che restituisce<br />
il maltolto, che è stata comandata da Dio.<br />
Nel<strong>la</strong> questione XL, Tommaso definisce “giusta” quel<strong>la</strong> guerra che risponde a tre con<strong>di</strong>zioni: 1. che sia <strong>di</strong>chiarata<br />
dall’autorità legittima; 2. che esista una giusta causa; 3. che il belligerante abbia una retta intenzione.<br />
23<br />
La <strong>pace</strong> politica, identificata con il vivere civile, è una costante del<strong>la</strong> riflessione dantesca: dal Convivio (dove<br />
<strong>la</strong> sua mancanza giustifica <strong>la</strong> costituzione dell’impero) alle Epistole (dove <strong>la</strong> pacifica convivenza umana è affidata<br />
all’autorità imperiale); cfr. G. CARLETTI, Dante politico. La felicità terrena secondo il pontefice, il filosofo,<br />
l’imperatore, Pescara, ESA, 2006.<br />
24<br />
Secondo Pierre Dubois, avvocato francese (1250-1311) molto attivo presso <strong>la</strong> corte dei Valois, tale compito è<br />
attribuito ad un Concilio composto da autorità ecclesiastiche ma anche <strong>la</strong>iche.<br />
25<br />
L. RUSSI, Dante politico nelle carte ine<strong>di</strong>te <strong>di</strong> Augusto Del Noce, in V. LATTANZI - F. MERCADANTE (a c. <strong>di</strong>),<br />
Augusto Del Noce. Essenze filosofiche e attualità storica, 2 voll., Roma, Spes-Fondazione Capograssi, 2000<br />
2001, I, pp. 242-57.<br />
6
Se è vero, come è vero, che solo sotto <strong>la</strong> <strong>pace</strong> l’uomo può vivere una vita degna, compito<br />
del<strong>la</strong> politica è permettere <strong>di</strong> raggiungere questo fine. Le leggi civili, che possono essere volu<br />
te solo dal<strong>la</strong> totalità del<strong>la</strong> citta<strong>di</strong>nanza (universitas civium), devono avere come obiettivo <strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong>. Altro compito ha <strong>la</strong> legge <strong>di</strong>vina, che riguarda <strong>la</strong> felicità ultramondana dell’uomo.<br />
Nel Defensor pacis (1324) <strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong>venta problema squisitamente politico perché fatto<br />
umano e terreno. Nonostante il titolo, l’opera marsiliana non si propone <strong>di</strong> trattare monografi<br />
camente <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, ma <strong>di</strong> mostrare le sue cause politiche e denunciare le ingerenze ecclesiasti<br />
che e religiose. Per questo sembra essere scritta non per <strong>di</strong>mostrare una tesi sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, ma per<br />
esporre una dottrina politica attraverso il topos del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
Da allievo <strong>di</strong> Aristotele, Marsilio recupera <strong>la</strong> naturale tendenza dell’uomo al<strong>la</strong> vita asso<br />
ciata perfettibile, ma ad un tempo sottolinea che tale tendenza è mossa da una naturale spinta<br />
verso <strong>la</strong> felicità del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> terrena. E’ chiaro come <strong>la</strong> <strong>pace</strong> marsiliana sia inserita all’interno<br />
del<strong>la</strong> società politica, a sua volta basata sul<strong>la</strong> pienezza del<strong>la</strong> sua autorità e del suo potere.<br />
La pacificazione non si consegue soltanto con l’assenza <strong>di</strong> guerra o con opere del<strong>la</strong> carità,<br />
ma attraverso un or<strong>di</strong>ne civile garantito.<br />
Il raggiungimento del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> prevede: il desiderio, <strong>la</strong> ricerca, <strong>la</strong> conservazione e<br />
l’allontanamento <strong>di</strong> ciò che <strong>la</strong> può pregiu<strong>di</strong>care. Questi quattro stati sono tutti umani. Al contrario<br />
<strong>di</strong> quanto sostenuto da altri, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> si ra<strong>di</strong>ca a queste <strong>di</strong>namiche e non al senso <strong>di</strong> giustizia,<br />
innato nell’uomo (etico) o derivato da Dio (teologico). La <strong>pace</strong> marsiliana è fondata su<br />
una convivenza equilibrata e artificialmente costruita 26 .<br />
Se può essere condotto qualche parallelismo a proposito dei rapporti tra politica e moralereligione,<br />
o a proposito del<strong>la</strong> superiorità (aristotelica) del tutto sulle parti, o a proposito<br />
dell’idea <strong>di</strong> nazione italiana, sul tema del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>la</strong> <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> Dante e Marsilio da Machiavelli<br />
è vasta. Per nul<strong>la</strong> interessato ad analizzare <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, il Fiorentino afferma l’impossibilità, oltre<br />
che l’inopportunità, <strong>di</strong> neutralizzare o eliminare <strong>la</strong> guerra. Il principe «faccia volentieri <strong>la</strong><br />
guerra per avere <strong>pace</strong>, e non cerchi <strong>di</strong> turbare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> per avere guerra» 27 .<br />
26<br />
L. RUSSI, L’idea <strong>di</strong> <strong>pace</strong> in Marsilio da Padova, in G. CARLETTI (a c. <strong>di</strong>), Prima <strong>di</strong> Machiavelli, Pescara, ESA,<br />
2006, pp. 87-106.<br />
27<br />
N. MACHIAVELLI, Dell’arte del<strong>la</strong> guerra (1521), a c. <strong>di</strong> S. Bertelli, Mi<strong>la</strong>no, Feltrinelli, 1961, p. 340.<br />
7
2. L’elogio antibellicista: Erasmo<br />
Proprio in esor<strong>di</strong>o dell’età moderna, che si appresta a glorificare l’ideologia militare e<br />
bellicista, un umanista come Erasmo smobilita il concetto del<strong>la</strong> guerra come strumento in<strong>di</strong>spensabile<br />
e fatale delle potenze politiche e religiose. Nessun richiamo al<strong>la</strong> concezione deterministica<br />
secondo <strong>la</strong> quale l’uomo sarebbe portato naturalmente al<strong>la</strong> guerra “nimico empio de<br />
l’umana natura” o vi aspirerebbe naturalmente 28 , egli pensa piuttosto, attraverso un’analisi<br />
dell’animo umano, a una tendenza <strong>di</strong> ognuno a non risolvere le proprie conflittualità.<br />
Se <strong>la</strong> salute – osserva – non è che il frutto dell’armonia <strong>di</strong> tutti gli organi e le funzioni<br />
dell’organismo, essa può essere paragonata al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> come stato naturale del<strong>la</strong> vita 29 .<br />
Nel<strong>la</strong> Quere<strong>la</strong> Pacis (1517), l’o<strong>la</strong>ndese <strong>di</strong>fende molti spunti già presenti nei suoi Adagia<br />
<strong>di</strong> qualche anno prima e in partico<strong>la</strong>re riba<strong>di</strong>sce il proverbio “dulce bellum inexpertis” – chi<br />
ama <strong>la</strong> guerra non l’ha vista in faccia 30 . La guerra è considerata un momento <strong>di</strong> crisi<br />
dell’umanità, in quanto con essa avviene un ce<strong>di</strong>mento agli istinti peggiori da cui invece <strong>la</strong><br />
natura, dandole <strong>la</strong> ragione, aveva voluto salvar<strong>la</strong>.<br />
Di qui il suo elogio del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, “lo stato più benefico <strong>di</strong> tutti e il più felice ad un tempo” 31 .<br />
La sua pax è volontaria concor<strong>di</strong>a, in sintonia con <strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a dell’universo, è ricerca <strong>di</strong> equilibrio,<br />
all’unisono con il modello naturale. «Quasi sempre – <strong>di</strong>ce Erasmo – è l’interesse<br />
privato del principe a spingere al<strong>la</strong> guerra che, se proprio dovesse essere fatta, dovrebbe perseguire<br />
un rilevante interesse pubblico». La sua idea <strong>di</strong> <strong>pace</strong> è quin<strong>di</strong> inscritta nel<strong>la</strong> più complessiva<br />
visione del mondo che lo porta ad essere ra<strong>di</strong>calmente e razionalmente contro ogni<br />
tentativo <strong>di</strong> elogio del<strong>la</strong> guerra, definita sempre innaturale, antieconomica, antiumana, anticristiana.<br />
Il buon principe, cioè il governante che vuole <strong>la</strong> felicità dei suoi sud<strong>di</strong>ti, cerca <strong>di</strong> raggiungere<br />
e <strong>di</strong>fendere <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, massimo bene del<strong>la</strong> collettività. Il principe (evangelico) è un<br />
uomo libero che governa uomini liberi. Il popolo come può obbe<strong>di</strong>re al proprio governante,<br />
<strong>la</strong>ddove questi persegua il bene pubblico, può altresì contrastarlo, per evitare che <strong>di</strong>venti un<br />
tiranno.<br />
28<br />
ERASMO, Elogio del<strong>la</strong> follia, Torino, Utet, 1974.<br />
29<br />
ERASMO, Quere<strong>la</strong> pacis, Torino, Utet, 1968, pp. 32-3.<br />
30<br />
ERASMO, Adagia. Sei saggi politici in forma <strong>di</strong> proverbi, a c. <strong>di</strong> S. Seidel Menchi, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1980, p.<br />
199.<br />
31<br />
Ivi, p. 231.<br />
8
Al contrario del suo amico Thomas More, che nell’Utopia 32 (1516) critica le motivazioni<br />
e le conseguenze delle guerre ma che <strong>di</strong><strong>la</strong>ta il concetto <strong>di</strong> “guerra giusta” (fino a considerare<br />
tale non solo quel<strong>la</strong> <strong>di</strong>fensiva ma anche quel<strong>la</strong> coloniale, quel<strong>la</strong> umanitaria e quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> vendet<br />
ta), per il filosofo <strong>di</strong> Rotterdam <strong>la</strong> guerra (giusta) non può essere in alcun modo giustificata.<br />
Nessuna <strong>pace</strong> sarà mai così iniqua da non essere preferibile al<strong>la</strong> più giusta delle guerre 33 .<br />
Questo archetipo non ebbe un gran seguito nel mondo cattolico <strong>di</strong> quegli anni, che preferì<br />
con<strong>di</strong>videre il punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> un Bel<strong>la</strong>rmino 34 o <strong>di</strong> un Suárez 35 , per i quali <strong>la</strong> guerra era “un<br />
mezzo, anche se molto grave e pericoloso, per <strong>la</strong> <strong>pace</strong>”, ma nemmeno nei movimenti religiosi<br />
riformatori.<br />
Chi invece pensò ad un piano <strong>di</strong> organizzazione <strong>di</strong> una <strong>pace</strong> “generale” fu il monaco parigino<br />
Émeric Crucé <strong>di</strong> cui poco o nul<strong>la</strong> sappiamo ma che ci ha <strong>la</strong>sciato Le nouveau Cynée<br />
(1623) 36 , dove espose l’idea <strong>di</strong> un congresso permanente <strong>di</strong> tutti gli stati con sede a Venezia e<br />
con compiti <strong>di</strong> Corte internazionale. Come Cinea aveva suggerito a Pirro <strong>di</strong> desistere dai propositi<br />
bellicosi, così il “nuovo” Cinea suggeriva ai monarchi e ai principi <strong>di</strong> abbandonare le<br />
guerre in favore <strong>di</strong> una <strong>pace</strong> permanente.<br />
Chi saldò il progetto <strong>di</strong> salvezza delle nazioni con una prospettiva pansofica <strong>di</strong> pacificazione<br />
fu il teologo moravo Amos Comenio. Nel<strong>la</strong> sua opera La via del<strong>la</strong> luce 37 (scritta a Londra<br />
tra il 1641 e il 1642) auspicava <strong>la</strong> fine delle guerre e dei <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong> politici e religiosi grazie<br />
all’affermarsi <strong>di</strong> libri, scuole e lingue universali.<br />
32<br />
TH. MORE, Utopia, a.c. <strong>di</strong> Luigi Firpo, Napoli, Guida, 1990.<br />
33<br />
Per criticare il “bellum justum” egli esplicita due bersagli: Bernardo <strong>di</strong> C<strong>la</strong>irvaux e Tommaso d’Aquino (Adagia,<br />
cit., p. 259). Nel<strong>la</strong> Institutio principis Christiani, de<strong>di</strong>cata nel 1515 a Carlo <strong>di</strong> Gand, futuro Carlo V, e pubblicata<br />
a Lovanio nel 1516, è invece polemico nei confronti <strong>di</strong> Agostino.<br />
34<br />
R. BELLARMINI, De controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos (1581-1593), II, Napoli,<br />
G. Giuliano, 1857, pp. 316-333.<br />
35<br />
F. SUÁREZ, De Charitate (1621), in Opera Omnia, XII, Parisiis 1858, p. 733.<br />
36<br />
Le Nouveau Cynée, ou Discours d'Etat représentant les occasions et moyens d'établir une paix générale et <strong>la</strong><br />
liberté du commerce pour tout le monde, Paris, J. Villery, 1623. Cfr. A. M. LAZZARINO DEL GROSSO, Introduzione<br />
a E. CRUCÉ, Il nuovo Cinea, Napoli, Guida, 1979.<br />
37<br />
Via lucis, vestigata et investiganda, Amsterdam, C. Cunradum, 1668. Cfr. C. SCARCELLA, Introduzione a A.<br />
COMENIO, La via del<strong>la</strong> luce, Pisa, Ed. del Cerro, 1992.<br />
9
3. Diritto delle genti e psicologia politica<br />
Sul<strong>la</strong> scia <strong>di</strong> alcune lezioni all’università <strong>di</strong> Sa<strong>la</strong>manca del teologo domenicano Vitoria<br />
sul<strong>la</strong> giustizia internazionale naturale e <strong>di</strong> alcune considerazioni sul<strong>la</strong> legalità da parte <strong>di</strong> Gentili<br />
38 , il giurista o<strong>la</strong>ndese Ugo Grozio riserva al termine <strong>pace</strong> pari <strong>di</strong>gnità col termine guerra<br />
nel titolo del<strong>la</strong> sua opera 39 . Del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> considerata in se stessa però si par<strong>la</strong> solo nelle ultime<br />
pagine, mentre <strong>la</strong> guerra è ampiamente analizzata e commentata non su principi <strong>di</strong> giustizia<br />
sostanziale ma su canoni <strong>di</strong> legittimità formale.<br />
La <strong>pace</strong>, nel De jure belli ac pacis (1625), è considerata in ultima analisi un mezzo per<br />
terminare <strong>la</strong> guerra, soprattutto quel<strong>la</strong> legale, ovvero condotta secondo il <strong>di</strong>ritto. Si delinea così<br />
un tratto <strong>di</strong> continuità tra il tempo del<strong>la</strong> guerra e quello del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, visti all’interno del<strong>la</strong><br />
legge, del <strong>di</strong>ritto delle genti e del<strong>la</strong> giustizia. Solo una guerra combattuta secondo il <strong>di</strong>ritto<br />
può avere come obiettivo <strong>la</strong> ricerca <strong>di</strong> una giusta <strong>pace</strong>. Così come <strong>la</strong> necessità <strong>di</strong> <strong>pace</strong> si giustifica<br />
anche in caso <strong>di</strong> guerra “giusta” Grozio elenca i motivi per iniziare una guerra secondo<br />
giustizia dopo aver illustrato i mo<strong>di</strong> alternativi per risolvere i contenziosi tra gli stati 40 .<br />
Nell’analisi groziana <strong>di</strong>ritto naturale, <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>vino e <strong>di</strong>ritto delle genti devono cercare e trovare<br />
necessariamente un punto <strong>di</strong> incontro. A conforto il giurista o<strong>la</strong>ndese cita non solo Aristotele<br />
ma anche scrittori <strong>la</strong>tini (come Cicerone e Sallustio) e filosofi cristiani (Agostino).<br />
Di naturale per l’Hobbes del Leviathan (1651) c’è <strong>la</strong> conflittualità. Definito lo stato <strong>di</strong> natura<br />
uno stato <strong>di</strong> guerra, ciò che caratterizza <strong>la</strong> società civile è il mantenimento del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> che<br />
solo lo stato può assicurare, amministrando il <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o naturale tra gli uomini. Hobbes giu<strong>di</strong>ca<br />
<strong>la</strong> guerra come il tempo normale, <strong>la</strong> modalità naturale delle re<strong>la</strong>zioni umane, mentre <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
gli appare “ogni altro tempo” 41 in cui non si esplica questa naturale <strong>di</strong>sposizione a combattersi.<br />
Sia sul piano definitorio che concettuale <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è quin<strong>di</strong> residuale del<strong>la</strong> guerra; il che non<br />
gli impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> scrivere che «si deve ricercare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> quando <strong>la</strong> si può avere» 42 .<br />
38<br />
FRANCISCO DE VITORIA, Relectio de iure belli (1539), in Corpus hispanorum de <strong>pace</strong>, vol. VI, Madrid, CSIC,<br />
1981.<br />
ALBERICO GENTILI, Commentatio de jure belli (1598), in Opera juri<strong>di</strong>ca selectiora, Neapoli, J. Gravier, 1770.<br />
39<br />
HUGONIS GROTII, De jure belli ac pacis, Parisii, apud Nico<strong>la</strong>um buon, 1625.<br />
40<br />
G. SAVIOLI, Il concetto <strong>di</strong> guerra giusta negli scrittori anteriori a Grozio, Napoli, Giannini, 1915.<br />
41<br />
TH. HOBBES, Leviatano, I, 13.<br />
42<br />
TH. HOBBES, De cive, cap. II, par. 2.<br />
10
La <strong>pace</strong> è l’e<strong>la</strong>borazione artificiale (contrattuale) prodotta dal<strong>la</strong> ragione umana matema<br />
tizzante. E questo, se è possibile sul fronte interno, grazie ai me<strong>di</strong>atori, è molto più <strong>di</strong>fficile<br />
sul piano internazionale. Nelle controversie tra stati non esiste un’autorità terza ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> pu<br />
nire le ingiustizie, un’entità super partes che costringa i contendenti al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>; <strong>di</strong> qui <strong>la</strong> guerra<br />
perpetua tra gli stati 43 , senza regole e senza <strong>di</strong>ritto. Ciò che muove il principio pax est quae<br />
renda è in Hobbes sempre e solo il calcolo utilitaristico. La <strong>pace</strong> <strong>di</strong>venta un valore se è razio<br />
nalmente vantaggiosa. La sua traduzione sul piano pratico è possibile solo se garantita dal<strong>la</strong><br />
spada.<br />
Locke, dopo aver <strong>di</strong>stinto nei Two Treatises of Government (1690) stato <strong>di</strong> natura e stato<br />
<strong>di</strong> guerra, caratterizzato dall’uso del<strong>la</strong> forza senza <strong>di</strong>ritto, definisce lo stato <strong>di</strong> <strong>pace</strong> come quel<br />
lo in cui non vi è alcun uso del<strong>la</strong> forza senza <strong>di</strong>ritto. Chiunque detenga il potere legis<strong>la</strong>tivo,<br />
deve governare secondo leggi fisse e «garantire <strong>la</strong> comunità da incursioni e invasioni, e <strong>di</strong>ri<br />
gere tutto a nessun altro fine che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> sicurezza e il pubblico bene del popolo» 44 .<br />
Per il Bo<strong>di</strong>n de La République (1576), se <strong>la</strong> guerra è una realtà inevitabile del<strong>la</strong> storia 45 ,<br />
essa è incomparabile con i beni e i vantaggi del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, quasi sempre appaiata all’amicizia svi<br />
luppabile grazie al commercio, alle alleanze e ai trattati.<br />
Per Spinoza, che parte dal<strong>la</strong> tendenza universale degli uomini all’autoconservazione,<br />
l’unica <strong>di</strong>fferenza tra <strong>la</strong> guerra e <strong>la</strong> <strong>pace</strong> sta nel fatto che per fare <strong>la</strong> prima è sufficiente <strong>la</strong> vo<br />
lontà <strong>di</strong> un singolo stato, mentre per ottenere <strong>la</strong> seconda à necessario il concorso <strong>di</strong> volontà <strong>di</strong><br />
almeno due stati 46 . Nel Trattato politico (1677) Spinoza salda <strong>la</strong> <strong>pace</strong> al<strong>la</strong> libertà dei citta<strong>di</strong>ni.<br />
43<br />
TH. HOBBES, Il <strong>di</strong>alogo fra un filosofo e uno stu<strong>di</strong>oso del <strong>di</strong>ritto comune d’Inghilterra, in Opere politiche, a c.<br />
<strong>di</strong> N. Bobbio, Torino, Utet, 1959, p. 412.<br />
44<br />
«E perché tutti gli uomini possano essere trattenuti dall’invadere i <strong>di</strong>ritti degli altri e dal recarsi danno l’un<br />
l’altro, e perché sia osservata <strong>la</strong> legge <strong>di</strong> natura, che vuol mantenere <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> conservazione <strong>di</strong> tutta l’umanità,<br />
l’esecuzione del<strong>la</strong> legge <strong>di</strong> natura è, in questo stato, posta nelle mani <strong>di</strong> ciascun uomo, per cui ognuno ha <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> punire i trasgressori <strong>di</strong> quel<strong>la</strong> legge in un grado tale che possa impe<strong>di</strong>re <strong>la</strong> sua vio<strong>la</strong>zione» (J. LOCKE, Due trattati<br />
sul governo e altri scritti politici, a c. <strong>di</strong> L. Pareyson, Torino, UTET, 1982, par. 19).<br />
45<br />
J. BODIN, I sei libri del<strong>la</strong> République, V, cap. 5.<br />
46<br />
B. SPINOZA, Trattato politico, c. III, par. 11-18.<br />
11
4. I progetti settecenteschi: Saint-Pierre, Rousseau e Kant<br />
Fino al XVIII secolo <strong>la</strong> politica (internazionale) appare un’alternanza infinita <strong>di</strong> guerra e<br />
<strong>pace</strong> fra potenze ora alleate ora rivali.<br />
Già verso <strong>la</strong> fine del Seicento si era cominciata ad ipotizzare qualche sorta <strong>di</strong> associazione<br />
politica finalizzata a realizzare una <strong>pace</strong> duratura. William Penn aveva applicato il modello<br />
contrattualistico ad un’associazione degli stati europei 47 .<br />
La costruzione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, che Erasmo aveva affidato alle buone intenzioni e alle sante i<br />
dee, in questo periodo s’inquadra nel nuovo spirito <strong>di</strong> tolleranza e nel<strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> favorire il<br />
libero commercio, che sembra <strong>di</strong>ventare fattore del “bonheur” d’un popolo.<br />
Per l’abate <strong>di</strong> Saint-Pierre, come Hobbes aveva mostrato <strong>la</strong> necessità dello Stato in or<strong>di</strong>ne<br />
al<strong>la</strong> protezione dei singoli, così era <strong>di</strong>ventato necessario creare una federazione super partes,<br />
ovvero un’unità politica sovrastatuale, ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> operare me<strong>di</strong>ante organismi politici propri a<br />
tute<strong>la</strong> dei prìncipi europei cristiani. Siamo all’inizio del secolo e <strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione irenica incontra<br />
l’istanza <strong>di</strong> cosmopolitismo. I progetti <strong>di</strong> <strong>pace</strong> cercano <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare progetti <strong>di</strong> rego<strong>la</strong>mentazione<br />
del mondo attraverso istituzioni arbitrali e organismi internazionali 48 . Nel suo Projet<br />
pur rendre <strong>la</strong> paix perpétuelle en Europe (1713) l’analisi politica si incentra sul<strong>la</strong> stretta inter<strong>di</strong>pendenza<br />
tra politica interna e politica internazionale, tra <strong>pace</strong> perpetua e patto confederativo<br />
europeo.<br />
E’ <strong>la</strong> prima volta che un autore usa l’aggettivo “perpetua” e Leibniz subito maligna <strong>di</strong><br />
pensare al<strong>la</strong> “pax perpetua” dei cimiteri 49 . In realtà l’abate ritiene che il suo progetto <strong>di</strong> Unione,<br />
essendo perfettamente razionale, possa e debba realizzarsi. L’appello al<strong>la</strong> ragione solidale<br />
avrebbe piegato l’uso del<strong>la</strong> forza al principio normativo.<br />
Prima del Dictionnaire philosophique (1764) <strong>di</strong> Voltaire, <strong>pace</strong> è «<strong>la</strong> tranquillità <strong>di</strong> cui gode<br />
una società politica, sia all’interno, grazie al buon or<strong>di</strong>ne che regna tra i suoi membri, sia<br />
all’esterno, grazie al<strong>la</strong> buona intesa in cui vive con altri popoli. [Il corpo politico] è sano, cioè<br />
nel suo stato naturale, solo quando gode del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. La <strong>pace</strong> dà vigore agli imperi; mantiene<br />
l’or<strong>di</strong>ne tra i citta<strong>di</strong>ni; <strong>la</strong>scia alle leggi <strong>la</strong> forza loro necessaria; favorisce l’aumento del<strong>la</strong> po<br />
47<br />
W. PENN, Essay towards the Present and Future of Europe, London, s.n., 1693.<br />
48<br />
Su C.-I. C. de Saint-Pierre cfr. M. BOTTARO PALUMBO, Saint-Pierre e <strong>la</strong> crisi del<strong>la</strong> Monarchia <strong>di</strong> Luigi XIV,<br />
Genova, Ecig, 1983.<br />
49<br />
Lettera al<strong>la</strong> principessa Pa<strong>la</strong>tina (1716), in E. NYS, “Revue de droit international et de légis<strong>la</strong>tion comparée”,<br />
XXII, 1890, p. 374.<br />
12
po<strong>la</strong>zione, l’agricoltura e il commercio; in una paro<strong>la</strong>, procura ai popoli quel<strong>la</strong> felicità ch’è il<br />
fine <strong>di</strong> qualsiasi società.» 50<br />
Al contrario <strong>di</strong> Voltaire che, a proposito <strong>di</strong> Saint-Pierre, aveva liquidato <strong>la</strong> sua <strong>pace</strong> “una<br />
chimera che non sussisterà tra i prìncipi più che tra gli elefanti e i rinoceronti” 51 , Rousseau<br />
de<strong>di</strong>ca una buona attenzione al<strong>la</strong> riflessione dell’Abate, perché <strong>la</strong> <strong>pace</strong> riguarda <strong>di</strong>rettamente i<br />
citta<strong>di</strong>ni, mentre <strong>la</strong> guerra riguarderebbe <strong>la</strong> <strong>di</strong>namica tra stati 52 .<br />
Nell’Estratto 53 , scritto dopo il Discorso sull’origine del<strong>la</strong> <strong>di</strong>seguaglianza 54 , Rousseau rie<br />
spone il ragionamento (animato da Saint Pierre) sui vantaggi economici, morali e politici <strong>di</strong><br />
un’alleanza federale tra i monarchi europei per una <strong>pace</strong> perpetua 55 . Di suo aggiunge il carat<br />
tere <strong>di</strong> sistema che lega ormai le nazioni, che sono costrette a cercare tra <strong>di</strong> loro una sorta <strong>di</strong><br />
or<strong>di</strong>ne garantito dal principio dell’equilibrio, che però non conduce sempre al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Infatti <strong>la</strong><br />
politica dell’equilibrio, più che al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> véritable, conduce alle tregue. Ecco perché egli con-<br />
corda con Saint-Pierre sul<strong>la</strong> necessità <strong>di</strong> un’alleanza durevole tra stati che garantisca <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
perpetua e renda i governanti consapevoli dei danni prodotti da qualunque tipo <strong>di</strong> guerra.<br />
La conclusione è: “se … il progetto resta inattuato, non è perché sia chimerico; è perché<br />
gli uomini sono privi <strong>di</strong> senno, ed essere savi in mezzo ai pazzi è una specie <strong>di</strong> follia”.<br />
Nel Giu<strong>di</strong>zio 56 Rousseau critica invece il progetto dell’abate 57 . Egli non è più tanto fidu<br />
cioso verso l’alleanza volontaria dei monarchi europei, che gli sembrano interessati solo ai<br />
propri interessi e alle proprie passioni. “Al giorno d’oggi <strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua è senz’altro un pro<br />
50 L’enciclope<strong>di</strong>a o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri (1751-1772), tr. it. <strong>di</strong> A. Pons, 2<br />
voll., Mi<strong>la</strong>no, Feltrinelli, 1966, II, p. 453.<br />
51 VOLTAIRE, Scritti politici, a c. <strong>di</strong> R. Fubini, Torino, Utet, 1964, p. 809. Voltaire redasse <strong>la</strong> voce “Guerra” per il<br />
Dictionnaire philosophique (1764).<br />
52 Due sono i frammenti generati dal<strong>la</strong> riflessione sugli scritti <strong>di</strong> Saint-Pierre e rimasti ine<strong>di</strong>ti fino al Novecento:<br />
Lo stato <strong>di</strong> guerra nasce dallo stato sociale e Lo stato <strong>di</strong> guerra (cfr. vol. III delle Oeuvres Completes, Paris,<br />
Gallimard, 1964. Contrario al<strong>la</strong> lettura antropologica hobbesiana, Rousseau esclude, nel primo <strong>di</strong> questi frammenti,<br />
l’assimi<strong>la</strong>zione dello stato <strong>di</strong> natura allo stato <strong>di</strong> guerra.<br />
E’, secondo lui, il potere politico che, una volta creato il citta<strong>di</strong>no, lo trasforma anche in soldato. C’è una contrad<strong>di</strong>zione<br />
tra <strong>la</strong> vita nello stato, rego<strong>la</strong>ta dal<strong>la</strong> legge civile, e <strong>la</strong> vita tra gli stati, rego<strong>la</strong>ta dal <strong>di</strong>ritto delle genti<br />
che porta a giustificare l’uso del<strong>la</strong> guerra.<br />
53 Extrait du Projet pour rendre <strong>la</strong> paix perpétuelle en Europe de l’Abée de Saint-Pierre, 1754.<br />
54 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Amsterdam, Marc Michel Rey,<br />
1755.<br />
55 Il suo approccio all’opera dell’Abate è declinata ne Les Confessione, IX.<br />
56 Jugement sur le Projet pour rendre <strong>la</strong> paix perpétuelle en Europe, pubblicato postumo nel 1784.<br />
57 Una prima <strong>di</strong>stanza dall’abate Rousseau l’aveva già presa nell’Estratto, quando aveva criticato <strong>la</strong> convinzione<br />
<strong>di</strong> Saint-Pierre sul fatto che “<strong>la</strong> vera gloria dei principi consistesse nel promuovere l’utilità pubblica e <strong>la</strong> felicità<br />
dei sud<strong>di</strong>ti; che tutti i loro interessi sono subor<strong>di</strong>nati al<strong>la</strong> reputazione; e che si acquista reputazione presso i saggi<br />
sul<strong>la</strong> misura del bene che si è fatto agli uomini; che l’iniziativa d’una <strong>pace</strong> perpetua, essendo <strong>la</strong> più grande fra<br />
quante mai ce ne siano state, è <strong>la</strong> più ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> coprire il suo autore <strong>di</strong> gloria immortale; che <strong>la</strong> medesima impresa,<br />
essendo <strong>la</strong> più utile per i popoli, è anche <strong>la</strong> più onorevole per i sovrani”.<br />
13
getto assurdo”, chiosa con<strong>di</strong>videndo ormai le critiche rivolte all’abate, ormai definito “utopi<br />
sta voltairiano” 58 .<br />
Verso <strong>la</strong> fine del Secolo e al<strong>la</strong> vigilia del<strong>la</strong> presa del<strong>la</strong> Bastiglia i progetti <strong>di</strong> <strong>pace</strong> perpetua<br />
sono annoverati tra i progetti “chimeriques”. Il che sta a testimoniare che, se sul piano delle<br />
idee il progresso dei lumi è stato notevole 59 , sul piano del<strong>la</strong> realtà fattuale siamo ancora fer<br />
mi 60 .<br />
Al contrario del<strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione filosofica (non solo) tedesca, Kant progetta il superamento<br />
del<strong>la</strong> guerra, definita uno scandalo del processo <strong>di</strong> umanizzazione. Per <strong>la</strong> prima volta un progetto<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong> non riguarda i confini europei ma il mondo intero. Se lo stato naturale è <strong>la</strong> guerra,<br />
l’obiettivo da raggiungere resta <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, che è uno stato non naturale, da istituire 61 . E questo<br />
riguarda sia gli in<strong>di</strong>vidui che gli stati. La creazione <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>namento internazionale <strong>di</strong><br />
<strong>pace</strong> è uno dei fini dell’azione pratica, lo scopo ultimo del passaggio dallo stato <strong>di</strong> natura al<strong>la</strong><br />
societas civilis.<br />
Nel progetto filosofico Per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua 62 (1795) sono in<strong>di</strong>viduate le con<strong>di</strong>zioni per<br />
poter realizzare il grande obiettivo: abbattimento del debito pubblico, rego<strong>la</strong>mentazione <strong>di</strong><br />
ogni conflitto, pratica del federalismo, rapporto tra politica e morale.<br />
Sono, queste, le con<strong>di</strong>zioni per una <strong>pace</strong> duratura. L’analisi kantiana, libera da connotazioni<br />
religiose, tocca tre ambiti: quello etico, quello giuri<strong>di</strong>co-politico, quello antropologico.<br />
Le sue riflessioni coniugano <strong>la</strong> prescrittività dell’idea-limite (<strong>pace</strong>) con <strong>la</strong> ricerca delle con<strong>di</strong>zioni<br />
formali e sostanziali (legis<strong>la</strong>tive, statuali, <strong>di</strong> politica internazionale) sulle quali si possono<br />
fondare l’idea e <strong>la</strong> prassi <strong>di</strong> una <strong>pace</strong> perpetua (duratura).<br />
La <strong>pace</strong> può essere costruita solo tra regimi che si associano e che con<strong>di</strong>vidono un impianto<br />
repubblicano 63 : questa è <strong>la</strong> prima con<strong>di</strong>zione positiva su cui Kant fonda il suo progetto.<br />
58<br />
A configurarsi nei piccoli stati come motore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> è il sistema economico, se si fonda sull’agricoltura e<br />
(non sull’industria e sul commercio) e su un’economia primaria (e non <strong>di</strong> bisogni indotti), cfr. J. J. ROUSSEAU,<br />
Progetto <strong>di</strong> costituzione per <strong>la</strong> Corsica (1765) e Considerazioni sul governo <strong>di</strong> Polonia e sul<strong>la</strong> sua progettata<br />
riforma (1770-71).<br />
59<br />
60 Encyclopé<strong>di</strong>e métho<strong>di</strong>que, Paris / Liège, Panckoucke; Plompteux, III, 1788, pp. 702-55.<br />
61 L’attenzione kantiana verso il tema del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, vista come un ideale antico ma attuale nell’Idea <strong>di</strong> una storia<br />
universale dal punto <strong>di</strong> vista cosmopolitico (1784), è già presente nelle Lezioni <strong>di</strong> antropologia (e lo sarà nel<strong>la</strong><br />
sua opera più rilevante, <strong>la</strong> Critica del<strong>la</strong> ragion pura).<br />
62 I. KANT, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Königsberg, Nicolovius, 1795. L’aggettivo ewigen<br />
è un pleonasmo, una sorta <strong>di</strong> forzatura formale che ha il compito <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care una realtà ideale opposta a quel<strong>la</strong><br />
<strong>di</strong> tregua. Il ra<strong>di</strong>calismo linguistico rinvia a quello categoriale e quin<strong>di</strong> al<strong>la</strong> forte normatività che caratterizza il<br />
sistema teorico kantiano.<br />
63 L’idea repubblicana si fonda sul consenso del citta<strong>di</strong>no («Bestimmung der Staatsbürger»), mentre tutte le idee<br />
non repubblicane si basano sull’esistenza <strong>di</strong> un «padrone dello Stato» («Staatseigentümer»).<br />
14
Il repubblicanismo non è una forma imperii ma una forma regiminis: non concerne <strong>la</strong> <strong>di</strong>stinzione<br />
c<strong>la</strong>ssica su chi detenga il potere politico all’interno dello Stato (uno, pochi, molti o tutti),<br />
ma come il potere sia esercitato. Da questo punto <strong>di</strong> vista richiama <strong>la</strong> dottrina del<strong>la</strong> separazione<br />
dei poteri, in posizione antinomica rispetto al <strong>di</strong>spotismo, dove volontà pubblica e<br />
privata coincidono nelle mani dell’autocrate. La preferenza accordata al<strong>la</strong> “federazione dei<br />
popoli” (Völkerbund) rispetto allo “stato dei popoli” (Völkerstaat) indebolisce le prospettive<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong>, ma egli si mostra convinto che l’opera <strong>di</strong> un organismo internazionale e l’opera <strong>di</strong> un<br />
governo repubblicano possano sopperire.<br />
Kant non considera invalicabile l’antitesi tra sovranità statale (in<strong>di</strong>visibile e non ce<strong>di</strong>bile)<br />
e organismo internazionale (da non confondere con autorità sovraor<strong>di</strong>nata anche se repubblicana).<br />
Dopo aver contestato lo jus ad bellum dello stato sovrano, formu<strong>la</strong> il passaggio dal <strong>di</strong>ritto<br />
internazionale interstatuale al <strong>di</strong>ritto cosmopolitico, i cui soggetti sarebbero gli in<strong>di</strong>vidui<br />
tito<strong>la</strong>ri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti. Il filosofo <strong>di</strong> Königsberg considera invece invalicabile <strong>la</strong> <strong>di</strong>stanza tra<br />
l’assolutezza del<strong>la</strong> norma e <strong>la</strong> realtà effettuale. La norma, come criterio <strong>di</strong>rettivo per <strong>la</strong> razionalizzazione<br />
del<strong>la</strong> realtà, mantiene incolmabile il gap tra realtà e idealità. La pax kantiana <strong>di</strong>venta<br />
sia ideale che rego<strong>la</strong>.<br />
Il ragionamento suscitò vasta eco: presso i sostenitori come presso i detrattori. La Friedens<strong>di</strong>skussion<br />
influenzò non solo il <strong>di</strong>battito in ambito tedesco ma coinvolse l’intera cultura<br />
europea.<br />
Analoga al<strong>la</strong> posizione kantiana 64 e <strong>di</strong>versa da quel<strong>la</strong> hegeliana 65 (per <strong>la</strong> quale <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è<br />
solo una limitazione del<strong>la</strong> guerra, una sorta <strong>di</strong> argine a che <strong>la</strong> guerra non degeneri in annien<br />
64 Dal saggio kantiano fiorisce una ricchissima letteratura (saranno più <strong>di</strong> settanta gli autori che prenderanno specifica<br />
posizione): cfr., tra gli altri, il libello filofrancese e rivoluzionario <strong>di</strong> J. GÖRRES, La <strong>pace</strong> universale, un<br />
ideale (1798) e, su posizioni più tra<strong>di</strong>zionali, F. GENTZ, Sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua (1800), a. c. <strong>di</strong> M. P. Paternò, Camerino,<br />
Univ . degli Stu<strong>di</strong>, 1992.<br />
65 Si pensi a ciò che il giovane Hegel scrive nel<strong>la</strong> Costituzione del<strong>la</strong> Germania: «<strong>la</strong> salute <strong>di</strong> uno Stato si manifesta,<br />
in generale, non tanto nel<strong>la</strong> tranquillità del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> quanto nell’agitazione del<strong>la</strong> guerra. La prima è <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione<br />
del go<strong>di</strong>mento e dell’attività nel<strong>la</strong> separatezza <strong>di</strong> ognuno, dove il governo è <strong>la</strong> saggia amministrazione domestica<br />
<strong>di</strong> un capofamiglia, il quale richieda ai sud<strong>di</strong>ti solo qualcosa <strong>di</strong> abituale; nel<strong>la</strong> guerra, invece, si mostra <strong>la</strong><br />
forza dell’associazione <strong>di</strong> tutti con l’intero, si scopre fino a quali richieste quest’associazione possa spingersi<br />
presso i singoli in virtù del<strong>la</strong> sua organizzazione e fino a che punto siano utili le iniziative che essi possono prendere<br />
in suo favore, mossi dal loro impulso e dal loro cuore» (G. W. F. HEGEL, La costituzione del<strong>la</strong> Germania, in<br />
ID., Scritti storici e politici, a c. <strong>di</strong> D. Losurdo, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 10).<br />
15
tamento, <strong>di</strong>struzione totale) è <strong>la</strong> tendenza <strong>di</strong> Fichte 66 a <strong>di</strong>staccarsi dal<strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione sul<strong>la</strong> guerra<br />
giusta e a contribuire al<strong>la</strong> costruzione in positivo <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> <strong>pace</strong> solida e duratura.<br />
66 J. G. FICHTE, Fondamento del <strong>di</strong>ritto naturale secondo i principi del<strong>la</strong> dottrina del<strong>la</strong> scienza (1796-7), a c. <strong>di</strong><br />
L. Fonnesu Bari, Laterza, 1994. Fichte aveva recensito <strong>la</strong> pax kantiana su “Philosophisches Journal” (1796, vol.<br />
IV, pp. 81-82).<br />
16
5. Le analisi ottocentesche: Constant, Tocqueville, Saint-Simon<br />
Nel<strong>la</strong> pubblicistica ottocentesca d’impronta liberale, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> si connette allo sviluppo eco<br />
nomico e scientifico.<br />
Il suo elogio, evidente nelle opere <strong>di</strong> Constant 67 , ma soprattutto ne La libertà degli antichi<br />
e quel<strong>la</strong> dei moderni (1819), conferenza pronunciata all’Ateneo <strong>di</strong> Parigi, è sempre funzionale<br />
all’esaltazione del progresso industriale, commerciale e civile. A <strong>di</strong>fferenza degli antichi, che<br />
intendevano <strong>la</strong> libertà come partecipazione attiva e costante dei citta<strong>di</strong>ni al potere, i moderni<br />
concepiscono <strong>la</strong> libertà come “pacifico go<strong>di</strong>mento dell’in<strong>di</strong>pendenza privata”. La con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong> è il presupposto per il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> quelle libertà civili, <strong>di</strong> cui il commercio resta<br />
l’espressione più emblematica.<br />
Siccome il commercio, al pari e meglio del<strong>la</strong> guerra, è il mezzo per possedere ciò che si<br />
desidera, <strong>la</strong> speranza è quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> raggiungere “un’epoca in cui il commercio sostituisca <strong>la</strong><br />
guerra”. Per Constant quest’epoca è giunta.<br />
Da una <strong>di</strong>versa ango<strong>la</strong>zione si pone l’analisi <strong>di</strong> un altro liberale sui generis: Tocqueville.<br />
Il nuovo or<strong>di</strong>ne post-rivoluzionario alimenta passioni egalitarie verso una pacificazione socia<br />
le che vale per gli in<strong>di</strong>vidui ma anche per gli stati. Nel<strong>la</strong> Democrazia in America 68 (1835<br />
1840) <strong>la</strong> <strong>pace</strong> assume almeno due <strong>di</strong>namiche: da una parte è lo spirito egalitario a estinguere<br />
lo spirito guerriero delle società aristocratiche, in<strong>di</strong>rizzando le democrazie verso <strong>la</strong> <strong>pace</strong>: “Gli<br />
stessi interessi, gli stessi timori, le stesse passioni, che allontanano i popoli democratici dalle<br />
rivoluzioni li allontanano anche dal<strong>la</strong> guerra”; dall’altra a desiderare <strong>la</strong> guerra restano gli e<br />
serciti democratici: <strong>di</strong> tutti gli eserciti, quelli che desiderano più ardentemente <strong>la</strong> guerra sono<br />
quelli democratici. E questo poiché sono attratti dal<strong>la</strong> voglia <strong>di</strong> guadagnare prestigio sociale,<br />
ruolo professionale e vantaggi economici. “L’amore eccessivo <strong>di</strong> tutti i citta<strong>di</strong>ni per <strong>la</strong> tran<br />
quillità – conclude – mette quoti<strong>di</strong>anamente <strong>la</strong> costituzione al<strong>la</strong> mercé dei soldati”.<br />
Il pacifismo <strong>la</strong>ico <strong>di</strong> primo ottocento annoverò in Francia molti pensatori politici e sociali:<br />
da Saint-Simon a Charles Renouvier, fondatore del<strong>la</strong> “Ligue de <strong>la</strong> paix et de <strong>la</strong> liberté” e teo<br />
67<br />
B. CONSTANT, De l'esprit de conquête et de l'usurpation, Paris 1814 e De <strong>la</strong> Liberté des Ancien et des Modernes,<br />
Paris 1819.<br />
68<br />
A. DE TOCQUEVILLE, De <strong>la</strong> démocratie en Amérique, cap. XXII, Pourquoi les peuples démocratiques désirent<br />
naturellement <strong>la</strong> paix, et les armées démocratiques naturellement <strong>la</strong> guerre. Altre “considerazioni sul<strong>la</strong> guerra<br />
nelle società democratiche “ sono nel cap. XXVI.<br />
17
izzatore degli Stati Uniti d’Europa; da Comte a Leroux e Buchez, per i quali <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è stret<br />
tamente connessa al<strong>la</strong> fraternità 69 .<br />
La <strong>pace</strong> è l’approdo <strong>di</strong> ogni utopia egalitaria: dal Viaggio in Icaria (1840) <strong>di</strong> Cabet al<strong>la</strong><br />
Teoria dei quattro movimenti (1808) <strong>di</strong> Fourier <strong>la</strong> società prefigurata non ha bisogno <strong>di</strong> passare<br />
dal<strong>la</strong> guerra al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> perché è già pacificata dai principi che <strong>la</strong> ispirano e <strong>la</strong> organizzano.<br />
La <strong>pace</strong> sansimoniana in partico<strong>la</strong>re è fondata sul<strong>la</strong> cooperazione sociale inscritta nel<strong>la</strong><br />
fratel<strong>la</strong>nza universale tra gli uomini. Ne La riorganizzazione del<strong>la</strong> società europea (1814) 70 ,<br />
scritta a quattro mani col suo giovane segretario Augustin Thierry, con l’ambizione <strong>di</strong> influenzare<br />
i principi riuniti nel congresso <strong>di</strong> Vienna, viene delineata una realtà politica <strong>di</strong><br />
stampo industriale e tecnocratico, ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> comportare una nuova era <strong>di</strong> <strong>pace</strong>, espressione <strong>di</strong><br />
un or<strong>di</strong>ne mon<strong>di</strong>ale soggetto a una legge comune. Questo “nuovo Cristianesimo” del progresso<br />
ha il compito <strong>di</strong> rigenerare l’umanità e in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> società europea. Soltanto con lo<br />
sviluppo del patriottismo europeo si potranno superare gli egoismi nazionali ed affermare <strong>la</strong><br />
federazione europea 71 , a partire dall’alleanza tra Francia e Inghilterra.<br />
E’ negli anni a cavallo del ’48 che l’aspirazione al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> da fatto intellettuale tende a trasformarsi<br />
in movimento <strong>di</strong> opinione e a incontrarsi con il messianismo umanitario dei gran<strong>di</strong><br />
romantici come Quinet e Hugo 72 .<br />
Chi, in quegli stessi anni, non si pose in alcun modo dall parte del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> fu Proudhon,<br />
che, nel suo voluminoso trattato intito<strong>la</strong>to La Guerre et <strong>la</strong> Paix (1861), ha esaltato <strong>la</strong> guerra<br />
come mezzo necessario, pur se brutale, per promuovere <strong>la</strong> giustizia 73 .<br />
Il tema del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> assume una partico<strong>la</strong>re critica nel pensiero <strong>di</strong> Marx a partire dal<strong>la</strong> guerra<br />
franco-prussiana (1870), anche se alcune basi erano state poste in occasione del<strong>la</strong> nascita<br />
del<strong>la</strong> prima Associazione internazionale degli operai (1864)..<br />
In contrapposizione a molti esponenti del<strong>la</strong> sinistra europea, il filosofo tedesco mostrandosi<br />
convinto che sta “per sorgere una società nuova, <strong>la</strong> cui legge internazionale sarà <strong>la</strong> <strong>pace</strong>,<br />
69 M. LARIZZA, Il pacifismo <strong>la</strong>ico nel<strong>la</strong> Francia ottocentesca (a. a. 1996-7) in M. GEUNA (a c. <strong>di</strong>), A. Comte e <strong>la</strong><br />
cultura francese dell’Ottocento, Mi<strong>la</strong>no, Cisalpino, 2004, pp. 191-3.<br />
70 De <strong>la</strong> réorganisation de <strong>la</strong> société européenne, Paris 1814.<br />
71 Seguace dell’impostazione saintsimoniana è Constantin PECQUEUR, De <strong>la</strong> paix (1842).<br />
72 Si veda il suo intervento al III congresso degli “Amici del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>” (Parigi 1849).<br />
73 P. J. PROUDHON, La guerra e <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, Lanciano, Carabba, 1920.<br />
18
perché <strong>la</strong> sua legge nazionale sarà dappertutto <strong>la</strong> stessa, il <strong>la</strong>voro” 74 , non ritiene <strong>di</strong> rinunciare ad<br />
una visione violenta del<strong>la</strong> rivoluzione anticapitalistica 75 .<br />
Già prima dell’esperienza fallita del<strong>la</strong> Comune <strong>di</strong> Parigi (1871), in Italia <strong>la</strong> subor<strong>di</strong>nazione te<br />
leologica del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> al<strong>la</strong> rivoluzione proletaria era stata criticata mentre posizioni contrarie in<br />
modo assoluto al<strong>la</strong> guerra avevano cominciato a farsi strada: “Non più guerre né per falsa glo<br />
ria, né per interessi falsi, ma <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e lo sviluppo interno del<strong>la</strong> libertà e prosperità pubblica<br />
per <strong>la</strong> realizzazione del benessere del popolo” 76 . Mentre <strong>la</strong> seconda Internazionale semplifica<br />
va il <strong>di</strong>battito sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong> riconnettendo sempre e comunque le cause del<strong>la</strong> guerra alle necessità<br />
del capitalismo e alle rivalità tra potenze capitalistiche, Enrico Bignami e Andrea Costa con<br />
netteranno socialismo e internazionalismo in una prospettiva pacifista 77 . L’ansia <strong>di</strong> <strong>pace</strong> sarà<br />
più evidente al<strong>la</strong> vigilia del primo conflitto, allorché <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> d’or<strong>di</strong>ne socialista sarà «guerra<br />
al<strong>la</strong> guerra».<br />
Il bisogno <strong>di</strong> <strong>pace</strong> sarà ancora più evidente dopo il conflitto, quando l’istanza socialista <strong>di</strong>viene<br />
progressivamente federalista, mentre l’a-priori del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong>venta il definitivo superamento<br />
del<strong>la</strong> <strong>di</strong>alettica vincitori/vinti.<br />
Anche Lenin affronterà il tema del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> cominciando a <strong>di</strong>stinguere <strong>la</strong> condanna socialista<br />
del<strong>la</strong> guerra tra popoli dal pacifismo dei borghesi o degli anarchici. «Dai primi ci <strong>di</strong>stinguiamo<br />
– <strong>di</strong>ce in Il socialismo e <strong>la</strong> guerra - in quanto compren<strong>di</strong>amo l’inevitabile legame delle<br />
guerre con <strong>la</strong> lotta delle c<strong>la</strong>ssi nell’interno <strong>di</strong> ogni paese» 78 .<br />
Pur riconoscendo che lo stato d’animo delle masse a favore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> esprime “un principio<br />
<strong>di</strong> protesta, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>gnazione e <strong>di</strong> coscienza del carattere reazionario del<strong>la</strong> guerra”, Lenin<br />
teorizza <strong>la</strong> necessità del<strong>la</strong> guerra civile contro i governi e contro <strong>la</strong> borghesia al fine <strong>di</strong> ottenere<br />
una <strong>pace</strong> “democratica e duratura” 79 .<br />
74 C. MARX, L’Associazione internazionale degli operai sul<strong>la</strong> guerra franco-prussiana, in ID., La guerra civile in<br />
Francia, a c. <strong>di</strong> P. Togliatti, Roma, E<strong>di</strong>tori Riuniti, 1974 2 , p. 31.<br />
75 Cfr. L. RUSSI, Garibal<strong>di</strong> e le idee del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>,<br />
76 “Libertà e giustizia”, Programma, 1867, articolo 11. Cfr. LE MONNIER, La paix perpétuelle, Paris 1867.<br />
77 Fondata nel 1907, <strong>la</strong> rivista «Coenobium» sban<strong>di</strong>erava l’istanza socialista verso <strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
78 «Compren<strong>di</strong>amo l’impossibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>struggere le guerre senza <strong>di</strong>struggere le c<strong>la</strong>ssi ed e<strong>di</strong>ficare il socialismo,<br />
come pure in quanto riconosciamo pienamente <strong>la</strong> legittimità, il carattere progressivo e <strong>la</strong> necessità delle guerre<br />
civili, cioè delle guerre del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse oppressa contro quel<strong>la</strong> che opprime, degli schiavi contro i padroni <strong>di</strong> schiavi,<br />
dei servi del<strong>la</strong> gleba contro i proprietari fon<strong>di</strong>ari, degli operai sa<strong>la</strong>riati contro <strong>la</strong> borghesia. E dai pacifisti e dagli<br />
anarchici noi marxisti ci <strong>di</strong>stinguiamo in quanto riconosciamo <strong>la</strong> necessità dell’esame storico (dal punto <strong>di</strong> vista<br />
del materialismo <strong>di</strong>alettico <strong>di</strong> Marx) <strong>di</strong> ogni singo<strong>la</strong> guerra. Nel<strong>la</strong> storia sono più volte avvenute guerre che, nonostante<br />
tutti gli orrori, le brutalità, le miserie e i tormenti inevitabilmente connessi con ogni guerra, sono state<br />
progressive; che, cioè, sono state utili all’evoluzione dell’umanità.»<br />
79 V. I. LENIN, Il socialismo e <strong>la</strong> guerra, Roma, E<strong>di</strong>tori Riuniti, 1975, p. 13. Su questa linea si collocheranno i<br />
pensatori comunisti dei paesi occidentali. Cfr. per tutti J. P. SARTRE, Les communistes et <strong>la</strong> paix, una serie <strong>di</strong> articoli<br />
apparsi tra il ’52 e il ’54 su «Temps modernes».<br />
19
6. Al tempo delle guerre mon<strong>di</strong>ali: Freud, Benedetto XV, de Coubertin<br />
Il ventesimo secolo si apre con l’istituzione <strong>di</strong> un premio mon<strong>di</strong>ale de<strong>di</strong>cato al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> 80 .<br />
E’ l’iniziativa <strong>di</strong> un fabbricante d’armi svedese, Alfred Nobel, che durerà fino ai giorni<br />
nostri ma che non impe<strong>di</strong>rà ciò che qualche anno prima un altro uomo d’affari, il po<strong>la</strong>cco Jean<br />
de Bloch 81 , aveva profetizzato: lunghissimi anni <strong>di</strong> guerra e molti milioni <strong>di</strong> morti.<br />
Non sono pochi gli intellettuali che considerano l’imminente primo conflitto mon<strong>di</strong>ale<br />
come un fatto positivo. Oswald Spengler 82 arriva ad<strong>di</strong>rittura a teorizzare che <strong>la</strong> storia umana –<br />
soprattutto in un periodo <strong>di</strong> c.d. alta civiltà – altro non è che <strong>la</strong> storia delle potenze politiche<br />
attraverso <strong>la</strong> guerra e che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è parte integrante <strong>di</strong> ogni conflitto, una sorta <strong>di</strong> (proudhonia<br />
na) “prosecuzione del<strong>la</strong> guerra con altri mezzi”; Max Weber si entusiasma per <strong>la</strong> prima guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale “veramente grande e meravigliosa al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ogni aspettativa” 83<br />
Diversa <strong>la</strong> posizione <strong>di</strong> Sigmund Freud (1856-1938). Insieme al<strong>la</strong> condanna del<strong>la</strong> guerra<br />
Freud <strong>di</strong>stingue due morali ai tempi <strong>di</strong> <strong>pace</strong>: una è quel<strong>la</strong> fondata sul dominio degli impulsi<br />
erotici sopra quelli aggressivi sottostanti; l’altra si fonda sul timore del<strong>la</strong> punizione e del<strong>la</strong> <strong>di</strong><br />
sapprovazione da parte del<strong>la</strong> comunità. Freud considera quest’ultima morale artificiosa e ipo<br />
crita.<br />
Nell’aprile del 1915 scrive le Considerazioni attuali sul<strong>la</strong> guerra e <strong>la</strong> morte 84 , uno dei<br />
suoi rari scritti metapsicologici.<br />
La contrad<strong>di</strong>zione tra i doveri pacifici dell’in<strong>di</strong>viduo come singolo e i suoi doveri bellici<br />
come citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong>venta drammatica per <strong>la</strong> coscienza in<strong>di</strong>viduale ma lo può <strong>di</strong>ventare anche per<br />
i popoli. La riflessione sull’istinto <strong>di</strong> morte lo porta a sostenere che <strong>la</strong> guerra non può essere<br />
facilmente debel<strong>la</strong>ta ma anche a combatter<strong>la</strong> con tutte le forze 85 .<br />
80 Tra i primi ad essere insigniti del premio fu il mi<strong>la</strong>nese Ernesto Teodoro Moneta (1833-1918), scelto nel 1907<br />
per <strong>la</strong> convinzione che <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, come <strong>la</strong> solidarietà, fosse il risultato dell’evoluzione civili <strong>di</strong> tutti i popoli. Si veda<br />
a tal proposito <strong>la</strong> conferenza Pace e <strong>di</strong>ritto nel<strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione italiana (25 agosto 1909), Mi<strong>la</strong>no 1909.<br />
81 J. DE BLOCH, La guerre, sei voll. tradotti dal po<strong>la</strong>cco in francese, del 1898.<br />
82 O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente (1918-1922)<br />
83 M. WEBER , M. Weber. Ein Lebensbild, Tubingen, Mohr, 1926, p. 536.<br />
84 S. FREUD, Considerazioni attuali sul<strong>la</strong> guerra e <strong>la</strong> morte, a.c. <strong>di</strong> M. Spinel<strong>la</strong>, Roma, Ed. Riuniti, 1982.<br />
85 Erich Fromm (1900-1980), sul<strong>la</strong> sua scia, ra<strong>di</strong>ca <strong>la</strong> guerra al<strong>la</strong> necrofilia, a un’aggressività <strong>di</strong>venuta maligna;<br />
mentre l’amore per <strong>la</strong> vita conduce allo spirito <strong>di</strong> <strong>pace</strong>, cfr. E. FROMM, Anatomia del<strong>la</strong> <strong>di</strong>struttività umana<br />
(1973), Mi<strong>la</strong>no, Mondadori, 1989.<br />
20
Nel 1932 lo scambio <strong>di</strong> lettere con Einstein (1879-1955) sul «perché del<strong>la</strong> guerra» 86 resta<br />
certamente un momento emblematico. Al<strong>la</strong> domanda del teorico del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tività sul<strong>la</strong> possibi<br />
lità <strong>di</strong> «liberare gli uomini dal<strong>la</strong> fatalità del<strong>la</strong> guerra», il fondatore del<strong>la</strong> psicanalisi risponde<br />
con un’analisi delle pulsioni <strong>di</strong> morte 87 . Così come aveva fatto allo scoppio del primo grande<br />
conflitto mon<strong>di</strong>ale, in Freud rimane un’antinomia: da una parte il riconoscimento del<strong>la</strong> insopprimibilità<br />
delle tendenze aggressive degli uomini; dall’altra l’invito all’in<strong>di</strong>gnazione perché<br />
«ogni uomo ha <strong>di</strong>ritto al<strong>la</strong> propria vita» 88 .Einstein, che rimane convinto che <strong>la</strong> guerra «non si<br />
può umanizzare, si può solo abolire», continuerà anche dopo <strong>la</strong> fine del<strong>la</strong> seconda guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale a manifestare per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> 89 .<br />
Durante un pontificato breve ma intenso (1914-1922) Benedetto XV definisce <strong>la</strong> guerra<br />
una “inutile strage” e <strong>la</strong> <strong>pace</strong> cristiana “giusta e duratura” 90 .<br />
Nel<strong>la</strong> Nota <strong>di</strong> <strong>pace</strong> (1° agosto 1917) 91 ai capi delle nazioni belligeranti il papa Giacomo<br />
Del<strong>la</strong> Chiesa riprende alcune considerazioni teoriche fatte da Leone XIII nel 1899 al<strong>la</strong> prima<br />
conferenza dell’Aja per il <strong>di</strong>sarmo, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> messa al bando delle armi chimiche. L’appello<br />
papale, se riesce a superare il tra<strong>di</strong>zionale concetto <strong>di</strong> “guerra giusta”, rimane un tentativo fallito<br />
ma generoso <strong>di</strong> porre fine al conflitto in favore <strong>di</strong> una <strong>pace</strong> fondata sul<strong>la</strong> giustizia 92 .<br />
Il pensiero del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, senza <strong>di</strong>lungarsi sul<strong>la</strong> guerra, definita “inumana” 93 , sarà ben presente<br />
nell’enciclica Pacem in terris (11 aprile 1963). Con essa verrà completamente abbandonata<br />
<strong>la</strong> teoria del<strong>la</strong> guerra “giusta”, per lungo tempo contemp<strong>la</strong>ta dal<strong>la</strong> teologia cattolica. Nel<br />
86 S. FREUD, Perché <strong>la</strong> guerra ? (1932), in Carteggio con Einstein ed altri scritti, Torino, Boringhieri, 1975, pp.<br />
15-23.<br />
87 La riflessione psicanalitica sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong> invita a «riconoscere» prima <strong>di</strong> tutto <strong>la</strong> morte, a smascherare «i nostri<br />
alienati desideri <strong>di</strong> morte». (F. FORNARI, Psicanalisi del<strong>la</strong> guerra atomica, Mi<strong>la</strong>no, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità, 1964).<br />
88 Riflessioni a due sulle sorti del mondo, pref. <strong>di</strong> E. Balducci, Torino, Bol<strong>la</strong>ti Boringhieri, 1989.<br />
Il filosofo e matematico inglese Whitehead definisce nel 1933 <strong>la</strong> <strong>pace</strong> «armonia che p<strong>la</strong>ca <strong>la</strong> turbolenza <strong>di</strong>struttiva<br />
e completa <strong>la</strong> civiltà» (A. NORTH WHITEHEAD, Adventures of Ideas, tr. it. <strong>di</strong> G. Guoli, Mi<strong>la</strong>no 1961).<br />
89 Nel 1955, insieme ad altri sette scienziati, il teorico del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tività firma il manifesto pacifista Parliamo come<br />
membri del<strong>la</strong> razza umana, pubblicato postumo da B. Russell, dove si incita l’umanità «a rinunciare al<strong>la</strong> guerra»<br />
(cfr. F. FORNARI e AA. VV., Dissacrazione del<strong>la</strong> guerra. Dal pacifismo al<strong>la</strong> società dei conflitti, Mi<strong>la</strong>no, Feltrinelli,<br />
1969). «Fin da quando, il 6 agosto 1945, una bomba fu sganciata su Hiroshima, io – scrive Russell il 12<br />
settembre 1961 – sono stato profondamente turbato al pensiero dell’incombente pericolo <strong>di</strong> una guerra nucleare.<br />
[...] Ho manifestato i miei timori in un <strong>di</strong>scorso al<strong>la</strong> Camera dei Lord tre mesi dopo il bombardamento» (B. RUS<br />
SELL, L’autobiografia, tr. it. <strong>di</strong> . P. Dettore Ricci, Mi<strong>la</strong>no, Longanesi, 1969-70, vol. III, pp. 251-2).<br />
90 Cfr. G. RUMI (a c. <strong>di</strong>), Benedetto XV e <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, Brescia, Morcelliana, 1990.<br />
91 «Civiltà cattolica», 1 sett. 1917.<br />
92 Cfr. anche SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI BENEDICTI PAPAE XV, Episto<strong>la</strong> Enciclica De Pacis Reconciliatione<br />
Christiana, 19 giugno 1920.<br />
93 L’aggettivo è usato nell’ultimo capitolo, intito<strong>la</strong>to La promozione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e del<strong>la</strong> comunità dei popoli, del<strong>la</strong><br />
costituzione pastorale Gau<strong>di</strong>um et spes (7 <strong>di</strong>c. 1965). Mai più <strong>la</strong> guerra è il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Paolo VI all’Assemblea<br />
del<strong>la</strong> N. V. (4 ottobre 1965). Lo sviluppo è il nuovo nome del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> è il titolo <strong>di</strong> un capitolo del<strong>la</strong> lettera enciclica<br />
Populorum progressio (26 marzo 1967).<br />
21
cuore del<strong>la</strong> “guerra fredda”, con le ferite del conflitto mon<strong>di</strong>ale ancora aperte, <strong>la</strong> Chiesa non<br />
bene<strong>di</strong>ce più le armi 94 ma invita esplicitamente a deporle, per una <strong>pace</strong> sostanziata dai <strong>di</strong>ritti<br />
umani.<br />
Giovanni Paolo II, nel messaggio natalizio del 1990, condanna <strong>la</strong> guerra come “avventura<br />
senza ritorno”.<br />
Prima <strong>di</strong> impegnarsi in politica Woodrow Wilson aveva insegnato scienza politica e storia<br />
all’università <strong>di</strong> Princeton, <strong>di</strong> cui era <strong>di</strong>venuto presidente. Da governatore del New Jersey e<br />
presidente degli Stati Uniti, si propone guida <strong>di</strong> <strong>pace</strong> e <strong>di</strong> democrazia per il mondo intero, nonostante<br />
l’entrata in guerra (aprile 1917) 95 . L’ambizioso piano wilsoniano <strong>di</strong> <strong>pace</strong> (8 gennaio<br />
1918) non risolverà in alcun modo gli antagonismi tra vincitori e vinti, tra chi voleva <strong>la</strong> vittoria<br />
dopo <strong>la</strong> guerra e chi propugnava <strong>la</strong> <strong>pace</strong> senza vittoria.<br />
La <strong>pace</strong> americana, che fino al<strong>la</strong> prima guerra mon<strong>di</strong>ale era stata un esempio, appare inesportabile<br />
in Europa. L’autodeterminazione, il governo democratico, <strong>la</strong> sicurezza collettiva, il<br />
<strong>di</strong>ritto internazionale, <strong>la</strong> lega delle nazioni e <strong>la</strong> strategia <strong>di</strong>plomatica rimangono obiettivi da<br />
perseguire ma al momento irrealizzabili.<br />
La conferenza <strong>di</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong> Parigi 96 , al<strong>la</strong> cui conclusione verrà stipu<strong>la</strong>to il trattato <strong>di</strong> Versailles,<br />
invece <strong>di</strong> convincere gli stati del<strong>la</strong> necessità <strong>di</strong> convivere ai fini dello sviluppo commerciale<br />
e del mantenimento del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, genera ancora una volta l’idea del<strong>la</strong> inevitabilità del<strong>la</strong><br />
guerra in quanto conseguenza <strong>di</strong> una immutabile tendenza più portata all’aggressione che al<strong>la</strong><br />
tranquillità 97 .<br />
La guerra che avrebbe dovuto mettere fine ad ogni guerra, nonostante l’immane per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
uomini morti, muti<strong>la</strong>ti e feriti, dà luogo ad una <strong>pace</strong> debole che produrrà vent’anni dopo<br />
un’altra guerra. 98<br />
94<br />
Giovanni XXIII, Pacem in terris. Con <strong>la</strong> Redemptor Hominis (1979) <strong>di</strong> Giovanni Paolo II <strong>la</strong> <strong>pace</strong> sociale e internazionale<br />
si identifica col «rispetto dei <strong>di</strong>ritti invio<strong>la</strong>bili dell’uomo, mentre <strong>la</strong> guerra nasce dal<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione <strong>di</strong><br />
questi...»<br />
95<br />
“E’ una cosa terribile gettare in guerra questo grande e pacifico popolo, nel<strong>la</strong> più terribile e <strong>di</strong>sastrosa <strong>di</strong> tutte<br />
le guerre, che sembra mettere in gioco <strong>la</strong> stessa civiltà. Ma il <strong>di</strong>ritto è più prezioso del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>; e noi dobbiamo<br />
combattere per le cose che abbiamo sempre tanto amato, per <strong>la</strong> democrazia, per il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> coloro che accettano<br />
l’autorità delle forme rappresentative, per i <strong>di</strong>ritti e <strong>la</strong> libertà delle piccole nazioni, per <strong>la</strong> sovranità universale<br />
del<strong>la</strong> giustizia esercitata attraverso un’unione <strong>di</strong> popoli liberi, che arrechi <strong>pace</strong> e sicurezza a tutte le nazioni e <strong>di</strong>a<br />
alfine libertà a tutto il mondo [...]. Con l’aiuto <strong>di</strong> Dio, l’America non può fare che questo” (The Public Papers of<br />
W. Wilson, a c. d. R. S. Baker e W.E. Dodd, voll. 6, New York, 1925-1927).<br />
96<br />
A. WALWORTH, Wilson and his Peacemakers: American Diplomacy at the Paris Peace Conference, 1919,<br />
New York, 1986.<br />
97<br />
G. MOSCA, Elementi <strong>di</strong> scienza politica, cap. VI.<br />
98<br />
Secondo il filosofo inglese progressista L. T. Hobhouse (1864-1929), messo in crisi dal conflitto, non ci sarebbe<br />
stata “alcuna <strong>pace</strong> duratura in Europa fino a quando <strong>la</strong> nazionalità e <strong>la</strong> libertà non fossero riconciliate” (Que<br />
22
Chi, nel ventennio tra le due guerre, de<strong>di</strong>ca al concetto <strong>di</strong> <strong>pace</strong> un’attenzione analitica è<br />
Max Scheler. In una conferenza del 1927, pubblicata postuma, critica sia l’approccio liberista<br />
proprio del liberalismo sia l’ango<strong>la</strong>zione imperialista o superficialmente internazionalista, sia<br />
il “semipacifismo” cristiano che quello comunista. Per Scheler <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è in primo luogo un<br />
concetto ontologico, cioè un «valore assolutamente positivo» 99 .<br />
C’è chi, nell’Italia fascista fonda un’idea impolitica <strong>di</strong> <strong>pace</strong> su una lunga serie <strong>di</strong> “non”:<br />
non col<strong>la</strong>borazione, non violenza, non uccisione, non menzogna. I “non” per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> non equivalgono<br />
a rassegnazione ma ambiscono ad essere passaggi operativi e positivi, perfino lotta.<br />
In questo <strong>la</strong> lettura capitiniana del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, influenzata dall’esperienza <strong>di</strong> Gandhi, più che<br />
utopistica può <strong>di</strong>rsi profetica se è vero che il primo guarda al futuro ideale mentre il secondo<br />
opera hic et nunc 100 .<br />
A metà degli anni trenta del secolo XX, il barone de Coubertin, artefice al<strong>la</strong> fine del secolo<br />
precedente del<strong>la</strong> ripresa delle moderne olimpia<strong>di</strong>, invia a una rivista belga un breve articolo<br />
dal titolo esemplificativo: Lo sport è un facitore <strong>di</strong> <strong>pace</strong>. 101<br />
L’ormai anziano barone si sofferma sul<strong>la</strong> protezione agli atleti data dalle “nazioni bellicose”<br />
(fra tutte, <strong>la</strong> Germania hitleriana) e dal Comintern (guidato dall’URSS staliniana). Una<br />
protezione strumentale ma non per questo destinata a soggiogare l’atleta che invece, al contrario<br />
degli altri, rispettoso com’è <strong>di</strong> regole e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina per se stesso, non “accetta <strong>di</strong> buon<br />
grado <strong>di</strong> subire un <strong>la</strong>vaggio del cervello”. «Dal momento che sono in<strong>di</strong>vidualisti – aggiunge –<br />
gli atleti tendono ad essere interessati a riconoscere il valore delle prestazioni dei loro rivali.<br />
Quando essi sono avversari politici o sociali, persino se si trovano nelle retroguar<strong>di</strong>e, nelle<br />
barricate o nelle trincee, li si vedrà sempre prestare attenzione non soltanto ai record che sono<br />
stions of War and Peace, London, Unwin, 1916, p. 191). Subito dopo <strong>la</strong> fine del conflitto, John Maynard Keynes<br />
<strong>di</strong>mostra ne le conseguenze economiche del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> (1919),Mi<strong>la</strong>no, Adelphi, 2007, che c’erano già tutte le premesse<br />
<strong>di</strong> una guerra futura.<br />
99<br />
Cfr. M. SCHELER, Die Idee des Friedens und der Pazifismus, Berlin, Neue Geist, 1931, tr. parz. <strong>di</strong> L. Bonanate,<br />
Mi<strong>la</strong>no 1972.<br />
100<br />
A. CAPITINI, Elementi <strong>di</strong> un’esperienza religiosa, Bari, Laterza, 1937. Cfr. N. BOBBIO, Religione e politica in<br />
A. Capitini, in ID., Maestri e compagni, Firenze, Passigli, 1984, pp. 260-99.<br />
101<br />
P. DE COUBERTIN, Le sport est pacificateur [Sport is a peacemaker], in “La Revue sportive illustrée”, XXXI,<br />
1935, p. 44. La bibliografia completa è <strong>di</strong> DE COUBERTIN (1863-1937) è in Olympism. Selected writings, Lausanne,<br />
C.I.O., 2000.<br />
23
stati battuti, ma anche ai tentativi infruttuosi <strong>di</strong> batterli, a con<strong>di</strong>zione che quei tentativi siano<br />
stati compiuti con coraggio, fino all’estremo limite delle proprie possibilità […]» 102<br />
Coubertin sapeva bene che Plutarco 103 , Tuci<strong>di</strong>de 104 , Pausania 105 e Senofonte 106 avevano<br />
utilizzato il termine ekecheirìa, e non eirene. L’ekecheirìa (letteralmente, momento in cui ci si<br />
astiene dall’usare le mani) è un istituto <strong>di</strong> portata più limitata e circoscritta a finalità eminen<br />
temente pratiche: contemp<strong>la</strong> una situazione <strong>di</strong> invio<strong>la</strong>bilità riconosciuta a persone e merci in<br />
caso <strong>di</strong> passaggio attraverso un territorio; in qualche maniera assimi<strong>la</strong>bile a quel<strong>la</strong> che oggi<br />
dovrebbe essere garantita alle associazioni umanitarie impegnate nell’aiuto a popo<strong>la</strong>zioni <strong>di</strong><br />
un territorio <strong>di</strong> guerra. Il barone è stato uno scienziato del<strong>la</strong> formazione 107 , che ha proposto<br />
l’olimpismo come modello <strong>di</strong> educazione a favore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, intesa non come l’antica eke<br />
cheirìa, armistizio <strong>di</strong> breve durata, ma in senso positivo, come alto momento <strong>di</strong> socialità e <strong>di</strong><br />
confronto.<br />
E’ anche per queste ragioni che nel 1937, al<strong>la</strong> vigilia del<strong>la</strong> morte, è tra i papabili per il<br />
Nober per <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, al<strong>la</strong> fine assegnato all’aristocratico inglese Gascoyne Cecil 108 .<br />
102<br />
Questa analisi, realistica e moderata, è presente anche nell’altro articolo de<strong>di</strong>cato al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, o meglio tregua,<br />
olimpica. P. DE COUBERTIN, Pax olimpica, in “Pro Sport”, 5 agosto 1935, p. 1.<br />
103<br />
PLUTARCO, Licurgo, 1, 2.<br />
104<br />
TUCIDIDE, La guerra del Peloponneso, IV, 58, 1; 117, 3; 119, 3; V, 15, 2: i passi par<strong>la</strong>no <strong>di</strong> “armistizi <strong>di</strong> breve<br />
durata”.<br />
105<br />
PAUSANIA, Periegesi dell’El<strong>la</strong>de, V, 2.<br />
106<br />
SENOFONTE, Anabasi, VII, 4, 28-32.<br />
107<br />
Cfr. F. CAMBI, Una pedagogia sportiva per <strong>la</strong> società <strong>di</strong> massa, introduzione a P. DE COUBERTIN, Memorie<br />
olimpiche, a c. <strong>di</strong> Rosel<strong>la</strong> Frasca; traduzione <strong>di</strong> Maria Luisa Frasca, Mi<strong>la</strong>no, Mondadori, 2003, p. XXXV.<br />
108<br />
Di E. A. R. Gascoyne Cecil, presidente del<strong>la</strong> Società delle Nazioni dal 1923 e futuro presidente onorario<br />
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, si veda The Way of Peace, London, Allen, 1928.<br />
24
7. Kelsen, Aron, Bobbio, Cotta, Bonanate<br />
Dopo due guerre mon<strong>di</strong>ali e devastanti, concluse con lo scoppio del<strong>la</strong> bomba atomica (a<br />
gosto 1945), conseguire <strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong>venta un’impresa ancora più ardua e certamente eroica 109 .<br />
Nel saggio La <strong>pace</strong> attraverso il <strong>di</strong>ritto (1944) 110 Kelsen teorizza, prima del<strong>la</strong> fondazione<br />
delle Nazioni Unite (1945), un or<strong>di</strong>namento internazionale model<strong>la</strong>to come uno stato in gran<br />
de (civitas maxima).<br />
Mutuato da Kant l’ideale del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua, fino a quel momento non raramente critica<br />
to perché giu<strong>di</strong>cato astratto, Kelsen <strong>di</strong>segna una strategia giuri<strong>di</strong>co-istituzionale per il mante<br />
nimento <strong>di</strong> una <strong>pace</strong> stabile e universale tra le nazioni. Il primo passaggio è costituito<br />
dall’unione lenta e progressiva <strong>di</strong> tutti gli stati in un grande stato federale mon<strong>di</strong>ale ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong><br />
limitare le singole sovranità statali 111 . L’applicazione delle norme è affidata a una Corte, da<br />
vanti a cui gli stati siano posti in regime <strong>di</strong> eguaglianza giuri<strong>di</strong>ca. La Corte è istituita me<strong>di</strong>ante<br />
un trattato internazionale con cui gli aderenti accettano <strong>la</strong> sua giuris<strong>di</strong>zione e si sottomettono<br />
alle decisioni dei giu<strong>di</strong>ci, anche se sfavorevoli. L’esistenza <strong>di</strong> regole internazionali e <strong>la</strong> prefi<br />
gurazione <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>ce autorizzato ad applicarle non possono garantire naturalmente <strong>la</strong> ri<br />
nuncia <strong>di</strong> ogni stato all’uso del<strong>la</strong> guerra, ma permettono <strong>di</strong> in<strong>di</strong>carne l’«illegittimità», cui <strong>la</strong><br />
comunità internazionale può rispondere con un uso legittimo del<strong>la</strong> forza. Non è pensabile in<br />
fatti una società organizzata in cui si realizzi l’idea (anarchica) dell’assoluta assenza del<strong>la</strong> for<br />
za. «Per garantire <strong>la</strong> <strong>pace</strong> – sostiene Kelsen – l’or<strong>di</strong>namento sociale non esclude tutti i tipi <strong>di</strong><br />
atti coercitivi; esso autorizza certi in<strong>di</strong>vidui a compiere tali atti in talune con<strong>di</strong>zioni. L’utilizzo<br />
del<strong>la</strong> forza, in generale proibito in quanto delitto, è eccezionalmente permesso come reazione<br />
contro il delitto, cioè come sanzione» 112 .<br />
Il ragionamento kelseniano, poggiando su una prospettiva giuri<strong>di</strong>ca cosmopolitica e sul<strong>la</strong><br />
capacità <strong>di</strong> costruire organismi terzi e internazionali deputati a risolvere i conflitti e le contese,<br />
inficia il principio del<strong>la</strong> “sovranità illimitata” degli stati.<br />
L’impianto kelseniano contiene il merito storico <strong>di</strong> aver internazionalizzato il tema del<strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong> e <strong>di</strong> avergli dato sostanza normativa e giu<strong>di</strong>ziaria 113 .<br />
109<br />
E. REVES, The anatomy of peace, New York, Harper and bros. 1945, tr. it. <strong>di</strong> I. Rossi Doria, Firenze, E<strong>di</strong>zioni<br />
Unite, 1946.<br />
110<br />
H. KELSEN, Peace through Law, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1944, tr. it. <strong>di</strong> L. Ciaurro,<br />
Torino, Giappichelli, 1990. In appen<strong>di</strong>ce pubblica il progetto <strong>di</strong> una “Lega permanente per il mantenimento<br />
del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>” ispirata al modello del Covenant del<strong>la</strong> Società delle Nazioni.<br />
111<br />
H. KELSEN, Peace through Law cit., pp. 3-9.<br />
112<br />
Ivi, p. 41.<br />
113<br />
D. ZOLO, La guerra, il <strong>di</strong>ritto e <strong>la</strong> <strong>pace</strong> in H. Kelsen, in “Filosofia politica”, a. XII (1998), n. 2, p. 208.<br />
25
Quando Aron scrive Pace e guerra tra le nazioni (1960-1) 114 siamo nel<strong>la</strong> stagione del<strong>la</strong><br />
c.d. “guerra fredda” che, nonostante l’imminente crisi <strong>di</strong> Cuba (ottobre-novembre 1962), si va<br />
trasformando in coesistenza pacifica. L’equilibrio mon<strong>di</strong>ale si regge ormai su due blocchi<br />
contrapposti. Contrariamente alle previsioni schmittiane 115 , in seguito al crollo dello ius pu<br />
blicum europaeum, si è fatto strada, per quanto <strong>di</strong>scutibile, un equilibrio precario sospeso tra<br />
guerra e <strong>pace</strong>. La minaccia nucleare nel<strong>la</strong> stagione del<strong>la</strong> guerra fredda dà al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> un valore<br />
praticamente assoluto, anche se basato sull’equilibrio del terrore. Il deterrente atomico, cioè<br />
una catastrofe generale dell’umanità senza né vinti né vincitori, genera l’idea <strong>di</strong> una “via<br />
bloccata” al<strong>la</strong> guerra. Se <strong>la</strong> <strong>pace</strong> appare impossibile, <strong>la</strong> guerra appare improbabile. Attraverso<br />
le pagine tuci<strong>di</strong>dee 116 sul<strong>la</strong> guerra del Peloponneso tra Sparta ed Atene 117 , Aron e<strong>la</strong>bora una<br />
teoria ragionevole dell’equilibrio bipo<strong>la</strong>re destinata a soppiantare <strong>la</strong> politica <strong>di</strong> potenza.<br />
In quello che può considerarsi un libro <strong>di</strong> teoria delle re<strong>la</strong>zioni internazionali si trovano<br />
una forte demistificazione del<strong>la</strong> guerra ma anche <strong>la</strong> subor<strong>di</strong>nazione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> al termine forte<br />
del<strong>la</strong> <strong>di</strong>ade.<br />
Aron <strong>di</strong>stingue tre tipi <strong>di</strong> <strong>pace</strong>: <strong>di</strong> potenza, d’impotenza e <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione. La prima for<br />
ma viene sud<strong>di</strong>visa in tre sottospecie a seconda che i gruppi politici siano in rapporto <strong>di</strong> ugua<br />
glianza (<strong>pace</strong> <strong>di</strong> equilibrio), <strong>di</strong> <strong>di</strong>suguaglianza (<strong>pace</strong> <strong>di</strong> egemonia) o <strong>di</strong> dominio (<strong>pace</strong> <strong>di</strong> impero,<br />
<strong>la</strong> pax romana).<br />
A metà degli anni settanta Michael Walzer ri<strong>la</strong>ncia il <strong>di</strong>battito sul<strong>la</strong> guerra “giusta” 118 ,<br />
praticabile quando risponde a tre criteri:<br />
a) La giusta causa del<strong>la</strong> guerra (ius ad bellum), in caso <strong>di</strong> resistenza o <strong>di</strong> ritorsione come<br />
punizione dell’oppressore, nonché <strong>la</strong> giusta intenzione (inefficacia dei mezzi pacifici);<br />
114<br />
R. ARON, Paix et guerre entre nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, tr. it. <strong>di</strong> F. Airol<strong>di</strong> Namer, Mi<strong>la</strong>no, E<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> Comunità, 1970.<br />
115<br />
C. SCHMITT, Inter <strong>pace</strong>m et bellum nihil me<strong>di</strong>um, «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», VI, 1939,<br />
pp. 594-5, tr. it. <strong>di</strong> A. Campi, Perugia, Bacco & Arianna, 1983.<br />
116<br />
Nato ad Atene verso il 455 a. C., esiliato per motivi politici, Tuci<strong>di</strong>de tornò in patria solo al<strong>la</strong> fine del<strong>la</strong> guerra<br />
con Sparta. Morì nel 400, probabilmente assassinato. L’opera sull’esperienza bellica, del<strong>la</strong> quale è ignoto il titolo<br />
originale, ci è giunta in otto libri, secondo una partizione che non sembra però risalire all’autore, quanto piuttosto<br />
a grammatici successivi: risulta incompleta, arrestandosi bruscamente al<strong>la</strong> campagna estiva del 411, nonostante<br />
<strong>la</strong> <strong>di</strong>chiarata intenzione <strong>di</strong> narrare gli eventi fino al<strong>la</strong> fine del<strong>la</strong> guerra.<br />
117<br />
La guerra del Peloponneso vide Atene e Sparta, a capo <strong>di</strong> due opposte coalizioni <strong>di</strong> città greche, contendersi il<br />
predominio. Iniziata nel 431 a. C., <strong>la</strong> guerra si concluse solo nel 404, con l’occupazione <strong>di</strong> Atene da parte del generale<br />
spartano Lisandro, con il definitivo tramonto <strong>di</strong> qualsiasi pretesa imperiale da parte del<strong>la</strong> pòlis attica.<br />
118<br />
M. WALZER, Just and Unjust Wars a moral argument with historical illustrations, New York, Basic Books<br />
1977, tr. it. <strong>di</strong> F. Armao, Napoli, Liguori, 1990.<br />
26
) Il giusto mezzo (ius in bello), che include <strong>la</strong> massima immunità possibile dei civili e <strong>la</strong><br />
proporzionalità dei mezzi bellici impiegati;<br />
c) Il giusto esito (ius post bellum), che riguarda <strong>la</strong> maniera con cui si mette fine al con<br />
flitto armato.<br />
Riaffiora l’idea che sia possibile giustificare una guerra <strong>di</strong> aggressione, se si determinano<br />
alcune con<strong>di</strong>zioni 119 . Già Grozio nel<strong>la</strong> sua opera aveva proposto un concetto innovativo <strong>di</strong><br />
“guerra giusta” 120 . In realtà ai nostri tempi il iustum bellum non è più il tentativo <strong>di</strong> sottoporre<br />
<strong>la</strong> guerra a regole morali, ma un ce<strong>di</strong>mento morale alle ragioni del<strong>la</strong> guerra 121 .<br />
Al<strong>la</strong> <strong>di</strong>scussione partecipano per <strong>la</strong> prima volta, favoriti da uno sviluppato sistema delle<br />
comunicazioni, <strong>la</strong>rghi settori dell’opinione pubblica.<br />
A Bobbio, che riunisce in volume alcuni saggi con il titolo Il problema del<strong>la</strong> guerra e le<br />
vie del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> 122 (1979), <strong>la</strong> guerra sembra il problema nodale del<strong>la</strong> riflessione politica mentre<br />
<strong>la</strong> <strong>pace</strong> appare un concetto definibile in rapporto al<strong>la</strong> guerra. La <strong>di</strong>stinzione tra <strong>pace</strong> negativa e<br />
<strong>pace</strong> positiva è basata, <strong>la</strong> prima, sul<strong>la</strong> non presenza del<strong>la</strong> guerra, <strong>la</strong> seconda, su una situazione<br />
giuri<strong>di</strong>camente rego<strong>la</strong>ta e duratura nel tempo.<br />
Questa <strong>di</strong>pendenza concettuale del<strong>la</strong> filosofia del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> dal<strong>la</strong> filosofia del<strong>la</strong> guerra ha una<br />
matrice hobbesiana. L’antitesi <strong>pace</strong>-guerra, esattamente ricalcata sul<strong>la</strong> identificazione stato <strong>di</strong><br />
natura – stato <strong>di</strong> guerra, è il punto <strong>di</strong> partenza per <strong>la</strong> ridefinizione bobbiana del contrattualismo<br />
hobbesiano in senso kantiano. Così come il pactum societatis d’impronta kantiana si<br />
completa con il pactum subiectionis <strong>di</strong> matrice hobbesiana.<br />
La definizione <strong>di</strong> <strong>pace</strong> si arricchisce <strong>di</strong> significati se si passa da un criterio c<strong>la</strong>ssificatoriodescrittivo<br />
a quello assiologico. La vera <strong>pace</strong> non si identifica con uno «stato <strong>di</strong> <strong>pace</strong> generale»<br />
ma coincide con uno «stato giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> <strong>pace</strong>».<br />
In Bobbio <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> <strong>pace</strong> equivale a quel<strong>la</strong> in cui regna il <strong>di</strong>ritto. Sul<strong>la</strong> linea già<br />
tracciata da Kant e da Kelsen, il filosofo torinese persegue <strong>la</strong> costruzione concettuale del<strong>la</strong> pa<br />
119 Sul<strong>la</strong> ripresa del<strong>la</strong> guerra “giusta” e sulle successive teorizzazioni <strong>di</strong> guerra “umanitaria” e <strong>di</strong> guerra “preventiva”<br />
si leggano le considerazioni, non sempre con<strong>di</strong>visibili, <strong>di</strong> A. ASOR ROSA, La guerra. Sulle forme attuali<br />
del<strong>la</strong> convivenza umana, Torino, Einau<strong>di</strong>, 2002.<br />
120 Cfr. pp. 49 sgg. Di queste <strong>di</strong>spense.<br />
121 D. ZOLO, I signori del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Una critica del globalismo giuri<strong>di</strong>co, Roma, Carocci, 1998.<br />
122 La prima stesura <strong>di</strong> questo testo possono essere considerate le Lezioni <strong>di</strong> filosofia del <strong>di</strong>ritto, a.a. 1964-5, Torino,<br />
Coop. Libri Univ., 1965, pp. 24-51. Ancor prima, in un saggio del 1952 dal titolo Pace e propaganda <strong>di</strong><br />
<strong>pace</strong>, Bobbio aveva denunciato <strong>la</strong> contrad<strong>di</strong>ttorietà tra l’aspirazione al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> fare rivoluzioni (Politica<br />
e cultura, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1955, pp. 53-63).<br />
27
ce attraverso il <strong>di</strong>ritto e attraverso l’istituzione <strong>di</strong> una società internazionale ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>rimere<br />
i conflitti tra stati. Il <strong>di</strong>ritto può effettivamente valere quando non solo ha <strong>di</strong>mostrato <strong>la</strong> razio<br />
nalità dei principi morali che lo animano, ma ne garantisce l’efficacia. Per questo, al fine <strong>di</strong><br />
garantire «<strong>la</strong> <strong>pace</strong> attraverso il <strong>di</strong>ritto», si deve, <strong>di</strong> fronte a vio<strong>la</strong>zioni dello stesso, poter usare<br />
<strong>la</strong> forza e minacciare <strong>la</strong> pena. Oltre il momento associativo, ci deve essere un patto che conse<br />
gni <strong>la</strong> forza dei singoli nelle mani <strong>di</strong> un’autorità internazionale: per ottenere l’efficacia <strong>di</strong> una<br />
<strong>pace</strong> attraverso il <strong>di</strong>ritto si deve dunque costruire anche un <strong>di</strong>ritto «perentorio» e non «provvi<br />
sorio», che possa costringere i componenti del sistema degli stati a sottostare, anche con <strong>la</strong><br />
forza, alle regole pattuite.<br />
L’istituzione internazionale, <strong>di</strong>venuta “Terzo” 123 , è, per quanto realizzabile, il tito<strong>la</strong>re del-<br />
<strong>la</strong> forza deputata a realizzare <strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Siamo così arrivati a sganciare <strong>la</strong> forza dal<strong>la</strong> guerra e a<br />
considerar<strong>la</strong> strumento per <strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
La tematica bobbiana del Terzo, definito “assente” 124 o debolmente presente, è da svilup<br />
pare. Per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> sono in<strong>di</strong>viduabili due tipi <strong>di</strong> Terzo super partes: l’arbitro (più forte) e il<br />
me<strong>di</strong>atore (più debole). L’arbitro può avere un potere coattivo oppure soltanto persuasivo.<br />
Al<strong>la</strong> fine del<strong>la</strong> sua lunga riflessione sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e sul<strong>la</strong> guerra (quarantacinque anni) Bob<br />
bio non si mostra ottimista: sia il pacifismo giuri<strong>di</strong>co che <strong>la</strong> politica del Terzo non gli appaiono<br />
partico<strong>la</strong>rmente decisivi. Ma non per questo possono essere abbandonati.<br />
Quello <strong>di</strong> Sergio Cotta è un percorso a ritroso: dal<strong>la</strong> logica del<strong>la</strong> guerra al<strong>la</strong> scoperta dei<br />
valori ontologici del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. La conquista del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> presuppone <strong>la</strong> ricerca del suo fondamento,<br />
in quanto, sul piano delle teorie e delle ideologie, <strong>la</strong> <strong>di</strong>mostrazione del valore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> si<br />
sarebbe rive<strong>la</strong>ta insufficiente. Sul piano pratico-operativo i mezzi per <strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong> (<strong>di</strong>sarmo, sviluppo, monopolio del<strong>la</strong> forza) sono utili ma non sufficienti. Cotta non intende<br />
mettere in dubbio il valore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, bensì si propone <strong>di</strong> ricercarne «un fondamento<br />
che lo sottragga tanto al<strong>la</strong> sua negazione […] quanto alle scelte puramente soggettive o ideologiche.<br />
Un siffatto fondamento può venir trovato […] – secondo il filosofo del <strong>di</strong>ritto – me<strong>di</strong>ante<br />
il rigoroso processo <strong>di</strong> «autocoscienza dell’io» che porti a riconoscere <strong>la</strong> verità del<strong>la</strong><br />
«re<strong>la</strong>zionalità ontologica dell’uomo». E’ infatti <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionalità, cioè l’essere in re<strong>la</strong>zione gli<br />
uni con gli altri, a formare <strong>la</strong> peculiarità del<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione umana. «La raggiunta chiarezza <strong>di</strong><br />
123 Cfr. P.P. PORTINARO, Il terzo. Una figura del politico, Mi<strong>la</strong>no, Angeli, 1986.<br />
124 N. BOBBIO, Il Terzo assente. Saggi e <strong>di</strong>scorsi sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e sul<strong>la</strong> guerra, a c. <strong>di</strong> P. Polito, Torino, Sonda, 1989.<br />
28
tale verità è il presupposto e il supporto assolutamente necessario per qualsiasi progetto <strong>di</strong> pa<br />
125<br />
ce» .<br />
E’ questa <strong>pace</strong>, propria del<strong>la</strong> struttura dell’esser-uomo, che ispira e sorregge nel profondo<br />
tutte le paci storiche, partico<strong>la</strong>ri e contingenti, nelle quali gli uomini <strong>di</strong> buona volontà manife<br />
stano, nell’impegno e nello sforzo <strong>di</strong> vincere se stessi, <strong>la</strong> consapevolezza, sia pure imperfetta,<br />
del proprio dovere <strong>di</strong> essere uomini.<br />
«La guerra, in<strong>di</strong>pendentemente dal<strong>la</strong> sua frequenza, è l’accidente (fenomenico e contin<br />
gente) del<strong>la</strong> vita umana, mentre <strong>la</strong> <strong>pace</strong> ne è <strong>la</strong> sostanza» 126 . Non possono essere neppure le<br />
consolidate filosofie del<strong>la</strong> guerra a giustificare il ricorso ad essa 127 . Ma neppure il binomio<br />
«terrore-<strong>di</strong>sarmo», pur utile, può fondare il valore profondo del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> «e tanto meno il suo in<br />
sé» 128 . Così come non può essere l’efficacia promozionale del binomio «benessere-sviluppo»,<br />
pur utile a ottenere una <strong>pace</strong> stabile, con<strong>di</strong>zione fondamentale del<strong>la</strong> coesistenza umana.<br />
La <strong>pace</strong> appartiene al<strong>la</strong> categoria dell’eternità, al cordone ombelicale che unisce gli in<strong>di</strong><br />
vidui al<strong>la</strong> <strong>di</strong>vinità, all’arché del Logos 129 . Non è il <strong>di</strong>ritto a creare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>pace</strong> ma è il<br />
fondamento <strong>di</strong> re<strong>la</strong>zionalità (ontologia pacifica) a creare il <strong>di</strong>ritto.<br />
Più che un valore, un ideale (questo lo è anche <strong>la</strong> guerra) o ad<strong>di</strong>rittura un’ideologia, <strong>la</strong> pa<br />
ce è «espressione del<strong>la</strong> verità più profonda dell’uomo, accertabile me<strong>di</strong>ante <strong>la</strong> <strong>di</strong>scesa nel<strong>la</strong><br />
sua interiorità». Laddove si scopra che «<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione è quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> vivere con e per l’altro: nel<strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>zione» 130 . In opposizione a modelli storici del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, Cotta ritiene che non sia il <strong>di</strong>ritto a<br />
creare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>pace</strong> ma che sia <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionalità dell’uomo a creare il <strong>di</strong>ritto ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong><br />
rego<strong>la</strong>re l’esistenza pacifica<br />
Bobbio da una parte e Cotta dall’altra hanno riproposto l’inquadramento del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> in<br />
rapporto ad un nuovo <strong>di</strong>mensionamento del<strong>la</strong> questione etico-giuri<strong>di</strong>ca, da sempre attuale ma<br />
oggi ri<strong>la</strong>nciato dal<strong>la</strong> crisi del<strong>la</strong> politica e del<strong>la</strong> sua subor<strong>di</strong>nazione all’economia. In questa<br />
prospettiva si colloca, da scienziato del<strong>la</strong> politica, Luigi Bonanate.<br />
125 S. COTTA, Dal<strong>la</strong> guerra al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Un itinerario filosofico, Mi<strong>la</strong>no, Rusconi, 1989, pp. 137 e 183. Il primo<br />
intervento <strong>di</strong> Cotta è stato La <strong>pace</strong> come <strong>di</strong>mensione dello spirito, in Atti, Bologna, Il Mulino, 1967, pp. 149-51.<br />
126 S. COTTA, Dal<strong>la</strong> guerra al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> cit., p. 111.<br />
127 Il primo, riconducibile al<strong>la</strong> «triade Machiavelli-Hobbes-Spinoza» e in<strong>di</strong>cato come «vitalistico-utilitario», afferma<br />
«<strong>la</strong> prioritaria origine antropologica (naturale) del<strong>la</strong> guerra, ma il valore (etico-assiologico) è attribuito<br />
al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>». Il secondo, incarnato da Hegel-Marx-Nietzsche, teorizzando «insieme tanto <strong>la</strong> prioritaria originarietà<br />
del<strong>la</strong> guerra quanto il suo valore etico, in base a una concezione <strong>di</strong>alettica del<strong>la</strong> storia [...] è qualificabile come<br />
storicistico-<strong>di</strong>alettico».<br />
128 S. COTTA, Dal<strong>la</strong> guerra al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> cit., p. 121.<br />
129 Sono presenti in questo passaggio le riflessioni sull’uomo contenute nell’opera Zum Wesen des Friedens <strong>di</strong><br />
E. JÜNGEL, tr. it. L’essenza del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, Brescia, Morcelliana, 1984.<br />
130 S. COTTA, Dal<strong>la</strong> guerra al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, cit., p. 173.<br />
29
Dopo aver criticato <strong>la</strong> politica <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssuasione del<strong>la</strong> guerra e <strong>la</strong> concezione residuale del<strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong>, lo Bonanate sostiene che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> «può contribuire al progresso morale, oppure a quello<br />
civile, o ancora a quello tecnico dell’umanità» almeno quanto <strong>la</strong> guerra 131 .<br />
La <strong>di</strong>mensione entro cui collocare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> dev’essere quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> politica internazionale,<br />
anche se quest’ultima soffre del fatto che i suoi mancati esiti sono drammatici.<br />
Se Bobbio aveva legato l’analisi del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> al piano del<strong>la</strong> <strong>di</strong>chiarazione dei <strong>di</strong>ritti<br />
dell’uomo, Bonanate sviluppa una teoria morale del<strong>la</strong> vita internazionale. Per <strong>di</strong>mostrare <strong>la</strong><br />
praticabilità <strong>di</strong> un’etica del<strong>la</strong> politica internazionale, l’Autore auspica un ulteriore progresso<br />
morale ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> portare all’abolizione del<strong>la</strong> guerra, non più vista come «retaggio eterno<br />
dell’umanità» 132 , e al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> produrre <strong>pace</strong>. L’unica possibilità <strong>di</strong> definizione positi<br />
va <strong>di</strong> <strong>pace</strong> è quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> non concepir<strong>la</strong> in astratto ma come situazione interna allo stato contrap<br />
posta al<strong>la</strong> guerra, come caratteristica prevalente delle re<strong>la</strong>zioni internazionali 133 . Il passaggio<br />
che porta dall’inevitabilità del<strong>la</strong> guerra all’inevitabilità del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> è l’or<strong>di</strong>ne che, però, non<br />
può essere che <strong>di</strong>namico, oltre che generalizzato 134 .<br />
Bonanate svinco<strong>la</strong> il pensiero sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong> da quello sul<strong>la</strong> guerra. Di fronte al progetto <strong>di</strong><br />
costruire una concor<strong>di</strong>a fondata sul<strong>la</strong> giustizia, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> deve essere considerata come valore<br />
che non <strong>di</strong>penda dai tempi <strong>di</strong> guerra ma che sia un valore in sé. Mentre <strong>la</strong> guerra non è mai<br />
stata giusta per entrambi le parti in lotta, possibile è invece costruire <strong>la</strong> «<strong>pace</strong> giusta». La <strong>pace</strong><br />
<strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione, che è naturalmente <strong>la</strong> più <strong>di</strong>fficile da realizzare. Essa va <strong>di</strong>stinta sia dal<strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
– tregua che dal<strong>la</strong> <strong>pace</strong> tra<strong>di</strong>zionale, che dal<strong>la</strong> <strong>pace</strong> del terrore.<br />
Bisogna ritornare a riflettere su un fondamento etico del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> internazionale: come è<br />
stato nel passato per <strong>la</strong> costruzione dell’or<strong>di</strong>ne interno agli stati, si può creare un sistema internazionale<br />
pacificato so<strong>la</strong>mente riconoscendo a tutti gli stati eguali <strong>di</strong>ritti e doveri. Come<br />
nel<strong>la</strong> politica interna ogni stato (che opera secondo <strong>di</strong>ritto) è obbligato a trattare egualmente<br />
gli in<strong>di</strong>vidui che ne fanno parte, a prescindere «dal<strong>la</strong> loro citta<strong>di</strong>nanza o appartenenza nazionale»,<br />
così è necessario che <strong>la</strong> politica internazionale persegua una <strong>pace</strong> <strong>di</strong> valore che possa<br />
con<strong>di</strong>zionare le scelte politiche. È possibile allora «fondare un’etica internazionale», scar<strong>di</strong>nando<br />
tutta <strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> pensiero politico che vedeva solo nello stato, nel<strong>la</strong> politica interna,<br />
«un minimo <strong>di</strong> valori morali» da conseguire. Non bisogna ricercare un fondamento assoluta<br />
131 L. BONANATE, La politica del<strong>la</strong> <strong>di</strong>ssuasione. La guerra nel<strong>la</strong> politica mon<strong>di</strong>ale, Torino, Giappichelli, 1971.<br />
132 N. ELIAS, Humana con<strong>di</strong>tio, tr. it. Bologna, Il Mulino, 1987, p. 62.<br />
133 L. BONANATE, Il sistema internazionale e <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, in G. PASQUINO (a c. <strong>di</strong>), Teoria e prassi delle re<strong>la</strong>zioni internazionali,<br />
Napoli, Liguori, 1981; ID., Che cosa sappiamo del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>?, in Né guerra né <strong>pace</strong>, Mi<strong>la</strong>no, Agnelli,<br />
1987.<br />
134 L. BONANATE, Per una teoria generale dell’or<strong>di</strong>ne politico internazionale, Mi<strong>la</strong>no, Ed. <strong>di</strong> Comunità, 1974.<br />
30
mente valido del<strong>la</strong> politica internazionale, ma non bisogna nemmeno rinunciare, in conse<br />
guenza <strong>di</strong> ciò, a porre il problema etico nel rapporto tra gli stati 135 . Perché bisogna superare il<br />
pregiu<strong>di</strong>zio, introdotto dal giusnaturalismo, che ha separato <strong>la</strong> politica interna da quel<strong>la</strong> inter<br />
nazionale, <strong>di</strong>stinguibile in base ad una «so<strong>la</strong> e fondamentale <strong>di</strong>cotomia»: or<strong>di</strong>ne contro anar<br />
chia, organizzazione contro in<strong>di</strong>fferenza, <strong>pace</strong> contro guerra. Questa spaccatura, secondo Bo<br />
nanate, ha riguardato <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione tra <strong>di</strong>ritti e doveri, riconosciuti nel<strong>la</strong> politica interna e inve<br />
ce scissi in quel<strong>la</strong> internazionale nell’ambito del<strong>la</strong> quale «ciascuno stato riven<strong>di</strong>ca <strong>di</strong>ritti ed<br />
esclude doveri».<br />
135 L. BONANATE, Etica e politica internazionale, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1992, pp. 77-8.<br />
31
Antologia<br />
I <strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> Irene<br />
32
1. L’autonomia concettuale<br />
1.1 Dante. La <strong>pace</strong> universale è il bene migliore tra quanti vengono istitui<br />
ti per <strong>la</strong> nostra beatitu<strong>di</strong>ne<br />
1.2 Marsilio. Dobbiamo desiderare <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, cercar<strong>la</strong> se non <strong>la</strong> posse<strong>di</strong>amo<br />
già, conservar<strong>la</strong> una volta che l’abbiamo raggiunta<br />
2. L’elogio antibellicista<br />
2.1 Erasmo. Intraprese per volontà dei principi [le guerre] furono condotte<br />
con grave danno del popolo a cui non interessavano per nul<strong>la</strong><br />
3. Diritto delle genti e psicologia politica<br />
3.1 Grozio. La <strong>pace</strong> è più sicura del<strong>la</strong> speranza <strong>di</strong> vincere una guerra<br />
3.2 Hobbes. La prima e fondamentale legge <strong>di</strong> natura è cercare <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, e<br />
conseguir<strong>la</strong><br />
3.3 Spinoza. La <strong>pace</strong> non consiste nell’assenza <strong>di</strong> guerra, ma nell’unione<br />
degli animi, ossia nel<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a<br />
4. I progetti settecenteschi<br />
4.1 Saint-Pierre. Per conservare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> bisogna sopprimere i pretesti <strong>di</strong> guerra<br />
4.2 Rousseau. Non tregue ma vere e proprie paci<br />
4.3 Kant. Per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua<br />
5. Le analisi ottocentesche<br />
5.1 Constant. Il commercio sostituisce <strong>la</strong> guerra e favorisce <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
5.2 Tocqueville. I popoli amano <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e gli eserciti <strong>la</strong> guerra<br />
5.3 Saint-Simon. Il più sicuro mezzo per mantenere <strong>la</strong> <strong>pace</strong> sarà quello <strong>di</strong> portar<strong>la</strong><br />
incessantemente fuori<br />
6. Al tempo delle guerre mon<strong>di</strong>ali<br />
6.1 Einstein-Freud. La guerra è vinta, ma non c’è <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
7. Nel<strong>la</strong> stagione del<strong>la</strong> “guerra fredda”<br />
7.1 Kelsen. La <strong>pace</strong> è caratterizzata dall’assenza del<strong>la</strong> forza<br />
33
7.2 Aron. La <strong>pace</strong> è il fine al quale tendono le società<br />
7.3 Bobbio. La <strong>pace</strong> è uno stato giuri<strong>di</strong>co<br />
7.4 Cotta. La re<strong>la</strong>zionalità è «<strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong> tutte le paci»<br />
7.5 Bonanate. Una teoria morale del<strong>la</strong> vita internazionale<br />
34
1. L’autonomia concettuale<br />
DANTE<br />
La <strong>pace</strong> universale è il bene migliore<br />
tra quanti vengono istituiti per <strong>la</strong> nostra beatitu<strong>di</strong>ne<br />
Nel<strong>la</strong> Monarchia 136 viene presentato un progetto <strong>di</strong> costruzione politica del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e quin<strong>di</strong> del<strong>la</strong><br />
beatitu<strong>di</strong>ne terrena: solo nel<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> <strong>pace</strong> l’uomo può praticare <strong>la</strong> via con cui raggiunge <strong>la</strong><br />
felicità.<br />
Dante ha analizzato nei primi capitoli dell’opera <strong>la</strong> psicologia umana: <strong>la</strong> natura umana si carat<br />
terizzerebbe per «essere ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> apprendere per mezzo dell’intelletto possibile».<br />
Il compito proprio del genere umano, considerato nel<strong>la</strong> sua globalità, consiste nell’attuare sempre<br />
tutta <strong>la</strong> potenza dell’intelletto possibile, in primo luogo ai fini del<strong>la</strong> specu<strong>la</strong>zione e in secondo<br />
luogo, come conseguenza e per estensione, ai fini dell’attività pratica 137 . E poiché tutto ciò<br />
che concerne <strong>la</strong> parte riguarda anche il tutto, capita all’uomo singolo che, quando <strong>la</strong> tranquillità<br />
è assoluta, si perfezioni in saggezza e sapienza. È quin<strong>di</strong> evidente che il genere umano si può<br />
de<strong>di</strong>care al proprio compito [...] quando si trova in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> quiete e <strong>pace</strong>. Per cui è palese<br />
che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> universale è il bene migliore tra quanti vengono istituiti per <strong>la</strong> nostra beatitu<strong>di</strong>ne.<br />
Proprio per questo ai pastori risuonò dall’alto una voce che annunciava non ricchezze, piaceri,<br />
onori, non vita lunga e salute, non forza e bellezza, ma <strong>pace</strong>. Dicevano infatti le schiere celesti:<br />
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e <strong>pace</strong> in terra agli uomini <strong>di</strong> buona volontà» 138 . Ed ancora, il<br />
Salvatore salutava gli uomini con l’annuncio «La <strong>pace</strong> sia con voi» 139 [...] Ed è proprio <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
universale che deve costituire il fondamento delle argomentazioni che seguono.<br />
136<br />
I brani che seguono sono tratti da DANTE, Monarchia, Mi<strong>la</strong>no, Garzanti, 1985 (tr. it. <strong>di</strong> Federico Sanguinetti basata<br />
sul testo <strong>la</strong>tino stabilito dall’E<strong>di</strong>zione Nazionale, Mi<strong>la</strong>no, Mondadori, 1965), I, IV – I, XVI (pp. 10-39).L’opera è <strong>di</strong>visa in<br />
tre libri, in cui l’autore affronta tre quaestiones <strong>di</strong>fferenti: se il Monarca sia necessario al benessere del mondo; se il popolo<br />
romano abbia acquisito l’impero universale attraverso il <strong>di</strong>ritto o <strong>la</strong> forza; se l’autorità del Monarca derivi <strong>di</strong>rettamente<br />
da Dio o da qualche suo ministro o vicario. Molteplici sono stati i tentativi <strong>di</strong> datare l’opera, coprendo l’arco delle<br />
ipotesi un periodo del<strong>la</strong> vita dantesca che va dai primi anni dell’esilio al<strong>la</strong> morte (1302-1321).<br />
137<br />
Come viene spiegato in altro passaggio dell’opera, <strong>la</strong> scienza politica non è meramente teorica, ovvero <strong>di</strong>retta «ad<br />
specu<strong>la</strong>tionem», ma pratica, conduce «ad operationem», dal momento che il suo «finis est agere atque facere» (Mn., I,<br />
II, 6; III, 9). Questa <strong>di</strong>fferenza è già tracciata nel Convivio, dove Dante spiega che l’intelletto può essere usato in modo<br />
«pratico e specu<strong>la</strong>tivo (pratico è tanto quanto operativo)» (Cv., IV, XXII, 10).<br />
138<br />
Lc., 2, 14.<br />
139<br />
Gv., 20, 21.<br />
35
Con<strong>di</strong>zione essenziale per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> universale è l’esistenza <strong>di</strong> un «or<strong>di</strong>ne» tra gli stati, dato dal<br />
fatto che tutti i regnanti riconoscano un unico sovrano mon<strong>di</strong>ale cui rimettere <strong>la</strong> decisione intorno<br />
alle loro controversie.<br />
Dove può sorgere una lite, ivi deve essere assicurato un giu<strong>di</strong>zio; in caso contrario sussisterebbe<br />
una situazione <strong>di</strong>fettosa, non suscettibile <strong>di</strong> perfettibilità [...] tra due principi, <strong>di</strong> cui l’uno non è<br />
soggetto all’altro, può crearsi, come è ovvio, un’occasione <strong>di</strong> lite per colpa loro o dei sud<strong>di</strong>ti: <br />
quin<strong>di</strong> tra i due litiganti è opportuno che si <strong>di</strong>a un contenzioso. E dal momento che l’uno non<br />
può giu<strong>di</strong>care l’altro, poiché nessuno dei due è soggetto all’altro – infatti fra due <strong>di</strong> pari potere<br />
non ci può essere chi prevalga – è opportuno che vi sia una terza persona, dotata <strong>di</strong> più ampia<br />
giuris<strong>di</strong>zione, che domini su ambedue nell’ambito delle proprie prerogative giuri<strong>di</strong>che. [...] e<br />
costui sarà il Monarca o Imperatore 140 .<br />
In una seconda accezione, l’Imperatore è foriero <strong>di</strong> <strong>pace</strong> perché instaura un governo unico su<br />
tutto il genere umano: in<strong>di</strong>ca le norme universalmente valide da cui devono prendere le mosse tutti<br />
gli or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci “partico<strong>la</strong>ri”.<br />
il genere umano può essere governato da un solo principe supremo, cioè dal Monarca. E, a proposito<br />
<strong>di</strong> questa affermazione, c’è da considerare che, quando si <strong>di</strong>ce “il genere umano può essere<br />
governato da un solo principe supremo”, ciò non deve significare che le più minute decisioni<br />
<strong>di</strong> qualunque municipio possano provenire <strong>di</strong>rettamente solo da lui [...]. D’altronde i popoli, i<br />
regni e le città hanno in sé caratteristiche peculiari che è opportuno siano rego<strong>la</strong>te da leggi <strong>di</strong>fferenziate:<br />
infatti <strong>la</strong> legge è rego<strong>la</strong> <strong>di</strong>rettiva del<strong>la</strong> vita. […]<br />
Ma questo è piuttosto il senso del<strong>la</strong> predetta espressione: il genere umano deve essere governato<br />
dal Monarca, per ciò che concerne le regole valide per tutti, e deve essere guidato, con una norma<br />
valida universalmente, al conseguimento del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Questa norma, o legge, i singoli principi<br />
debbono ricever<strong>la</strong> da lui 141 . […]<br />
Qualsiasi tipo <strong>di</strong> concor<strong>di</strong>a <strong>di</strong>pende dall’unità insita nei voleri; il genere umano, quando è nelle<br />
migliori con<strong>di</strong>zioni, rappresenta un certo tipo <strong>di</strong> concor<strong>di</strong>a. [...] D’altra parte ciò non può acca<br />
140 Quantunque nel<strong>la</strong> Monarchia non venga fatto alcun riferimento a personaggi storici coevi, dagli altri scritti danteschi<br />
emerge chiaramente come l’A. riponesse le proprie speranze nel tito<strong>la</strong>re del Sacro Romano Impero, fondato da Carlo<br />
Magno al<strong>la</strong> fine dell’VIII secolo. Quest’ultimo, e non l’impero bizantino, sarebbe infatti il legittimo erede dell’impero<br />
romano creato da Ottaviano Augusto. Nelle Epistole politiche e in numerosi passaggi del Para<strong>di</strong>so, l’imperatore cui<br />
l’Alighieri rivolge le migliori (e più frustrate) speranze <strong>di</strong> ricostituzione dell’autorità monarcale è Arrigo VII <strong>di</strong> Lussemburgo,<br />
il quale, eletto nel 1308, morì nel 1313 durante <strong>la</strong> spe<strong>di</strong>zione italiana, prima <strong>di</strong> aver pacificato il territorio<br />
del<strong>la</strong> peniso<strong>la</strong>.<br />
141 Viene impostato un doppio piano delle leggi umane. Quello che accomuna tutto il genere umano nel<strong>la</strong> ricerca del bene<br />
del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e quello che rego<strong>la</strong> <strong>la</strong> vita nelle singole comunità politiche. Mentre per ricercare il primo deve essere istituita<br />
un’autorità politica universale, per le seconde valgono gli or<strong>di</strong>namenti partico<strong>la</strong>ri, che comunque devono rispettare<br />
le le leggi dell’Impero.<br />
36
dere, se non vi sia una volontà unica che domini e <strong>di</strong>riga tutte le altre, riconducendole ad unità;<br />
[...] tale volontà non può essere unica, se non vi sia un principe unico per tutti, il cui volere pos<br />
sa dominare e <strong>di</strong>rigere tutti gli altri 142 .<br />
Dopo aver chiarito come <strong>la</strong> <strong>pace</strong> sia un dono <strong>di</strong> Dio agli uomini, ha <strong>di</strong>mostrato come solo sotto<br />
il governo <strong>di</strong> un unico sovrano essa sia praticabile, Dante chiude <strong>la</strong> filiera <strong>di</strong>mostrativa esplicitando<br />
il fatto che l’Impero stesso è stato voluto da Dio per il mantenimento del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> in terra.<br />
Conferma quanto sopra esposto un avvenimento memorabile, vale a <strong>di</strong>re quel<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione par<br />
tico<strong>la</strong>re dell’umanità che il Figlio <strong>di</strong> Dio, in procinto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare uomo per <strong>la</strong> salvezza<br />
dell’uomo, attese, o meglio, quando egli stesso volle, pre<strong>di</strong>spose. Infatti, se ripercorriamo con il<br />
pensiero <strong>la</strong> situazione del genere umano nelle varie epoche, ad iniziare dal<strong>la</strong> caduta dei primi<br />
genitori, punto <strong>di</strong> partenza deviante <strong>di</strong> tutti i nostri errori, troveremo che so<strong>la</strong>mente sotto il regno<br />
del <strong>di</strong>vino Augusto, grazie all’esistenza <strong>di</strong> una monarchia perfetta, il mondo fu dappertutto<br />
in <strong>pace</strong>. 143<br />
MARSILIO<br />
Dobbiamo desiderare <strong>la</strong> <strong>pace</strong>,<br />
cercar<strong>la</strong> se non <strong>la</strong> posse<strong>di</strong>amo già,<br />
conservar<strong>la</strong> una volta che l’abbiamo raggiunta<br />
Se in Dante <strong>la</strong> ricerca del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> è possibile solo sotto il monarca universale, nel Defensor pacis 144<br />
<strong>di</strong> Marsilio da Padova ogni or<strong>di</strong>namento politico (una singo<strong>la</strong> città, un regno, il Sacro Impero) può<br />
realizzare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> tra i propri citta<strong>di</strong>ni. In prima istanza, viene chiarita <strong>la</strong> <strong>di</strong>retta connessione tra <strong>pace</strong><br />
terrena, politica e felicità.<br />
142 Ancora una volta il germe <strong>di</strong> questo ragionamento si trova nel Convivio: «a queste guerre e le loro cagioni torre via,<br />
conviene <strong>di</strong> necessitade tutta <strong>la</strong> terra, e quanto a l’umana generazione a possedere è dato, essere Monarchia, cioè uno<br />
solo principato, e uno prencipe avere; lo quale, tutto possedendo e più desiderare non possendo, li regi tegna contenti ne<br />
li termini de li regni, sì che <strong>pace</strong> intra loro sia, ne <strong>la</strong> quale si posino le citta<strong>di</strong>, e in questa posa le vicinanze s’amino, in<br />
questo amore le case prendano ogni loro bisogno, lo qual preso, l’uomo viva felicemente; che è quello per che esso è<br />
nato. »<br />
143 La transizione romana dal regime repubblicano a quello imperiale viene dagli storici inquadrata in un periodo variabile<br />
che inizia con le innovazioni istituzionali del 28-27 a.C., in cui si instaura lo stato dell’auctoritas, ovvero <strong>la</strong> giustificazione<br />
giuri<strong>di</strong>ca del nuovo potere imperiale. Da notare che piena potestas (potere <strong>di</strong> fatto) Ottaviano godeva sui domini<br />
romani sin dal<strong>la</strong> vittoria contro Antonio nel<strong>la</strong> battaglia <strong>di</strong> Azio (31 a.C.).<br />
144 I seguenti brani fanno riferimento all’opera MARSILIO DA PADOVA, Il <strong>di</strong>fensore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> (trad. it. <strong>di</strong> Mario Conetti,<br />
C<strong>la</strong>u<strong>di</strong>o Fiocchi, Stefano Radoice, Stefano Simonetta), 2 voll., Mi<strong>la</strong>no, Bur, 2001, I, 1 – II, 17.<br />
L’opera fu conclusa a Parigi il 24 giugno 1324, come l’autore stesso in<strong>di</strong>ca nel<strong>la</strong> conclusione.<br />
37
Tutti i regni devono desiderare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> in cui i popoli progre<strong>di</strong>scono, e in cui è custo<strong>di</strong>to il bene<br />
delle popo<strong>la</strong>zioni. Questa infatti è <strong>la</strong> nobile madre delle buone arti; moltiplicandosi il genere<br />
umano ne amplia le possibilità e ne nobilita i costumi. E chi ha ricercato poco <strong>la</strong> tranquillità mostra<br />
<strong>di</strong> ignorare cose così importanti». Cassiodoro 145 , nel<strong>la</strong> prima delle sue Epistole, premessi<br />
questi princìpi, ha espresso i vantaggi e i frutti del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> dei regimi civili per spingere le volontà<br />
degli uomini a stare in <strong>pace</strong> gli uni con gli altri e quin<strong>di</strong> al<strong>la</strong> tranquillità, mostrando, fra questi<br />
ottimi beni, quale fosse il migliore per gli uomini, ovvero <strong>la</strong> vita degna dell’ essere umano che<br />
nessuno può conseguire senza <strong>pace</strong> e tranquillità.[...]<br />
Tuttavia, poiché “i contrari producono i contrari” 146 , dal<strong>la</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a 147 , che è il contrario del<strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong>, derivano frutti dannosissimi per le comunità politiche: come si può vedere, anzi è noto a<br />
quasi tutti gli uomini, a proposito dell’Italia. Per tutto il tempo in cui i suoi abitanti hanno vissuto<br />
pacificamente, hanno goduto dei frutti del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong> cui abbiamo par<strong>la</strong>to, e sono progre<strong>di</strong>ti<br />
così tanto da sottomettere tutto il mondo abitato. Tuttavia, non appena sono sorte liti e <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>e<br />
tra loro, il loro regno ha cominciato ad essere tormentato da sventure e <strong>di</strong>sgrazie <strong>di</strong> ogni tipo ed<br />
a subire il dominio <strong>di</strong> detestati popoli stranieri. E, d’altra parte, anche oggi, <strong>di</strong> nuovo, esso è <strong>la</strong>cerato,<br />
quasi <strong>di</strong>strutto, dal<strong>la</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a così che può essere invaso facilmente da chiunque voglia<br />
o abbia il potere <strong>di</strong> conquistarlo. [...]<br />
Quei miseri sono dunque precipitati nelle tenebre per <strong>la</strong> loro conflittualità reciproca, che si sa<br />
essere una cattiva <strong>di</strong>sposizione dei governi civili, così come <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ttia lo è per gli animali.<br />
Malgrado le cause originarie del<strong>la</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a siano molteplici e malgrado molte siano legate tra<br />
loro, quasi tutte, potendo manifestarsi nei mo<strong>di</strong> comuni, sono state descritte dal più esimio dei<br />
filosofi nel<strong>la</strong> Scienza civile 148 .<br />
La scienza politica deve indagare quale possa essere il regime che conduce all’armonia: si tratta<br />
<strong>di</strong> un «corpo» in cui le singole componenti cooperino al funzionamento del meccanismo generale.<br />
Tra queste un compito fondamentale assumono il «governo» e il «legis<strong>la</strong>tore».<br />
La città è come una natura animata o come un animale. Infatti, come un animale ben <strong>di</strong>sposto<br />
secondo natura è formato da alcune parti proporzionate, ben or<strong>di</strong>nate tra loro, che si comunicano<br />
reciprocamente le loro funzioni in vista del tutto, così, se è stata ben <strong>di</strong>sposta e istituita secondo<br />
145<br />
CASSIODORO, Varie, I, 1. Uomo politico e scrittore romano del VI secolo, fu attivo sotto il regno <strong>di</strong> Teodorico, in<br />
partico<strong>la</strong>re cercando <strong>di</strong> avvicinare goti e romani.<br />
146<br />
ARISTOTELE, Politica, V, 8, 1307b, 29-30.<br />
147<br />
L’A. ricorda e cita il Sallustio del De bello Jugurthino: “Con <strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a le piccole cose crescono, con <strong>la</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a<br />
le cose più gran<strong>di</strong> vanno in rovina” ( X, 6).<br />
148<br />
Il riferimento è al V libro del<strong>la</strong> Politica aristotelica, in cui l’oggetto <strong>di</strong> indagine sono «le cause per cui le costituzioni<br />
mutano, quante sono e <strong>di</strong> quale natura, in che modo ogni tipo <strong>di</strong> costituzione va in rovina, quali sono gli schemi <strong>di</strong> mutamento<br />
più frequenti» (Politica, V, 1, 1301°, tr. it. a c. <strong>di</strong> C. A. Viano, Torino 1955, p. 213).<br />
38
agione, <strong>la</strong> comunità politica è costituita da parti <strong>di</strong> questo tipo. Sembra esserci una re<strong>la</strong>zione tra<br />
<strong>la</strong> comunità politica, le sue parti e <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, così come esiste una re<strong>la</strong>zione tra l’animale, le sue<br />
parti e <strong>la</strong> salute 149 . Possiamo riconoscere <strong>la</strong> verità <strong>di</strong> questa affermazione logica da ciò che tutti<br />
gli uomini comprendono a proposito <strong>di</strong> ciascuna <strong>di</strong> queste due re<strong>la</strong>zioni. Infatti ritengono che <strong>la</strong><br />
salute consiste nel<strong>la</strong> miglior <strong>di</strong>sposizione dell’animale secondo natura, e che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> consiste<br />
nel<strong>la</strong> miglior <strong>di</strong>sposizione del<strong>la</strong> comunità politica istituita secondo ragione. Ma <strong>la</strong> salute, come<br />
<strong>di</strong>cono i me<strong>di</strong>ci più esperti quando <strong>la</strong> descrivono, è <strong>la</strong> buona <strong>di</strong>sposizione dell’animale attraverso<br />
<strong>la</strong> quale ciascuna delle sue parti può compiere perfettamente le funzioni che si ad<strong>di</strong>cono al<strong>la</strong><br />
sua natura; quin<strong>di</strong>, secondo questa analogia, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> sarà <strong>la</strong> buona <strong>di</strong>sposizione del<strong>la</strong> comunità<br />
politica grazie al<strong>la</strong> quale ciascuna delle sue parti potrà compiere perfettamente le azioni che le si<br />
ad<strong>di</strong>cono secondo ragione e secondo <strong>la</strong> propria istituzione. E poiché chi dà una buona definizione<br />
nello stesso tempo specifica il contrario, l’opposto del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> consisterà nel<strong>la</strong> cattiva <strong>di</strong>sposizione<br />
del<strong>la</strong> comunità politica, così come <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ttia lo è <strong>di</strong> un animale, per cui tutte le sue parti o<br />
alcune non possono svolgere le azioni <strong>di</strong> loro pertinenza, assolutamente o completamente.<br />
Quin<strong>di</strong>, con lo stesso modo allegorico abbiamo par<strong>la</strong>to del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e del suo contrario. […]<br />
Coloro che vivono in modo civile non solo vivono, come fanno gli animali o gli schiavi, ma vivono<br />
una vita degna dell’ essere umano, de<strong>di</strong>candosi così ad attività liberali, come quelle proprie<br />
delle virtù dell’anima sia pratica che specu<strong>la</strong>tiva. [...]<br />
Poiché tra gli uomini così riuniti sorgono litigi e risse che, non rego<strong>la</strong>te da una norma <strong>di</strong> giustizia,<br />
causerebbero <strong>di</strong>spute e <strong>di</strong>visioni tra gli uomini e, in questo modo lo sgreto<strong>la</strong>rsi del<strong>la</strong> comunità<br />
politica, gli uomini hanno dovuto stabilire in questa associazione una legge e il suo custode<br />
o autore. Poiché questo custode ha il potere <strong>di</strong> allontanare coloro che si comportano in modo offensivo<br />
e gli altri singoli in<strong>di</strong>vidui che, tanto all’interno quanto dall’esterno, agitano o tentano <strong>di</strong><br />
opprimere <strong>la</strong> comunità, si è dovuto fare in modo che questa possedesse gli strumenti con cui resistere<br />
a essi.<br />
[...] Visto che sono <strong>di</strong>verse le cose necessarie per gli uomini che vogliono vivere una vita degna<br />
dell’ essere umano, che non possono essere amministrate da uomini <strong>di</strong> un solo or<strong>di</strong>ne o funzione,<br />
è stato necessario che in questa comunità ci fossero <strong>di</strong>verse funzioni o or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> uomini che<br />
potessero così procurare e amministrare le <strong>di</strong>verse cose <strong>di</strong> questo tipo, <strong>di</strong> cui gli uomini hanno<br />
bisogno per vivere una vita degna dell’essere umano. Ma questi or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> uomini o cariche,<br />
non consistono in altro che nel<strong>la</strong> molteplicità e nel<strong>la</strong> <strong>di</strong>stinzione delle parti del<strong>la</strong> comunità<br />
politica. […]<br />
Noi abbiamo anticipato un <strong>di</strong>scorso in generale sulle parti del<strong>la</strong> comunità politica, nel<strong>la</strong> cui azione<br />
e perfetta re<strong>la</strong>zione reciproca, non ostaco<strong>la</strong>ta dall’ esterno, consiste <strong>la</strong> <strong>pace</strong> del<strong>la</strong> comunità.<br />
Ora ripren<strong>di</strong>amo il <strong>di</strong>scorso su <strong>di</strong> esse affinché, con una definizione più compiuta <strong>di</strong> queste<br />
parti, rispetto sia alle loro funzioni o finalità sia alle loro altre cause appropriate, vengano mag<br />
149<br />
Riprendendo <strong>la</strong> metafora organicistica <strong>di</strong> Aristotele, l’A. fa esplicito riferimento a Politica, I, 2 e V, 3, in verità I, 5,<br />
1254a, 31 ss.; e V, 3, 1302b, 34 ss.<br />
39
giormente chiarite le cause del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e del suo contrario; <strong>di</strong>remo che le parti o piuttosto le fun<br />
zioni del<strong>la</strong> comunità politica sono <strong>di</strong> sei tipi: [...] l’artigianato, l’esercito, <strong>la</strong> parte finanziaria, il<br />
sacerdozio e <strong>la</strong> parte giu<strong>di</strong>ziaria o deliberativa. 150 […]<br />
L’istituzione e <strong>la</strong> <strong>di</strong>stinzione delle parti del<strong>la</strong> comunità politica sono prodotte da una certa causa<br />
efficiente che prima abbiamo chiamato legis<strong>la</strong>tore; perciò il legis<strong>la</strong>tore stesso ha stabilito queste<br />
parti, le ha <strong>di</strong>stinte e le separa come fa <strong>la</strong> natura nell’animale, cioè in primo luogo creando o isti<br />
tuendo nel<strong>la</strong> comunità politica una so<strong>la</strong> parte che [...] abbiamo chiamato governo o parte giu<strong>di</strong><br />
ziaria e istituendo, attraverso questa, le altre parti [...]<br />
Il legis<strong>la</strong>tore o causa efficiente prima e specifica del<strong>la</strong> legge è il popolo, o l’intero corpo dei citta<strong>di</strong>ni,<br />
o <strong>la</strong> sua parte prevalente, per mezzo del<strong>la</strong> sua elezione o volontà espressa a parole nell’<br />
assemblea generale dei citta<strong>di</strong>ni, che comanda o specifica che cosa si deve fare o meno riguardo<br />
le azioni civili degli uomini sotto <strong>la</strong> minaccia <strong>di</strong> una pena o punizione temporale: intendo <strong>la</strong> parte<br />
prevalente considerata come quantità e qualità delle persone in quel<strong>la</strong> comunità politica per <strong>la</strong><br />
quale è stata emanata una legge»<br />
La causa del<strong>la</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a civile in Italia è in<strong>di</strong>viduata nell’ingerenza del<strong>la</strong> funzione sacerdotale<br />
in quel<strong>la</strong> governativa. Compete allora al «governante» riprendere il proprio compito e al «legis<strong>la</strong>tore»<br />
porre sotto il proprio controllo <strong>la</strong> chiesa.<br />
Tuttavia c’è una causa insolita del<strong>la</strong> mancanza <strong>di</strong> <strong>pace</strong> o del<strong>la</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a nelle comunità politiche<br />
[...] Questa causa, impedendo continuamente fino a ora, e ora ancora <strong>di</strong> più, l’azione propria del<br />
governante nel regno italico 151 , lo ha privato e lo priva del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e degli altri vantaggi conseguenti<br />
<strong>di</strong> cui abbiamo par<strong>la</strong>to; lo ha tormentato e lo tormenta con ogni <strong>di</strong>sagio, e lo ha quasi<br />
colmato <strong>di</strong> ogni tipo <strong>di</strong> miseria e ingiustizia.<br />
[...] Poiché questa peste rovinosa, profondamente nemica del<strong>la</strong> quiete umana e <strong>di</strong> ogni sua felicità,<br />
potrebbe contaminare, col male del<strong>la</strong> sua stessa ra<strong>di</strong>ce corrotta, gli altri regni cristiani, ritengo<br />
che sia assolutamente necessario allontanar<strong>la</strong>. […]<br />
Se per garantire il benessere temporale del<strong>la</strong> collettività conviene che sia il legis<strong>la</strong>tore a scegliere<br />
le persone alle quali assegnare ogni altro ufficio pubblico e a designare il governante, in modo<br />
che <strong>la</strong> scelta sia <strong>la</strong> migliore possibile e l’ufficio venga conferito al can<strong>di</strong>dato più idoneo [...] a<br />
maggior ragione sembra spettare al legis<strong>la</strong>tore umano o al<strong>la</strong> totalità dei fedeli <strong>la</strong> scelta <strong>di</strong> coloro<br />
150 Il riferimento è ancora al<strong>la</strong> Politica <strong>di</strong> Aristotele, VII, 7, 1328b, 2 ss.<br />
151 I protagonisti storici cui fa riferimento Marsilio sono l’imperatore Ludovico IV <strong>di</strong> Baviera, cui d’altronde l’opera è<br />
esplicitamente de<strong>di</strong>cata, e il papa Giovanni XXII. I due, negli anni ’20 del Trecento, sono al centro <strong>di</strong> un aspro confronto<br />
sul<strong>la</strong> natura dell’istituto imperiale e in partico<strong>la</strong>re sul dominio dell’Italia. Da notare come anche <strong>la</strong> funzione imperiale<br />
sia per Marsilio eminentemente “governativa”. L’imperatore amministra <strong>la</strong> giustizia, ma <strong>la</strong> sua autorità deriva dal legis<strong>la</strong>tore,<br />
ovvero l’insieme dei popoli che vivono nel territorio dell’Impero. Questo processo è descritto in modo esplicito<br />
in un’opera più tarda del Padovano, il Defensor minor (1342), da leggersi in tutto come integrazione (e in alcuni passaggi<br />
rettifica) delle posizioni espresse nel Defensor pacis.<br />
40
che debbono essere nominati sacerdoti, come pure il potere <strong>di</strong> affidare ad alcuni <strong>di</strong> loro <strong>la</strong> guida<br />
delle <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>ocesi 152 .<br />
152 Per questa via, nel pensiero marsiliano, vengono a coincidere universitas civium e universitas fidelium. Nel<strong>la</strong> duplice<br />
veste civile e religiosa <strong>la</strong> comunità stabilisce le regole in ogni ambito del<strong>la</strong> propria esistenza. Qualora esistessero regole<br />
valide sul<strong>la</strong> comunità religiosa non provenienti dal legis<strong>la</strong>tore umano ma dal<strong>la</strong> parte sacerdotale, sarebbe costantemente<br />
minata l’unità e <strong>la</strong> stabilità del corpo politico: in quanto fedele, il citta<strong>di</strong>no si troverebbe ad obbe<strong>di</strong>re a regole alternative<br />
a quelle civili.<br />
41
2. L’elogio antibellicista<br />
ERASMO<br />
Intraprese per volontà dei principi,<br />
[le guerre] furono condotte con grave danno del popolo,<br />
cui non interessavano per nul<strong>la</strong><br />
Nel<strong>la</strong> prima parte de Il <strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> 153 l’A. si sofferma sul<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione dell’uomo che,<br />
concepito dal<strong>la</strong> natura per essere l’animale più pacifico del creato, produce nel<strong>la</strong> società <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a e<br />
conflitto perenni. Ad ogni livello l’uomo è portato a combattere con il proprio simile: nel<strong>la</strong> politica<br />
come nel<strong>la</strong> chiesa, tra gli stu<strong>di</strong>osi come dentro il nucleo familiare; ciò è conseguenza <strong>di</strong> una non pacificata<br />
situazione che l’uomo sconta in prima istanza verso se stesso, con il proprio animo.<br />
Solo gli uomini, ai quali più che a tutti si ad<strong>di</strong>ceva <strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a unanime, che più <strong>di</strong> tutti ne<br />
hanno bisogno, solo essi <strong>la</strong> natura, in tante altre cose potente ed efficace, non riesce a riconciliare,<br />
né li unisce l’educazione, né li mettono d’accordo i tanti vantaggi che deriverebbero loro dal<br />
consenso, né infine <strong>la</strong> provata esperienza <strong>di</strong> mali sì gran<strong>di</strong> li riconduce al reciproco amore. [...]<br />
In tutti gli uomini sono stati instil<strong>la</strong>ti i semi delle scienze e delle virtù, un’indole mite e pacifica,<br />
<strong>la</strong> propensione al reciproco affetto, per cui è bello essere amati, e dolce fare del bene senza interesse,<br />
a meno che uno sia corrotto da desideri malvagi che, come i farmaci <strong>di</strong> Circe 154 , lo facciano<br />
degenerare da uomo in animale. È anzi proprio per questo che <strong>la</strong> gente chiama ‘umano’<br />
quanto tende al reciproco affetto, sì che il termine ‘umanità’ in<strong>di</strong>ca non tanto <strong>la</strong> nostra natura,<br />
quanto piuttosto una condotta degna del<strong>la</strong> natura dell’uomo. [...] La natura ci ha insegnato <strong>la</strong><br />
concor<strong>di</strong>a in tutti i mo<strong>di</strong>. [...]<br />
Quando sento <strong>di</strong>re ‘uomo’, subito mi s<strong>la</strong>ncio come verso un essere nato per me, fiduciosa <strong>di</strong><br />
trovare ricetto e riposo; quando sento fare il nome dei cristiani, volo ad<strong>di</strong>rittura sperando <strong>di</strong> regnare<br />
tra loro. Eppure <strong>di</strong> nuovo, devo <strong>di</strong>rlo con vergogna e pena, piazze e pa<strong>la</strong>zzi, tribunali e<br />
templi, da ogni parte risuonano <strong>di</strong> liti, quante mai se ne sentono presso i pagani [...] Scorgo una<br />
città; nasce subito <strong>la</strong> speranza: almeno costoro andranno d’accordo, riparati dalle stesse mura,<br />
rego<strong>la</strong>ti dalle stesse leggi, riuniti dal comune pericolo come i passeggeri del<strong>la</strong> stessa nave. Infelice!<br />
anche qui tutto è straziato dai <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>, tanto che mi è ben <strong>di</strong>fficile trovare una casa che mi<br />
153<br />
I brani <strong>di</strong> seguito riportati sono tratti da ERASMO DA ROTTERDAM, Il <strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, a c. <strong>di</strong> Luigi Firpo, Mi<strong>la</strong>no,<br />
TEA, 1993, pp. 112-5, 147-53.<br />
154<br />
Come è narrato nell’O<strong>di</strong>ssea (IX, 210-43), con una pozione malefica <strong>la</strong> maga Circe aveva trasformato i compagni <strong>di</strong><br />
Ulisse in maiali.<br />
42
ospiti per qualche giorno. Ma <strong>la</strong>scio il popolo, agitato come il mare dalle tempeste delle sue<br />
passioni.<br />
Come in un porto mi rifugio nelle sale dei principi. Senza dubbio, vi sarà qui, mi <strong>di</strong>co, un posto<br />
per <strong>la</strong> Pace; questi sono più saggi del volgo; sono essi <strong>la</strong> coscienza e l’occhio del popolo. [...]<br />
Vedo i saluti gentili, gli abbracci amichevoli, i brin<strong>di</strong>si allegri, e gli altri doveri del<strong>la</strong> cortesia.<br />
Purtroppo, cosa indegna, non mi è riuscito <strong>di</strong> scorgere neppure l’ombra del<strong>la</strong> vera concor<strong>di</strong>a.<br />
Tutto è falso, finto; tutto è corrotto da fazioni palesi e da <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong> e contrasti segreti. Al<strong>la</strong> fine mi<br />
rendo conto che presso costoro non solo non c’è posto per <strong>la</strong> Pace, ma che proprio lì è il fonte, il<br />
seme <strong>di</strong> tutte le guerre. Dove, dunque, recarmi, dopo tante speranze deluse? Ma forse i principi<br />
sono gran<strong>di</strong> piuttosto che dotti, e si <strong>la</strong>sciano guidare dal<strong>la</strong> cupi<strong>di</strong>gia piuttosto che dal retto giu<strong>di</strong>zio.<br />
[...]<br />
Cosa mi resta, se non <strong>la</strong> santa àncora <strong>di</strong> salvezza del<strong>la</strong> religione? La sua pratica, ancorché comune<br />
a tutti i cristiani, è tuttavia peculiare, per il titolo, il culto, i riti, a coloro che sono comunemente<br />
onorati del nome <strong>di</strong> sacerdoti. Visti da lontano, tutto mi fa sperare che un porto <strong>di</strong> salvezza<br />
mi attenda. [... ]E invece, ed è cosa indegna, quasi mai il collegio è d’accordo col vescovo;<br />
e questo sarebbe poco, se gli stessi sacerdoti non fossero <strong>di</strong>visi in fazioni. [...] Un’ultima<br />
speranza mi arrideva: che fra tante famiglie, ci fosse pure, da qualche parte, un posto qualunque<br />
per me. [...] Ma anche qui si è insinuata <strong>la</strong> scelleratissima dea del<strong>la</strong> Discor<strong>di</strong>a, a <strong>di</strong>videre con i<br />
contrasti degli animi coloro che tanti legami dovrebbero congiungere. E tuttavia qui vorrei trovare<br />
il mio posto, piuttosto che fra coloro che con tanti titoli, con tanta pompa, con tante cerimonie,<br />
vanno proc<strong>la</strong>mando il sommo amore. Al<strong>la</strong> fine cominciai a desiderare che mi offrisse rifugio<br />
il petto <strong>di</strong> un sol uomo. Neppur questo mi è toccato, perché ogni uomo è in lotta con se<br />
stesso. La ragione è in lotta con gli affetti, <strong>la</strong> passione con <strong>la</strong> passione; mentre <strong>la</strong> pietà trae da<br />
una parte, <strong>la</strong> cupi<strong>di</strong>gia sollecita dall’altra. La sensualità suggerisce una cosa, un’altra l’ira,<br />
un’altra l’ambizione, un’altra ancora l’avi<strong>di</strong>tà.<br />
Oltre che <strong>la</strong> natura umana è l’insegnamento cristiano ad entrare in contrad<strong>di</strong>zione con l’indole<br />
non pacifica dell’uomo. Cristo è stato l’esempio <strong>di</strong> come l’uomo debba vivere in <strong>pace</strong>, dando in<strong>di</strong>cazione<br />
affinché <strong>la</strong> sua Chiesa fosse fondata sul<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a. Le guerre, in partico<strong>la</strong>re quelle condotte<br />
tra cristiani, rappresentano <strong>la</strong>cerazioni ancora più inaccettabili del corpo mistico dei fedeli.<br />
Considera <strong>la</strong> vita del Cristo. Che altro è, se non una lezione <strong>di</strong> <strong>pace</strong> e <strong>di</strong> reciproco amore? Che<br />
altro insegnano i suoi precetti, le sue parabole se non <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e il reciproco affetto? [...]<br />
Chi annuncia Cristo, annuncia <strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Chi pre<strong>di</strong>ca <strong>la</strong> guerra, pre<strong>di</strong>ca colui che è il più <strong>di</strong>ssimile<br />
da Cristo. Perché mai venne in terra il figlio <strong>di</strong> Dio, se non per riconciliare il mondo col Padre?<br />
per unire gli uomini fra loro con un reciproco in<strong>di</strong>ssolubile amore? infine per farsi amico<br />
l’uomo. [...]<br />
43
Togli lo spirito dal corpo; subito si <strong>di</strong>ssolve l’unità delle membra. Togli <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, e perisce ogni<br />
società <strong>di</strong> vita cristiana. [...] Che il popolo cristiano si chiami ‘chiesa’, che altro in<strong>di</strong>ca se non<br />
l’unanimità? Ma che cosa hanno in comune accampamenti militari e chiesa? Chiesa significa<br />
unione, accampamento militare conflitto. Se ti vanti d’essere parte del<strong>la</strong> chiesa, che hai a che fare<br />
con <strong>la</strong> guerra? se sei lontano dal<strong>la</strong> chiesa, che cosa hai a che fare con Cristo?<br />
La causa principale delle guerre è <strong>la</strong> brama <strong>di</strong> possesso dei governanti, che utilizzano pretesti<br />
pseudolegali per accampare pretese territoriali. Per un cristiano non può esistere una giusta causa <strong>di</strong><br />
guerra. L’interesse privato viene assurto a obiettivo dello stato, mentre <strong>la</strong> felicità pubblica ne viene<br />
estromessa: al<strong>la</strong> guerra si accompagna così sempre <strong>la</strong> presa oppressiva del tiranno sul popolo, mentre<br />
tutti si appel<strong>la</strong>no regnanti cristiani. Poco e<strong>di</strong>ficante è anche l’esempio del<strong>la</strong> chiesa, per nul<strong>la</strong> <strong>di</strong>sposta<br />
a condannare l’empietà <strong>di</strong> simile condotta, e anzi impegnata a fomentare e condurre nuove<br />
campagne militari.<br />
Salgono [...] le fiamme al viso a ricordare le cause vergognose e inconsistenti per cui i principi<br />
cristiani chiamano il mondo al<strong>la</strong> guerra. L’uno trova, o inventa, un titolo scaduto o stantio, come<br />
se importi molto chi sia ad amministrare, se rettamente amministra per il bene pubblico. Un altro<br />
denuncia non so che omissione in un trattato <strong>di</strong> cento capitoli. Un altro ancora ha dei rancori<br />
privati perché gli hanno portato via <strong>la</strong> promessa sposa, o per un’uscita troppo libera nei suoi<br />
confronti. Ma più scellerati <strong>di</strong> tutti quanti sono quelli che, rendendosi conto che <strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a<br />
popo<strong>la</strong>re limita il potere del principe, mentre i contrasti lo rafforzano con perfi<strong>di</strong>a tirannica mettono<br />
su chi ecciti <strong>di</strong> proposito i conflitti, in modo da <strong>di</strong>videre il popolo unito, più facilmente<br />
spogliando così i sud<strong>di</strong>ti infelici. Questo fanno uomini scelleratissimi, che si alimentano dei mali<br />
del popolo, e che in tempo <strong>di</strong> <strong>pace</strong> hanno ben poco da fare nello Stato. Ma quale furia infernale<br />
ha potuto instil<strong>la</strong>re questo veleno in petti cristiani? Chi ha insegnato ai cristiani questa tirannide,<br />
ignota a Dionigi, a Mezenzio, a Fa<strong>la</strong>ride 155 ? Belve piuttosto che uomini, nobilitati solo dal<strong>la</strong><br />
tirannide, dotati solo del<strong>la</strong> capacità <strong>di</strong> nuocere, in nul<strong>la</strong> concor<strong>di</strong> se non nell’opprimere lo Stato.<br />
Eppure i colpevoli <strong>di</strong> tali misfatti sono considerati cristiani, e coperti <strong>di</strong> sangue cristiano entrano<br />
nelle chiese e si accostano agli altari, essi degni solo <strong>di</strong> essere deportati in isole remote. Se<br />
i cristiani sono come le membra <strong>di</strong> un solo corpo, perché non si rallegra ognuno dell’altrui felicità?<br />
Oggi sembra quasi una giusta causa <strong>di</strong> guerra, che il regno confinante sia, in tutte le cose<br />
sue, un poco più fondo. [...]<br />
155 I tre personaggi storici citati sono esempi emblematici <strong>di</strong> tirannia nell’epoca c<strong>la</strong>ssica. Fa<strong>la</strong>ride fu tiranno <strong>di</strong> Agrigento<br />
nel VI sec. a. C.; Mezenzio fu tiranno <strong>di</strong> Cere, città etrusca, nel IV sec.; a partire dal 405 e per buona parte del IV<br />
secolo su Siracusa tiranneggiarono Dionigi I e in seguito il figlio Dionigi II.<br />
44
Se poi non si sanno ricordare le guerre lontane, chi vuole torni con <strong>la</strong> memoria a quelle <strong>di</strong> questi<br />
ultimi do<strong>di</strong>ci anni 156 , ne ripensi le cause e troverà che tutte, intraprese per volontà dei prìncipi,<br />
furono condotte con grave danno del popolo, a cui non interessavano per nul<strong>la</strong>.<br />
Neppure i loro sacerdoti si vergognano <strong>di</strong> fare <strong>la</strong> guerra, quei sacerdoti a cui un tempo Dio, perfino<br />
nel<strong>la</strong> dura e crudele legge <strong>di</strong> Mosè, vietò <strong>di</strong> macchiarsi <strong>di</strong> sangue. Non si vergognano i teologi<br />
cristiani, maestri <strong>di</strong> vita; non si vergognano quanti professano una vita rigidamente religiosa;<br />
non si vergognano i vescovi, i car<strong>di</strong>nali, i vicari <strong>di</strong> Cristo 157 : non si vergognano <strong>di</strong> farsi promotori<br />
e fiaccole <strong>di</strong> quelle guerre che Cristo ha così profondamente detestato. Che ha a che fare<br />
<strong>la</strong> mitra con l’elmo? il pastorale con <strong>la</strong> spada? il Vangelo con lo scudo? Come è possibile salutare<br />
il popolo con l’augurio del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, e insieme spingere il mondo alle più violente battaglie?<br />
Per conciliare le controversie tra gli stati bisogna giu<strong>di</strong>care sempre coll’intenzione <strong>di</strong> conservare<br />
<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a tra le genti cristiane. Se poi il governo tirannico è <strong>la</strong> mol<strong>la</strong> del<strong>la</strong> guerra, per costruire<br />
<strong>la</strong> <strong>pace</strong> bisognerà partire da un miglioramento del rapporto tra principi e popoli. Erasmo elenca infine<br />
quali garanzie <strong>di</strong> stabilità possano essere date all’assetto internazionale, per evitare che da esso<br />
sorgano motivi <strong>di</strong> guerra tra i governanti.<br />
156<br />
Ci sono leggi, ci sono saggi, veneran<strong>di</strong> abati, vescovi reveren<strong>di</strong>, col cui salutare consiglio è possibile<br />
comporre i contrasti. Perché non ricorrere al loro arbitrato? non potranno mai essere così<br />
iniqui da procurare danni maggiori del ricorso alle armi. Nessuna <strong>pace</strong> sarà mai così iniqua da<br />
non essere preferibile al<strong>la</strong> più giusta delle guerre. Considera prima tutto quello che una guerra<br />
comporta, e reca con sé, e capirai che razza <strong>di</strong> guadagno ci farai. […]<br />
Se sinceramente avversate <strong>la</strong> guerra, vi darò un consiglio per mantenere <strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Una <strong>pace</strong> sicura<br />
non è fondata né su parentele <strong>di</strong> principi, né su trattati, dai quali anzi ve<strong>di</strong>amo che spesso<br />
traggono origine le guerre. Bisogna purificare le fonti da cui questo ma<strong>la</strong>nno scaturisce: sono le<br />
cupi<strong>di</strong>gie scellerate a generare questi sconvolgimenti. [...]Tutto commisurino all’interesse dello<br />
Stato, e in tal modo provvederanno meglio anche ai propri interessi. Un re che senta in questo<br />
modo si <strong>la</strong>scerà mai indurre a estorcere ricchezze ai sud<strong>di</strong>ti per assoldare barbari mercenari? Ridurrà<br />
mai i suoi al<strong>la</strong> fame per arricchire qualche crudele condottiero? Esporrà <strong>la</strong> vita dei suoi a<br />
tanti pericoli? Non credo. Eserciti il comando ricordando che è un uomo che comanda a uomini<br />
un uomo libero che comanda a uomini liberi, infine un cristiano che comanda a cristiani. A sua<br />
volta il popolo gli deve obbe<strong>di</strong>enza per quanto contribuisce al<strong>la</strong> pubblica utilità. Nul<strong>la</strong>ltro esige<br />
un buon principe. La cupi<strong>di</strong>gia del cattivo principe sarà arginata dal<strong>la</strong> volontà unanime dei cit<br />
157 Il riferimento, come è esplicitato in altri passaggi dello scritto, è a Giulio II (al secolo Giuliano del<strong>la</strong> Rovere), protagonista<br />
nel<strong>la</strong> Lega antiveneziana <strong>di</strong> Cambrai (1508) e ad<strong>di</strong>rittura ispiratore del<strong>la</strong> Lega Santa contro il re francese Luigi<br />
XII (1511).<br />
45
ta<strong>di</strong>ni. Da entrambe le parti si faccia il debito conto dell’interesse dei singoli. Il massimo<br />
dell’onore abbiano quanti avranno allontanata <strong>la</strong> guerra e restituita <strong>la</strong> <strong>pace</strong> con le loro capacità e<br />
il loro consiglio. […]<br />
Infine gran parte del<strong>la</strong> causa del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> sta nel volere <strong>la</strong> <strong>pace</strong> dal fondo dell’anima. Quelli infatti<br />
che hanno davvero a cuore <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, afferrano tutte le occasioni <strong>di</strong> <strong>pace</strong>; gli ostacoli, o non considerano,<br />
o rimuovono, e molto sopportano purché sia salvo un bene così grande. Ora invece si<br />
vanno a cercare fonti <strong>di</strong> guerra; quello che contribuisce a generare concor<strong>di</strong>a si sminuisce, e perfino<br />
si nasconde; quello che tende al<strong>la</strong> guerra, si ingran<strong>di</strong>sce e si esaspera. Ho ritegno a riferire<br />
le trage<strong>di</strong>e che si riesce a far nascere da futilità d’ogni genere, le catastrofi che nascono da una<br />
minima scintil<strong>la</strong>. Si rievocano a schiere le offese ricevute; ognuno esagera i1 male che gli è stato<br />
fatto, mentre dei benefizi è così profondo l’oblio, che potresti giurare che si va cercando <strong>la</strong><br />
guerra. Spesso è l’interesse privato del principe che spinge il mondo al<strong>la</strong> guerra, mentre il motivo<br />
per far<strong>la</strong> dovrebbe essere un rilevante interesse pubblico. E invece, quando non ci sono cause,<br />
sono proprio i prìncipi a foggiare le cause dei conflitti, servendosi perfino delle denominazioni<br />
dei vari paesi per alimentare gli o<strong>di</strong> reciproci. E l’errore del<strong>la</strong> stupida plebe i magnati alimentano,<br />
e con loro certi sacerdoti, per servirsene indebitamente a proprio vantaggio. L’inglese<br />
è nemico del francese per <strong>la</strong> so<strong>la</strong> ragione che questi è francese. Lo scozzese, solo perché è scozzese,<br />
detesta l’inglese. Il tedesco litiga col francese, lo spagnuolo con tutti e due. Quale malvagità!<br />
<strong>la</strong> vuota denominazione <strong>di</strong> una terra li <strong>di</strong>vide, ma perché mai non li uniscono tante altre cose?<br />
Tu, inglese, detesti il francese? Ma perché mai, invece, non vuoi bene a chi è un uomo come<br />
te, uomo all’uomo, cristiano al cristiano? [...]<br />
Ma, forse, ti sembra prova <strong>di</strong> animo poco nobile perdonare le offese; e invece non c’è prova più<br />
sicura <strong>di</strong> animo meschino, e niente affatto regio, del<strong>la</strong> vendetta. Tu cre<strong>di</strong> <strong>di</strong> venir meno al<strong>la</strong> tua<br />
<strong>di</strong>gnità regale, se trattando con un principe confinante, magari parente o affine, che forse in altri<br />
casi ha perfino ben meritato, rinunci a qualche minima cosa a cui avevi <strong>di</strong>ritto. Eppure quanto<br />
più in basso trascini <strong>la</strong> tua maestà quando sei costretto a comprare bande <strong>di</strong> barbari, ultima feccia<br />
<strong>di</strong> delinquenti sempre insaziabili, o quando umile e supplice man<strong>di</strong> ambasciatori a mercenari<br />
vilissimi e pericolosissimi, quando affi<strong>di</strong> <strong>la</strong> stessa tua vita, e le fortune dei tuoi, al<strong>la</strong> fede <strong>di</strong> chi<br />
non ha nul<strong>la</strong> <strong>di</strong> stimabile, né <strong>di</strong> sacro. E se ti sembrerà che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> ti costi, non pensare: ci rimetto<br />
questo; ma, piuttosto a questo prezzo compro <strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
A questo punto, forse, qualcuno <strong>di</strong>rà, con maggior sottigliezza: concederei tutto senza <strong>di</strong>fficoltà,<br />
se si trattasse <strong>di</strong> una questione privata. Sono un principe e, mi piaccia o meno, tratto un affare <strong>di</strong><br />
pubblico interesse. In realtà non sarà facile che <strong>di</strong>chiari una guerra chi non pensa che al pubblico<br />
interesse. Ve<strong>di</strong>amo al contrario che quasi tutte le cause <strong>di</strong> guerra nascono da cose che non riguardano<br />
affatto il popolo.<br />
46
3. Tra <strong>di</strong>ritto delle genti e psicologia politica<br />
GROZIO<br />
La <strong>pace</strong> è più sicura del<strong>la</strong> speranza <strong>di</strong> vincere una guerra<br />
Ugo Grozio 158 nel De Jure Belli ac Pacis (1625) 159 illustra i car<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> quel <strong>di</strong>ritto internazionale<br />
con cui si sarebbero dovuti rego<strong>la</strong>re i mo<strong>di</strong> del<strong>la</strong> guerra e conseguentemente del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
E <strong>la</strong> buona fede deve essere preservata, non solo per altre ragioni ma anche perché <strong>la</strong> speranza<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong> non deve essere mai abbandonata. Perché non solo ogni stato è sostenuto dal<strong>la</strong> buona<br />
fede, come <strong>di</strong>chiara Cicerone 160 , ma anche <strong>la</strong> più grande società degli stati. [...]<br />
Ancora, durante l’intero periodo in cui viene condotta una guerra l’anima non può essere tenuta<br />
serena e fiduciosa in Dio se non guarda sempre verso <strong>la</strong> <strong>pace</strong>. E’ verissimo ciò che <strong>di</strong>ce Sallustio:<br />
“I sapienti conducono <strong>la</strong> guerra col fine del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>” 161 . Con questa si accompagna<br />
l’opinione <strong>di</strong> Agostino: “Non cercare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> per far nascere una guerra, ma conduci <strong>la</strong> guerra<br />
affinché sia ottenuta <strong>la</strong> <strong>pace</strong>” 162 . Aristotele stesso in più <strong>di</strong> un punto 163 condanna coloro che si<br />
de<strong>di</strong>cano al<strong>la</strong> guerra come fosse il loro ultimo scopo.[...]<br />
Se dunque <strong>la</strong> <strong>pace</strong> può essere assicurata, essa in buona sostanza si identifica con <strong>la</strong> remissione<br />
delle crudeltà, delle per<strong>di</strong>te umane e dei danni subiti: in partico<strong>la</strong>r modo tra i Cristiani, cui Dio<br />
inviò <strong>la</strong> sua <strong>pace</strong>. Di quest’ultima egli ci vuole i migliori interpreti, per quanto è in noi possibile,<br />
dal momento che cercare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è prerogativa <strong>di</strong> tutti. L’uomo buono suscita e porta a termine<br />
una guerra sempre malvolentieri.<br />
Proponendo i mo<strong>di</strong> legali con cui è possibile portare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> dopo una guerra, Grozio pone <strong>di</strong><br />
nuovo al centro gli stati sovrani. Essi sono ancora i protagonisti del <strong>di</strong>ritto internazionale: se hanno<br />
158<br />
Grozio (nome italianizzato dal fiammingo Huig van Groot, altresì noto all’epoca col nome <strong>la</strong>tino <strong>di</strong> Hugo Grotius)<br />
vive da protagonista politico <strong>la</strong> lotta che le Province Unite conducono contro gli Spagnoli per l’in<strong>di</strong>pendenza e che, iniziata<br />
negli ultimi decenni del ‘500, si concluderà solo con <strong>la</strong> fine del<strong>la</strong> Guerra dei Trent’anni (1648). Anche <strong>la</strong> protestante<br />
O<strong>la</strong>nda è sconvolta da una <strong>di</strong>sputa religiosa <strong>di</strong> cui Grozio farà le spese con un forzato esilio: il suo capo<strong>la</strong>voro,<br />
De Jure Belli ac Pacis, viene infatti pubblicato a Parigi nel 1625 e de<strong>di</strong>cato al re Luigi XIII. Nel pieno del<strong>la</strong> guerra, il<br />
libro ha un successo e una circo<strong>la</strong>zione imme<strong>di</strong>ata.<br />
159<br />
I brani che seguono sono traduzioni originali basate sull’e<strong>di</strong>zione del 1696 (Hugonis Grotii, De jure belli et (sic) pacis<br />
libri tres, Francofurti ad Moenum, typis Juannis Baveri, MDCXCVI, III, XX – III, XXV).<br />
160<br />
«Nec enim ul<strong>la</strong> res vehementius rempublicam continet, quam fides» (De Offic., II. XXIV).<br />
161<br />
«Postremo sapientes, pacis causa, bellum gerunt, <strong>la</strong>borem spe otii sustentant» (Epistu<strong>la</strong> ad Caesarem. De Re publica<br />
or<strong>di</strong>nanda, XL).<br />
162<br />
«Non enim pax quaeritur, ut bellum excitetur: sed bellum geritur, ut pax adquiratur» (Epistu<strong>la</strong> ad Bonifacium,<br />
CCVII).<br />
163<br />
47
<strong>la</strong> capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare guerra, per loro è prevista anche <strong>la</strong> possibilità <strong>di</strong> cominciare uno dei percor<br />
si verso <strong>la</strong> pacificazione. I trattati <strong>di</strong> <strong>pace</strong>, in partico<strong>la</strong>re, proprio perché si reggono sul<strong>la</strong> volontà po<br />
litica (degli stati) e hanno come garanzia <strong>la</strong> loro forza, godono <strong>di</strong> più forte e durevole stabilità.<br />
Tra le cause che portano a terminare una guerra alcune sono principali, altre accessorie. Sono<br />
principali quelle che concludono una guerra o per propria azione, come i trattati, o attraverso il<br />
consenso dato a qualche altro elemento, come il giu<strong>di</strong>zio del<strong>la</strong> sorte, l’esito <strong>di</strong> un duello, o il<br />
pronunciamento <strong>di</strong> un arbitro. Degli ultimi tre, il primo si basa sul puro caso, mentre gli altri<br />
due combinano il caso con le qualità del<strong>la</strong> mente e del corpo, o con <strong>la</strong> capacità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio [...]<br />
Giungere ad accor<strong>di</strong> che pongano fine al<strong>la</strong> guerra è prerogativa <strong>di</strong> coloro che possono anche iniziare<br />
un conflitto, ciascuno è infatti rego<strong>la</strong>tore <strong>di</strong> ciò che è <strong>di</strong> propria competenza. Da ciò consegue<br />
che in una guerra pubblica 164 da entrambe le parti in lotta questo potere appartenga a coloro<br />
che hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare il potere sovrano.<br />
Laddove non siano compresenti le concause ottimali <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> <strong>pace</strong>, è comunque possibile<br />
arrivare a una <strong>pace</strong> legale. Straor<strong>di</strong>naria è <strong>la</strong> possibilità <strong>di</strong> affidarsi al<strong>la</strong> sorte, vista comunque<br />
come un atto volontario del sovrano politico.<br />
L’esito <strong>di</strong> una guerra non può in tutti i casi essere lecitamente soggetto al<strong>la</strong> sorte, ma solo in<br />
quei casi in cui <strong>la</strong> materia è una <strong>di</strong> quelle sopra cui abbiamo pieno potere. Infatti lo stato è strettamente<br />
obbligato verso <strong>la</strong> vita, <strong>la</strong> virtù e simili aspetti da tute<strong>la</strong>re dei sud<strong>di</strong>ti; mentre il re è obbligato<br />
verso il bene dello stato [...] Se ad un’attenta analisi <strong>la</strong> parte attaccata in una guerra ingiusta<br />
si reputi così tanto più debole da non avere speranza <strong>di</strong> resistere, può avvenire comunque<br />
<strong>di</strong> mostrarsi combattiva, in considerazione del fatto che un pericolo certo può essere evitato attraverso<br />
il ricorso a uno incerto; in tal caso questo è il minore dei mali. [...]<br />
I duelli sono concordati su un numero stabilito <strong>di</strong> combattenti, per il fine <strong>di</strong> terminare una guerra<br />
165 [...]<br />
164 Come Grozio ha precedentemente spiegato, <strong>la</strong> guerra può essere condotta tra stati, e ha quin<strong>di</strong> il criterio del<strong>la</strong> pubblicità,<br />
tra una parte statuale e una non (mista), oppure tra privati.<br />
165 Grozio spiega che «tali combattimenti,[sono] per esempio, con uno in ogni parte, come quello <strong>di</strong> Enea e Turno, o <strong>di</strong><br />
Mene<strong>la</strong>o e Paride ; con due per ciascuna parte, come quello tra gli Etoli e gli Elei; con tre per ogni parte, come quello<br />
tra gli Orazi, che erano Romani, e i Curiazi, che erano Albani; o con trecento per ogni parte, come quello tra Lacedemoni<br />
e Argivi». Con il duello combattuto tra il troiano Enea e il rutulo Turno si conclude l’Eneide <strong>di</strong> Virgilio, nel XII<br />
libro: tale episo<strong>di</strong>o termina <strong>la</strong> guerra in Italia per il possesso del territorio su cui sorgerà Alba Longa. Nel III libro<br />
dell’Iliade viene narrato il duello tra il principe troiano Paride e Mene<strong>la</strong>o, re spartano, che avrebbe dovuto terminare il<br />
conflitto tra <strong>la</strong> città <strong>di</strong> Troia e gli eserciti achei. La leggenda romana (ripresa da Livio nel suo Ab urbe con<strong>di</strong>ta, I, 24-25)<br />
narra lo scontro dei tre fratelli romani e tre albani per decidere <strong>la</strong> guerra tra Roma e Alba Longa avvenuta all'epoca del<br />
re Tullo Ostilio. L’ultimo duello ricordato avvenne durante <strong>la</strong> guerra tra Argivi e Spartani per <strong>la</strong> contesa del<strong>la</strong> regione<br />
del<strong>la</strong> Tirea. Ne fanno menzione Erodoto (Storie, I, 82), Stobaeus (Florilegium,opera conosciuta anche con il titolo <strong>di</strong><br />
Sermones, VII,.68) e Valerio Massimo (Factorum et Dictorum Memorabilium, III, 2-4).<br />
48
HOBBES<br />
Proculo 166 ci insegna che ci sono due tipi <strong>di</strong> arbitrati. Un tipo è quello a cui dovremmo rendere<br />
obbe<strong>di</strong>enza sia se è giusto che ingiusto; e questo tipo <strong>di</strong> arbitrato, <strong>di</strong>ce, si attua quando le parti<br />
ricorrono a un arbitro con un compromesso. Nell’altro caso <strong>la</strong> decisione dell’arbitro deve essere<br />
accolta nel<strong>la</strong> misura in cui rispecchia criteri <strong>di</strong> onestà ed equità. [...] Un arbitro può essere scelto<br />
in entrambi i mo<strong>di</strong>. O è scelto con il fine del<strong>la</strong> so<strong>la</strong> riconciliazione, come leggiamo per gli Ate<br />
niesi quando furono scelti come arbitri tra i Ro<strong>di</strong> e Demetrio 167 ; oppure egli serve come uno <strong>la</strong><br />
cui decisione deve essere assolutamente obbe<strong>di</strong>ta. Con questa tipologia abbiamo a che fare in<br />
questa sede [par<strong>la</strong>ndo del<strong>la</strong> questione <strong>di</strong> creare <strong>la</strong> <strong>pace</strong>], come abbiamo fatto in precedenza<br />
quando abbiamo par<strong>la</strong>to dei meto<strong>di</strong> per evitare <strong>la</strong> guerra.<br />
La prima e fondamentale legge <strong>di</strong> natura<br />
è cercare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e conseguir<strong>la</strong><br />
Nel Leviatano (1651) 168 <strong>di</strong> Hobbes il problema del<strong>la</strong> costruzione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> coincide con il pas<br />
saggio allo stato politico. La guerra come con<strong>di</strong>zione naturale dell’uomo si esprime in una <strong>di</strong>namica<br />
antisociale che è totalizzante del<strong>la</strong> vita dell’uomo.<br />
La natura ha fatto gli uomini così uguali nelle facoltà del corpo e del<strong>la</strong> mente che, sebbene a<br />
volte si trovi un uomo <strong>di</strong> fisico palesemente più forte o <strong>di</strong> mente più acuta <strong>di</strong> un altro, tuttavia<br />
quando si calco<strong>la</strong> tutto insieme, <strong>la</strong> <strong>di</strong>fferenza tra uomo e uomo non è così considerevole che uno<br />
possa pretendere per sé qualsiasi beneficio che anche un altro non possa pretendere. […]<br />
Da questa uguaglianza <strong>di</strong> abilità nasce l’uguaglianza del<strong>la</strong> speranza <strong>di</strong> ottenere i nostri scopi.<br />
Quin<strong>di</strong>, se due uomini desiderano <strong>la</strong> stessa cosa, che però non può essere posseduta da entrambi,<br />
<strong>di</strong>ventano nemici, e sul<strong>la</strong> strada verso il loro scopo (che è principalmente <strong>la</strong> propria conservazione<br />
e a volte soltanto il loro piacere) cercano <strong>di</strong> sottomettersi e <strong>di</strong> <strong>di</strong>struggersi l’un l’altro. [...]<br />
Con questo è evidente che, per tutto il tempo in cui gli uomini vivono senza un potere comune<br />
che li tenga soggiogati, si trovano in quel<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione chiamata guerra e questa guerrra è tale<br />
che ogni uomo è contro ogni uomo. Infatti, <strong>la</strong> GUERRA non consiste soltanto nelle battaglie o<br />
166<br />
Lo spunto è ripreso dal<strong>la</strong> V Episto<strong>la</strong> <strong>di</strong> Proculo inserita nel Digesto giustinianeo (Lib. XVII. Tit. II. Pro socio, Leg.<br />
LXXVI).<br />
167<br />
Il riferimento è alle Vite parallele <strong>di</strong> Plutarco, nel<strong>la</strong> parte de<strong>di</strong>cata al<strong>la</strong> vita del re <strong>di</strong> Macedonia Demetrio Poliorcete.<br />
Il <strong>di</strong>adoco è accostato ad Antonio sotto un profilo negativo: il primo coinvolto nello scontro per l’ere<strong>di</strong>tà politica <strong>di</strong> Alessandro<br />
Magno, il secondo nell’ultima fase delle guerre civili scatenatesi a Roma dopo l’uccisione <strong>di</strong> Cesare.<br />
168<br />
I brani che seguono fanno riferimento a TH. HOBBES, Leviatano, a c. <strong>di</strong> R. Santi, Mi<strong>la</strong>no, Bompiani, 2001, pp. 202-3,<br />
207, 211-5, 275-7, 281-95.<br />
49
nell’atto del combattimento, […] ma in una nota <strong>di</strong>sposizione a combattere, per cui per tutto il<br />
tempo non c’è assicurazione del contrario. Tutto il resto del tempo è PACE. 169<br />
Cosa sceglierebbero razionalmente in<strong>di</strong>vidui liberi ed eguali, e per questo in conflitto tra <strong>di</strong> loro, per<br />
assicurarsi invece una convivenza pacifica? Semplice è <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione dell’uomo naturale: il <strong>di</strong>ritto<br />
innato a dominare gli altri che, visto reciprocamente, è <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione da cui germina il perenne con<br />
flitto. Da questa realtà antropologica emerge un profilo psicologico inquietante: <strong>la</strong> paura del<strong>la</strong> mor<br />
te, nel<strong>la</strong> consapevolezza <strong>di</strong> non poter garantirsi da soli <strong>la</strong> sopravvivenza. La legge <strong>di</strong> natura si basa<br />
allora su un principio naturale dell’uomo, ovvero l’istinto al<strong>la</strong> conservazione.<br />
Le passioni che rendono gli uomini inclini al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> sono <strong>la</strong> paura del<strong>la</strong> morte, il desiderio delle<br />
cose necessarie per vivere comodamente e <strong>la</strong> speranza <strong>di</strong> ottenerle con <strong>la</strong> propria operosità. Inol<br />
tre, <strong>la</strong> ragione suggerisce articoli <strong>di</strong> <strong>pace</strong> convenienti, in base ai quali gli uomini possano essere<br />
spinti ad accordarsi. […]<br />
E poiché <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione umana [...] è una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> guerra <strong>di</strong> ogni uomo contro tutti gli altri,<br />
in questo caso ognuno è governato dal<strong>la</strong> propria ragione e non c’è nul<strong>la</strong>, che possa utilizzare,<br />
che non gli sia <strong>di</strong> aiuto, preservando <strong>la</strong> sua vita contro i suoi nemici; ne consegue che in una tale<br />
con<strong>di</strong>zione ogni uomo ha <strong>di</strong>ritto ad ogni cosa, perfino al corpo <strong>di</strong> un altro. Quin<strong>di</strong>, per tutto il<br />
tempo in cui persiste questo <strong>di</strong>ritto natura <strong>di</strong> ogni uomo ad ogni cosa, nessun uomo (per quanto<br />
sia forte o saggio) può avere <strong>la</strong> sicurezza <strong>di</strong> vivere per tutto il tempo che <strong>la</strong> natura concede normalmente<br />
agli uomini <strong>di</strong> vivere. Di conseguenza, è un precetto o una rego<strong>la</strong> generale del<strong>la</strong> ragione<br />
che ogni uomo dovrebbe sforzarsi <strong>di</strong> cercare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> nel<strong>la</strong> misura in cui ha speranza <strong>di</strong><br />
ottener<strong>la</strong> e quando non può ottener<strong>la</strong>, che possa ricercare ed utilizzare tutti gli aiuti e i vantaggi<br />
del<strong>la</strong> guerra. La prima arte <strong>di</strong> questa rego<strong>la</strong> contiene <strong>la</strong> prima e fondamentale legge <strong>di</strong> natura,<br />
che è ricercare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e perseguir<strong>la</strong>; <strong>la</strong> seconda, <strong>la</strong> sintesi del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> natura, che è <strong>di</strong>fendere<br />
noi stessi con tutti i mezzi possibili.<br />
Da questa fondamentale legge <strong>di</strong> natura, che or<strong>di</strong>na agli uomini <strong>di</strong> cercare <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, è derivata<br />
questa seconda legge, che un uomo sia <strong>di</strong>sposto, quando lo sono anche gli altri, a deporre questo<br />
<strong>di</strong>ritto a tutte le cose, nel<strong>la</strong> misura in cui lo riterrà necessario per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> propria <strong>di</strong>fe<br />
169 Hobbes fa riferimento anche al<strong>la</strong> guerra esterna, tra gli stati, ma non <strong>la</strong> identifica con una con<strong>di</strong>zione miserevole:<br />
«Ma, anche se non c’è mai stato un tempo in cui i singoli uomini erano in una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> guerra l’uno contro l’altro,<br />
tuttavia in ogni tempo i re e le persone con l’autorità sovrana si trovano, a causa del<strong>la</strong> loro in<strong>di</strong>pendenza, in uno stato <strong>di</strong><br />
gelosia continua e nel<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione e posizione dei g<strong>la</strong><strong>di</strong>atori, che stanno con le armi puntate e gli occhi fissati l’uno<br />
sull’altro, cioè con le fortificazioni, le guarnigioni e i cannoni <strong>di</strong>slocati sulle frontierre dei loro regni e con spie che sorvegliano<br />
<strong>di</strong> continuo i territori confinanti e questa è una posizione <strong>di</strong> guerra. Ma, poiché con questo sostengono<br />
l’operosità dei loro sud<strong>di</strong>ti, da ciò non segue quel<strong>la</strong> sofferenza che accompagna <strong>la</strong> libertà dei singoli uomini» (ivi, p.<br />
209-11).<br />
50
sa, e che si accontenti <strong>di</strong> tanta libertà contro gli altri uomini quanta ne concederebbe agli altri<br />
uomini contro se stesso.<br />
Da queste evidenze del<strong>la</strong> ragione si passa a creare lo Stato, il quale sarà preposto a <strong>di</strong>fendere <strong>la</strong><br />
sicurezza dei sud<strong>di</strong>ti dalle minacce interne e da quelle interne.<br />
Nonostante le leggi <strong>di</strong> natura […], se non viene eretto un potere o se non è abbastanza grande<br />
per <strong>la</strong> nostra sicurezza , ogni uomo può e vuole fare legittimamente affidamento sul<strong>la</strong> propria<br />
forza e sul<strong>la</strong> propria abilità per premunirsi contro tutti gli altri uomini. […]<br />
Per erigere un tale potere comune, che sia ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>fenderli dalle invasioni degli stranieri e<br />
dai torti reciproci e, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> renderli sicuri in modo che possano nutrirsi con le loro attività e<br />
con i frutti del<strong>la</strong> terra e vivere felicemente, l’unica maniera è quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> conferire tutto il loro potere<br />
e <strong>la</strong> loro forza ad un solo uomo o ad una assemblea <strong>di</strong> uomini, che possa ridurre tutte le loro<br />
volontà, con <strong>la</strong> pluralità <strong>di</strong> voci, ad un’unica volontà. Questo equivale a nominare un uomo o<br />
un’assemblea <strong>di</strong> uomini per rappresentare <strong>la</strong> loro persona e significa che ognuno <strong>di</strong> loro si riconosce<br />
e ammette <strong>di</strong> essere l’autore <strong>di</strong> tutto ciò che attuerà chi rappresenta <strong>la</strong> sua persona o ne<br />
causerà l’attuazione per quanto riguarda <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> sicurezza comune. Così, tutti quanti sottomettono<br />
le proprie volontà al<strong>la</strong> sua volontà e i propri giu<strong>di</strong>zi al suo giu<strong>di</strong>zio. Questo è più che<br />
acconsentire o concordare: è l’unità reale <strong>di</strong> tutti quanti in una ed una stessa persona, compiuta<br />
attraverso il patto <strong>di</strong> ogni uomo con ogni altro uomo, come se ogni uomo <strong>di</strong>cesse ad ogni altro:<br />
io autorizzo e cedo il mio <strong>di</strong>ritto ad autogovernarmi a questo uomo o a questa assemblea <strong>di</strong><br />
uomini,a questa con<strong>di</strong>zione: che tu gli ceda il tuo <strong>di</strong>ritto ed autorizzi tutte le sue azioni in modo<br />
simile. Fatto questo, <strong>la</strong> moltitu<strong>di</strong>ne così unita in una persona si chiama STATO. […]<br />
E, poiché il fine <strong>di</strong> questa istituzione è <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> tutti quanti e chiunque ha <strong>di</strong>ritto al<br />
fine, ha <strong>di</strong>ritto ai mezzi, a qualsiasi uomo o assemblea che ha <strong>la</strong> sovranità appartiene il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
giu<strong>di</strong>care sia i mezzi <strong>pace</strong> che quelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa e anche i loro ostacoli ed elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo,<br />
nonché il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> fare qualsiasi cosa ritenuta necessaria, sia preventivamente, per conservare <strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong> e <strong>la</strong> sicurezza prevenendo le <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>e e l’ostilità dall’estero, sia, quando <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> sicurezza<br />
sono perdute, per il loro recupero 170 . E dunque […] al<strong>la</strong> sovranità è connesso il giu<strong>di</strong>zio su<br />
quali opinioni e quali dottrine siano contrarie al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e quali vi conducono […] Infatti, le azioni<br />
degli uomini derivano dalle loro opinioni e il buon governo delle azioni degli uomini consiste<br />
nel buon governo delle loro opinioni, con lo scopo del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e del<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a. […] Appartiene<br />
dunque a chi detiene il potere sovrano <strong>la</strong> prerogativa <strong>di</strong> essere giu<strong>di</strong>ce e <strong>di</strong> nominare<br />
tutti i giu<strong>di</strong>ci delle opinioni e delle dottrine, come una cosa necessaria al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, tramite cui prevenire<br />
<strong>la</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a e <strong>la</strong> guerra civile.[…]<br />
170 Da notare come Hobbes, nel delineare i compiti dello Stato, oppone al<strong>la</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a interna, «<strong>di</strong>scord at home», <strong>la</strong> ricerca<br />
del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, «peace», mentre al<strong>la</strong> minaccia esterna, «hostility from abroad», <strong>la</strong> ricerca del<strong>la</strong> sicurezza, «security»,<br />
che spesso deve essere ottenuta con <strong>la</strong> decisione <strong>di</strong> muovere guerra per <strong>di</strong>fendersi.<br />
51
SPINOZA<br />
E’ connesso al<strong>la</strong> sovranità l’intero potere <strong>di</strong> prescrivere le regole attraverso cui ognuno riesce a<br />
sapere <strong>di</strong> quali beni può fruire e quali azioni può compiere senza essere molestato da altri suoi<br />
con-sud<strong>di</strong>ti; e questo è ciò che gli uomini chiamano proprietà. Infatti, prima del<strong>la</strong> costituzione<br />
del potere sovrano (come si è già mostrato) tutti gli uomini hanno <strong>di</strong>ritto a tutte le cose e questo<br />
causa necessariamente <strong>la</strong> guerra; dunque, questa proprietà, essendo necessaria per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>di</strong><br />
pendendo dal potere sovrano, è l’atto <strong>di</strong> quel potere allo scopo del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> pubblica. Queste rego<br />
le del<strong>la</strong> proprietà (o meum e tuum), del bene e del male, del legittimo e dell’illegittimo nelle a<br />
zioni dei sud<strong>di</strong>ti, sono le leggi civili, cioè le leggi <strong>di</strong> ogni singolo stato. […]<br />
E’ connesso al<strong>la</strong> sovranità il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> amministrare <strong>la</strong> giustizia, cioè <strong>di</strong> ascoltare e <strong>di</strong> decidere<br />
tutte le controversie che possono sorgere […] Infatti senza che si decidano le controversie, non<br />
esiste protezione <strong>di</strong> un sud<strong>di</strong>to dai torti <strong>di</strong> un altro […]<br />
E’ connesso al<strong>la</strong> sovranità il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> fare <strong>la</strong> guerra e <strong>la</strong> <strong>pace</strong> con le altre nazioni e gli altri stati,<br />
cioè <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care quando questo è per il bene pubblico.<br />
La <strong>pace</strong> […]non consiste nell’assenza <strong>di</strong> guerra,<br />
ma nell’unione degli animi, ossia nel<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a<br />
Nel Trattato politico 171 Spinoza stabilisce il legame tra <strong>pace</strong> e libertà dei citta<strong>di</strong>ni. Le migliori<br />
costituzioni cercano <strong>di</strong> garantire questa con<strong>di</strong>zione. Al contrario, solo su un’apparente tranquillità si<br />
reggono i governi che tengono i sud<strong>di</strong>ti in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> paura e schiavitù.<br />
Quale sia <strong>la</strong> migliore costituzione per qualsivoglia potere, lo si comprende facilmente a partire<br />
dal fine dello stato civile: che non è niente altro che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> sicurezza del<strong>la</strong> vita. E dunque il<br />
miglior potere è quello grazie al quale gli uomini conducono <strong>la</strong> loro esistenza in concor<strong>di</strong>a e il<br />
<strong>di</strong>ritto rimane invio<strong>la</strong>to. E’ certo infatti che le se<strong>di</strong>zioni, le guerre, il <strong>di</strong>sprezzo o <strong>la</strong> trasgressione<br />
delle leggi, non vanno tanto imputati al<strong>la</strong> malvagità dei sud<strong>di</strong>ti quanto al<strong>la</strong> cattiva costituzione<br />
del potere. Gli uomini, infatti, non nascono civili, ma lo <strong>di</strong>ventano.[...]<br />
Di uno Stato i cui sud<strong>di</strong>ti, in preda al terrore, non prendono le armi, si deve piuttosto <strong>di</strong>re che è<br />
senza guerra anziché gode del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. La <strong>pace</strong>, infatti, non è assenza <strong>di</strong> guerra, ma una virtù che<br />
171 B. SPINOZA, Trattato politico, a c. <strong>di</strong> L. Pezzillo, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 31-3, 35-6, 45, 49-52.<br />
52
nasce dal vigore dell’animo [...] Quello Stato, inoltre, in cui <strong>la</strong> <strong>pace</strong> deriva dall’inerzia dei sud<br />
<strong>di</strong>ti, che sono guidati come pecore perché imparino unicamente a servire, può essere detto più<br />
correttamente solitu<strong>di</strong>ne che Stato.<br />
Quando dunque <strong>di</strong>ciamo che il miglior potere è quello in virtù del quale gli uomini trascorrono<br />
<strong>la</strong> loro vita nel<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a, intendo [...] quello che ha istituito una moltitu<strong>di</strong>ne libera. Una moltitu<strong>di</strong>ne<br />
libera è infatti condotta più dal<strong>la</strong> speranza che dal<strong>la</strong> paura [...]<br />
Ma sembra che l’esperienza insegni, per contro, che nell’interesse del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e del<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a,<br />
ogni potestà sia da conferire a uno solo. E, infatti, nessun potere è rimasto tanto a lungo senza<br />
alcun apprezzabile mutamento quanto quello dei Turchi, e, per contro, nessuno è stato meno duraturo<br />
<strong>di</strong> quelli popo<strong>la</strong>ri, ossia democratici, e nessuno dove si siano prodotte tante se<strong>di</strong>zioni. Ma<br />
se bisogna chiamare <strong>pace</strong> <strong>la</strong> schiavitù, <strong>la</strong> barbarie, <strong>la</strong> solitu<strong>di</strong>ne, niente è più misero che <strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
[...] E’ nell’interesse del<strong>la</strong> schiavitù, dunque, e non del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, che tutta <strong>la</strong> potestà sia trasmessa<br />
ad uno solo: <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, infatti, come abbiamo già detto, non consiste nell’assenza <strong>di</strong> guerra, ma<br />
nell’unione degli animi, ossia nel<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a. [...]<br />
Se uno stato si regge a monarchia, bisogna in<strong>di</strong>care i contorni costituzionali che fanno sì che<br />
anch’esso rispetti <strong>la</strong> libertà dei sud<strong>di</strong>ti e l’obiettivo del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
E’ certo inoltre che ognuno preferisce dominare piuttosto che essere dominato. Nessuno cede,<br />
infatti, volentieri il potere, come <strong>di</strong>ce Sallustio nel<strong>la</strong> prima orazione a Cesare 172 . E’ dunque evidente<br />
che una moltitu<strong>di</strong>ne nel suo insieme non trasferirebbe mai il suo <strong>di</strong>ritto a pochi o ad uno<br />
solo, se solo potesse raggiungere l’unità al suo interno, e far sì che le controversie che per lo più<br />
sorgono nei consigli numerosi, non degenerino in se<strong>di</strong>zioni; perciò una moltitu<strong>di</strong>ne trasferisce<br />
liberamente a un re solo ciò che in nessun modo può avere in sua potestà, cioè <strong>la</strong> facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>rimere<br />
le controversie e <strong>di</strong> prendere decisioni con rapi<strong>di</strong>tà. [...]<br />
E’ necessario che il monarca abbia dei consiglieri, che soccorrano il re col loro parere e che<br />
prendano spesso il suo posto [...] Dal momento che <strong>la</strong> natura umane è fatta in modo tale che ciascuno<br />
cerca il suo utile personale con <strong>la</strong> più grande passione, e ritiene che le <strong>di</strong>sposizioni giuri<strong>di</strong>che<br />
più giuste siano quelle necessarie al<strong>la</strong> conservazione e all’accrescimento dei suoi beni, e<br />
in tanto sostiene <strong>la</strong> causa altrui, in quanto pensa <strong>di</strong> consolidare in tal modo ciò che è suo, ne segue<br />
che devono essere necessariamente eletti dei consiglieri per i quali gli affari privati e l’utile<br />
<strong>di</strong>pendano dal<strong>la</strong> comune salute e dal<strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong> tutti; ed è evidente che se sono eletti da ogni<br />
gruppo o c<strong>la</strong>sse <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni, ciò che in questo consiglio avrà avuto più voti, sarà utile al<strong>la</strong> maggior<br />
parte dei sud<strong>di</strong>ti. [...]<br />
Nessuno può dubitare del fatto che <strong>la</strong> maggior parte <strong>di</strong> questo consiglio non desidererà mai fare<br />
<strong>la</strong> guerra, ma avrà grande attenzione e amore per <strong>la</strong> <strong>pace</strong>. In effetti, oltre a temere sempre <strong>di</strong><br />
172 Epistu<strong>la</strong> ad Caesarem de re oublica or<strong>di</strong>nanda, I, 1, 4.<br />
53
perdere, con una guerra, i propri beni insieme al<strong>la</strong> libertà, va aggiunto che <strong>la</strong> guerra richiede<br />
nuove spese alle quali far fronte, oltre al fatto che figli e parenti dei membri del consiglio che si<br />
occupano degli affari privati, sarebbero obbligati ad impegnarsi con le armi, in guerra, e a partire<br />
come militari, e da lì non potrebbero riportare che inutili cicatrici. […]<br />
A sostegno del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e del<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a si aggiunge inoltre qualcos’altro, che è pure <strong>di</strong> grande<br />
rilievo, ossia che nessun citta<strong>di</strong>no possegga beni immobili. Così il pericolo derivante dal<strong>la</strong> guerra<br />
è per tutti il medesimo: tutti, infatti, per realizzare profitti, si daranno al commercio, o si presteranno<br />
denaro a vicenda, soprattutto nel caso in cui sia stata emanata, come un tempo presso<br />
gli Ateniesi, una legge che proibisca a ciascuno <strong>di</strong> prestare a usura il proprio denaro ad altri che<br />
non siano i propri concitta<strong>di</strong>ni; così tutti si occuperanno <strong>di</strong> affari collegati gli uni con gli altri o<br />
che hanno bisogno degli stessi mezzi per essere condotti a termine; e dunque <strong>la</strong> maggior parte <strong>di</strong><br />
questo consiglio sarà per lo più <strong>di</strong> uno stesso parere a proposito degli affari comuni e delle opere<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong> [...]<br />
Se nel<strong>la</strong> monarchia è comunque possibile salvaguardare libertà e <strong>pace</strong>, le costituzioni aristocratiche<br />
necessitano <strong>di</strong> correttivi ancora meno profon<strong>di</strong>.<br />
Nel determinare dunque i fondamenti del potere aristocratico, bisogna in primo luogo guardare<br />
che essi poggino unicamente sul<strong>la</strong> volontà e <strong>la</strong> potenza <strong>di</strong> questo consiglio supremo, così che,<br />
per quanto possibile, lo stesso consiglio supremo, così che, per quanto possibile, lo stesso consiglio<br />
sia soggetto solo a se stesso, e non abbia da temere alcun pericolo da parte del<strong>la</strong> moltitu<strong>di</strong>ne.<br />
Per determinare questi fondamenti che devono poggiare sul<strong>la</strong> volontà e potenza del supremo<br />
consiglio, consideriamo i fondamenti del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> propri del potere monarchico e che sono<br />
inadatti a questo potere. In effetti, se sostituiremo a questi altri fondamenti equivalenti, adatti al<br />
potere aristocratico, e <strong>la</strong>sceremo i rimanenti già posti, sarà senza dubbio eliminata ogni causa <strong>di</strong><br />
se<strong>di</strong>zione, o comunque questo potere non sarà meno sicuro del monarchico, ma al contrario sarà<br />
tanto sicuro, e <strong>la</strong> sua situazione migliore, quanto più, rispetto al potere monarchico, si avvicinerà<br />
al potere assoluto senza pregiu<strong>di</strong>zio per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> libertà; quanto più grande è in effetti il <strong>di</strong>ritto<br />
del<strong>la</strong> somma potestà, tanto più <strong>la</strong> forma del potere si accorda con il dettame del<strong>la</strong> ragione, e<br />
<strong>di</strong> conseguenza è più adatta al<strong>la</strong> conservazione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e del<strong>la</strong> libertà.<br />
La democrazia è infine l’assetto che più agevolmente può garantire il potere assoluto del corpo<br />
politico. Se, secondo ragione, nelle società democratiche il <strong>di</strong>ritto politico deve essere garantito a<br />
tutti, le «esperienze» storiche insegnano invece, al fine <strong>di</strong> conservare <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, a non estendere tale<br />
prerogativa anche alle donne.<br />
54
Passo infine al<strong>la</strong> terza forma <strong>di</strong> potere, perfettamente assoluto, che chiamiamo democrazia. In<br />
effetti, tutti coloro che sono nati da genitori citta<strong>di</strong>ni, o in suolo patrio, o che hanno acquistato<br />
meriti nei confronti del<strong>la</strong> repubblica, oppure per altre cause, per le quali <strong>la</strong> legge or<strong>di</strong>na che sia<br />
conferito a qualcuno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>no, tutti costoro, <strong>di</strong>co, con <strong>di</strong>ritto pretendono per sé il <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> voto al consiglio supremo, e <strong>di</strong> accesso alle cariche pubbliche, ne è lecito negarglielo,<br />
tranne che per via <strong>di</strong> un crimine o <strong>di</strong> infamia. […]<br />
Nessuna ragione ci obbliga ad escludere le donne dal governo. […] È lecito sicuramente affermare<br />
che per natura le donne non hanno un <strong>di</strong>ritto uguale agli uomini ma che sono necessariamente<br />
inferiori ad essi, e che non può accadere che i due sessi governino insieme, e ancor meno<br />
che gli uomini siano governati dalle donne. […] gli uomini mal sopportano che le donne che<br />
amano si interessino in qualche modo ad altri, e altre cose del genere, allora vedremo senza <strong>di</strong>fficoltà<br />
che non può avvenire, senza gran pregiu<strong>di</strong>zio per <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, che uomini e donne regnino in<br />
egual modo.<br />
55
4. I progetti settecenteschi<br />
SAINT-PIERRE<br />
Per conservare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> bisogna sopprimere i pretesti <strong>di</strong> guerra<br />
Nel Progetto 173 <strong>di</strong> Saint-Pierre (1658-1743) sono esposti i punti fondamentali per costruire una<br />
pacifica convivenza tra gli stati europei. Questo sistema <strong>di</strong>pende dall’instaurazione <strong>di</strong> «garanzie suf<br />
ficienti», che sole possono far superare <strong>la</strong> reciproca sfiducia tra i governanti.<br />
Se si potesse proporre un trattato ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> rendere l’Unione solida e inalterabile e <strong>di</strong> dare pertanto<br />
a tutto il mondo una garanzia sufficiente <strong>di</strong> <strong>pace</strong> per i principi non si troverebbero che ben<br />
pochi inconvenienti e comunque non gravi e si troverebbero, per contro, un gran numero <strong>di</strong> vantaggi,<br />
vantaggi ben superiori a quelli offerti dal presente sistema <strong>di</strong> guerra, talché molti principi,<br />
specie fra i meno potenti, principierebbero ad approvare <strong>la</strong> loro firma al trattato per poi proporne<br />
<strong>la</strong> firma ad altri e, infine, gli stessi principi più potenti, una volta esaminato da cima a fondo il<br />
trattato, finirebbero facilmente con lo scoprire che non sarebbe loro mai possibile prendere un<br />
partito, né firmare un accordo più giovevole <strong>di</strong> questo.<br />
Credo, altresì, <strong>di</strong> non aver trascurato sforzo alcuno per trovare, come ho trovato, i mezzi praticabili<br />
e sufficienti, che presentano gli articoli del trattato <strong>di</strong> Unione, trattato in cui si trova per<br />
tutti una garanzia sufficiente <strong>di</strong> <strong>pace</strong> perpetua. [...]<br />
Se <strong>la</strong> società europea, che qui si propone, può procurare a tutti i principi cristiani garanzia sufficiente<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong> perpetua all’interno, come all’esterno, dei loro Stati, non c’è principe che non cavi<br />
ben più vantaggi dal<strong>la</strong> firma del trattato per <strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> società europea <strong>di</strong> quanti ne<br />
caverebbe non firmandolo. [...]<br />
Non è altresì <strong>di</strong>fficile comprendere che, quanto più il presente progetto contemp<strong>la</strong> i mezzi intesi<br />
a rendere inalterabile <strong>la</strong> <strong>pace</strong> in Europa, tanto più può contribuire ad agevo<strong>la</strong>re <strong>la</strong> conclusione <strong>di</strong><br />
quel che oggi è in <strong>di</strong>scussione a Utrecht 174 , giacché gli alleati del<strong>la</strong> casa d’Austria desiderano <strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong> quanto noi e <strong>la</strong> so<strong>la</strong> <strong>di</strong>fferenza è che non <strong>la</strong> vogliono altro che al<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione che vengano<br />
loro offerte Garanzie sufficienti del<strong>la</strong> sua durata. […]<br />
La società europea avrà inizio a partire dal momento in cui due sovrani ne avranno firmato il<br />
trattato e sarà tutta quanta formata nel momento in cui tutti gli altri sovrani cristiani, a <strong>di</strong>stanza<br />
<strong>di</strong> tempo gli uni dagli altri, avranno apposto <strong>la</strong> loro firma. [...]<br />
173<br />
C. I. DE SAINT-PIERRE, Scritti politici. Per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua e sul<strong>la</strong> polisino<strong>di</strong>a, a c. <strong>di</strong> G. A. Roggerone, Lecce, Micel<strong>la</strong>,<br />
1996, pp. .<br />
174<br />
Il Trattato <strong>di</strong> Utrecht firmato nel 1713 pose fine al<strong>la</strong> guerra <strong>di</strong> successione spagno<strong>la</strong>.<br />
56
I sovrani, rappresentati dai delegati qui sottoscritti, hanno convenuto sugli articoli seguenti. A<br />
vrà vita da questo momento in futuro una società, un’Unione permanente e perpetua fra i sovra<br />
ni sottoscritti e, se è possibile, fra tutti i sovrani cristiani, nell’intento <strong>di</strong> rendere inalterabile <strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong> in Europa. In vista <strong>di</strong> questo fine, l’Unione stipulerà, se è possibile, con i sovrani musulmani<br />
suoi confinanti trattati <strong>di</strong> lega offensiva e <strong>di</strong>fensiva, intesi a mantenere ciascuno in <strong>pace</strong><br />
entro il suo territorio»<br />
L’Unione nasce al fine <strong>di</strong> garantire il potere interno dei singoli stati, aiuterà con <strong>la</strong> propria forza<br />
quei governanti che si trovano in <strong>di</strong>fficoltà a causa <strong>di</strong> opposizioni interne. Per quanto riguarda <strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong> «esterna», essa <strong>di</strong>pende in primo luogo dall’eliminare le cause del<strong>la</strong> guerra: ogni sovrano farà<br />
in modo <strong>di</strong> contentarsi del proprio «possesso attuale».<br />
Per un sovrano <strong>la</strong> cosa più importante è quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> riuscire a governare il proprio Stato con minore<br />
<strong>di</strong>fficoltà, vale a <strong>di</strong>re con maggiore autorità il modo che, accrescendo <strong>la</strong> felicità dei suoi sud<strong>di</strong>ti,<br />
possa accrescere <strong>la</strong> propria. Per questo, occorre sia sicuro non soltanto che l’Unione non gli<br />
frapporrà ostacoli, ma anche che essa lo aiuterà a sottomettere gli spiriti ribelli e a dare vita alle<br />
istituzioni da lui giu<strong>di</strong>cate convenienti al proprio bene e a quello dei suoi popoli ; l’Unione infatti<br />
non si preoccuperà mai <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care <strong>la</strong> condotta dei principi, limitandosi a sostenerne sempre<br />
<strong>la</strong> volontà. Ora i sovrani saranno tanto più <strong>di</strong>sposti ad accordarsi l’uno con l’altro su questo<br />
articolo, quanto più saranno interessati ad accrescere <strong>la</strong> loro autorità sui sud<strong>di</strong>ti.[…]<br />
Per conservare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> bisogna, finché è possibile, sopprimere i pretesti <strong>di</strong> guerra. Fra questi<br />
pretesti, uno dei più importanti è l’ingran<strong>di</strong>mento territoriale, che non può esser fatto che a spese<br />
dei vicini. Così prima base del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> è che ciascuno si contenti del suo e che nessuno riguar<strong>di</strong><br />
come suo quel che al presente non possiede.[…]<br />
Nessuna società è però durevole senza garanzia reciproca dei soci e fra queste garanzie ve ne è<br />
una essenziale e fondamentale, vale a <strong>di</strong>re che ciascuno rinunci per sempre a tutte le speranze, a<br />
tutte le pretese, che egli possa nutrire <strong>di</strong> possedere un giorno una qualche parte <strong>di</strong> territorio posseduto<br />
da un altro e che, altresì, ciascuno si attenga al punto fisso del suo possesso attuale, Ora,<br />
nel presupposto <strong>di</strong> questa reciproca rinuncia, <strong>di</strong> questa mutua cessione <strong>di</strong> pretese, tutti troveranno<br />
nel sistema del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> infinitamente più <strong>di</strong> quel che cercano e cercano invano nel sistema del<strong>la</strong><br />
guerra […]<br />
Nessun sovrano prenderà le armi e compirà atti <strong>di</strong> ostilità altro che contro chi sarà <strong>di</strong>chiarato<br />
nemico del<strong>la</strong> società europea. [...]<br />
57
Il sovrano che prenderà le armi prima che l’Unione abbia <strong>di</strong>chiarato guerra o che rifiuterà <strong>di</strong> da<br />
re esecuzione a un rego<strong>la</strong>mento dell’Unione o che ancora, a una sentenza del Senato 175 , sarà <strong>di</strong><br />
chiarato nemico del<strong>la</strong> società. La società gli farà guerra sino a che non venga <strong>di</strong>sarmato e sino<br />
all’esecuzione del<strong>la</strong> sentenza e del rego<strong>la</strong>mento.<br />
175 Si fa riferimento al Senato d’Europa, <strong>la</strong> cui composizione è chiarita poco oltre (art. IX). Ad esso competeranno compiti<br />
specifici <strong>di</strong> decidere in merito a «tutto ciò che concerne <strong>la</strong> salvezza o un grande vantaggio del<strong>la</strong> società in generale e<br />
a cui bisogna porre imme<strong>di</strong>atamente rime<strong>di</strong>o»<br />
58
JEAN-JACQUES ROUSSEAU<br />
Non tregue ma vere e proprie paci<br />
.<br />
.<br />
Nell’Estratto 176 Rousseau, conscio che un progetto <strong>di</strong> <strong>pace</strong> duratura sia <strong>la</strong> più lodevole tra le idee<br />
umane, chiede al lettore <strong>di</strong> seguirlo nelle argomentazioni non rifiutando ciò che è convincente.<br />
Rousseau concede un primo omaggio a coloro che da sempre riflettono sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua in<br />
Europa, «dolce e pacifica società <strong>di</strong> fratelli, che vivono in perpetua concor<strong>di</strong>a, tutti guidati dagli<br />
stessi principi, tutti lieti del<strong>la</strong> comune felicità». Iniziando invece a «ragionare obbiettivamente»,<br />
propone il superamento del<strong>la</strong> contrad<strong>di</strong>zione in atto tra lo stato civile dell’uomo con i suoi concitta<strong>di</strong>ni<br />
e lo stato <strong>di</strong> natura in cui vivono gli stati tra <strong>di</strong> loro. Leghe, trattati, anche formali alleanze hanno<br />
rappresentato solo un mero simu<strong>la</strong>cro <strong>di</strong> un progetto federativo.<br />
Se mezzo c’è <strong>di</strong> eliminare queste pericolose contrad<strong>di</strong>zioni, può essere solo una forma <strong>di</strong> governo<br />
federativo, che, unendo i popoli con legami simili a quelli che uniscano gl’in<strong>di</strong>vidui, sottometta<br />
del pari gli uni e gli altri all’autorità delle leggi. […]<br />
Riconosciamo dunque che il rapporto reciproco delle potenze europee è propriamente uno stato<br />
<strong>di</strong> guerra e che tutti i trattati parziali fra talune <strong>di</strong> queste potenze sono più tregue passeggere che<br />
vere e proprie paci 177 , sia perché, <strong>di</strong> solito, si stipu<strong>la</strong>no sul<strong>la</strong> so<strong>la</strong> garanzia delle parti contraenti,<br />
sia perché i <strong>di</strong>ritti degli uni e degli altri non vi trovano mai una soluzione ra<strong>di</strong>cale, e questi <strong>di</strong>ritti<br />
non del tutto estinti, o le pretese ce ne tengono luogo, fra potenze che non riconoscono nessuna<br />
autorità superiore, <strong>di</strong>venteranno, senza fallo, fonte <strong>di</strong> nuove guerre, non appena altre circostanze<br />
avranno dato nuove forze ai pretendenti.<br />
La mancanza <strong>di</strong> un potere superiore coattivo che si faccia garante del<strong>la</strong> stabilità europea è conseguenza<br />
<strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto internazionale <strong>di</strong> fatto inesistente, che serve solo ad essere piegato verso<br />
l’interesse del<strong>la</strong> singo<strong>la</strong> potenza («puissance»). Al contrario <strong>la</strong> società internazionale nuova deve<br />
passare attraverso <strong>la</strong> chiarificazione dei comuni interessi.<br />
176 I brani sono tratti dall’opera J. J. ROUSSEAU, Estratto del progetto <strong>di</strong> <strong>pace</strong> perpetua dell’abate <strong>di</strong> Saint-Pierre, trad.<br />
it. <strong>di</strong> Maria Garin, pp. 323-341, in ID., Scritti politici, , 3 voll., Laterza, Bari 1971, II, pp. 319-347.<br />
177 Si noti <strong>la</strong> contrapposizione tra <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione internazionale attuale segnata da trattati parziali, equivalenti a tregue<br />
passeggere, e <strong>la</strong> vera <strong>pace</strong> («véritable paix») che si configura politicamente, come si legge nel seguito, in «une confédération<br />
solide et durable».<br />
59
Se ho insistito sull’uguale <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> forze che risulta in Europa dal<strong>la</strong> costituzione attuale è<br />
stato per ricavarne una conseguenza importante ai fini dell’istituzione <strong>di</strong> un’associazione generale;<br />
infatti, per costituire un’associazione salda e durevole, bisogna creare tra tutti i membri un<br />
rapporto <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>pendenza reciproca da rendere impossibile che uno, da solo, sia in grado <strong>di</strong> resistere<br />
a tutti gli altri e da opporre alle associazioni partico<strong>la</strong>ri capaci <strong>di</strong> nuocere al<strong>la</strong> grande associazione<br />
ostacoli sufficienti a impe<strong>di</strong>re <strong>la</strong> riuscita dei loro piani; senza <strong>di</strong> ciò <strong>la</strong> confederazione<br />
sarebbe inutile e, sotto un’apparente soggezione, ognuno sarebbe <strong>di</strong> fatto in<strong>di</strong>pendente. Ora,<br />
se questi ostacoli sono quali ho detto prima nel<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione attuale, in cui tutte le potenze hanno<br />
piena libertà <strong>di</strong> formare tra loro delle leghe e <strong>di</strong> stipu<strong>la</strong>re trattati offensivi, si può giu<strong>di</strong>care <strong>di</strong><br />
quel che rappresenterebbero quando vi fosse una grande lega armata, sempre pronta a prevenire<br />
quelli che volessero tentare <strong>di</strong> <strong>di</strong>strugger<strong>la</strong> o <strong>di</strong> resisterle.<br />
Come nel progetto <strong>di</strong> Saint-Pierre, cinque articoli regoleranno <strong>la</strong> vita nel<strong>la</strong> federazione: gli organi<br />
che <strong>la</strong> governeranno, le modalità del loro funzionamento; <strong>la</strong> <strong>di</strong>fesa dei governi legittimi contro<br />
le se<strong>di</strong>zioni interne e le soluzioni delle controversie per quel che riguarda i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà; <strong>la</strong> messa<br />
al bando dello Stato tra<strong>di</strong>tore, <strong>la</strong> capacità <strong>di</strong> ogni componente <strong>di</strong> proporre mo<strong>di</strong>fiche al fine <strong>di</strong><br />
migliorare <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione del singolo Stato o <strong>di</strong> tutta <strong>la</strong> federazione.<br />
Rousseau intende quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare perché sia conveniente al singolo governante giungere a<br />
una simile pacificazione.<br />
In effetti – si <strong>di</strong>rà – voi togliete ai sovrani il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> farsi giustizia da sé, d’essere ingiusti<br />
quanto vogliono; li private del potere <strong>di</strong> ingran<strong>di</strong>rsi; li fate rinunciare a quell’apparato <strong>di</strong> potenza<br />
e <strong>di</strong> terrore con cui amano spaventare il mondo; a quel<strong>la</strong> gloria delle conquiste da cui traggono<br />
il loro onore; li forzate, infine, ad essere equi e pacifici. Quali saranno i compensi per tante<br />
rinunce? [...]<br />
Tutte le potenze europee hanno, le une contro le altre, <strong>di</strong>ritti e pretese; <strong>di</strong> questi <strong>di</strong>ritti, per <strong>la</strong> loro<br />
natura, non si potrà mai decidere pienamente perché manca una rego<strong>la</strong> comune e costante<br />
per giu<strong>di</strong>carne e perché spesso si fondano su fatti equivoci e incerti. E neanche le controversie<br />
che ne risultano potrebbero mai trovare una soluzione definitiva, sia per mancanza <strong>di</strong> arbitro<br />
competente, sia perché ogni principe, dandosene l’opportunità, torna senza scrupolo sulle cessioni<br />
che gli sono state strappate con <strong>la</strong> forza, per trattato, da altri più potenti <strong>di</strong> lui, o in seguito<br />
a guerre sfortunate. E’ dunque un errore pensare soltanto alle proprie pretese sugli altri <strong>di</strong>menticando<br />
quelle degli altri su <strong>di</strong> noi, quando nessuna delle due parti <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> mezzi più giusti e<br />
più favorevoli per far valere queste pretese reciproche. Appena tutto viene a <strong>di</strong>pendere dal<strong>la</strong> sorte,<br />
il possesso attuale acquista un prezzo che <strong>la</strong> saggezza non permette <strong>di</strong> rischiare per un guadagno<br />
avvenire, neppure quando le probabilità pro e contro sono al<strong>la</strong> pari [...].<br />
60
Consideriamo il <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> uomini, <strong>di</strong> danaro, <strong>di</strong> forze <strong>di</strong> ogni specie, <strong>la</strong> prostrazione in cui <strong>la</strong><br />
guerra più fortunata getta un qualunque Stato; e paragoniamo questo danno ai vantaggi che trae:<br />
troveremo che spesso perde quanto crede <strong>di</strong> guadagnare e che il vincitore, sempre più debole <strong>di</strong><br />
prima, ha come unica conso<strong>la</strong>zione quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> vedere il vinto più indebolito <strong>di</strong> lui; e si tratta an<br />
che <strong>di</strong> una superiorità più apparente che reale perché <strong>la</strong> superiorità eventualmente acquistata nei<br />
confronti dell’avversario è andata in pari tempo perduta <strong>di</strong> fronte alle potenze neutrali che, sen<br />
za mutamento <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione, re<strong>la</strong>tivamente a noi si sono rafforzate nel<strong>la</strong> misura in cui noi ci<br />
siamo indeboliti.<br />
Se non tutti i re hanno ancora superato <strong>la</strong> follia delle conquiste, sembra almeno che i più saggi<br />
comincino a intravvedere che talvolta esse costano più <strong>di</strong> quanto non rendano.<br />
I singoli stati sono garantiti anche per quel che riguarda <strong>la</strong> loro sovranità. In politica estera perdono<br />
<strong>la</strong> facoltà <strong>di</strong> muovere guerra a piacimento in cambio <strong>di</strong> mutua riconoscenza <strong>di</strong> questo principio<br />
dagli altri stati, ma in politica interna nessun loro <strong>di</strong>ritto è cambiato, anzi, nel<strong>la</strong> forza federale trovano<br />
migliore <strong>di</strong>fesa dai nemici esterni e più solida tute<strong>la</strong> contro le ribellioni interne.<br />
D’altro <strong>la</strong>to è ben <strong>di</strong>verso <strong>di</strong>pendere da altri e <strong>di</strong>pendere soltanto da un corpo in cui si è membri<br />
e <strong>di</strong> cui ciascuno, a sua volta, è capo; in quest’ultimo caso, infatti, non si fa che rassicurare <strong>la</strong><br />
propria libertà me<strong>di</strong>ante le garanzie che le si offrono; nelle mani <strong>di</strong> un padrone essa risulterebbe<br />
alienata, mentre in quelle degli associati essa si rafforza 178<br />
KANT<br />
Per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua<br />
Kant costruisce un sistema delle re<strong>la</strong>zioni internazionali che si oppone al<strong>la</strong> logica dello statopotenza,<br />
non solo perché combatte alle fondamenta <strong>la</strong> ragione politica dell’Ancien Régime, ma perché<br />
propone <strong>di</strong> rego<strong>la</strong>re <strong>la</strong> politica internazionale secondo un co<strong>di</strong>ce da tutti riconosciuto.<br />
178 Straor<strong>di</strong>nario parallelo si instaurerà con il corpo politico descritto nel<strong>la</strong> successiva opera Il contratto sociale (1762),<br />
quando Rousseau si sofferma sul patto sociale. Se esso nasce per «trovare una forma <strong>di</strong> associazione che <strong>di</strong>fenda e protegga<br />
con tutta <strong>la</strong> forza comune <strong>la</strong> persona e i beni <strong>di</strong> ciascun associato, e per <strong>la</strong> quale ciascuno, unendosi a tutti, non<br />
obbe<strong>di</strong>sca tuttavia che a se stesso, e resti libero come prima», <strong>la</strong> sua formu<strong>la</strong> si può così enunciare: «chi si dà a tutti non<br />
si dà a nessuno; e siccome non vi è associato sul quale ciascuno non acquisti un <strong>di</strong>ritto pari a quello che gli cede su <strong>di</strong><br />
sé, tutti guadagnano l’equivalente <strong>di</strong> quello che perdono, e una maggiore forza per conservare quello che hanno» (Il<br />
contratto sociale, tr. it. <strong>di</strong> Valentino Gerratana, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1945, pp. 23-24).<br />
61
L’opera kantiana 179 si artico<strong>la</strong> in due <strong>di</strong>verse sezioni. La prima concerne gli «articoli prelimina<br />
ri», in cui viene previsto <strong>di</strong> non attuare alcuni comportamenti che minano <strong>la</strong> possibilità <strong>di</strong> instaurare<br />
una <strong>pace</strong> durevole.<br />
Il primo <strong>di</strong> essi fornisce un’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> come <strong>la</strong> <strong>pace</strong> non equivalga nel<strong>la</strong> concezione kantia<br />
na a interruzione del<strong>la</strong> guerra:<br />
“Un trattato <strong>di</strong> <strong>pace</strong> non può valere come tale se viene fatto con <strong>la</strong> segreta riserva<br />
<strong>di</strong> materia per una futura guerra”.<br />
Infatti, se così fosse, si tratterebbe soltanto <strong>di</strong> una tregua e non <strong>di</strong> <strong>pace</strong>, che significa<br />
<strong>la</strong> fine <strong>di</strong> tutte le ostilità, e a cui aggiungere l’aggettivo perpetuo è già un sospetto<br />
pleonasmo.<br />
Nel terzo articolo si prospetta <strong>la</strong> fine degli eserciti permanenti, ancora nel<strong>la</strong> prospettiva che gli<br />
in<strong>di</strong>vidui non sono mezzi <strong>di</strong> cui lo Stato può <strong>di</strong>sporre:<br />
“Gli eserciti permanenti (miles perpetuus) 180 devono con il tempo scomparire del tutto.”<br />
Infatti, pronti come sono a mostrarsi sempre armati a questo scopo, minacciano costantemente<br />
<strong>di</strong> guerra gli altri Stati e spingono questi a superarsi a vicenda nel<strong>la</strong> quantità degli armati, che<br />
non conosce limiti, e poiché, con i costi che ciò richiede, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong>venta al<strong>la</strong> fine ancora più pesante<br />
<strong>di</strong> una breve guerra, sono allora essi stessi causa <strong>di</strong> guerre <strong>di</strong> aggressione, per liberarsi da<br />
questo peso.<br />
L’articolo sesto prevede alcune limitazioni nel modo <strong>di</strong> condurre i conflitti. Pur essendo in sostanza<br />
una rego<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> guerra (ius belli), Kant non prevede <strong>la</strong> possibilità che una guerra, condotta<br />
per sanare un <strong>di</strong>ritto vio<strong>la</strong>to, possa essere legittima. Al contrario, in assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (nel<strong>la</strong><br />
con<strong>di</strong>zione naturale) è <strong>la</strong> logica del più forte che <strong>di</strong>venta perentoria:<br />
“Nessuno Stato in guerra con un altro si può permettere ostilità tali da rendere necessariamente<br />
impossibile <strong>la</strong> reciproca fiducia in una <strong>pace</strong> futura: per esempio, l’impiego <strong>di</strong> assassini (percussores),<br />
<strong>di</strong> avvelenatori (venefici), <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione <strong>di</strong> una capito<strong>la</strong>zione, l’organizzazione del<br />
tra<strong>di</strong>mento (perduellio) nello Stato nemico ecc.”<br />
179 I brani sono tratti da I. KANT, Per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua, tr. it. a c. <strong>di</strong> Roberto Bor<strong>di</strong>ga, Mi<strong>la</strong>no, Feltrinelli, 1995 3 , pp. 45<br />
68. Il trattato kantiano viene pubblicato in un momento molto delicato del<strong>la</strong> vita pubblica del filosofo. Il 12 ottobre<br />
1794 Federico Guglielmo II gli aveva or<strong>di</strong>nato <strong>di</strong> astenersi dal trattare temi che toccassero <strong>la</strong> religione. Al rescritto reale<br />
Kant aveva accettato <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>re, pur ribadendo il proprio ruolo <strong>di</strong> intellettuale e <strong>di</strong> professore all’università <strong>di</strong> Königsberg.<br />
180 Sebbene nel<strong>la</strong> traduzione italiana si verifichi <strong>la</strong> contrapposizione tra «<strong>pace</strong> perpetua» e «milizie permanenti (miles<br />
perpetuus)», nel testo originale <strong>la</strong> <strong>pace</strong> si accosta all’attributo «ewig» mentre gli eserciti («Heere») da eliminare sono<br />
«stehende».<br />
62
Si tratta <strong>di</strong> stratagemmi <strong>di</strong>sonorevoli. Infatti anche in guerra deve pur continuare a esserci una<br />
certa fiducia nel modo <strong>di</strong> pensare del nemico, perché altrimenti non potrebbe essere conclusa al<br />
cuna <strong>pace</strong> e le ostilità si trasformerebbero in una guerra <strong>di</strong> sterminio (internecinum); poiché <strong>la</strong><br />
guerra è solo il triste rime<strong>di</strong>o necessario nello stato <strong>di</strong> natura (dove non esiste alcun tribunale<br />
che possa giu<strong>di</strong>care in forza del <strong>di</strong>ritto) per affermare con <strong>la</strong> violenza il proprio <strong>di</strong>ritto, in essa<br />
nessuna delle due parti può venire <strong>di</strong>chiarata nemico illegittimo (perché ciò già presuppone una<br />
sentenza del giu<strong>di</strong>ce), ma è solo il suo esito (come se si fosse davanti a un cosiddetto tribunale<br />
<strong>di</strong>vino) che decide da quale parte stia <strong>la</strong> ragione<br />
Nel<strong>la</strong> seconda parte dell’opera Kant stabilisce le regole me<strong>di</strong>ante cui tra gli Stati si può costruire<br />
un assetto pacifico. L’unica garanzia può provenire dai mo<strong>di</strong> del <strong>di</strong>ritto (legalità).<br />
In primo luogo, i rapporti internazionali devono cominciare con <strong>la</strong> costruzione all’interno <strong>di</strong><br />
ogni singolo Stato <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>namento repubblicano, il quale quantomeno si orienterà verso <strong>la</strong> via<br />
del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, <strong>la</strong>ddove ogni regime <strong>di</strong>spotico non ha nessuna remora verso <strong>la</strong> guerra.<br />
“In ogni Stato <strong>la</strong> costituzione civile deve essere repubblicana.”<br />
La costituzione fondata in primo luogo secondo i principi del<strong>la</strong> libertà dei membri <strong>di</strong> una società<br />
(in quanto uomini), in secondo luogo secondo i principi del<strong>la</strong> <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> tutti da un’unica<br />
legis<strong>la</strong>zione comune (in quanto sud<strong>di</strong>ti), in terzo luogo secondo <strong>la</strong> legge del<strong>la</strong> loro eguaglianza<br />
(in quanto citta<strong>di</strong>ni) [...] è quel<strong>la</strong> repubblicana. [...]<br />
La costituzione repubblicana [...] ha anche <strong>la</strong> prospettiva dell’esito desiderato, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua.<br />
E <strong>la</strong> ragione è <strong>la</strong> seguente. Se (come deve per forza accadere in questa costituzione) per decidere<br />
“se debba esserci o no <strong>la</strong> guerra” viene richiesto il consenso dei citta<strong>di</strong>ni, allora <strong>la</strong> cosa più naturale<br />
è che, dovendo decidere <strong>di</strong> subire loro stessi tutte le ca<strong>la</strong>mità del<strong>la</strong> guerra (il combattere <strong>di</strong><br />
persona; il pagare <strong>di</strong> tasca propria i costi del<strong>la</strong> guerra; il riparare con grande fatica le rovine che<br />
<strong>la</strong>scia <strong>di</strong>etro <strong>di</strong> sé e, per colmo delle sciagure, ancora un’altra che rende amara <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, il caricarsi<br />
<strong>di</strong> debiti che, a causa delle prossime nuove guerre, non si estingueranno mai), rifletteranno<br />
molto prima <strong>di</strong> iniziare un gioco così brutto. Al contrario, invece, in una costituzione non repubblicana,<br />
decidere <strong>la</strong> guerra è <strong>la</strong> cosa sul<strong>la</strong> quale si riflette <strong>di</strong> meno al mondo, poiché il sovrano<br />
non è il concitta<strong>di</strong>no, ma il proprietario dello Stato, e <strong>la</strong> guerra non toccherà minimamente i<br />
suoi banchetti, le sue battute <strong>di</strong> caccia, i suoi castelli in campagna, le sue feste <strong>di</strong> corte e così via,<br />
e può allora <strong>di</strong>chiarare <strong>la</strong> guerra come una specie <strong>di</strong> gara <strong>di</strong> piacere per futili motivi e, per rispetto<br />
delle forme, affidare con in<strong>di</strong>fferenza al corpo <strong>di</strong>plomatico, sempre pronto a questa bisogna,<br />
il compito <strong>di</strong> giustificar<strong>la</strong>.<br />
63
Dallo Stato repubblicano, dall’imperativo morale che ne rego<strong>la</strong> i rapporti interni, deriva l’idea<br />
<strong>di</strong> una garanzia sovranazionale del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, in cui, seppur in mancanza <strong>di</strong> un’autorità universale, gli<br />
Stati siano pronti ad accettare il riconoscimento <strong>di</strong> reciproche libertà.<br />
“Il <strong>di</strong>ritto internazionale deve fondarsi su un federalismo <strong>di</strong> liberi Stati.”<br />
I popoli, in quanto Stati, possono essere giu<strong>di</strong>cati come singoli uomini che si fanno reciproca<br />
mente ingiustizia già solo per il fatto <strong>di</strong> esser l’uno vicino all’altro nello stato <strong>di</strong> natura (ossia<br />
nell’in<strong>di</strong>pendenza da leggi esterne); e ciascuno <strong>di</strong> essi può e deve esigere <strong>di</strong> entrare con lui in<br />
una costituzione simile a quel<strong>la</strong> civile, nel<strong>la</strong> quale a ciascuno sia garantito il suo <strong>di</strong>ritto. Questo<br />
costituirebbe una federazione <strong>di</strong> popoli, che tuttavia non dovrebbe essere uno stato <strong>di</strong> popoli.<br />
Questa sarebbe una contrad<strong>di</strong>zione perché ogni Stato ha dentro <strong>di</strong> sé il rapporto <strong>di</strong> un superiore<br />
(il legis<strong>la</strong>tore) con un inferiore (che obbe<strong>di</strong>sce, il popolo cioè) [...]<br />
Attraverso un trattato <strong>di</strong> <strong>pace</strong> viene posta fine a questa guerra ma non allo stato <strong>di</strong> guerra [...]<br />
tra gli Stati [...] deve necessariamente esserci una federazione <strong>di</strong> tipo partico<strong>la</strong>re, che si può<br />
chiamare federazione <strong>di</strong> <strong>pace</strong> (foedus pacificum), che si <strong>di</strong>fferenzierebbe dal trattato <strong>di</strong> <strong>pace</strong><br />
(pactum pacis) per il fatto che questo cerca <strong>di</strong> porre fine semplicemente a una guerra, quel<strong>la</strong> invece<br />
a tutte le guerre per sempre. Questa federazione non si propone <strong>la</strong> costruzione <strong>di</strong> una potenza<br />
politica, ma semplicemente <strong>la</strong> conservazione e <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> libertà <strong>di</strong> uno Stato preso<br />
a sé e contemporaneamente degli altri Stati federati, senza che questi si sottomettano (come gli<br />
in<strong>di</strong>vidui nello stato <strong>di</strong> natura) a leggi pubbliche e al<strong>la</strong> costrizione da esse esercitata. Non è cosa<br />
impossibile immaginarci <strong>la</strong> realizzabilità (<strong>la</strong> realtà oggettiva) <strong>di</strong> questa idea <strong>di</strong> federazione, che<br />
si deve estendere progressivamente a tutti gli Stati e che conduce così al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua. [...]<br />
Per gli Stati, nel rapporto tra loro, è impossibile secondo <strong>la</strong> ragione pensare <strong>di</strong> uscire dal<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione<br />
del<strong>la</strong> mancanza <strong>di</strong> legge, che non contiene altro che <strong>la</strong> guerra, se non rinunciando, esattamente<br />
come fanno i singoli in<strong>di</strong>vidui, al<strong>la</strong> loro libertà selvaggia (senza legge), sottomettendosi<br />
a pubbliche leggi costrittive e formando così uno stato dei popoli (civitas gentium), che dovrà<br />
sempre crescere, per arrivare a comprendere finalmente tutti i popoli del<strong>la</strong> Terra. Ma poiché essi,<br />
secondo <strong>la</strong> loro idea <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale, non vogliono assolutamente una cosa del genere<br />
[...] allora al posto dell’idea positiva <strong>di</strong> una repubblica universale (se non si vuole che tutto<br />
vada perduto) c’è solo il surrogato negativo <strong>di</strong> un’alleanza contro <strong>la</strong> guerra, permanente e sempre<br />
più estesa, che può trattenere il torrente delle tendenze ostili e irrispettose <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto, ma<br />
nel costante pericolo che questo torrente <strong>di</strong><strong>la</strong>ghi.<br />
A conclusione degli articoli definitivi, Kant sancisce il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ospitalità, come vera e propria<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza del mondo, derivato dal fatto che originariamente <strong>la</strong> Terra apparteneva a<br />
tutto il genere umano senza <strong>di</strong>stinzione.<br />
64
“Il <strong>di</strong>ritto cosmopolitico deve essere limitato alle con<strong>di</strong>zioni dell’ospitalità universale.”<br />
Ora, poiché con <strong>la</strong> comunanza (più o meno stretta) tra i popoli del<strong>la</strong> Terra, che al<strong>la</strong> fine ha dap<br />
pertutto prevalso, si è arrivati a tal punto che <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto commessa in una parte<br />
del mondo viene sentita in tutte le altre parti, allora l’idea <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto cosmopolitico non appare<br />
più come un tipo <strong>di</strong> rappresentazione chimerica ed esaltata del <strong>di</strong>ritto, ma come un necessario<br />
completamento del co<strong>di</strong>ce non scritto sia del <strong>di</strong>ritto politico sia del <strong>di</strong>ritto internazionale verso il<br />
<strong>di</strong>ritto pubblico dell’umanità, e quin<strong>di</strong> verso <strong>la</strong> <strong>pace</strong> perpetua.<br />
65
5. Le analisi ottocentesche<br />
CONSTANT<br />
Il commercio sostituisce <strong>la</strong> guerra e favorisce <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
Nell’opera <strong>di</strong> Benjamin Constant 181 (1767-1830) <strong>la</strong> guerra e <strong>la</strong> <strong>pace</strong> sono analizzate in rapporto<br />
allo sviluppo economico-industriale. Le re<strong>la</strong>zioni commerciali tra gli stati moderni sono il contrario<br />
delle re<strong>la</strong>zioni che intercorrevano tra gli stati antichi.<br />
Tutte le repubbliche antiche erano racchiuse entro stretti confini. La più popolosa, <strong>la</strong> più poten<br />
te, <strong>la</strong> più importante tra loro non raggiungeva in estensione il più piccolo degli Stati moderni.<br />
Come inevitabile conseguenza del<strong>la</strong> scarsa estensione, lo spirito <strong>di</strong> tali repubbliche era bellico<br />
so; ogni popolo urtava continuamente i vicini, o era urtato da loro. Spinti in tal modo dal<strong>la</strong> ne<br />
cessità gli uni contro gli altri, si combattevano o si minacciavano senza posa. Quelli che non vo<br />
levano essere conquistatori non potevano deporre le armi, sotto pena <strong>di</strong> essere conquistati. Tutti<br />
acquistavano <strong>la</strong> sicurezza, l’in<strong>di</strong>pendenza, <strong>la</strong> loro intera esistenza a prezzo del<strong>la</strong> guerra. Era essa<br />
l’interesse costante, l’occupazione pressoché abituale degli Stati liberi dell’antichità.<br />
Lo spettacolo che ci offre il mondo moderno è tutto all’opposto. Gli Stati più piccoli dei nostri<br />
giorni sono senza confronto più vasti <strong>di</strong> Sparta o <strong>di</strong> Roma per cinque secoli del<strong>la</strong> sua storia. La<br />
stessa <strong>di</strong>visione dell’Europa in vari Stati è, grazie al progresso dei lumi, piuttosto apparente che<br />
reale. Mentre in passato ogni popolo formava una famiglia iso<strong>la</strong>ta, destinata ad essere nemica<br />
delle altre famiglie, ora una massa d’uomini esiste sotto nomi <strong>di</strong>versi e sotto mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi<br />
d’organizzazione sociale, essendo però per sua natura omogenea. E’ abbastanza forte per non<br />
avere niente da temere dalle orde dei barbari. E’ abbastanza illuminata a che <strong>la</strong> guerra sia <strong>di</strong> peso.<br />
La sua uniforme tendenza inclina al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
Questa <strong>di</strong>fferenza ne comporta un’altra. La guerra è anteriore al commercio; <strong>la</strong> guerra e il commercio<br />
sono infatti soltanto due mezzi <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> raggiungere il medesimo scopo: possedere ciò<br />
che si desidera. Il commercio non è che un omaggio reso al<strong>la</strong> forza del possessore dall’aspirante<br />
al possesso. E’ un tentativo <strong>di</strong> ottenere per via amichevole ciò che non si spera più <strong>di</strong> conquistare<br />
con <strong>la</strong> violenza. Un uomo che fosse sempre il più forte non avrebbe mai l’idea del commercio.<br />
E’ l’esperienza, provandogli che <strong>la</strong> guerra, cioè l’impiego del<strong>la</strong> sua forza contro <strong>la</strong> forza <strong>di</strong><br />
altri, lo espone a resistenza e scacchi ripetuti, a indurlo a ricorrere al commercio cioè a un mezzo<br />
più mite e sicuro d’impegnare l’interesse <strong>di</strong> un altro a consentire a ciò che conviene al suo<br />
181<br />
B. CONSTANT, La libertà degli antichi, paragonata a quel<strong>la</strong> dei moderni, a c. <strong>di</strong> Giovanni Paoletti, Torino, Einau<strong>di</strong>,<br />
2001, pp. 9-12, 15-6.<br />
66
proprio interesse. La guerra è l’istinto, il commercio è il calcolo. Ma per questo stesso motivo<br />
deve giungere un’epoca in cui il commercio sostituisca <strong>la</strong> guerra. A quest’epoca noi siamo arrivati.<br />
[...]<br />
Il commercio [...] è oggi <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione or<strong>di</strong>naria, l’unico fine, l’universale tendenza, <strong>la</strong> vera vita<br />
delle nazioni. Esse vogliono <strong>la</strong> quiete, il benessere; e come fonte del benessere, l’operosità. La<br />
guerra è giorno dopo giorno un mezzo sempre meno efficace <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare le loro aspettative. Le<br />
opportunità ch’essa offre non costituiscono più, né per in<strong>di</strong>vidui, né per le nazioni, benefici pari<br />
ai risultati del <strong>la</strong>voro pacifico e degli scambi rego<strong>la</strong>ri. Fra gli antichi, una guerra vittoriosa aumentava<br />
<strong>la</strong> ricchezza pubblica e privata in schiavi, tributi, spartizioni <strong>di</strong> terre. Fra i moderni, una<br />
guerra vittoriosa costa infallibilmente più <strong>di</strong> quanto renda<br />
TOCQUEVILLE<br />
I popoli amano <strong>la</strong> <strong>pace</strong> e gli eserciti <strong>la</strong> guerra<br />
Con <strong>la</strong> Democrazia in America 182 (1835-1840) <strong>di</strong> Tocqueville lo stu<strong>di</strong>o delle con<strong>di</strong>zioni politiche<br />
che portano al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> (interna e internazionale) si lega all’indagine sul funzionamento del<strong>la</strong> democrazia,<br />
vista come processo inevitabile.<br />
Quasi tutte le rivoluzioni che hanno mutato <strong>la</strong> faccia dei popoli sono state fatte per consacrare o<br />
per <strong>di</strong>struggere <strong>la</strong> <strong>di</strong>seguaglianza. Se mettete da parte le cause secondarie che hanno prodotto le<br />
gran<strong>di</strong> agitazioni umane, troverete quasi sempre come causa principale <strong>la</strong> <strong>di</strong>seguaglianza. Sono i<br />
poveri che hanno voluto strappare i beni ai ricchi ovvero i ricchi che hanno tentato <strong>di</strong> incatenare<br />
i poveri Se, dunque, riuscirete a fondare una società tale che in essa ognuno abbia qualcosa da<br />
conservare e poco da perdere, avrete fatto molto per <strong>la</strong> <strong>pace</strong> nel mondo. [...]<br />
Tutti costoro sono naturalmente nemici dei movimenti violenti.<br />
Al<strong>la</strong> repulsione verso il <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne pubblico, nei popoli democratici si accompagna il rifiuto del<strong>la</strong><br />
guerra. La guerra <strong>di</strong>strugge le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> benessere che si costruiscono in tempo <strong>di</strong> <strong>pace</strong>. Al contempo,<br />
una democrazia non può evitare <strong>di</strong> avere un esercito, dal momento che, anche controvoglia,<br />
un popolo democratico può essere costretto a combattere.<br />
182 3<br />
A. DE TOCQUEVILLE Democrazia in America, a c. <strong>di</strong> Giorgio Candeloro, Mi<strong>la</strong>no, Bur, 2002 , L. III, XXI-XXIII, XXVI<br />
pp. 679-85, 695-8.<br />
67
Il numero sempre crescente dei proprietari amici del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, lo sviluppo del<strong>la</strong> ricchezza mobile,<br />
che <strong>la</strong> guerra <strong>di</strong>vora tanto rapidamente, <strong>la</strong> mansuetu<strong>di</strong>ne dei costumi, <strong>la</strong> mitezza dei cuori, <strong>la</strong> <strong>di</strong>sposizione<br />
al<strong>la</strong> pietà che l’eguaglianza ispira, <strong>la</strong> freddezza del<strong>la</strong> ragione, che rende gli uomini<br />
poco sensibili alle emozioni violente e poetiche che nascono fra le armi: tutte queste cause unite<br />
contribuiscono ad estinguere lo spirito militare.<br />
Credo che si possa ammettere come rego<strong>la</strong> generale e costante che, presso i popoli civili, le passioni<br />
guerriere <strong>di</strong>verranno più rare e meno vive via via che le con<strong>di</strong>zioni si faranno più eguali.<br />
La guerra, tuttavia, è un accidente cui tutti i popoli sono soggetti, i popoli democratici come tutti<br />
gli altri. Qualunque sia il gusto che queste nazioni hanno per <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, bisogna che esse siano<br />
pronte a respingere <strong>la</strong> guerra o, in altri termini, bisogna che abbiano un esercito. [...]<br />
L’eguaglianza delle con<strong>di</strong>zioni e i costumi, come le istituzioni, che ne derivano, non sottraggono<br />
un popolo democratico all’obbligo <strong>di</strong> mantenere un esercito, il quale esercita sempre sul suo<br />
destino una grande influenza. E’ importante, quin<strong>di</strong>, ricercare quali siano i naturali istinti <strong>di</strong><br />
quelli che lo compongono. [...]<br />
Negli eserciti democratici [...] tutti i soldati possono <strong>di</strong>ventare ufficiali, ciò generalizza il desiderio<br />
dell’avanzamento ed estende infinitamente i limiti dell’ambizione militare.<br />
Presso i popoli democratici accade spesso che l’ufficiale non abbia altri beni oltre lo stipen<strong>di</strong>o e<br />
altra considerazione oltre i suoi onori militari. Ogni volta che cambia <strong>di</strong> funzioni, cambia <strong>di</strong> fortuna,<br />
<strong>di</strong>viene, in un certo senso, un altro uomo. [...]<br />
Negli eserciti democratici il desiderio <strong>di</strong> avanzare è quasi generale; è ardente, tenace, continuo;<br />
si accresce con tutti gli altri desideri e si estingue solo con <strong>la</strong> vita. Ora, è facile vedere che, <strong>di</strong><br />
tutti gli eserciti del mondo, quelli in cui l’avanzamento deve essere più lento in tempo <strong>di</strong> <strong>pace</strong>,<br />
sono gli eserciti democratici. Siccome il numero dei gra<strong>di</strong> è naturalmente limitato, il numero dei<br />
concorrenti gran<strong>di</strong>ssimo e <strong>la</strong> legge dell’eguaglianza pesa su tutti, nessuno può fare rapi<strong>di</strong> progressi<br />
e molti non riescono a muoversi dal posto che occupano. Così, il bisogno <strong>di</strong> fare carriera<br />
è più grande e <strong>la</strong> possibilità più picco<strong>la</strong> che altrove.<br />
Tutti gli ambiziosi che militano in un esercito democratico desiderano, quin<strong>di</strong>, ardentemente <strong>la</strong><br />
guerra, perché <strong>la</strong> guerra vuota i posti e permette <strong>di</strong> passare sopra al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> anzianità, unico<br />
privilegio naturale nel<strong>la</strong> democrazia.<br />
Arriviamo, dunque, al singo<strong>la</strong>re risultato, che, <strong>di</strong> tutti gli eserciti, quelli che desiderano più ardentemente<br />
<strong>la</strong> guerra sono quelli democratici e che, fra i popoli, quelli che amano <strong>di</strong> più <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
sono i popoli democratici e ciò che rende <strong>la</strong> cosa straor<strong>di</strong>naria è che questi effetti contrari sono<br />
entrambi prodotti dall’eguaglianza.<br />
I citta<strong>di</strong>ni, essendo eguali, concepiscono ogni giorno il desiderio e scoprono <strong>la</strong> possibilità <strong>di</strong> mutare<br />
<strong>la</strong> loro con<strong>di</strong>zione e aumentare il loro benessere: ciò li <strong>di</strong>spone naturalmente ad amare <strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong>, che fa prosperare l’industria e permette a ognuno <strong>di</strong> giungere a capo delle sue piccole imprese;<br />
d’altro canto <strong>di</strong> quelli che seguono <strong>la</strong> carriera delle armi e, rendendo gli onori accessibili<br />
68
a tutti, fa sognare ai soldati i campi <strong>di</strong> battaglia. Da tutte e due le parti troviamo <strong>la</strong> stessa irrequietezza<br />
d’animo, un desiderio dei beni altrettanto insaziabile; solo il mezzo <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfarlo è<br />
<strong>di</strong>verso.<br />
Queste <strong>di</strong>sposizioni contrarie del<strong>la</strong> nazione e dell’esercito fanno correre gran<strong>di</strong> pericoli alle società<br />
democratiche. [...]<br />
Nel<strong>la</strong> società democratica quasi tutti i citta<strong>di</strong>ni hanno delle proprietà da conservare, mentre gli<br />
eserciti democratici sono generalmente condotti da proletari, <strong>la</strong> maggior parte dei quali ha poco<br />
da perdere nei tumulti civili. <strong>la</strong> massa del<strong>la</strong> nazione teme naturalmente le rivoluzioni più che nei<br />
secoli aristocratici, ma i capi dell’esercito le temono molto meno.<br />
Inoltre, siccome nei popoli democratici, come ho detto ora, i citta<strong>di</strong>ni più ricchi, più istruiti, più<br />
capaci non entrano nel<strong>la</strong> carriera militare, avviene che l’esercito, nel suo insieme, finisce per costituire<br />
una picco<strong>la</strong> nazione a parte, nel<strong>la</strong> quale l’intelligenza è meno <strong>di</strong>ffusa e le abitu<strong>di</strong>ni sono<br />
più grosso<strong>la</strong>ne che nel<strong>la</strong> grande. Ora, questa picco<strong>la</strong> nazione meno civile possiede le armi, ed<br />
essa so<strong>la</strong> sa servirsene.<br />
Ciò che accresce effettivamente il pericolo che lo spirito militare e turbolento dell’esercito fa<br />
correre ai popoli democratici è il carattere pacifico dei citta<strong>di</strong>ni; nul<strong>la</strong> è più pericoloso <strong>di</strong> un esercito<br />
in seno a una nazione niente affatto guerriera; l’amore eccessivo <strong>di</strong> tutti i citta<strong>di</strong>ni per <strong>la</strong><br />
tranquillità mette quoti<strong>di</strong>anamente <strong>la</strong> costituzione al<strong>la</strong> mercè dei soldati.<br />
Si può, dunque, <strong>di</strong>re in generale che i popoli democratici, se sono naturalmente portati verso <strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong> dai loro interessi e dai loro istinti, sono continuamente attratti verso <strong>la</strong> guerra e le rivoluzioni<br />
dai loro eserciti.<br />
Il desiderio del singolo popolo <strong>di</strong> non utilizzare <strong>la</strong> guerra <strong>di</strong>venterà prospettiva <strong>di</strong>ffusa che potrà<br />
garantire, tra i popoli democratici, una <strong>pace</strong> solida e duratura.<br />
Quando il principio dell’eguaglianza non si sviluppa presso una nazione ma contemporaneamente<br />
presso molti popoli vicini, come accade ai nostri giorni in Europa, gli uomini che abitano<br />
questi <strong>di</strong>versi paesi, nonostante le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> lingua, <strong>di</strong> usi e <strong>di</strong> leggi, si rassomigliano tutti su<br />
<strong>di</strong> un punto: che temono in modo eguale <strong>la</strong> guerra e amano egualmente <strong>la</strong> <strong>pace</strong>. [...]<br />
Così se da un <strong>la</strong>to è <strong>di</strong>fficile nei secoli democratici trascinare i popoli al<strong>la</strong> guerra, d’altra parte è<br />
quasi impossibile che due <strong>di</strong> essi si facciano iso<strong>la</strong>tamente <strong>la</strong> guerra.<br />
SAINT-SIMON<br />
Il più sicuro mezzo per mantenere <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
sarà quello <strong>di</strong> portar<strong>la</strong> incessantemente fuori<br />
69
Nell’opuscolo La riorganizzazione del<strong>la</strong> società europea 183 ,Saint-Simon ipotizza un par<strong>la</strong>mento<br />
d’Europa con funzioni <strong>di</strong> garanzia del<strong>la</strong> convivenza pacifica tra i popoli: giu<strong>di</strong>cherà le <strong>di</strong>spute tra i<br />
governi nazionali e prescriverà, secondo i caratteri comuni dell’Europa, i principi su cui fondare <strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong>.<br />
L’Europa avrà <strong>la</strong> migliore organizzazione possibile se tutte lo nazioni che comprende, essendo<br />
ciascuna governata da un par<strong>la</strong>mento, riconoscono <strong>la</strong> supremazia <strong>di</strong> un par<strong>la</strong>mento generale posto<br />
al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> tutti i governi nazionali ed investito del potere <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care le loro contese.[…]<br />
È l’istituzione che forma gli uomini, <strong>di</strong>ce Montesquieu 184 ; così, questa tendenza che fa uscire il<br />
patriottismo fuori dei confini del<strong>la</strong> patria, questa abitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> considerare gl’interessi<br />
dell’Europa al posto degli interessi nazionali, sarà, per coloro che devono formare il par<strong>la</strong>mento<br />
europeo. un frutto necessario del<strong>la</strong> sua esistenza.<br />
E’ vero; son dunque gli uomini che fanno 1’istituzione; e l’istituzione non può crearsi se non li<br />
trova già bell’e formati o, almeno, preparati ad esserlo.<br />
Appare necessario perciò <strong>di</strong> non ammettere nel<strong>la</strong> camera dei deputati del par<strong>la</strong>mento europeo, e<br />
cioè in uno dei due poteri attivi del<strong>la</strong> costituzione europea, se non uomini i quali, per re<strong>la</strong>zioni<br />
più estese, per abitu<strong>di</strong>ni circoscritte il meno possibile all’ambiente natio, per <strong>la</strong>vori, <strong>la</strong> cui utilità<br />
non è limitata agli usi nazionali, ma si stende su tutti i popoli, siano più capaci <strong>di</strong> arrivare subito<br />
a quel<strong>la</strong> generalità <strong>di</strong> vedute, che deve essere lo spirito <strong>di</strong> corpo, a quell’interesse generale, che<br />
dev’essere l’interesse <strong>di</strong> corpo del par<strong>la</strong>mento europeo.<br />
Negozianti, sapienti, magistrati ed amministratori soltanto devono esser chiamati a formare <strong>la</strong><br />
camera dei deputati del grande par<strong>la</strong>mento.<br />
E in effetti, tutto quel <strong>di</strong> comune che v’è negli interessi del<strong>la</strong> società europea può essere rapportato<br />
alle scienze, alle arti, al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, al commercio, all’amministrazione ed all’industria.<br />
Ogni milione d’uomini che sappiano leggere e scrivere in Europa, dovrà designare al<strong>la</strong> camera<br />
dei comuni del grande par<strong>la</strong>mento un negoziante, un sapiente, un amministratore ed un magistrato.<br />
Così, supponendo che in Europa vi siano sessanta milioni <strong>di</strong> uomini che sappiano leggere<br />
e scrivere, <strong>la</strong> camera sarà composta <strong>di</strong> duecentoquaranta membri. […]<br />
E’ certamente vero che <strong>la</strong> proprietà costituisce <strong>la</strong> stabilità del governo, ma è solo quando <strong>la</strong> proprietà<br />
non è separata dal progresso, che il governo può solidamente riposare su <strong>di</strong> essa. Conviene,<br />
dunque, che il governo chiami nel suo seno e faccia partecipi del<strong>la</strong> proprietà quelli tra i non<br />
proprietari che uno straor<strong>di</strong>nario merito <strong>di</strong>stingue, allo scopo <strong>di</strong> non far essere <strong>di</strong>visi il talento ed<br />
il possesso; giacché il talento, che è <strong>la</strong> più grande forza e <strong>la</strong> forza più attiva, usurperebbe presto<br />
<strong>la</strong> proprietà, se non fosse a questa unito.[...]<br />
183<br />
H. DE SAINT-SIMON – A. THIERRY, Sogno d’una felice Europa, a c. <strong>di</strong> C. Curcio, Roma, Colombo, 1945, pp. 96-100,<br />
144-7, i brani riportati sono traduzioni dall’opera De <strong>la</strong> réorganisation de <strong>la</strong> Société européenne, Libro II, capp. I-V;<br />
libro III, concl.<br />
184<br />
70
Senza attività all’esterno, non v’è tranquillità all’interno. I1 più sicuro mezzo per mantenere <strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong> nel<strong>la</strong> confederazione sarà quello <strong>di</strong> portar<strong>la</strong> incessantemente fuor <strong>di</strong> se stessa e <strong>di</strong> occupar<strong>la</strong><br />
senza tregua in gran<strong>di</strong> <strong>la</strong>vori interni. Popo<strong>la</strong>re il globo del<strong>la</strong> razza europea, ch’è superiore a tutte<br />
le altre razze <strong>di</strong> uomini, renderlo viaggiabile ed abitabile come l’Europa, ecco l’impresa con cui<br />
il par<strong>la</strong>mento europeo dovrà continuamente esercitare l’attività dell’Europa, tenendo<strong>la</strong> sempre<br />
viva.[...]<br />
Un co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> morale, così generale come nazionale ed in<strong>di</strong>viduale. sarà redatto a cura del gran<br />
par<strong>la</strong>mento, per essere insegnato in tutta l’Europa. Vi sarà <strong>di</strong>mostrato che i principî, sui quali riposerà<br />
<strong>la</strong> confederazione europea sono i migliori, i più soli<strong>di</strong>, i soli capaci <strong>di</strong> rendere <strong>la</strong> società<br />
così felice come può esser<strong>la</strong> in considerazione e del<strong>la</strong> natura umana e dello stato dei suoi lumi.<br />
Il gran par<strong>la</strong>mento permetterà l’intera libertà <strong>di</strong> coscienza ed il libero esercizio <strong>di</strong> tutte le religioni:<br />
ma proibirà quelle i cui principi saranno contrari al grande co<strong>di</strong>ce morale, che sarà stato<br />
fissato.<br />
Così, vi sarà tra i popoli europei ciò che forma il legame e <strong>la</strong> base <strong>di</strong> ogni associazione politica;<br />
conformità d’istituzioni, unione <strong>di</strong> interessi, rapporti <strong>di</strong> massima, comunanza morale e <strong>di</strong> istruzione<br />
pubblica. [...]<br />
Verrà senza dubbio un giorno, in cui tutti i popoli dell’Europa sentiranno che bisogna rego<strong>la</strong>re i<br />
punti <strong>di</strong> interesse generale, prima <strong>di</strong> affrontare gl’interessi nazionali; allora i mali cominceranno<br />
a <strong>di</strong>venire minori, i dubbi a svanire, le guerre a spegnersi; è lì, che miriamo incessantemente, è lì<br />
che il cuore dello spirito umano ci porta!<br />
71
6. Al tempo delle guerre mon<strong>di</strong>ali<br />
EINSTEIN - FREUD<br />
La guerra è vinta, ma non c’è <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
Einstein analizza le cause del<strong>la</strong> guerra tra gli stati interpretando tutte le manifestazioni <strong>di</strong> più dete<br />
riore aggressività del<strong>la</strong> storia umana: le guerre civili e <strong>di</strong> religione, le persecuzioni razziali. La matrice<br />
profonda risiederebbe nel<strong>la</strong> psicologia umana, caratterizzata da forte aggressività ma <strong>di</strong> norma<br />
dormiente.<br />
Lettera <strong>di</strong> Albert Einstein a Sigmund Freud (30 luglio 1932) 185<br />
Caro Dottor Freud,<br />
La Società delle Nazioni 186 e il suo Istituto Internazionale per <strong>la</strong> Cooperazione Intellettuale 187 , a Parigi,<br />
mi hanno chiesto <strong>di</strong> invitare una persona <strong>di</strong> mia scelta a un franco scambio <strong>di</strong> vedute su un problema<br />
che io ritengo <strong>di</strong> grande rilevanza; mi offre <strong>la</strong> gradevole possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scutere con Lei <strong>di</strong><br />
una questione che nel<strong>la</strong> situazione attuale sembra <strong>la</strong> più importante fra tutte quelle che <strong>la</strong> nostra civiltà<br />
deve affrontare. Il problema è questo; esiste possibilità <strong>di</strong> liberare l’umanità dal<strong>la</strong> minaccia <strong>di</strong><br />
guerra? Tutti sanno ormai che, cogli sviluppi del<strong>la</strong> scienza moderna, l’alternativa è tra <strong>la</strong> vita e <strong>la</strong><br />
morte del<strong>la</strong> civiltà nel<strong>la</strong> sua struttura attuale; tuttavia, nonostante tutti gli sforzi fatti, ogni tentativo<br />
per trovare una soluzione è fallito miseramente.<br />
Einstein presenta <strong>la</strong> soluzione che già da tempo ha maturato, ovvero un’organizzazione internazionale<br />
che possa <strong>di</strong>rimere le tensioni.<br />
Immune da pregiu<strong>di</strong>zi nazionalistici, personalmente vedo un modo semplice per trattare l’aspetto<br />
superficiale (cioè organizzativo) del problema: istituire per consenso internazionale un ente, con<br />
compiti legis<strong>la</strong>tivi e giu<strong>di</strong>ziari, che risolva le controversie fra gli stati. [...]<br />
L’insuccesso <strong>di</strong> tutti i più sinceri sforzi fatti durante l’ultimo decennio per conseguire questo obiettivo<br />
ci induce a credere che entrino in azione forti fattori psicologici che paralizzano ogni tentativo.<br />
185<br />
I brani riportati sono tratti da S. FREUD (1932), Perché <strong>la</strong> guerra? (Carteggio con Einstein), in ID., Opere, vol. XI,<br />
Torino, Boringhieri, 1979, pp. 285-303.<br />
186<br />
Si tratta <strong>di</strong> un'organizzazione internazionale fondata il 25 gennaio 1919, prevista dal<strong>la</strong> parte I del Trattato <strong>di</strong> Versailles<br />
con cui si chiuse definitivamente <strong>la</strong> I guerra mon<strong>di</strong>ale. La sua missione venne prevista proprio per prevenire le cause<br />
<strong>di</strong> un nuovo conflitto.<br />
187<br />
Nel 1931 l'Istituto internazionale per <strong>la</strong> cooperazione intellettuale, organo interno del<strong>la</strong> Società delle Nazioni e precursore<br />
dell'UNESCO, promosse una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>battiti tra le personalità più in vista dell'epoca su temi d'attualità<br />
72
Non è <strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduare alcuni <strong>di</strong> tali fattori. La brama dl potere che caratterizza le c<strong>la</strong>ssi <strong>di</strong> go<br />
verno in ogni nazione comporta l’ostilità verso ogni limitazione del<strong>la</strong> sovranità nazionale. [...]<br />
Prendere atto <strong>di</strong> questi fatti evidenti, tuttavia, costituisce solo un primo passo verso <strong>la</strong> comprensione<br />
del<strong>la</strong> situazione reale. Un’altra questione si impone imme<strong>di</strong>atamente: come è possibile che questa<br />
ristretta cricca riesca a piegare al servizio delle proprie ambizioni <strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> una maggioranza destinata<br />
a per<strong>di</strong>te e a sofferenze in caso <strong>di</strong> guerra? [...]. L’ovvia risposta sembrerebbe che quel<strong>la</strong> minoranza,<br />
l’attuale c<strong>la</strong>sse dominante, tiene sotto il tallone <strong>la</strong> scuo<strong>la</strong>, <strong>la</strong> stampa, spesso anche le Chiese.<br />
Ciò <strong>la</strong> pone in grado <strong>di</strong> incana<strong>la</strong>re e <strong>di</strong> dominare le emozioni delle masse e <strong>di</strong> farsi gioco <strong>di</strong> loro.<br />
Anche questa risposta tuttavia non fornisce una soluzione esauriente. Da essa sorge un’altra questione:<br />
come può accadere che questi espe<strong>di</strong>enti riescano a risvegliare negli uomini un entusiasmo<br />
così selvaggio da spingerli ad agire fino al sacrificio del<strong>la</strong> propria vita? C’è una so<strong>la</strong> possibile risposta.<br />
È perché l’uomo ha dentro <strong>di</strong> sé una brama <strong>di</strong> o<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> <strong>di</strong>struzione. In tempi normali questa<br />
passione esiste allo stato <strong>la</strong>tente ed emerge solo in circostanze eccezionali, ma è re<strong>la</strong>tivamente facile<br />
suscitar<strong>la</strong> e portar<strong>la</strong> al livello <strong>di</strong> una psicosi collettiva. Qui forse si trova il punto cruciale rispetto a<br />
tutti i complessi fattori che stiamo considerando, un enigma che solo un esperto nel campo degli istinti<br />
umani può risolvere.<br />
Infine, si arriva al quesito fondamentale, cui Freud più <strong>di</strong> tutti dovrebbe dare risposta: <strong>la</strong> possibilità<br />
<strong>di</strong> poter control<strong>la</strong>re le facoltà mentali dell’uomo in modo da poter impe<strong>di</strong>re che l’istinto al<strong>la</strong> <strong>di</strong>struzione,<br />
in ogni caso <strong>di</strong> conflittualità (non solo quel<strong>la</strong> tra gli stati), venga reso innocuo.<br />
È possibile control<strong>la</strong>re lo sviluppo mentale dell’uomo, in modo da renderlo immune dal<strong>la</strong> psicosi<br />
dell’o<strong>di</strong>o e del<strong>la</strong> <strong>di</strong>struzione? Non sto assolutamente pensando solo alle cosiddette masse ignoranti.<br />
L’esperienza <strong>di</strong>mostra che proprio <strong>la</strong> cosiddetta « intellighenzia » è più incline a queste <strong>di</strong>sastrose<br />
suggestioni collettive, poiché gli intellettuali non hanno un contatto <strong>di</strong>retto con le durezze del<strong>la</strong> vita,<br />
ma le conoscono attraverso <strong>la</strong> loro manifestazione più comoda e sintetica, attraverso le pagine dei<br />
giornali.<br />
In conclusione: finora ho par<strong>la</strong>to solo delle guerre fra le nazioni, quelle che in<strong>di</strong>chiamo come conflitti<br />
internazionali. Ma sono ben cosciente del fatto che l’istinto aggressivo agisce anche sotto altre<br />
forme e in altre circostanze.<br />
Lettera <strong>di</strong> S. Freud a A. Einstein (settembre 1932)<br />
Dopo aver esplicitato il dubbio <strong>di</strong> impegnarsi su un tema (<strong>la</strong> ricerca del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>) che sembra de<br />
stinato al<strong>la</strong> politica, Freud riprende e sviluppa i temi <strong>di</strong> Einstein.<br />
Caro signor Einstein, [....]<br />
73
Lei comincia con il rapporto tra <strong>di</strong>ritto e forza. È certamente il punto <strong>di</strong> partenza giusto per <strong>la</strong><br />
nostra indagine. Posso sostituire <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> “forza” con <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> più incisiva e più dura “violenza”?<br />
Diritto e violenza sono per noi oggi termini opposti. È facile mostrare che l’uno si è sviluppato<br />
dall’altro e, se risaliamo ai primor<strong>di</strong> del<strong>la</strong> vita umana per verificare come ciò sia da<br />
principio accaduto, <strong>la</strong> soluzione del problema ci appare senza <strong>di</strong>fficoltà. Mi scusi se nel seguito<br />
parlo <strong>di</strong> ciò che è universalmente noto come se fosse nuovo; <strong>la</strong> concatenazione dell’insieme mi<br />
obbliga a farlo.<br />
I conflitti d’interesse tra gli uomini sono dunque in linea <strong>di</strong> principio decisi me<strong>di</strong>ante l’uso del<strong>la</strong><br />
violenza. Ciò avviene in tutto il regno animale, <strong>di</strong> cui l’uomo fa inequivocabilmente parte; per<br />
gli uomini si aggiungono, a <strong>di</strong>re il vero, anche i conflitti <strong>di</strong> opinione, che arrivano fino alle più<br />
alte cime dell’astrazione e sembrano esigere, per essere decisi, un’altra tecnica. Ma questa è una<br />
complicazione che interviene più tar<strong>di</strong>. Inizialmente, in una picco<strong>la</strong> orda umana, <strong>la</strong> maggiore<br />
forza musco<strong>la</strong>re decise a chi dovesse appartenere qualcosa o <strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> chi dovesse essere<br />
portata ad attuazione. Presto <strong>la</strong> forza musco<strong>la</strong>re viene accresciuta o sostituita me<strong>di</strong>ante l’uso <strong>di</strong><br />
strumenti; vince chi ha le armi migliori o le adopera più abilmente. Con l’introduzione delle armi<br />
<strong>la</strong> superiorità intellettuale comincia già a prendere il posto del<strong>la</strong> forza musco<strong>la</strong>re bruta, benché<br />
lo scopo finale del<strong>la</strong> lotta rimanga il medesimo[...]<br />
Questo è dunque lo stato originario, il predominio del più forte, del<strong>la</strong> violenza bruta o sostenuta<br />
dall’intelligenza. Sappiamo che questo regime è stato mutato nel corso dell’evoluzione, che una<br />
strada condusse dal<strong>la</strong> violenza al <strong>di</strong>ritto, ma quale? Una so<strong>la</strong> a mio parere: quel<strong>la</strong> che passava<br />
per l’accertamento che lo strapotere <strong>di</strong> uno solo poteva essere bi<strong>la</strong>nciato dall’unione <strong>di</strong> più deboli.<br />
L’union fait <strong>la</strong> force. La violenza viene spezzata dall’unione <strong>di</strong> molti, <strong>la</strong> potenza <strong>di</strong> coloro<br />
che si sono uniti rappresenta ora il <strong>di</strong>ritto in opposizione al<strong>la</strong> violenza del singolo. Ve<strong>di</strong>amo così<br />
che il <strong>di</strong>ritto è <strong>la</strong> potenza <strong>di</strong> una comunità. È ancora sempre violenza, pronta a volgersi contro<br />
chiunque le si opponga, opera con gli stessi mezzi, persegue gli stessi scopi; <strong>la</strong> <strong>di</strong>fferenza risiede<br />
in realtà solo nel fatto che non è più <strong>la</strong> violenza <strong>di</strong> un singolo a trionfare, ma quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> comunità.<br />
Ma perché si compia questo passaggio dal<strong>la</strong> violenza al nuovo <strong>di</strong>ritto deve adempiersi una<br />
con<strong>di</strong>zione psicologica. L’unione dei più deve essere stabile, durevole. Se essa si costituisse solo<br />
allo scopo <strong>di</strong> combattere il prepotente e si <strong>di</strong>ssolvesse dopo averlo sopraffatto, non si otterrebbe<br />
niente. Il prossimo personaggio che si ritenesse più forte ambirebbe <strong>di</strong> nuovo a dominare<br />
con <strong>la</strong> violenza, e il giuoco si ripeterebbe senza fine.<br />
La comunità politica che limita <strong>la</strong> violenza del singolo me<strong>di</strong>ante il <strong>di</strong>ritto può tenersi in <strong>pace</strong> solo<br />
nel<strong>la</strong> misura in cui è composta da in<strong>di</strong>vidui «egualmente forti». In verità il <strong>di</strong>ritto si trasforma<br />
storicamente nel<strong>la</strong> forma <strong>di</strong> oppressione dei più forti sui più deboli nel<strong>la</strong> società. Nel confronto tra<br />
chi spinge per creare un <strong>di</strong>ritto come base dell’eguaglianza e chi lo vuole piegare al<strong>la</strong> <strong>di</strong>fferenza si<br />
74
itorna al<strong>la</strong> violenza da cui scaturisce una nuova costruzione giuri<strong>di</strong>ca, con sempre maggiore capaci<br />
tà <strong>di</strong> instaurare <strong>la</strong> <strong>pace</strong>.<br />
Con ciò, penso, tutto l’essenziale è gia stato detto: il trionfo sul<strong>la</strong> violenza me<strong>di</strong>ante <strong>la</strong> trasmissione<br />
del potere a una comunità più vasta che viene tenuta insieme dai legami emotivi tra i suoi<br />
membri. Tutto il resto sono precisazioni e ripetizioni. La cosa è semplice finché <strong>la</strong> comunità<br />
consiste solo <strong>di</strong> un certo numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui ugualmente forti. Le leggi <strong>di</strong> questo sodalizio determinano<br />
allora fino a che punto debba essere limitata <strong>la</strong> libertà <strong>di</strong> ogni in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong> usare <strong>la</strong><br />
sua forza in modo violento, al fine <strong>di</strong> rendere possibile una vita collettiva sicura. Ma un tale stato<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong> è pensabile solo teoricamente, nel<strong>la</strong> realtà le circostanze si complicano perché <strong>la</strong> comunità<br />
fin dall’inizio comprende elementi <strong>di</strong> forza ineguale, uomini e donne, genitori e figli, e<br />
ben presto, in conseguenza del<strong>la</strong> guerra e dell’assoggettamento, vincitori e vinti, che si trasformano<br />
in padroni e schiavi. Il <strong>di</strong>ritto del<strong>la</strong> comunità <strong>di</strong>viene allora espressione dei rapporti <strong>di</strong><br />
forza ineguali all’interno <strong>di</strong> essa, le leggi vengono fatte da e per quelli che comandano e concedono<br />
scarsi <strong>di</strong>ritti a quelli che sono stati assoggettati. Da allora in poi vi sono nel<strong>la</strong> comunità<br />
due fonti d’inquietu<strong>di</strong>ne - ma anche <strong>di</strong> perfezionamento - del <strong>di</strong>ritto. In primo luogo il tentativo<br />
<strong>di</strong> questo o quel signore <strong>di</strong> ergersi al <strong>di</strong> sopra delle restrizioni valide per tutti, per tornare dunque<br />
dal regno del <strong>di</strong>ritto a quello del<strong>la</strong> violenza; in secondo luogo gli sforzi costanti dei sud<strong>di</strong>ti per<br />
procurarsi più potere e per vedere riconosciuti dal<strong>la</strong> legge questi mutamenti, dunque, al contrario,<br />
per inoltrarsi dal <strong>di</strong>ritto ineguale verso il <strong>di</strong>ritto uguale per tutti. […]<br />
Ve<strong>di</strong>amo dunque che anche all’interno <strong>di</strong> una collettività non può venire evitata <strong>la</strong> risoluzione<br />
violenta dei conflitti. Ma le necessità e le coincidenze <strong>di</strong> interessi che derivano dal<strong>la</strong> vita in comune<br />
sul<strong>la</strong> medesima terra favoriscono una rapida conclusione <strong>di</strong> tali lotte, e le probabilità che<br />
in queste con<strong>di</strong>zioni si giunga a soluzioni pacifiche sono in continuo aumento. [...]<br />
Per quanto riguarda <strong>la</strong> nostra epoca, si impone <strong>la</strong> medesima conclusione a cui Lei è giunto per<br />
una via più breve. Una prevenzione sicura del<strong>la</strong> guerra è possibile solo se gli uomini si accordano<br />
per costituire un’autorità centrale, al cui verdetto vengano deferiti tutti i conflitti <strong>di</strong> interessi.<br />
Sono qui chiaramente racchiuse due esigenze <strong>di</strong>verse: quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> creare una simile Corte suprema,<br />
e quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> assicurarle il potere che le abbisogna. La prima senza <strong>la</strong> seconda non gioverebbe<br />
a nul<strong>la</strong>. Ora <strong>la</strong> Società delle Nazioni è stata concepita come suprema potestà del genere, ma <strong>la</strong><br />
seconda con<strong>di</strong>zione non è stata adempiuta; <strong>la</strong> Società delle Nazioni non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> forza propria<br />
e può averne una solo se i membri del<strong>la</strong> nuova associazione - i singoli Stati - glie<strong>la</strong> concedono.<br />
Tuttavia per il momento ci sono scarse probabilità che ciò avvenga. Ci sfuggirebbe il significato<br />
<strong>di</strong> un’istituzione come quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> Società delle Nazioni, se ignorassimo il fatto che qui ci troviamo<br />
<strong>di</strong> fronte a un tentativo coraggioso, raramente intrapreso nel<strong>la</strong> storia dell’umanità e forse<br />
mai in questa misura. Essa è il tentativo <strong>di</strong> acquisire me<strong>di</strong>ante il richiamo a determinati princìpi<br />
ideali l’autorità (cioè l’influenza coercitiva) che <strong>di</strong> solito si basa sul possesso del<strong>la</strong> forza. […] È<br />
75
fin troppo chiaro che gli ideali nazionali da cui oggi i popoli sono dominati spingono in<br />
tutt’altra <strong>di</strong>rezione. C’è chi pre<strong>di</strong>ce che soltanto <strong>la</strong> penetrazione universale del modo <strong>di</strong> pensare<br />
bolscevico 188 potrà mettere fine alle guerre, ma in ogni caso siamo oggi ben lontani da tale meta,<br />
che forse sarà raggiungibile solo a prezzo <strong>di</strong> spaventose guerre civili. Sembra dunque che il tentativo<br />
<strong>di</strong> sostituire <strong>la</strong> forza reale con <strong>la</strong> forza delle idee sia per il momento votato all’insuccesso.<br />
È un errore <strong>di</strong> calcolo non considerare il fatto che il <strong>di</strong>ritto originariamente era violenza bruta e<br />
che esso ancor oggi non può fare a meno <strong>di</strong> ricorrere al<strong>la</strong> violenza.<br />
Freud riprende quin<strong>di</strong> il tema delle pulsioni opposte che governano <strong>la</strong> psiche umana. Da ciò deriverebbero<br />
le proposte per consentire <strong>di</strong> attuare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> tra gli uomini: in<strong>di</strong>retta, ovvero passando<br />
per <strong>la</strong> psiche umana; <strong>di</strong>retta, attraverso l’azione del potere politico.<br />
Posso ora procedere a commentare un’altra delle Sue proposizioni. Lei si meraviglia che sia tanto<br />
facile infiammare gli uomini al<strong>la</strong> guerra, e presume che in loro ci sia effettivamente qualcosa,<br />
una pulsione all’o<strong>di</strong>o e al<strong>la</strong> <strong>di</strong>struzione, che è pronta ad accogliere un’istigazione siffatta. Di<br />
nuovo non posso far altro che convenire senza riserve con Lei. Noi cre<strong>di</strong>amo all’esistenza <strong>di</strong> tale<br />
istinto e negli ultimi anni abbiamo appunto tentato <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are le sue manifestazioni. [...]<br />
Partendo dal<strong>la</strong> nostra dottrina mitologica delle pulsioni, giungiamo facilmente a una formu<strong>la</strong> per<br />
definire le vie in<strong>di</strong>rette <strong>di</strong> lotta al<strong>la</strong> guerra. Se <strong>la</strong> propensione al<strong>la</strong> guerra è un prodotto del<strong>la</strong> pulsione<br />
<strong>di</strong>struttiva, contro <strong>di</strong> essa è ovvio ricorrere all’antagonista <strong>di</strong> questa pulsione: l’Eros. Tutto<br />
ciò che fa sorgere legami emotivi tra gli uomini deve agire contro <strong>la</strong> guerra. Questi legami possono<br />
essere <strong>di</strong> due tipi. In primo luogo re<strong>la</strong>zioni che pur essendo prive <strong>di</strong> meta sessuale assomiglino<br />
a quelle che si hanno con un oggetto d’amore. La psicoanalisi non ha bisogno <strong>di</strong> vergognarsi<br />
se qui par<strong>la</strong> <strong>di</strong> amore, perché <strong>la</strong> religione <strong>di</strong>ce <strong>la</strong> stessa cosa: “ama il prossimo tuo come<br />
te stesso”.<br />
Ora, questo è un precetto facile da esigere, ma <strong>di</strong>fficile da attuare. L’altro tipo <strong>di</strong> legame emotivo<br />
è quello per identificazione. Tutto ciò che provoca solidarietà significative tra gli uomini risveglia<br />
sentimenti comuni <strong>di</strong> questo genere, le identificazioni. Su <strong>di</strong> esse riposa in buona parte<br />
l’assetto del<strong>la</strong> società umana.<br />
L’abuso <strong>di</strong> autorità da Lei <strong>la</strong>mentato mi suggerisce un secondo metodo per combattere in<strong>di</strong>rettamente<br />
<strong>la</strong> tendenza al<strong>la</strong> guerra. Fa parte dell’innata e ineliminabile <strong>di</strong>seguaglianza tra gli uomini<br />
<strong>la</strong> loro <strong>di</strong>stinzione in capi e seguaci. Questi ultimi sono <strong>la</strong> stragrande maggioranza, hanno bisogno<br />
<strong>di</strong> un’autorità che prenda decisioni per loro, al<strong>la</strong> quale perlopiù si sottomettono incon<strong>di</strong>zionatamente.<br />
Richiamandosi a questa realtà, si dovrebbero de<strong>di</strong>care maggiori cure, più <strong>di</strong> quanto<br />
si sia fatto finora all’educazione <strong>di</strong> una categoria superiore <strong>di</strong> persone dotate <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza<br />
<strong>di</strong> pensiero, inaccessibili alle intimidazioni e cultrici del<strong>la</strong> verità, alle quali dovrebbe spettare <strong>la</strong><br />
188 Il bolscevismo era stato il movimento che aveva condotto <strong>la</strong> rivoluzione russa del 1917.<br />
76
guida delle masse prive <strong>di</strong> autonomia. […] Ma secondo ogni probabilità questa è una speranza<br />
utopistica. Le altre vie per impe<strong>di</strong>re in<strong>di</strong>rettamente <strong>la</strong> guerra sono certo più praticabili, ma non<br />
promettono alcun rapido successo. E’ triste pensare a mulini che macinano talmente adagio che<br />
<strong>la</strong> gente muore <strong>di</strong> fame prima <strong>di</strong> ricevere <strong>la</strong> farina.<br />
In ultimo Freud affronta il tema del pacifismo. La speranza, concreta ma impreve<strong>di</strong>bile, è che il<br />
rifiuto delle pulsioni guerresche <strong>di</strong>venti un giorno patrimonio <strong>di</strong> tutta l’umanità.<br />
Perché ci in<strong>di</strong>gniamo tanto contro <strong>la</strong> guerra, Lei e io e tanti altri, perché non <strong>la</strong> pren<strong>di</strong>amo come<br />
una delle molte e penose ca<strong>la</strong>mità del<strong>la</strong> vita? La guerra sembra conforme al<strong>la</strong> natura, pienamen<br />
te giustificata biologicamente, in pratica assai poco evitabile. Non inorri<strong>di</strong>sca perché pongo <strong>la</strong><br />
domanda. [...] credo che <strong>la</strong> ragione principale per cui ci in<strong>di</strong>gniamo contro <strong>la</strong> guerra è che non<br />
possiamo fare a meno <strong>di</strong> farlo. Siamo pacifisti perché dobbiamo esserlo per ragioni organiche:<br />
ci è poi facile giustificare il nostro atteggiamento con argomentazioni.<br />
So <strong>di</strong> dovermi spiegare, altrimenti non sarò capito. Ecco quello che voglio <strong>di</strong>re: da tempi immemorabili<br />
l’umanità è soggetta al processo dell’incivilimento (altri, lo so, chiamano più volentieri<br />
questo processo: civilizzazione). Dobbiamo ad esso il meglio <strong>di</strong> ciò che siamo <strong>di</strong>venuti e<br />
buona parte <strong>di</strong> ciò <strong>di</strong> cui soffriamo. […]<br />
Dei caratteri psicologici del<strong>la</strong> civiltà, due sembrano i più importanti: il rafforzamento<br />
dell’intelletto, che comincia a dominare <strong>la</strong> vita pulsionale, e l’interiorizzazione dell’aggressività,<br />
con tutti i vantaggi e i pericoli che ne conseguono. Orbene, poiché <strong>la</strong> guerra contrad<strong>di</strong>ce nel<br />
modo più stridente a tutto l’atteggiamento psichico che ci è imposto dal processo civile, dobbiamo<br />
necessariamente ribel<strong>la</strong>rci contro <strong>di</strong> essa: semplicemente non <strong>la</strong> sopportiamo più; non si<br />
tratta soltanto <strong>di</strong> un rifiuto intellettuale e affettivo, per noi pacifisti si tratta <strong>di</strong> un’intolleranza<br />
costituzionale, per così <strong>di</strong>re del<strong>la</strong> massima i<strong>di</strong>osincrasia. E mi sembra che le degradazioni estetiche<br />
del<strong>la</strong> guerra non abbiano nel nostro rifiuto una parte molto minore delle sue crudeltà.<br />
Quanto dovremo aspettare perché anche gli altri <strong>di</strong>ventino pacifisti? Non si può <strong>di</strong>rlo, ma forse<br />
non è una speranza utopistica che l’influsso <strong>di</strong> due fattori - un atteggiamento più civile e il giustificato<br />
timore degli effetti <strong>di</strong> una guerra futura - ponga fine alle guerre in un prossimo avvenire.<br />
Per quali vie <strong>di</strong>rette o traverse non possiamo indovinarlo. Nel frattempo possiamo <strong>di</strong>rci: tutto<br />
ciò che promuove l’evoluzione civile <strong>la</strong>vora anche contro <strong>la</strong> guerra.<br />
La saluto cor<strong>di</strong>almente e Le chiedo scusa se le mie osservazioni L’hanno delusa.<br />
77
7. Nel<strong>la</strong> stagione del<strong>la</strong> “guerra fredda”<br />
KELSEN<br />
La <strong>pace</strong> è caratterizzata dall’assenza del<strong>la</strong> forza<br />
Pur consapevole delle insormontabili <strong>di</strong>fficoltà del suo progetto <strong>di</strong> Pace attraverso il <strong>di</strong>ritto 189 , Kel<br />
sen si attarda ad artico<strong>la</strong>re il ragionamento.<br />
Quantunque una società nasca per garantire <strong>la</strong> <strong>pace</strong> tra i suoi componenti, il suo or<strong>di</strong>namento deve<br />
prevedere, come capacità sanzionatoria, l’utilizzo del<strong>la</strong> forza. Se così è stato per costruire <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
dentro gli stati, per costruire una <strong>pace</strong> internazionale <strong>la</strong> via più <strong>di</strong>retta sembra essere <strong>la</strong> creazione <strong>di</strong><br />
uno «Stato mon<strong>di</strong>ale» che unifichi i poteri dei singoli componenti.<br />
La <strong>pace</strong> è una situazione caratterizzata dall’assenza del<strong>la</strong> forza. In una società organizzata, comunque,<br />
l’assenza assoluta del<strong>la</strong> forza — l’idea dell’anarchismo — non è possibile. L’utilizzo<br />
del<strong>la</strong> forza nelle re<strong>la</strong>zioni interin<strong>di</strong>viduali è impe<strong>di</strong>to dal fatto <strong>di</strong> essere riservato al<strong>la</strong> comunità.<br />
Per garantire <strong>la</strong> <strong>pace</strong> l’or<strong>di</strong>namento sociale non esclude tutti i tipi <strong>di</strong> atti coercitivi; esso autorizza<br />
certi in<strong>di</strong>vidui a compiere tali atti in talune con<strong>di</strong>zioni. L’utilizzo del<strong>la</strong> forza, in generale<br />
proibito in quanto delitto, è eccezionalmente permesso come reazione contro il delitto, cioè come<br />
sanzione [...]<br />
Quando sorge <strong>la</strong> domanda sul come assicurare <strong>la</strong> <strong>pace</strong> internazionale, sul come eliminare il più<br />
terribile utilizzo del<strong>la</strong> forza - vale a <strong>di</strong>re <strong>la</strong> guerra - dalle re<strong>la</strong>zioni interstatali, nessuna risposta<br />
sembra essere <strong>di</strong> per sé più evidente <strong>di</strong> questa: unire tutti i singoli Stati o, almeno, tanti quanto<br />
sia possibile, in uno Stato mon<strong>di</strong>ale, concentrare tutti i loro strumenti <strong>di</strong> potere, le loro forze armate,<br />
e porli a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un governo mon<strong>di</strong>ale sottoposto a leggi varate da un par<strong>la</strong>mento<br />
mon<strong>di</strong>ale. Se agli Stati si permette <strong>di</strong> continuare ad esistere solo come membri <strong>di</strong> una potente<br />
federazione mon<strong>di</strong>ale, allora <strong>la</strong> <strong>pace</strong> tra loro sarà assicurata.<br />
Di fronte all’impraticabilità, nell’imme<strong>di</strong>ato, <strong>di</strong> creare un unico Stato federale, Kelsen intende<br />
proporre il primo passo me<strong>di</strong>ante cui giungere a quell’obiettivo: «un’unione internazionale <strong>di</strong> Stati»<br />
che si regga sull’esistenza <strong>di</strong> un «<strong>di</strong>ritto internazionale». Rispetto alle esperienze passate <strong>di</strong> costruzione<br />
<strong>di</strong> una «comunità internazionale» secondo il <strong>di</strong>ritto, bisogna prima <strong>di</strong> tutto fare in modo che<br />
gli stati creino «un’autorità» al<strong>la</strong> quale demandare il compito <strong>di</strong> <strong>di</strong>rimere i contenziosi: per questa<br />
189 I brani sono tratti dal volume H. KELSEN, La <strong>pace</strong> attraverso il <strong>di</strong>ritto, trad. it. a c. <strong>di</strong> L. Ciaurro, Torino, Giappichelli,<br />
1990, pp. 41-80 (orig. Peace through Law, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1944).<br />
78
via viene tolta ai singoli stati <strong>la</strong> possibilità <strong>di</strong> decidere sulle vio<strong>la</strong>zioni del <strong>di</strong>ritto e tantomeno <strong>di</strong><br />
giustificare un’iniziativa <strong>di</strong> guerra sul<strong>la</strong> base <strong>di</strong> un (presunto) <strong>di</strong>ritto vio<strong>la</strong>to.<br />
Se si accetta uno Stato mon<strong>di</strong>ale come un obiettivo desiderabile, è più che probabile che esso<br />
possa essere conseguito solo attraverso una serie <strong>di</strong> passaggi. Da un punto <strong>di</strong> vista strategico,<br />
non v’è che una domanda seria: qual è il prossimo passo da compiere su questa strada?<br />
Ovviamente, in un primo tempo potrebbe essere costituita solo un’unione internazionale <strong>di</strong> Stati<br />
190 [...] Questo significa che <strong>la</strong> soluzione del problema <strong>di</strong> una <strong>pace</strong> durevole può essere reperita<br />
solo all’interno del<strong>la</strong> struttura del <strong>di</strong>ritto internazionale [...]<br />
Un attento esame del<strong>la</strong> natura delle re<strong>la</strong>zioni internazionali e del<strong>la</strong> specifica tecnica del <strong>di</strong>ritto<br />
internazionale presenta una <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> fondo per ogni sforzo <strong>di</strong> rendere pacifiche le re<strong>la</strong>zioni<br />
tra Stati. Il fatto è che in caso <strong>di</strong> controversie tra Stati non esiste un’autorità accettata generalmente<br />
e obbligatoriamente come competente a rego<strong>la</strong>re le controversie internazionali, cioè a rispondere<br />
imparzialmente al<strong>la</strong> domanda su quale delle parti in conflitto abbia ragione e quale abbia<br />
torto. Se gli Stati non raggiungono un accordo o non sottopongono volontariamente le loro<br />
controversie ad un arbitrato, ciascuno Stato è autorizzato a decidere da sé <strong>la</strong> questione se l’altro<br />
Stato abbia vio<strong>la</strong>to o stia per vio<strong>la</strong>re i suoi <strong>di</strong>ritti; e lo Stato che si considera danneggiato è autorizzato<br />
a far rispettare il <strong>di</strong>ritto — cioè quello che esso ritiene il <strong>di</strong>ritto — facendo ricorso al<strong>la</strong><br />
guerra o al<strong>la</strong> rappresaglia contro i presunti vio<strong>la</strong>tori. Poiché l’altro Stato ha <strong>la</strong> stessa competenza<br />
a decidere da sé <strong>la</strong> questione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, il problema giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> fondo rimane senza una soluzione<br />
decisiva. [...] Finché non è possibile togliere agli Stati interessati <strong>la</strong> prerogativa <strong>di</strong> risolvere <strong>la</strong><br />
questione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e trasferir<strong>la</strong> una volta per tutte ad una autorità imparziale, cioè ad una corte<br />
internazionale, ogni ulteriore progresso sul<strong>la</strong> strada del<strong>la</strong> pacificazione del mondo è del tutto escluso.<br />
Conseguentemente, il passo successivo su cui i nostri sforzi debbono essere concentrati è quello<br />
<strong>di</strong> pervenire ad un trattato internazionale concluso dal maggior numero possibile <strong>di</strong> Stati, vincitori<br />
o vinti, che istituisca una Corte internazionale tito<strong>la</strong>re <strong>di</strong> una giuris<strong>di</strong>zione obbligatoria.<br />
Questo significa che tutti gli Stati del<strong>la</strong> Lega costituita in questo trattato dovrebbero essere obbligati<br />
a rinunciare al<strong>la</strong> guerra e alle rappresaglie come strumenti <strong>di</strong> rego<strong>la</strong>zione dei conflitti, a<br />
sottoporre tutte le loro controversie senza eccezione al<strong>la</strong> decisione del<strong>la</strong> Corte e ad applicare fedelmente<br />
le sue decisioni.<br />
Per instaurare una «giuris<strong>di</strong>zione obbligatoria» il passo successivo è quello <strong>di</strong> creare un’autorità<br />
internazionale in grado <strong>di</strong> far eseguire le decisione prese dal tribunale internazionale. La creazione<br />
190 Nell’imme<strong>di</strong>ata impraticabilità <strong>di</strong> costruire un «World Federal State », Kelsen in<strong>di</strong>ca un momento <strong>di</strong> passaggio in un<br />
«International Union of States». Attraverso il <strong>di</strong>ritto, essa si caratterizzerebbe come una «Permanent League for the<br />
Maintenance of Peace», ovvero in cui il patto <strong>di</strong> associazione tra gli Stati non sia revocabile, al fine <strong>di</strong> tenere in <strong>pace</strong> i<br />
loro rapporti. Evidenti sono il richiamo e il superamento del progetto kantiano.<br />
79
<strong>di</strong> un esecutivo «centralizzato» che possa utilizzare una forza <strong>di</strong> polizia sovrastatuale è possibile solo<br />
con <strong>la</strong> creazione politica <strong>di</strong> una federazione mon<strong>di</strong>ale. Con il patto istitutivo le forze saranno ancora<br />
quelle dei singoli stati ma <strong>di</strong>rette da un organo che rappresenta tutta <strong>la</strong> comunità.<br />
La prima obiezione al<strong>la</strong> proposta <strong>di</strong> creare una Corte con giuris<strong>di</strong>zione obbligatoria riguarda<br />
l’esecuzione delle decisioni del<strong>la</strong> Corte nel caso in cui uno Stato non adempia all’obbligo <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>re<br />
al<strong>la</strong> Corte o faccia ricorso al<strong>la</strong> guerra o al<strong>la</strong> rappresaglia in <strong>di</strong>spregio dei patti. E’ evidente<br />
che il metodo più efficace per far rispettare gli or<strong>di</strong>ni e i giu<strong>di</strong>cati del<strong>la</strong> Corte è<br />
l’organizzazione <strong>di</strong> un potere esecutivo centralizzato, cioè una Forza <strong>di</strong> polizia internazionale<br />
<strong>di</strong>versa e in<strong>di</strong>pendente dalle forze armate degli Stati membri, ponendo questa forza armata a <strong>di</strong>sposizione<br />
<strong>di</strong> una unità amministrativa centrale, <strong>la</strong> cui funzione sia quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> eseguire le decisioni<br />
del<strong>la</strong> Corte. [...] una Lega con un potere esecutivo centralizzato non è più una Confederazione<br />
internazionale <strong>di</strong> Stati, ma è uno Stato essa stessa.<br />
Non vi può essere dubbio che lo sforzo <strong>di</strong> organizzare una tale forza <strong>di</strong> polizia deve fare i conti<br />
con una tenace resistenza dei governi; e il trattato internazionale che istituisca <strong>la</strong> Forza <strong>di</strong> polizia<br />
internazionale deve ottenere <strong>la</strong> ratifica <strong>di</strong> tutti i governi interessati. Una pubblica opinione più o<br />
meno favorevole all’organizzazione <strong>di</strong> una polizia mon<strong>di</strong>ale non è sufficiente. Una forza <strong>di</strong> polizia<br />
chiamata internazionale” rappresenta una restrizione ra<strong>di</strong>cale, se non <strong>la</strong> totale <strong>di</strong>struzione,<br />
del<strong>la</strong> sovranità dello Stato. [...]<br />
L’organizzazione <strong>di</strong> un potere esecutivo centralizzato, il più <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong> tutti i problemi<br />
dell’organizzazione mon<strong>di</strong>ale, non può essere il primo passo: può solo essere uno degli ultimi<br />
passi, un passo che in ogni caso non può essere intrapreso con successo prima che <strong>la</strong> Corte internazionale<br />
sia stata istituita e abbia, con <strong>la</strong> propria attività imparziale, ottenuto <strong>la</strong> fiducia dei<br />
governi. Poiché allora, e solo allora, vi saranno sufficienti garanzie che le Forze armate del<strong>la</strong><br />
Lega saranno usate esclusivamente per preservare il <strong>di</strong>ritto, sul<strong>la</strong> base <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong><br />
un’autorità imparziale.<br />
Senza arrivare all’estremo del<strong>la</strong> sua eliminazione, con <strong>la</strong> creazione quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> un super-stato<br />
mon<strong>di</strong>ale, Kelsen crede che bisogna comunque limitare <strong>la</strong> sovranità statuale. Il <strong>di</strong>ritto internazionale<br />
si può ben conciliare con <strong>la</strong> sovranità dei singoli componenti, i quali rimangono tra <strong>di</strong> loro autonomi<br />
e egualmente e so<strong>la</strong>mente obbligati verso regole comuni. Questa eguaglianza giuri<strong>di</strong>ca non deve poi<br />
essere inficiata da una <strong>di</strong>seguaglianza <strong>di</strong> «potere», dal<strong>la</strong> maggiore influenza reale che, nelle re<strong>la</strong>zioni<br />
internazionali, alcuni stati possono far valere.<br />
Se sovranità significa “suprema” autorità, <strong>la</strong> sovranità degli Stati come soggetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale<br />
non può significare una autorità assoluta, ma solo una autorità re<strong>la</strong>tivamente suprema;<br />
<strong>la</strong> potestà <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto degli Stati è “suprema” in quanto non assoggettata al<strong>la</strong> potestà giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong><br />
80
alcun altro Stato. Lo Stato è “sovrano” poiché è assoggettato solo al <strong>di</strong>ritto internazionale, non<br />
al <strong>di</strong>ritto interno <strong>di</strong> qualsiasi altro Stato. La sovranità dello Stato nei confronti del <strong>di</strong>ritto inter<br />
nazionale è l’in<strong>di</strong>pendenza giuri<strong>di</strong>ca dello Stato rispetto agli altri Stati. Questo è il normale si<br />
gnificato attribuito al termine “sovranità” dagli stu<strong>di</strong>osi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale. La sovranità è<br />
qualche volta definita come “potere” supremo. In questo senso, potere significa autorità, cioè<br />
potere giuri<strong>di</strong>co, capacità <strong>di</strong> imporre e conferire <strong>di</strong>ritti. Se “potere” non ha questo significato in<br />
re<strong>la</strong>zione all’ambito delle norme e dei valori, quanto piuttosto il significato <strong>di</strong> ‘capacità <strong>di</strong> produrre<br />
un effetto” — un significato re<strong>la</strong>tivo all’ambito del<strong>la</strong> realtà determinato dalle leggi del<strong>la</strong><br />
causalità — allora è facile <strong>di</strong>mostrare che <strong>la</strong> sovranità come potere supremo in quest’ultimo senso<br />
non può essere caratteristica degli Stati come entità giuri<strong>di</strong>che. Con riguardo al loro potere<br />
effettivo i vari Stati <strong>di</strong>fferiscono moltissimo l’uno dall’altro. Comparato con una cosiddetta<br />
Grande Potenza, uno Stato come il Liechtenstein non ha alcun potere, anche se è denominato<br />
“potere” nel<strong>la</strong> fraseologia <strong>di</strong>plomatica. Se “potere” significa potere effettivo, ossia <strong>la</strong> capacità <strong>di</strong><br />
realizzare un effetto, “potere supremo” significherebbe essere <strong>la</strong> causa prima, una prima causa.<br />
In questo senso, solo Dio come creatore del mondo è sovrano; un tale concetto <strong>di</strong> sovranità è<br />
metafisico, non scientifico.<br />
ARON<br />
La <strong>pace</strong> è il fine al quale tendono le società<br />
Aron c<strong>la</strong>ssifica nel suo Pace e guerra tra le nazioni 191 (1962) gli esempi storico-politici del<strong>la</strong><br />
<strong>pace</strong> come del<strong>la</strong> guerra secondo un criterio che parta dal<strong>la</strong> centralità dello Stato-potenza: è il modo<br />
in cui sono organizzati i «rapporti <strong>di</strong> forza» tra gli stati a determinare lo schema politico internazionale.<br />
La <strong>pace</strong> si è presentata a noi finora come <strong>la</strong> sospensione più o meno duratura delle modalità violente<br />
del<strong>la</strong> rivalità tra unità politiche. Si <strong>di</strong>ce che regna <strong>la</strong> <strong>pace</strong> quando i rapporti tra le nazioni<br />
non comportano le forme militari del<strong>la</strong> lotta. Ma siccome questi rapporti pacifici si svolgono<br />
all’ombra delle battaglie del passato e nel timore, o nell’attesa, delle battaglie future, il principio<br />
del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, nel senso in cui Montesquieu si serve <strong>di</strong> questo termine nel<strong>la</strong> sua teoria dei governi 2 ,<br />
non è per sua natura <strong>di</strong>fferente dal principio del<strong>la</strong> guerra: le paci sono fondate sul<strong>la</strong> potenza, va<br />
191 R. ARON, Pace e guerra tra le nazioni, tr. it. Fulvia Airol<strong>di</strong> Namer, Mi<strong>la</strong>no, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità, 1970, pp. 187<br />
193 (orig. Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann Lévy, 1962).<br />
2 «Vale a <strong>di</strong>re il sentimento o, come <strong>di</strong>remmo oggi, <strong>la</strong> pulsione o l’emozione necessaria al mantenimento <strong>di</strong> un certo tipo<br />
<strong>di</strong> governo: virtù, onore, timore». Il riferimento montesquieiano riconduce ai libri II-VIII dell’Esprit des lois (1748).<br />
81
le a <strong>di</strong>re sul rapporto tra le capacità <strong>di</strong> agire le une sulle altre delle unità politiche. Poiché i rap<br />
porti <strong>di</strong> potenza in un tempo <strong>di</strong> <strong>pace</strong>, pur senza essere il riflesso esatto del rapporto delle forze<br />
attuali o potenziali, sono un’espressione più o meno deformata <strong>di</strong> esso, i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> <strong>pace</strong> possono<br />
essere riferiti ai tipi <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> forze. Distinguo tre tipi <strong>di</strong> <strong>pace</strong>, equilibrio, egemonia,<br />
impero: in un dato spazio storico, le forze delle unità politiche o si controbi<strong>la</strong>nciano o sono denominate<br />
da quelle <strong>di</strong> una <strong>di</strong> essi, oppure infine sono superate da quelle <strong>di</strong> una <strong>di</strong> esse in modo<br />
che tutte le unità, salvo una, perdono <strong>la</strong> loro autonomia e tendono a sparire in quanto centri <strong>di</strong><br />
decisioni politiche. Lo stato imperiale, in definitiva, si riserva il monopolio del<strong>la</strong> violenza legittima.<br />
Si potrebbe obiettare che proprio per questo <strong>la</strong> <strong>pace</strong> imperiale cessa <strong>di</strong> essere, per definizione,<br />
una “congiuntura <strong>di</strong> politica estera”. La <strong>pace</strong> imperiale non si <strong>di</strong>stinguerebbe dal<strong>la</strong> <strong>pace</strong> civile,<br />
sarebbe l’or<strong>di</strong>ne interno <strong>di</strong> un impero. Potremmo tener conto <strong>di</strong> questa obiezione soltanto se <strong>la</strong><br />
tipologia fosse puramente astratta, priva <strong>di</strong> re<strong>la</strong>zioni con i dati del<strong>la</strong> storia. Anche se ci sono casi<br />
in cui <strong>la</strong> <strong>pace</strong> imperiale, una volta stabilitasi, non si <strong>di</strong>stingue più dal<strong>la</strong> <strong>pace</strong> nazionale,<br />
l’assimi<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> imperiale in quanto tale al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> civile si indurrebbe a <strong>di</strong>sconoscere<br />
<strong>la</strong> <strong>di</strong>versità delle situazioni 192 . […]<br />
Tra <strong>la</strong> <strong>pace</strong> dell’equilibrio e <strong>la</strong> <strong>pace</strong> dell’impero si interca<strong>la</strong> <strong>la</strong> <strong>pace</strong> dell’egemonia. L’assenza<br />
<strong>di</strong> guerre non <strong>di</strong>pende dall’approssimativa parità <strong>di</strong> forze che regna tra le unità politiche e impe<strong>di</strong>sce<br />
che una <strong>di</strong> esse o una co<strong>la</strong>zione impongano <strong>la</strong> propria volontà, ma <strong>di</strong>pende al contrario<br />
dal<strong>la</strong> superiorità incontestabile <strong>di</strong> una delle unità. Questa superiorità è tale che gli stati insod<strong>di</strong>sfatti<br />
<strong>di</strong>sperano <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare lo status quo, e tuttavia lo stato egemonico non cerca <strong>di</strong> assorbire<br />
le unità ridotte all’impotenza. Esso non abusa dell’egemonia, rispetta le forme esteriori<br />
dell’in<strong>di</strong>pendenza degli stati e non aspira all’impero.<br />
Passando a esempi concreti, Aron in<strong>di</strong>vidua solo in America settentrionale l’esistenza <strong>di</strong> una<br />
<strong>pace</strong> egemonica, mentre nel resto del mondo non c’è mai stato storicamente un termine me<strong>di</strong>o tra<br />
<strong>pace</strong> d’equilibrio e <strong>pace</strong> dettata dal<strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione imperiale.<br />
192 L’A. al riguardo evidenzia alcuni esempi. La «<strong>pace</strong> dell’impero tedesco dopo il 1871, a parte i resti <strong>di</strong> sovranità conservati<br />
dal<strong>la</strong> Baviera, col passare degli anni <strong>di</strong>fferiva sempre meno dal<strong>la</strong> <strong>pace</strong> interna del<strong>la</strong> repubblica francese. Invece<br />
le polis greche sottomesse da Filippo e trascinate da Alessandro al<strong>la</strong> conquista dell’Asia non avevano perduto completamente<br />
<strong>la</strong> loro autonomia politico-amministrativa, non erano state private <strong>di</strong> tutti gli attributi che per noi sono costitutivi<br />
del<strong>la</strong> sovranità, <strong>di</strong>sponevano imme<strong>di</strong>atamente in caso <strong>di</strong> rivolta, <strong>di</strong> un embrione <strong>di</strong> forza armata. La guerra degli ebrei<br />
- sempre secondo Aron - ci ricorderebbe, se fosse necessario, <strong>la</strong> precarietà del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> romana; i popoli conquistati non<br />
venivano <strong>di</strong>sarmati completamente. Alle antiche istituzioni ed ai sovrani, ormai protetti da Roma, si sovrapponeva, senza<br />
eliminarli, l’or<strong>di</strong>ne imperiale. In altri termini, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> imperiale fa capo al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> civile a mano a mano che scompaiono<br />
i ricor<strong>di</strong> delle unità politiche un tempo in<strong>di</strong>pendenti e che gli in<strong>di</strong>vidui che popo<strong>la</strong>no <strong>la</strong> zona pacificata si sentono<br />
meno uniti al<strong>la</strong> comunità, tra<strong>di</strong>zionale o locale, e più uniti allo stato conquistatore». Ancora, secondo Aron,<br />
l’«impero che Bismarck forgiò con il ferro e con il fuoco <strong>di</strong>ventò uno stato nazionale: l’impero romano restò fino al<strong>la</strong><br />
fine una zona pacificata. I re <strong>di</strong> Francia forgiarono <strong>la</strong> nazione francese: <strong>la</strong> Francia fece regnare per un certo tempo <strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
imperiale nell’Africa settentrionale».<br />
82
Nell’America settentrionale, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> egemonica che fanno regnare gli Stati Uniti non è un aspetto,<br />
parziale e fuggitivo, <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> equilibrio, ma è il risultato duraturo del<strong>la</strong> sproporzione,<br />
dovuta al<strong>la</strong> situazione geografica e accentuata dal<strong>la</strong> storia, tra le forze del<strong>la</strong> repubblica degli Stati<br />
Uniti e quelle del Messico o del Canada. […]<br />
Una volta consolidata <strong>la</strong> federazione e conquistate o occupate le terre dell’ovest e del sud, domati<br />
o espulsi gli in<strong>di</strong>ani o gli altri europei, gli Stati Uniti erano troppo forti perché sul continente<br />
americano potesse costituirsi un sistema <strong>di</strong> equilibrio, erano troppo in<strong>di</strong>fferenti al<strong>la</strong> gloria<br />
<strong>di</strong> regnare e non avevano abbastanza bisogno <strong>di</strong> terra per minacciare l’in<strong>di</strong>pendenza degli stati<br />
vicini, a nord ed a sud. La combinazione dell’egemonia e del<strong>la</strong> politica <strong>di</strong> buon vicinato si<br />
chiama <strong>la</strong> <strong>pace</strong> americana.<br />
C<strong>la</strong>ssificare le paci secondo i rapporti tra le potenze che le reggono consente <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care una via<br />
anche per leggere le guerre.<br />
La c<strong>la</strong>ssificazione ternaria delle paci ci fornisce nello stesso tempo una c<strong>la</strong>ssificazione, <strong>la</strong> più<br />
formale e <strong>la</strong> più generica, delle guerre: le guerre “perfette”, conformi al<strong>la</strong> nozione politica del<strong>la</strong><br />
guerra, sono interstatali: in esse si affrontano unità politiche che si riconoscono reciprocamente<br />
esistenza e legittimità. Chiameremo soprastatali o imperiali le guerre il cui oggetto, origine o<br />
conseguenza, sia l’eliminazione <strong>di</strong> certi belligeranti e <strong>la</strong> formazione <strong>di</strong> un’unità al livello superiore.<br />
Chiameremo infrastatali o infraimperiali le guerre <strong>la</strong> cui posta è il mantenimento o <strong>la</strong> decomposizione<br />
<strong>di</strong> un’unità politica, nazionale o imperiale.<br />
Le guerre interstatali <strong>di</strong>ventano imperiali quando uno degli attori <strong>di</strong> un sistema internazionale<br />
in caso <strong>di</strong> vittoria sarebbe portato ad estendere, volontariamente o no, <strong>la</strong> propria egemonia o il<br />
proprio impero sui rivali. Le guerre interstatali tendono ad ampliarsi in guerre iperboliche quando<br />
uno degli attori rischia <strong>di</strong> acquistare una schiacciante superiorità <strong>di</strong> forze 193 […]. La violenza<br />
<strong>di</strong> un conflitto può non essere imputabile né al<strong>la</strong> tecnica <strong>di</strong> combattimento né alle passioni dei<br />
belligeranti, bensì al<strong>la</strong> geometria dei rapporti delle forze. L’importanza del<strong>la</strong> posta in gioco – libertà<br />
delle polis greche o degli stati europei – è ciò che rinfoco<strong>la</strong> l’ardore guerriero. Le gran<strong>di</strong><br />
guerre segnano spesso il passaggio da una configurazione all’altra, da un sistema all’altro – e<br />
questo passaggio ha, a sua volta, molte cause.<br />
193 Come esempi storici Aron adduce <strong>la</strong> prima guerra mon<strong>di</strong>ale e <strong>la</strong> guerra del Peloponneso. Quest’ultimo, ricostruito<br />
mirabilmente nelle pagine <strong>di</strong> Tuci<strong>di</strong>de, vide Atene e Sparta, a capo <strong>di</strong> due opposte coalizioni <strong>di</strong> città greche, contendersi<br />
il predominio sul<strong>la</strong> Grecia. Iniziata nel 431 e a. C., <strong>la</strong> guerra si concluse solo nel 404, con l’occupazione <strong>di</strong> Atene da<br />
parte del generale spartano Lisandro, e con il definitivo tramonto <strong>di</strong> qualsiasi pretesa imperiale da parte del<strong>la</strong> pòlis attica.<br />
83
BOBBIO<br />
La <strong>pace</strong> è uno stato giuri<strong>di</strong>co<br />
Ne Il terzo assente 194 Bobbio afferma che, per arrivare al<strong>la</strong> vera <strong>pace</strong>, non è sufficiente stabilire<br />
le regole <strong>di</strong> un accordo tra gli stati, quanto in<strong>di</strong>care le conseguenze per chi intende contravvenirle. Il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>pace</strong> deve essere sia «valido» che «efficace».<br />
Si può par<strong>la</strong>re correttamente <strong>di</strong> <strong>pace</strong> attraverso il <strong>di</strong>ritto o <strong>di</strong> stato giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> <strong>pace</strong> (e non <strong>di</strong> stato<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong> in generale) solo quando l’accordo avviene in un contesto normativo in cui vi sono<br />
non soltanto regole che stabiliscono le modalità per <strong>la</strong> istituzione <strong>di</strong> un accordo ma anche regole<br />
che stabiliscono quali sono le modalità che debbono essere osservate nel caso in cui l’accordo<br />
non venga osservato dall’uno o dall’altro dei due contraenti. Per usare espressioni tecniche del<br />
linguaggio giuri<strong>di</strong>co, il contesto normativo in cui si può par<strong>la</strong>re correttamente <strong>di</strong> <strong>pace</strong> attraverso<br />
il <strong>di</strong>ritto è quello in cui sono previste regole non soltanto per <strong>la</strong> vali<strong>di</strong>tà ma anche per l’efficacia<br />
dell’accordo. Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui non è garantita l’efficacia, ovvero l’osservanza, non sono strumenti<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong>, ma sono spesso nuove occasioni <strong>di</strong> conflitto o <strong>di</strong> guerra.<br />
Prova ne sia che ogni sistema <strong>di</strong> regole sulle modalità degli accor<strong>di</strong> si presuppone si fon<strong>di</strong>, anche<br />
solo tacitamente, sul<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> generale che i patti debbono essere osservati (pacta sunt servanda).<br />
Ma questa rego<strong>la</strong>, <strong>di</strong> per se stessa considerata, è una rego<strong>la</strong> morale, una rego<strong>la</strong> cioè <strong>la</strong><br />
cui osservanza <strong>di</strong>pende unicamente dalle buone ragioni che possono essere addotte dai due contendenti<br />
per preferirne l’osservanza piuttosto che l’inosservanza. […] Che senso ha stipu<strong>la</strong>re dei<br />
patti se non si accetta preliminarmente il principio che i patti debbono essere osservati? Del resto,<br />
anche <strong>la</strong> morale utilitaristica è in grado <strong>di</strong> addurre i suoi buoni argomenti in favore dello<br />
stesso principio: quale utilità posso trarre dal non mantenere le promesse quando ammetto, e<br />
non posso non ammettere, che gli altri possano fare altrettanto? Ma se ammetto che gli altri possano<br />
fare altrettanto che vantaggio posso trarre dal non mantenere <strong>la</strong> mia promessa? Non ne dovremo<br />
trarre <strong>la</strong> conseguenza che il mantenere le promesse ha senso soltanto in una società in cui<br />
il principio che le promesse debbano essere mantenute venga rispettato?<br />
194<br />
N. BOBBIO, Il terzo assente. Saggi e <strong>di</strong>scorsi sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e <strong>la</strong> guerra, a c. <strong>di</strong> P. Polito, Torino-Mi<strong>la</strong>no, Sonda, 1989,<br />
pp. 126-35.<br />
84
La <strong>pace</strong> internazionale deve prevedere l’uso del<strong>la</strong> «forza coattiva» garantito dal <strong>di</strong>ritto: dal pat-<br />
to <strong>di</strong> associazione si deve giungere a un patto <strong>di</strong> soggezione. Se nel primo caso l’esistenza del<strong>la</strong> pa<br />
ce <strong>di</strong>pende dal<strong>la</strong> volontà dei singoli componenti <strong>di</strong> rispettare il patto sottoscritto, nel secondo caso<br />
sarà <strong>la</strong> «forza» del nuovo «stato federale» a imporre il rispetto del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>pace</strong>.<br />
L’esperienza storica <strong>di</strong>mostra che occorre minacciare pene tali o terrene o ultraterrene (ove<br />
quest’ultime siano cre<strong>di</strong>bili, ma l’universo in cui le pene ultraterrene sono ancora cre<strong>di</strong>bili si va<br />
restringendo sempre più) tali da costituire una remora per ogni potenziale deviante. A questo<br />
punto entra in scena il <strong>di</strong>ritto. Ma è chiaro che al punto in cui entra in scena il <strong>di</strong>ritto, il proble<br />
ma non è più quello del<strong>la</strong> vali<strong>di</strong>tà del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>, qualunque essa sia, ma quello del<strong>la</strong> sua efficacia,<br />
nel nostro caso specifico, non più quello del fondamento razionale del principio pacta sunt ser<br />
vanda ma del<strong>la</strong> sua effettiva (quanto è più possibile) applicazione. […]<br />
La maggiore o minore stabilità del<strong>la</strong> società civile che nasce dal<strong>la</strong> eliminazione dello stato <strong>di</strong><br />
natura <strong>di</strong>pende dal<strong>la</strong> natura del patto <strong>di</strong> unione, se questo sia soltanto un patto <strong>di</strong> associazione<br />
(pactum societatis) o anche un patto <strong>di</strong> sottomissione (pactum subiectionis).<br />
Secondo l’idea del <strong>di</strong>ritto che qui ho sostenuto, per giungere a uno stato <strong>di</strong> <strong>pace</strong> permanente<br />
non basta il primo genere <strong>di</strong> patto, occorre anche il secondo. Un’unione fondata esclusivamente<br />
su un patto <strong>di</strong> associazione è al<strong>la</strong> mercè del<strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> appartenervi dei singoli membri: in essa<br />
<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> pacta sunt servanda ha lo status <strong>di</strong> principio unicamente morale, e pertanto può aver<br />
efficacia soltanto in una società <strong>di</strong> esseri pienamente morali, <strong>di</strong> esseri cioè <strong>la</strong> cui condotta non<br />
s’ispiri al<strong>la</strong> massima del<strong>la</strong> morale politica: “Il fine giustifica i mezzi”.<br />
Riprendendo una nota <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> Kant, si può affermare che, volendo chiamare stato giuri<strong>di</strong>co<br />
anche lo stato nascente da un patto <strong>di</strong> associazione per <strong>di</strong>stinguerlo dallo stato <strong>di</strong> natura in<br />
cui l’in<strong>di</strong>viduo agisce per conto suo, bisognerebbe avere l’avvertenza <strong>di</strong> definirlo stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
provvisorio per <strong>di</strong>stinguerlo dallo stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto perentorio che nasce soltanto quando i membri<br />
del gruppo mettono in comune oltre l’uso <strong>di</strong> parte dei loro beni anche l’uso del<strong>la</strong> forza. Nel linguaggio<br />
tecnico dei giuristi il passaggio dallo stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto provvisorio a quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto perentorio<br />
corrisponde al passaggio da una confederazione <strong>di</strong> stati a uno stato federale. Sia però<br />
ben chiaro che uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto provvisorio, o comunque lo si voglia chiamare, non rappresenta<br />
che una prima fase, ancora imperfettissima, nel percorso del processo del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> attraverso<br />
il <strong>di</strong>ritto. Le gran<strong>di</strong> unioni internazionali, come <strong>la</strong> Società delle Nazioni dopo <strong>la</strong> prima guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite dopo <strong>la</strong> seconda, stanno a <strong>di</strong>mostrare quanto<br />
poco un semplice patto <strong>di</strong> associazione sia in grado <strong>di</strong> garantire <strong>la</strong> “<strong>pace</strong> perpetua”. Se a circa<br />
quarant’anni dal<strong>la</strong> fondazione dell’ONU non è scoppiata una terza guerra mon<strong>di</strong>ale (ne erano<br />
bastati venti per <strong>la</strong> seconda, nonostante <strong>la</strong> Società delle Nazioni), non <strong>di</strong>pende certo<br />
dall’esistenza delle Nazioni Unite ma da un tacito accordo fra le due superpotenze a non usare<br />
l’una contro l’altra le armi nucleari che non potrebbero non essere impiegate in una guerra<br />
85
mon<strong>di</strong>ale. La fase finale del cammino del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> attraverso il <strong>di</strong>ritto è lo stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto perentorio,<br />
ovvero quello stato in cui si è venuto costituendo un or<strong>di</strong>namento normativo in cui esiste un<br />
potere coattivo ca<strong>pace</strong> <strong>di</strong> rendere efficaci le norme dell’or<strong>di</strong>namento».<br />
COTTA<br />
La re<strong>la</strong>zionalità è «<strong>la</strong> <strong>pace</strong> <strong>di</strong> tutte le paci»<br />
L’indagine su «cos’è l’uomo», contenuta nell’opera Dal<strong>la</strong> guerra al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Un itinerario filosofico<br />
195 , porta Cotta a invalidare sia le precedenti «filosofie del<strong>la</strong> guerra» che le teorie <strong>di</strong> molti<br />
pensatori del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. La soluzione consiste nel prospettare in termini nuovi <strong>la</strong> centralità del<strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
nell’esistenza umana.<br />
Cotta analizza i due principali orientamenti del pensiero moderno che «si pronunciano in favore<br />
del valore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> e in<strong>di</strong>cano <strong>la</strong> via o il mezzo per raggiunger<strong>la</strong>»:<br />
Il primo fonda il valore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> sul (superamento del) terrore e ne determina il mezzo nel <strong>di</strong>sarmo;<br />
viene dunque argomentato me<strong>di</strong>ante una doppia negazione: togliere il terrore e (perciò)<br />
togliere le armi. Il secondo segue invece una via doppiamente positiva: fonda il valore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
sul (raggiungimento del) benessere e ne determina il mezzo nello sviluppo tecnologico.<br />
Sebbene, per <strong>di</strong>verse vie, questi approcci al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> ne segnalino il valore, non eliminano problemi<br />
<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sia teorico che pratico per stabilire un fondamento durevole del<strong>la</strong> concor<strong>di</strong>a.<br />
Sul piano delle teorie e anche delle ideologie, <strong>la</strong> <strong>di</strong>mostrazione del valore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, tanto per <strong>la</strong><br />
via negativa — assenza del<strong>la</strong> guerra e conseguente rimozione del<strong>la</strong> paura (o terrore) da essa<br />
provocata — quanto per <strong>la</strong> via positiva — utilità e benessere — si è rive<strong>la</strong>ta insufficiente. Entrambe<br />
le vie portano, infatti, a risultati parziali e talora, per giunta, implicanti contrad<strong>di</strong>zioni al<br />
proprio interno; perciò risultano in definitiva inconcludenti. La ragione <strong>di</strong> tale inconcludenza va<br />
ravvisata nell’incapacità <strong>di</strong> eliminare per quelle vie <strong>la</strong> causa profonda del<strong>la</strong> guerra e del<strong>la</strong> conseguente<br />
paura reciproca: <strong>la</strong> <strong>di</strong>fferenza, e quin<strong>di</strong> <strong>la</strong> possibile inimicizia-ostilità, tra gli in<strong>di</strong>vidui<br />
e tra gli aggregati sociali. La paura del<strong>la</strong> guerra non toglie l’inimicizia per quel potenziale antagonista<br />
che è l’estraneo; così pure non <strong>la</strong> tolgono utilità e benessere nei confronti del concorrente<br />
o rivale.<br />
195 S. COTTA, Dal<strong>la</strong> guerra al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Un itinerario filosofico, Mi<strong>la</strong>no, Rusconi, 1989, pp. 117-84.<br />
86
Sul piano pratico-operativo, i mezzi ritenuti adeguati per <strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> in confor<br />
mità alle varie teorie — monopolio statale del<strong>la</strong> forza, <strong>di</strong>sarmo, sviluppo — si sono rive<strong>la</strong>ti ben<br />
sì utili e forse anche necessari in parte, ma non sufficienti.<br />
L’Autore si sofferma sul<strong>la</strong> «reciproca connessione tra <strong>di</strong>ritto e <strong>pace</strong>». Se il punto <strong>di</strong> partenza è il<br />
modo in cui il <strong>di</strong>ritto palesa «il senso <strong>di</strong> coesistenzialità pacifica tra le persone», Cotta giunge al<strong>la</strong><br />
«premessa antropologica» che può veramente fondare l’«essere» e il «valore» del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> tra gli uo<br />
mini.<br />
La coscienza che possiede il senso del <strong>di</strong>ritto, raggiunto me<strong>di</strong>ante <strong>la</strong> riflessione sull’esperienza<br />
vissuta, è consapevole, e rende testimonianza, del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> aurea del<strong>la</strong> convivenza umana: il<br />
comune e reciproco rispetto del<strong>la</strong> persona, da cui scaturisce <strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Ma questa è un valore e un<br />
dovere da assumere e seguire perché quel<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> li prescrive affinché <strong>la</strong> vita sia migliore: <strong>la</strong><br />
«vita buona»; oppure <strong>la</strong> <strong>pace</strong> ha <strong>la</strong> propria ragion d’essere, il proprio fondamento, in qualche<br />
cosa che, appartenendo in proprio e in modo essenziale all’esser-uomo, <strong>la</strong> costituisce in valore?<br />
in altri termini: <strong>la</strong> coscienza giuri<strong>di</strong>ca produce, me<strong>di</strong>ante lo strumento normativo. una con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong> <strong>pace</strong>, oppure <strong>la</strong> ri-produce, al proprio livello, informandosi a una sottostante antropologia?<br />
E <strong>la</strong> questione accennata poc’anzi è ora da affrontare in modo esplicito. [...]<br />
Nel corso del<strong>la</strong> presente esposizione, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> è stata posta ripetutamente sotto il segno del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionalità<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo umano, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione interpersonale e, per converso, <strong>la</strong> guerra sotto il<br />
segno del<strong>la</strong> trasgressione <strong>di</strong> codesta re<strong>la</strong>zione. Sono giunto perciò, grazie soprattutto ad Agostino,<br />
a enunciare <strong>la</strong> formu<strong>la</strong> sintetica «in quanto è re<strong>la</strong>zionale, l’essere è <strong>pace</strong>». Del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionalità<br />
interpersonale del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, non mi sembra che si possa dubitare, quand’anche <strong>la</strong> si svilisca a inerzia<br />
nel<strong>la</strong> quoti<strong>di</strong>anità meramente ripetitiva, secondo <strong>la</strong> <strong>di</strong>scutibilissima, anzi infondata, tesi dei<br />
pensatori <strong>di</strong>alettici. Meno indubitabile, invece, può apparire l’attribuzione del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionalità<br />
all’essere dell’uomo.<br />
Non si possono ritenere «veritiere» tutte quelle teorie che si fondano sul<strong>la</strong> natura guerresca<br />
dell’uomo; al contrario <strong>la</strong> vera con<strong>di</strong>zione dell’uomo è nel<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, che verifica nell’esistenza <strong>la</strong> «re<strong>la</strong>zionalità<br />
ontologica» degli esseri umani.<br />
Sul piano conoscitivo non v’è dunque antitesi tra l’io e l’altro io, nel senso che solo o quello o<br />
questo sia conoscibile quale uomo. Ma allora, l’assenza dell’antitesi teoretica rende priva <strong>di</strong> un<br />
fondamento <strong>di</strong> verità, quanto all’agire pratico, l’antinomia tra l’io e l’altro io, nel senso d’una<br />
opposizione ra<strong>di</strong>cale del loro nomos, o principio <strong>di</strong>rettivo dell’azione. Questa antinomia contrad<strong>di</strong>rebbe,<br />
infatti, <strong>la</strong> verità dell’uomo.<br />
87
Pertanto l’assunzione, tipica dei pensatori <strong>di</strong>alettici esaminati, del<strong>la</strong> guerra a principio del<strong>la</strong> vita,<br />
quasi a con<strong>di</strong>zione trascendentale del<strong>la</strong> pensabilità <strong>di</strong> questa, si rive<strong>la</strong> un assurdo, poiché nega <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>zionalità ontologica dell’uomo. Di questa, invece, è espressione <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, <strong>la</strong> quale è dunque in<br />
ra<strong>di</strong>ce, come aveva lucidamente compreso Agostino, <strong>la</strong> veritiera con<strong>di</strong>zione dell’esistenza umana<br />
(e forse dell’esserci del cosmo), che essa configura quale coesistenza.<br />
Questo ragionamento non sembra però esten<strong>di</strong>bile al<strong>la</strong> guerra empirica e contingente, che non<br />
nega <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionalità ontologica, ma <strong>la</strong> interrompe <strong>di</strong> fatto (e non <strong>di</strong> principio) soltanto sul piano<br />
dell’esistenza. La guerra empirica si configura quale possibilità reale dovuta al<strong>la</strong> contingente<br />
accentuazione soggettivistica delle <strong>di</strong>versità, che altera bensì <strong>la</strong> parità umana — l’estraneo è il<br />
nemico — ma non cancel<strong>la</strong> l’uguaglianza: il nemico è uomo. Ma codesta possibilità ha per con<strong>di</strong>zione<br />
intrascen<strong>di</strong>bile che l’essere sussista, altrimenti <strong>la</strong> possibilità del<strong>la</strong> stessa guerra, come <strong>di</strong><br />
ogni altra possibilità, non avrebbe modo nemmeno <strong>di</strong> sorgere.<br />
Rispetto al<strong>la</strong> contingente possibilità reale del<strong>la</strong> guerra empirica, si chiarisce il duplice e inscin<strong>di</strong>bile<br />
statuto epistemologico del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>. Per un verso è <strong>la</strong> con<strong>di</strong>zione intrascen<strong>di</strong>bile perché sia<br />
pensabile teoreticamente e vi sia esistenzialmente <strong>la</strong> suddetta guerra, come ogni altra forma <strong>di</strong><br />
vita (non può esservi <strong>di</strong>alogo tra «nemici»!) per l’altro verso è il valore morale <strong>di</strong>rettivo che <strong>la</strong><br />
proibisce. In quanto valore, <strong>la</strong> <strong>pace</strong> statuisce quale sia il dovere dell’agire umano […]<br />
Concludo. L’obbiettivo <strong>di</strong> questo libro non era quello <strong>di</strong> mettere in dubbio il valore del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>,<br />
bensì quello <strong>di</strong> ricercarne un fondamento che lo sottraesse tanto al<strong>la</strong> sua negazione, per opera<br />
del<strong>la</strong> concezione agonistica dell’esistenza, quanto alle scelte puramente soggettive o ideologiche<br />
e quin<strong>di</strong> alle ambiguità segna<strong>la</strong>te nell’introduzione. Un siffatto fondamento può venir trovato, a<br />
mio giu<strong>di</strong>zio, me<strong>di</strong>ante il rigoroso processo <strong>di</strong> autocoscienza dell’io, che lo porta a riconoscere<br />
<strong>la</strong> verità del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zionalità ontologica dell’uomo. La raggiunta chiarezza <strong>di</strong> tale verità è il presupposto<br />
e il supporto assolutamente necessari per qualsiasi progetto <strong>di</strong> <strong>pace</strong>.»<br />
BONANATE<br />
Una teoria morale del<strong>la</strong> vita internazionale<br />
Se <strong>la</strong> guerra non può essere giusta per entrambe le parti in lotta, <strong>la</strong> <strong>pace</strong>, teoricamente, lo può<br />
essere per tutti. Storicamente, si legge nell’opera <strong>di</strong> Bonanate 196 , questa eventualità non si è mai verificata,<br />
dal momento che <strong>la</strong> <strong>pace</strong> si è sempre costruita come esito <strong>di</strong> una guerra e sotto <strong>la</strong> volontà<br />
del vincitore. Ciò <strong>di</strong> fatto ha impe<strong>di</strong>to <strong>di</strong> pensare al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> come valore in sé.<br />
196<br />
L. BONANATE, La <strong>pace</strong> tra etica e politica, in A. PAVAN – A. TABANO (a c. <strong>di</strong>), La <strong>pace</strong> dall’emozione al<strong>la</strong> responsabilità,<br />
Genova, Marietti, 1991, pp. 39-54.<br />
88
Rispetto al<strong>la</strong> critica principale che dall’interno del <strong>di</strong>battito sul<strong>la</strong> guerra giusta si muove a<br />
quest’ultima impostazione—e cioè che <strong>la</strong> possibilità che una guerra venga considerata giusta da<br />
entrambe le parti vanifica qualsiasi sforzo giustificatorio — l’ipotesi del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> giusta mostra<br />
tutta <strong>la</strong> sua forza: nul<strong>la</strong> osta — a <strong>di</strong>fferenza del caso bellico — a che una <strong>pace</strong> giusta per tutte le<br />
parti si realizzi. Ma va anzi naturalmente riconosciuto che siamo <strong>di</strong> fronte a un caso che nel<strong>la</strong><br />
storia non si è finora mai verificato (almeno a partire da quando esistono gli stati nazionali), per<br />
il semplice fatto che <strong>la</strong> natura del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> che il sistema internazionale ha conosciuto è sempre<br />
<strong>di</strong>scesa dall’esito <strong>di</strong> una guerra, cioè da una circostanza che separando vincitori e vinti, ha permesso<br />
ai primi <strong>di</strong> imporre il contenuto che meglio loro conviene al<strong>la</strong> <strong>pace</strong>, al<strong>la</strong> quale i vinti dovevano<br />
sottostare. La <strong>pace</strong>, insomma, finora è sempre stata ingiusta.[...]<br />
Quanto sappiamo dunque del<strong>la</strong> <strong>pace</strong>? Essa viene solitamente concepita in termini negativi rispetto<br />
al<strong>la</strong> guerra, o ad<strong>di</strong>rittura come mero evento post-bellico come quel<strong>la</strong> situazione, <strong>di</strong> fatto,<br />
che si instaura al termine del<strong>la</strong> guerra quando quest’ultima si è esaurita. Non è un caso dunque<br />
che — nonostante l’immenso impegno dei fondatori del<strong>la</strong> peace research — al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> si continui<br />
a pensare come a un fatto piuttosto che come a un valore in sé. [...]<br />
Tutto ciò dovrà tuttavia essere riferito specificamente al<strong>la</strong> <strong>di</strong>mensione al<strong>la</strong> quale il problema<br />
pratico del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> appartiene, cioè al<strong>la</strong> vita internazionale, o meglio ai rapporti internazionali, al<br />
cui livello potremo in primo luogo osservare che è davvero impossibile scindere <strong>la</strong> riflessione<br />
sul<strong>la</strong> <strong>pace</strong> da quel<strong>la</strong> sul<strong>la</strong> guerra (sono davvero due facce <strong>di</strong> una so<strong>la</strong> medaglia: <strong>la</strong> politica internazionale).<br />
[...]<br />
Diremo allora che <strong>la</strong> <strong>di</strong>ffusione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> nel mondo rappresenta <strong>la</strong> pre-con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> qualsiasi<br />
approfon<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>scussione sull’uso da farne, sul modo in cui essa potrà essere utilizzata, e che <strong>la</strong><br />
gerarchizzazione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> corrisponde in sostanza alle <strong>di</strong>verse fasi che essa può attraversare<br />
— dal<strong>la</strong> <strong>pace</strong>-tregua (o intervallo, sospensione, come durante <strong>la</strong> Guerra dei trent’anni) al<strong>la</strong> <strong>pace</strong><br />
tra<strong>di</strong>zionale (<strong>la</strong> semplice assenza <strong>di</strong> ostilità — eticamente poco più che neutra, se pur sempre<br />
preferibile al<strong>la</strong> guerra, essa non <strong>di</strong>scende da una convinta volontà <strong>di</strong> <strong>pace</strong>), al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> del terrore<br />
(quantitativamente superiore al<strong>la</strong> precedente, ma più totalitaria ancora), al<strong>la</strong> <strong>pace</strong> giusta, infine,<br />
o <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione (il massimo immaginabile <strong>di</strong> <strong>pace</strong> — e dunque <strong>la</strong> forma più <strong>di</strong>fficile da realizzare,<br />
se è vero che per realizzarsi è necessario «che il tenore delle re<strong>la</strong>zioni internazionali muti<br />
ra<strong>di</strong>calmente, che cessi l’era del sospetto e cominci quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> sicurezza»).<br />
La «coessenzialità» dei <strong>di</strong>ritti e dei doveri su cui si regge <strong>la</strong> costruzione dell’or<strong>di</strong>ne statuale può<br />
essere trascritta anche nel sistema internazionale.<br />
L’immagine del<strong>la</strong> politica internazionale che così emerge può facilmente apparire ingenua o<br />
troppo ottimistica; ma poiché essa si propone <strong>di</strong> condurre a una teoria del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> internazionale<br />
89
non priva dì risvolti normativi e in qualche modo impegnata a favorire contestualmente una mi<br />
gliore conoscenza dei meccanismi del<strong>la</strong> vita internazionale, rendendo<strong>la</strong> sempre più una compo<br />
nente quoti<strong>di</strong>ana e permanente del<strong>la</strong> nostra analisi del<strong>la</strong> realtà, può darsi che ingenuità e ottimismo<br />
siano necessari. La portata dei problemi che cadono sotto l’intestazione del<strong>la</strong> <strong>pace</strong> è immensa<br />
e <strong>di</strong> gran<strong>di</strong>ssima importanza, cosicché i <strong>di</strong>fetti iniziali potrebbero venir bi<strong>la</strong>nciati<br />
dall’eventuale novità dei risultati. La sfida è dunque grande, dato che le trasformazioni del<strong>la</strong> politica<br />
internazionale, se sono certo più rare che non nel<strong>la</strong> vita interna, quando avvengono sono<br />
tanto più sconvolgenti e sovente anche più drammatiche <strong>di</strong> quelle. [...]<br />
L’idea che sto cercando <strong>di</strong> sviluppare è che una teoria morale del<strong>la</strong> vita internazionale sia possibile,<br />
che essa trovi il presupposto nell’in<strong>di</strong>viduazione dei doveri degli stati, e che il contemperamento<br />
tra questi ultimi dovrebbe avvenire seguendo regole <strong>di</strong> giustizia, deducibili<br />
dall’obbe<strong>di</strong>enza degli stati a un obbligo fondamentale: il trattamento <strong>di</strong> tutti gli in<strong>di</strong>vidui su base<br />
ugualitaria, in<strong>di</strong>pendentemente non soltanto da razza, sesso, cultura, estrazione sociale (come è<br />
successo con le Dichiarazioni dei <strong>di</strong>ritti), ma piuttosto e principalmente dal<strong>la</strong> loro citta<strong>di</strong>nanza o<br />
appartenenza nazionale. La spinta al superamento del pensiero tra<strong>di</strong>zionale sull’impossibilità <strong>di</strong><br />
un’etica internazionale è offerta dal<strong>la</strong> presa <strong>di</strong> coscienza del fatto che in effetti le prese <strong>di</strong> posizione<br />
internazionali degli stati obbe<strong>di</strong>scono, praticamente sempre, a scelte <strong>di</strong> tipo morale, o meglio<br />
a giustificazioni tratte da questo ambito — per quanto sempre riferite al compito del<strong>la</strong> salvaguar<strong>di</strong>a<br />
dell’interesse nazionale. [...]<br />
Le strade del <strong>di</strong>battito su etica e politica interna e internazionale si separano in questo punto:<br />
quel «minimo <strong>di</strong> valori morali» sembra esser conseguibile esclusivamente all’interno dello stato,<br />
non tra gli stati — nel primo caso una qualche integrazione nazionale esiste, mentre sul piano<br />
internazionale non si darebbe nul<strong>la</strong> <strong>di</strong> simile. La vera immoralità sarà dunque quel<strong>la</strong> dello<br />
statista che non tenesse conto <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>fferenza e volesse agire sul<strong>la</strong> scena internazionale secondo<br />
gli stessi principi in base ai quali agisce in politica interna. [...]<br />
In sostanza, l’impossibilità <strong>di</strong> offrire un fondamento assoluto al<strong>la</strong> morale politica ha prodotto re<strong>la</strong>tivismo,<br />
pluralismo o definitiva autonomia del<strong>la</strong> politica rispetto al<strong>la</strong> morale e non<br />
l’abbandono del tema. E’ sufficiente questa «sconfitta» per rinunciare a qualsiasi estensione del<strong>la</strong><br />
problematica dell’etica ai rapporti tra gli stati? L’improbabilità <strong>di</strong> un fondamento assoluto è<br />
una ragione sufficiente per escludere che si possa <strong>di</strong>scutere <strong>di</strong> teorie dell’obbligo politico internazionale,<br />
<strong>di</strong> qualche principio <strong>di</strong> giustizia internazionale?<br />
90



![(Microsoft PowerPoint - Lezione 8b.ppt [modalit\340 compatibilit\340])](https://img.yumpu.com/15217439/1/190x135/microsoft-powerpoint-lezione-8bppt-modalit340-compatibilit340.jpg?quality=85)