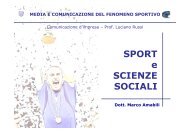MAURICE HALBWACHS Les cadres sociaux de la mémoire Paris ...
MAURICE HALBWACHS Les cadres sociaux de la mémoire Paris ...
MAURICE HALBWACHS Les cadres sociaux de la mémoire Paris ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>MAURICE</strong> <strong>HALBWACHS</strong><br />
<strong>Les</strong> <strong>cadres</strong> <strong>sociaux</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mémoire</strong><br />
<strong>Paris</strong> 1925<br />
Cap.5<br />
La <strong>mémoire</strong> collettive <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille<br />
1. I quadri <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita collettiva ed i ricordi di famiglia<br />
Si è par<strong>la</strong>to spesso, nelle pagine prece<strong>de</strong>nti, <strong>de</strong>l<strong>la</strong> memoria collettiva e <strong>de</strong>i suoi<br />
quadri senza consi<strong>de</strong>rar<strong>la</strong> dal punto di vista <strong>de</strong>l gruppo o <strong>de</strong>i gruppi <strong>de</strong>i quali essa<br />
costituisce una <strong>de</strong>lle funzioni più importanti. Ci siamo limitati finora a osservare e<br />
segna<strong>la</strong>re quanto di sociale vi è nei ricordi individuali, in quelli, cioè nei quali ogni<br />
uomo ritrova il suo passato e cre<strong>de</strong>, spesso, di non ritrovare nient’altro che questo.<br />
Ora che abbiamo riconosciuto fino a che punto l’individuo si trova, per questo aspetto<br />
come per tanti altri, a dipen<strong>de</strong>re dal<strong>la</strong> società, è naturale consi<strong>de</strong>rare il gruppo stesso<br />
come capace di ricordo ed attribuire una memoria al<strong>la</strong> famiglia, ad esempio, così<br />
come ad ogni altro insieme collettivo.<br />
Non si tratta di una semplice metafora. I ricordi familiari si sviluppano, in<br />
verità, nelle coscienze <strong>de</strong>i diversi componenti <strong>de</strong>l gruppo domestico come su tanti<br />
terreni diversi: anche quando vivono a stretto contatto, a maggior ragione quando <strong>la</strong><br />
vita li allontana, ognuno di essi ricorda a suo modo il passato familiare comune. Le<br />
coscienze restano per certi aspetti impenetrabili le une alle altre, ma solo per certi<br />
aspetti. Nonostante le distanze create tra di loro dal contrasto <strong>de</strong>i temperamenti e<br />
dal<strong>la</strong> varietà <strong>de</strong>lle circostanze, i componenti di una famiglia sanno bene che, per aver<br />
condiviso <strong>la</strong> stessa vita quotidiana e per i legami che gli scambi continui di impressioni<br />
e di opinioni hanno stretto tra di loro e <strong>de</strong>i quali avvertono allora tanto più<br />
fortemente <strong>la</strong> resistenza quando si sforzano di romperli, i pensieri <strong>de</strong>gli altri hanno<br />
spinto in loro <strong>de</strong>i rami che non possiamo seguire e <strong>de</strong>i quali non possiamo cogliere <strong>la</strong><br />
trama, nel suo complesso, se non a condizione di riunire tutti questi pensieri, ed in<br />
qualche modo di ricollegarli. Un bambino, in una c<strong>la</strong>sse, è come un’unità umana<br />
completa finché lo si consi<strong>de</strong>ra solo dal punto di vista <strong>de</strong>l<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong>; lo stesso<br />
bambino, se si pensa invece ai suoi genitori, se, senza allontanarsi dall’ambiente<br />
sco<strong>la</strong>stico, par<strong>la</strong> ai compagni o al maestro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua famiglia, <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua casa, non<br />
appare più che come una parte o un frammento separato di una totalità; perché i suoi<br />
gesti, le sue parole di sco<strong>la</strong>ro si accordano così bene, finché egli vi si trova, col<br />
quadro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong>, che lo si confon<strong>de</strong> con <strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> stessa; ma non lo si confon<strong>de</strong><br />
con <strong>la</strong> sua famiglia, finché ne resta lontano, perché i pensieri che lo riconducono ai<br />
genitori e che egli può esprimere non trovano appigli nel<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong>: nessuno li<br />
compren<strong>de</strong>, nessuno può completarli; ed essi certamente non bastano a se stessi.<br />
Se ci si limitasse al<strong>la</strong> memoria individuale, non si capirebbe, in partico<strong>la</strong>re, che<br />
i ricordi di famiglia riproducono altro che le circostanze nelle quali siamo entrati in<br />
contatto con questo o quel nostro parente. Continui o intermittenti, questi incontri<br />
darebbero luogo a <strong>de</strong>lle impressioni successive, ciascuna <strong>de</strong>lle quali indubbiamente in<br />
1
grado di durare e restare i<strong>de</strong>ntica a se stessa per un periodo più o meno lungo, ma<br />
senza altra stabilità di quel<strong>la</strong> comunicata loro dal<strong>la</strong> coscienza individuale che le sperimenta,<br />
D’altra parte, poiché in un gruppo di individui ve ne sono sempre taluni che<br />
cambiano, anche l’aspetto <strong>de</strong>l<strong>la</strong> totalità cambierebbe senza sosta per ognuna <strong>de</strong>lle sue<br />
parti. I ricordi familiari si ridurrebbero così ad una serie di quadri successivi:<br />
rifletterebbero innanzitutto le variazioni emotive o intellettuali di coloro che<br />
compongono il gruppo domestico. La famiglia obbedirebbe al<strong>la</strong> pressione <strong>de</strong>i suoi<br />
membri, e li seguirebbe nei loro movimenti. La sua vita trascorrerebbe come <strong>la</strong> loro,<br />
contemporanea al<strong>la</strong> loro, e le tradizioni di famiglia non durerebbero più di quanto<br />
possa loro convenire.<br />
Ma non è affatto così. In qualsiasi modo si entri in una famiglia, per nascita,<br />
per matrimonio o in altro modo, ci troviamo a far parte di un gruppo nel quale il<br />
nostro posto è fissato non dai nostri sentimenti personali, ma da regole e costumi che<br />
non dipendono da noi e che esistevano prima di noi. Lo sappiamo bene e non<br />
confondiamo le nostre impressioni e le reazioni affettive dinanzi ai nostri cari con i<br />
pensieri ed i sentimenti che essi ci impongono. “Bisogna — ha <strong>de</strong>tto Durkheim —<br />
distinguere radicalmente dal<strong>la</strong> famiglia l’aggregazione di esseri uniti da un legame<br />
fisiologico, dal quale <strong>de</strong>rivano sentimenti psicologici individuali che troviamo anche<br />
negli animali” 1 . Si dirà che i sentimenti che noi proviamo per i nostri genitori si<br />
spiegano con <strong>de</strong>i rapporti di consanguineità, rapporti individuali, così da essere essi<br />
stessi sentimenti individuali? Ma, innanzitutto, il bambino, nel quale questi<br />
sentimenti si formano e si manifestano con tanta intensità, non compren<strong>de</strong> <strong>la</strong> natura<br />
ditali rapporti. Ci sono, poi, società nelle quali <strong>la</strong> parente<strong>la</strong> non dipen<strong>de</strong> dal<strong>la</strong><br />
consanguineità. Tuttavia i sentimenti familiari non si spiegano neppure con le cure<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> madre, con l’ascen<strong>de</strong>nte fisico <strong>de</strong>l padre, con <strong>la</strong> coabitazione abituale con<br />
fratelli e sorelle. Dietro tutto questo, e che domina tutto questo, c’è un sentimento al<br />
tempo stesso oscuro e preciso di ciò che è <strong>la</strong> parente<strong>la</strong>, che non può nascere che nel<strong>la</strong><br />
famiglia e che si spiega solo con essa. Poco importa che i nostri sentimenti ed i nostri<br />
atteggiamenti siano, sotto questo aspetto, impressi in noi o insegnati da individui: non<br />
si ispirano anch’essi forse ad una concezione generale <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia? E lo stesso<br />
acca<strong>de</strong> per le re<strong>la</strong>zioni familiari che si stabiliscono tra sposi. Nell’antichità il<br />
matrimonio non è mai stato <strong>la</strong> pura consacrazione di un’unione fondata su di un sentimento<br />
reciproco. La fanciul<strong>la</strong> greca o romana entrava in una nuova famiglia <strong>de</strong>l<strong>la</strong><br />
quale doveva accettare il culto e le tradizioni. Nelle nostre società, né l’uomo né <strong>la</strong><br />
donna sanno bene, prima <strong>de</strong>l matrimonio, in che rapporto si troveranno e quali ordini<br />
di i<strong>de</strong>e e di sentimenti s’imporranno loro, per il fatto di costituire una nuova famiglia.<br />
Nul<strong>la</strong>, nel loro passato individuale, può farglielo preve<strong>de</strong>re. Nessuno di loro, anche<br />
dopo il matrimonio, potrà insegnare all’altro ciò che cre<strong>de</strong> egli stesso di ignorare. Ma<br />
entrambi obbediranno a <strong>de</strong>lle regole tradizionali, che hanno appreso inconsciamente<br />
nel<strong>la</strong> loro famiglia, come i loro figli le appren<strong>de</strong>ranno dopo di loro. È così che noi<br />
sappiamo al di là di ogni dubbio, tutto ciò che occorre fare, in qualsiasi situazione<br />
familiare le circostanze possano metterci.<br />
Bisogna dunque ammettere che le impressioni e le esperienze di individui uniti<br />
da rapporti di parente<strong>la</strong> ricevono <strong>la</strong> loro forma e gran parte <strong>de</strong>l loro significato da<br />
2
queste concezioni che comprendiamo e nelle quali ci compenetriamo per il solo fatto<br />
di entrare nel gruppo domestico o di farne parte Ben presto il bambino adotta nei<br />
confronti <strong>de</strong>l padre, <strong>de</strong>l<strong>la</strong> madre e di tutti i suoi un atteggiamento che non si spiega<br />
solo con l’intimità di vita, con <strong>la</strong> differenza d’età, con i sentimenti abituali d’affetto<br />
per coloro che ci circondano, di rispetto nei confronti di esseri più forti di noi e dai<br />
quali dipendiamo e di riconoscenza per i servizi che essi ci rendono. Sentimenti di<br />
questo tipo, per spontanei che siano, seguono sentieri già tracciati in prece<strong>de</strong>nza e che<br />
non dipendono da noi, ma <strong>de</strong>i quali <strong>la</strong> società si è curata di stabilire <strong>la</strong> direzione. Non<br />
c’è nul<strong>la</strong> di meno naturale, invero, di questo genere di manifestazioni affettive, niente<br />
che più si conformi a precetti e più risulti da una specie di “dressage”. I sentimenti,<br />
anche mo<strong>de</strong>rati, sono soggetti a molte fluttuazioni e si spostano, o si sposterebbero<br />
spesso, se non li si ostaco<strong>la</strong>sse, da una persona all’altra. Già è davvero straordinario<br />
che <strong>la</strong> famiglia riesca così generalmente ad ottenere dai suoi componenti che si amino<br />
sempre, nonostante <strong>la</strong> lontananza e le separazioni, e che spendano al suo interno <strong>la</strong><br />
maggior parte <strong>de</strong>lle risorse affettive <strong>de</strong>lle quali dispongono. Certo, anche all’interno<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia, non sempre i sentimenti si rego<strong>la</strong>no sui rapporti di parente<strong>la</strong>. Capita<br />
che si amino <strong>de</strong>i nonni ed anche <strong>de</strong>gli zii, <strong>de</strong>lle zie, quanto e più <strong>de</strong>l padre o <strong>de</strong>l<strong>la</strong><br />
madre, che si preferisca un cugino ad un fratello. Ma a stento lo confessiamo a noi<br />
stessi e l’espressione <strong>de</strong>i sentimenti si rego<strong>la</strong> nondimeno sul<strong>la</strong> struttura <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia:<br />
ed è ciò che conta, se non per l’individuo, almeno perché il gruppo conservi autorità e<br />
coesione. Certo, ancora, si hanno <strong>de</strong>gli amici al di fuori <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia; si possono<br />
amare persone diverse dai propri familiari. Ma in questi casi, o <strong>la</strong> famiglia riesce a far<br />
proprie queste re<strong>la</strong>zioni e questi legami, sia che amici di questo genere, per il<br />
privilegio accordato loro dall’anzianità <strong>de</strong>i nostri rapporti, o perché apriamo loro<br />
l’intimità <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra casa, divengano quasi <strong>de</strong>i parenti, sia che il matrimonio<br />
trasformi in parente<strong>la</strong> ciò che non era che <strong>la</strong> vicinanza di due individui. Oppure essa<br />
se ne disinteressa, come se tra questo tipo di affettività capricciosa, srego<strong>la</strong>ta, fantastica<br />
ed i sentimenti ben <strong>de</strong>finiti e permanenti sui quali essa si fonda non esistesse<br />
possibile confronto. Oppure, infine, essa pren<strong>de</strong> atto <strong>de</strong>l fatto che uno <strong>de</strong>i suoi<br />
membri è passato in un altro gruppo e si è separato da lei, sia che attenda il ritorno <strong>de</strong>l<br />
figliol prodigo, sia che faccia finta di averlo dimenticato. I nostri sentimenti, dunque,<br />
o si sviluppano nei quadri <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra famiglia e si conformano al<strong>la</strong> sua organizzazione,<br />
oppure non possono essere condivisi dagli altri componenti <strong>de</strong>l<strong>la</strong> stessa,<br />
che, almeno in punto di diritto, rifiutano di farsi coinvolgere in essi o di prestar loro<br />
attenzione.<br />
È soprattutto quando paragoniamo diversi tipi di organizzazione familiare che<br />
ci sorpren<strong>de</strong> tutto ciò che vi è di acquisito e di esterno in quei sentimenti che<br />
avremmo potuto cre<strong>de</strong>re elementari ed universali quant’altri mai. Ed innanzitutto, a<br />
seconda che <strong>la</strong> discen<strong>de</strong>nza sia maschile o femminile, il figlio riceve o meno il nome<br />
<strong>de</strong>l padre, fa o non fa parte <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua famiglia. In una società a discen<strong>de</strong>nza matrilineare,<br />
il bambino non solo da piccolo, ma in misura tanto maggiore quanto più<br />
diviene consapevole <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua situazione in mezzo agli altri uomini, consi<strong>de</strong>ra <strong>la</strong><br />
madre ed i parenti di quest’ultima come <strong>la</strong> sua famiglia ristretta e trascura invece il<br />
padre, i cui antenati non sono i suoi. Nelle nostre società un fratello ritiene di avere<br />
3
con sua sorel<strong>la</strong> <strong>de</strong>i rapporti altrettanto stretti che con suo fratello; consi<strong>de</strong>riamo<br />
parenti allo stesso titolo zii e cugini paterni o materni; in Grecia, dove <strong>la</strong> famiglia non<br />
compren<strong>de</strong>va che i discen<strong>de</strong>nti di un maschio per via maschile, era <strong>de</strong>l tutto diverso.<br />
La famiglia romana era un corpo ampio che si annetteva, grazie all’adozione, nuovi<br />
componenti e collegava a sé un gran numero di schiavi e di clienti 2 . Nelle nostre<br />
società, nelle quali <strong>la</strong> famiglia ten<strong>de</strong> sempre più a ridursi al gruppo coniugale, come<br />
potrebbero i sentimenti che uniscono gli sposi e che con quelli che li uniscono ai loro<br />
figli bastano, quasi, a costituire l’atmosfera affettiva <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia, non trarre una<br />
parte <strong>de</strong>l<strong>la</strong> loro forza dal fatto che essi sono quasi l’unico cemento che amalgama i<br />
membri <strong>de</strong>l gruppo? Nel<strong>la</strong> famiglia romana, al contrario, l’unione coniugale non è<br />
che uno <strong>de</strong>i tanti rapporti che uniscono al padre di famiglia non solo coloro che hanno<br />
il suo stesso sangue, ma i clienti, i liberti, gli schiavi, i figli adottivi: i sentimenti<br />
coniugali vi giocano quindi solo un ruolo di secondo piano; <strong>la</strong> donna consi<strong>de</strong>ra suo<br />
marito soprattutto come il pater familias ed il marito, dal canto suo, ve<strong>de</strong> nel<strong>la</strong><br />
moglie, non una “metà” <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia, ma un elemento tra i tanti <strong>de</strong>l<strong>la</strong> stessa e che<br />
potrebbe venir eliminato da essa senza minacciarne <strong>la</strong> vitalità o ridurne <strong>la</strong> sostanza. Si<br />
è spiegata l’instabilità <strong>de</strong>i matrimoni a Roma e <strong>la</strong> frequenza <strong>de</strong>i divorzi con<br />
l’intervento <strong>de</strong>i parenti, sia <strong>de</strong>l marito che <strong>de</strong>l<strong>la</strong> moglie, che avrebbero avuto il potere<br />
di sciogliere un’unione conclusa con il loro consenso 3 ma non si sarebbe tollerato<br />
quest’intervento se il divorzio avesse minacciato l’esistenza stessa <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia,<br />
come nelle nostre società. Se è vero che “ammettendo a Roma una media di tre o<br />
quattro matrimoni per persona nel corso <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita siamo “al di sotto piuttosto che al<br />
di sopra <strong>de</strong>l<strong>la</strong> realtà” così che questo regime matrimoniale corrispon<strong>de</strong>rebbe ad una<br />
“poligamia successiva, i sentimenti <strong>de</strong>gli sposi dovevano distinguersi dal tipo di<br />
legame che si accompagna all’i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l matrimonio indissolubile.<br />
Oltre a queste regole comuni a tutta una società, esistono consuetudini e modi<br />
di pensare propri di ogni famiglia, e che parimenti impongono, ed anche più<br />
<strong>de</strong>cisamente, <strong>la</strong> loro forma alle opinioni ed ai sentimenti <strong>de</strong>i loro membri.<br />
“Nell’antica Roma — ci dice Fustel <strong>de</strong> Cou<strong>la</strong>nges — non c’erano né regole né forme<br />
o rituale comune per <strong>la</strong> religione domestica. Ogni famiglia go<strong>de</strong>va <strong>de</strong>l<strong>la</strong> più completa<br />
indipen<strong>de</strong>nza. Nessuna forza esterna aveva il diritto di rego<strong>la</strong>rne il culto o <strong>la</strong> fe<strong>de</strong>.<br />
Non vi era altro sacerdote che il padre. Come sacerdote, egli non riconosceva nessuna<br />
gerarchia. Il pontefice di Roma poteva pure assicurarsi che il padre di famiglia<br />
compisse tutti i riti religiosi, ma non aveva il diritto di richie<strong>de</strong>re <strong>la</strong> più picco<strong>la</strong><br />
modifica. Suo quisque ritu sacrificium faciat, quel<strong>la</strong> era <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> assoluta. Ogni<br />
famiglia aveva le proprie cerimonie, le sue feste partico<strong>la</strong>ri,<br />
le sue formule di preghiera ed i suoi inni. Solo il padre, unico interprete ed unico<br />
pontefice <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua religione, poteva insegnar<strong>la</strong>, e poteva insegnar<strong>la</strong> solo a suo figlio.<br />
I riti, le parole <strong>de</strong>l<strong>la</strong> preghiera, i canti, che erano parte centrale di questa religione<br />
domestica erano un patrimonio, una proprietà sacra che <strong>la</strong> famiglia non condivi<strong>de</strong>va<br />
con nessuno e che era finanche proibito rive<strong>la</strong>re agli estranei. Parimenti nelle società<br />
di oggi più tradizionali, ogni famiglia I ha il suo carattere, i suoi ricordi che è <strong>la</strong> so<strong>la</strong> a<br />
commemorare ed i suoi segreti che rive<strong>la</strong> solo ai suoi componenti. Ma questi ricordi,<br />
come d’altra parte le tradizioni religiose <strong>de</strong>lle famiglie antiche, non consistono solo in<br />
4
una serie d’immagini individuali <strong>de</strong>l passato. Sono, al tempo stesso, <strong>de</strong>i mo<strong>de</strong>lli,<br />
<strong>de</strong>gli esempi e quasi <strong>de</strong>gli insegnamenti. In essi si esprime l’atteggiamento generale<br />
<strong>de</strong>l gruppo; essi non ne riproducono solo <strong>la</strong> storia, ma ne <strong>de</strong>finiscono <strong>la</strong> natura, le<br />
qualità, le <strong>de</strong>bolezze. Quando si dice: “Nel<strong>la</strong> nostra famiglia si vive a lungo, oppure:<br />
si è fieri, oppure: non ci si arricchisce”, si par<strong>la</strong> di una proprietà fisica o morale che si<br />
suppone inerente al gruppo, e che quest’ultimo trasmette ai suoi membri. E talvolta il<br />
luogo o <strong>la</strong> regione d’origine <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia o questa o quel<strong>la</strong> figura caratteristica di<br />
uno <strong>de</strong>i suoi membri che diviene il simbolo, più o meno misterioso, <strong>de</strong>l fondo<br />
comune da cui essi traggono i loro tratti distintivi. In ogni caso, con diversi elementi<br />
di questo genere, tratti dal passato, <strong>la</strong> memoria familiare compone un quadro che<br />
ten<strong>de</strong> a conservare intatto e che costituisce in qualche modo l’armatura tradizionale<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia. Pur essendo costituito da fatti che ebbero un loro tempo, da immagini<br />
che non durarono che un attimo, dal momento che vi si ritrovano i giudizi che <strong>la</strong><br />
famiglia e quelle ad essa vicine hanno dato su di essi, esso partecipa <strong>de</strong>l<strong>la</strong> natura di<br />
quelle nozioni collettive che non hanno né un luogo né un tempo <strong>de</strong>finito e che sembrano<br />
dominare il corso <strong>de</strong>l tempo.<br />
Supponiamo, ora, di ricordare un evento <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra vita familiare che si è<br />
impresso, come si suoi dire, nel<strong>la</strong> nostra memoria. Cerchiamo di eliminare da esso<br />
quelle i<strong>de</strong>e e quei giudizi tradizionali che <strong>de</strong>finiscono lo spirito <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia. Cosa<br />
resta? Ma è poi possibile operare una simile separazione e<br />
distinguere nel ricordo <strong>de</strong>ll’evento “l’immagine di ciò che è accaduto una so<strong>la</strong> volta,<br />
che fa riferimento ad un istante ed ad un luogo unici” e le nozioni nelle quali si<br />
esprime in generale <strong>la</strong> nostra esperienza <strong>de</strong>ll’agire e <strong>de</strong>i modi di essere <strong>de</strong>i nostri<br />
parenti?<br />
Quando Chateaubriand <strong>de</strong>scrive, in una pagina famosa, come si passavano le<br />
serate al castello di Comhourg, si tratta forse di un evento che è accaduto una so<strong>la</strong><br />
volta? Davvero egli è stato, una sera più <strong>de</strong>lle altre, colpito dai silenziosi andirivieni<br />
<strong>de</strong>l padre, dall’aspetto <strong>de</strong>l<strong>la</strong> stanza e dai <strong>de</strong>ttagli che egli sottolinea nel suo quadro?<br />
No: egli ha, invece, certamente con<strong>de</strong>nsato in una so<strong>la</strong> scena i ricordi di molte serate,<br />
così come si erano impressi nel<strong>la</strong> sua memoria ed in quel<strong>la</strong> <strong>de</strong>i suoi: è il riassunto di<br />
un intero periodo, è l’i<strong>de</strong>a dì un genere di vita. Vi si intrave<strong>de</strong> il carattere <strong>de</strong>gli attori,<br />
quale risulta indubbiamente dal ruolo che spetta loro in questa scena ma anche dal<br />
loro modo di essere abituale e da tutta <strong>la</strong> loro storia. Certo, ciò che più ci interessa è<br />
lo stesso Chateaubriand ed il senso di oppressione, di tristezza e di noia provocato in<br />
lui dal contatto con queste persone e cose. Ma come non ve<strong>de</strong>re che in un altro<br />
ambiente questo sentimento non avrebbe potuto nascere, o che, se vi fosse nato,<br />
sarebbe stato i<strong>de</strong>ntico solo in apparenza e che esso implica <strong>de</strong>lle abitudini familiari<br />
che esistevano solo in quel<strong>la</strong> picco<strong>la</strong> nobiltà di provincia <strong>de</strong>ll’antica Francia, così<br />
come le tradizioni proprie <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia di Chateaubriand? È un quadro ricostruito e<br />
ben lungi dal dover rinunciare a riflettere, per ve<strong>de</strong>rlo ripresentarsi nel<strong>la</strong> sua realtà di<br />
un tempo, è grazie al<strong>la</strong> riflessione che l’autore sceglie quei tratti fisici e quelle<br />
partico<strong>la</strong>rità di abbigliamento, che egli dice, ad esempio, a proposito <strong>de</strong>l padre,
guancia secca e bianca, senza rispon<strong>de</strong>rci>> oppure di sua madre che “el<strong>la</strong> si gettava<br />
sospirando su di una vecchia dormeuse damascata” e che ricorda “il gran<strong>de</strong><br />
can<strong>de</strong><strong>la</strong>bro d’argento, sormontato da una can<strong>de</strong><strong>la</strong>", l’orologio che scandiva questa<br />
passeggiata notturna, e <strong>la</strong> picco<strong>la</strong> torre ad ovest, tutti tratti raggruppati ad arte, per<br />
farci meglio compren<strong>de</strong>re il carattere <strong>de</strong>i genitori, <strong>la</strong> monotonia di quest’esistenza<br />
reclusa, analoga d’altra parte a quel<strong>la</strong> di molti gentiluomini di campagna di quei<br />
tempi, e per ricreare l’atmosfera abituale di quelle serate in famiglia così strane.<br />
Certo, è una <strong>de</strong>scrizione fatta molto tempo dopo da uno scrittore; chi _racconta è<br />
obbligato a tradurre i suoi ricordi, per comunicarli ciò che dice non corrispon<strong>de</strong> forse<br />
esattamente a tutto ciò che egli rievoca. Ma cosi com’è <strong>la</strong> scena dà, non di meno, con<br />
un’avvincente miniatura, l’i<strong>de</strong>a di una famiglia, e pur essendo un riassunto di<br />
riflessioni e sentimenti collettivi, essa proietta comunque, sullo schermo di un passato<br />
oscuro e confuso, un’immagine di singo<strong>la</strong>re vivacità.<br />
Una data scena che è avvenuta in casa nostra, di cui i nostri genitori sono stati<br />
protagonisti e che si è impressa nel<strong>la</strong> nostra memoria, non riappare dunque con i tratti<br />
di un tempo, così come <strong>la</strong> vivemmo allora. La ricomponiamo e vi inseriamo elementi<br />
presi a prestito da tanti periodi, prece<strong>de</strong>nti o seguenti. L’i<strong>de</strong>a che abbiamo a<strong>de</strong>sso<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> natura morale <strong>de</strong>i nostri genitori e <strong>de</strong>ll’avvenimento stesso, giudicato a distanza,<br />
s’impone con troppa forza al nostro spirito perché non ne traiamo ispirazione. E lo<br />
stesso acca<strong>de</strong> per quegli eventi e quelle figure che si stagliano sullo sfondo <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita<br />
familiare, <strong>la</strong> riassumono e servono come punti di riferimento a chi vuole localizzare<br />
tratti e circostanze meno importanti. Pur avendo una data, potremmo in realtà<br />
spostarli lungo <strong>la</strong> linea <strong>de</strong>l tempo senza modificarli: si sono arricchiti di tutto ciò che<br />
prece<strong>de</strong> e sono già pregni di tutto ciò che segue. Quanto più spesso si fa riferimento<br />
ad essi, quanto più vi riflettiamo, lungi dal semplificarsi, concentrano in sé più realtà,<br />
perché si collocano al punto di convergenza di un numero maggiore di riflessioni.<br />
Così, nel quadro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> memoria familiare, ci sono certo figure e fatti che hanno <strong>la</strong><br />
funzione di punti di riferimento; ma ognuna di queste figure esprime un carattere<br />
nel<strong>la</strong> sua totalità, ognuno di questi fatti riassume un intero periodo <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita <strong>de</strong>l<br />
gruppo; sono al tempo stesso immagini e nozioni. Riflettiamo su di essi: sarà<br />
indubbiamente come se fossimo nuovamente in contatto col passato. Ma ciò vuoi dire<br />
soltanto che a partire dal quadro ci sentiamo capaci di ricostruire l’immagine <strong>de</strong>lle<br />
persone e <strong>de</strong>i fatti.<br />
2. La famiglia ed il gruppo religioso. La famiglia ed il gruppo contadino. Natura<br />
specifica <strong>de</strong>i sentimenti familiari<br />
È vero che i<strong>de</strong>e di ogni sorta possono evocare in noi <strong>de</strong>i ricordi di famiglia.<br />
Dato che, in effetti, <strong>la</strong> famiglia è il gruppo all’interno <strong>de</strong>l quale trascorre <strong>la</strong> maggior<br />
parte <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra vita, <strong>la</strong> maggior parte <strong>de</strong>i nostri pensieri si mesco<strong>la</strong> ai pensieri<br />
familiari. Sono i genitori coloro che ci hanno comunicato le prime nozioni su persone<br />
e cose. A lungo abbiamo conosciuto il mondo esterno solo attraverso le ripercussioni<br />
<strong>de</strong>gli eventi esterni sul<strong>la</strong> cerchia <strong>de</strong>i nostri parenti. Pensiamo ad una città? Essa può<br />
6
icordarci un viaggio che vi facemmo un tempo con nostro fratello. Pensiamo ad una<br />
professione? Ci ricorda un dato parente che <strong>la</strong> esercita. Pensiamo al<strong>la</strong> ricchezza? Ci<br />
raffigureremo questo o quel componente <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia, sforzandoci di vagliarne <strong>la</strong><br />
posizione. Non c’è dunque oggetto che si proponga al<strong>la</strong> nostra riflessione a partire dal<br />
quale, grazie ad una serie di associazioni di i<strong>de</strong>e, non sia possibile ritrovare un<br />
pensiero che ci rituffi nel passato remoto o recente, in mezzo ai nostri cari.<br />
Da ciò non <strong>de</strong>riva affatto che quello che abbiamo chiamato il quadro <strong>de</strong>l<strong>la</strong><br />
memoria familiare comprenda tutte quelle nozioni che corrispondono ad oggetti <strong>de</strong>l<br />
tutto diversi dal<strong>la</strong> famiglia stessa. Supponiamo che leggendo, per caso, mi cada Sotto<br />
gli occhi il nome di una città francese, Compiègne, e che, come ho <strong>de</strong>tto, mi ricordi in<br />
quest’occasione di un viaggio che vi feci in compagnia di mio fratello. Delle due cose<br />
l’una. O <strong>la</strong> mia attenzione non si concentra specificamente su mio fratello in quanto<br />
tale, ma sul<strong>la</strong> città che abbiamo visitato, sul<strong>la</strong> foresta nel<strong>la</strong> quale abbiamo<br />
passeggiato: ricordo allora le osservazioni che ci scambiavamo su tutto ciò che<br />
colpiva <strong>la</strong> vista o nel<strong>la</strong> casualità <strong>de</strong>l<strong>la</strong> conversazione e mi sembra di poter sostituire a<br />
mio fratello un amico che non ha con me alcun rapporto di parente<strong>la</strong>, senza che il mio<br />
ricordo ne venga seriamente alterato: mio fratello non è, in qualche modo, che un<br />
attore tra gli altri, in una scena il cui reale interesse non risie<strong>de</strong> nei rapporti di<br />
parente<strong>la</strong> che ci uniscono, sia che io pensi soprattutto al<strong>la</strong> città e cerchi di ricostruirne<br />
meglio l’aspetto, sia che ricordi una data i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l<strong>la</strong> quale discutemmo nel corso <strong>de</strong>l<strong>la</strong><br />
passeggiata: allora pur pensando a mio fratello, non ho tuttavia <strong>la</strong> sensazione di<br />
ricordare un evento <strong>de</strong>l<strong>la</strong> mia vita familiare. Oppure con questo ricordo, è proprio su<br />
mio fratello in quanto tale che si dirige il mio interesse. Ma allora, se lo osservo con<br />
maggiore attenzione, mi accorgo che l’immagine che ho in mente non si riferisce a<br />
quel periodo più che ad un altro. Lo vedo piuttosto tale qual era pochi giorni fa, se<br />
voglio rievocarne i tratti. Ma ben più che sui suoi tratti, <strong>la</strong> mia attenzione si concentra<br />
sui rapporti che ci sono stati e che ci sono ancora tra lui, me ed i diversi componenti<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> mia famiglia. Quanto ai <strong>de</strong>ttagli <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra gita, essi passano a poco a poco<br />
sullo sfondo, o <strong>de</strong>stano <strong>la</strong> mia attenzione solo nel<strong>la</strong> misura in cui sono stati per noi<br />
l’occasione di pren<strong>de</strong>r coscienza <strong>de</strong>i legami che esistevano tra noi e con tutti i nostri.<br />
In altri termini, quel ricordo qualunque divenuto un ricordo di famiglia solo a partire<br />
dal momento in cui, al<strong>la</strong> nozione che l’aveva fatto riapparire nel<strong>la</strong> mia memoria,<br />
nozione di una i città <strong>de</strong>l<strong>la</strong>. Francia che è essa stessa parte <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nozione che io ho<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> Francia, si è sostituita, per inquadrare quest’immagine ed anche per modificar<strong>la</strong><br />
e rifon<strong>de</strong>r<strong>la</strong>, un’altra nozione, al tempo stesso generale e partico<strong>la</strong>re, quel<strong>la</strong> <strong>de</strong>l<strong>la</strong> mia<br />
famiglia. Sarebbe dunque inesatto dire che l’i<strong>de</strong>a di un luogo evoca un ricordo di<br />
famiglia: è solo a condizione di scartare quest’i<strong>de</strong>a e di illuminare l’immagine<br />
evocata grazie ad un’altra i<strong>de</strong>a, non più di un luogo, ma di un gruppo di parenti, che<br />
possiamo ricollegar<strong>la</strong> a questo gruppo e che essa pren<strong>de</strong> allora <strong>la</strong> forma di un ricordo<br />
di famiglia.<br />
È tanto più importante distinguere da tutte le altre queste nozioni puramente e<br />
specificamente familiari, che formano il quadro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> memoria domestica, perché in<br />
molte società <strong>la</strong> famiglia non è solo un gruppo di parenti, ma può venir <strong>de</strong>finita, a<br />
quel che sembra, sul<strong>la</strong> base <strong>de</strong>llo spazio che occupa, <strong>de</strong>l<strong>la</strong> professione esercitata dai<br />
7
suoi componenti, <strong>de</strong>l loro livello sociale, etc. Ma se il gruppo domestico coinci<strong>de</strong><br />
talvolta con un gruppo locale, se talvolta <strong>la</strong> vita ed il pensiero <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia sono<br />
invasi da preoccupazioni economiche o religiose, o da altre ancora, esiste tuttavia una<br />
differenza di natura tra <strong>la</strong> parente<strong>la</strong>, da un <strong>la</strong>to, e <strong>la</strong> religione, là professione, <strong>la</strong><br />
ricchezza etc., dall’altro. Ed è per questo che <strong>la</strong> famiglia ha una memoria propria, allo<br />
stesso titolo <strong>de</strong>gli altri tipi di comunità: ciò che passa in primo piano in questa<br />
memoria sono i rapporti di parente<strong>la</strong> e, se vi prendono posto <strong>de</strong>gli eventi che a prima<br />
vista si riconnettono ad i<strong>de</strong>e di tutt’altro tipo, è perché per certi aspetti essi possono<br />
esser consi<strong>de</strong>rati anch’essi come eventi familiari, ed è perché li si consi<strong>de</strong>ra allora<br />
sotto questo aspetto.<br />
È vero che in certe società, antiche o mo<strong>de</strong>rne, si è potuto affermare che <strong>la</strong><br />
famiglia da un <strong>la</strong>to si confon<strong>de</strong>va con il gruppo religioso e che d’altra parte, legata al<br />
suolo, essa faceva tutt’uno con <strong>la</strong> casa ed il campo. I Greci ed i Romani <strong>de</strong>lle età antiche<br />
non distinguevano <strong>la</strong> famiglia dal foco<strong>la</strong>re dove si celebravano i culti <strong>de</strong>gli <strong>de</strong>i<br />
Lari. Ora il foco<strong>la</strong>re “è il simbolo <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita se<strong>de</strong>ntaria... Deve esser posto sul suolo.<br />
Una volta posto, non <strong>de</strong>ve più essere spostato... E <strong>la</strong> famiglia... si radica al suolo<br />
come l’altare stesso. L’i<strong>de</strong>a di domicilio <strong>de</strong>riva naturalmente. La famiglia è legata al<br />
foco<strong>la</strong>re; il foco<strong>la</strong>re lo è al suolo; una stretta re<strong>la</strong>zione si stabilisce dunque tra il suolo<br />
e <strong>la</strong> famiglia. Là <strong>de</strong>ve essere <strong>la</strong> sua dimora stabile che essa non penserà a <strong>la</strong>sciare” 4 .<br />
Ma i foco<strong>la</strong>ri <strong>de</strong>vono essere nettamente separati gli uni dagli altri, come i culti <strong>de</strong>lle<br />
diverse famiglie. “Bisogna che attorno al foco<strong>la</strong>re, ad una certa distanza, vi sia una<br />
recinzione. Poco importa che sia costituita da una siepe, da una divisione di legno, o<br />
da un muro di pietra. Quale che sia, essa segna il limite che separa <strong>la</strong> proprietà di un<br />
foco<strong>la</strong>re dal<strong>la</strong> proprietà di un altro. Questa recinzione è consi<strong>de</strong>rata sacra”. E lo stesso<br />
acca<strong>de</strong> per le tombe. “Come le case non dovevano essere contigue, le tombe non<br />
dovevano toccarsi … I morti sono <strong>de</strong>lle divinità che appartengono esclusivamente ad<br />
una famiglia e che essa so<strong>la</strong> ha il diritto di invocare. I morti hanno preso possesso <strong>de</strong>l<br />
suolo; vivono sotto questo piccolo cumulo; é nessuno, che non sia <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia può<br />
pensare di mesco<strong>la</strong>rsi ad essi. Nessuno, d’altra parte, ha il diritto di privarli <strong>de</strong>l suolo<br />
che occupano; una tomba, per gli antichi, non può mai esser distrutta o spostata” 5 .<br />
Ogni campo era circondato, come una casa, da una recinzione. Non era un muro di<br />
pietra, ma “una striscia di terra di qualche pie<strong>de</strong> di <strong>la</strong>rghezza che doveva restare<br />
incolta e che l’aratro non doveva mai toccare. Questo spazio era sacro: il diritto<br />
romano lo dichiarava imprescrittibile: apparteneva al<strong>la</strong> religione... Su questa striscia,<br />
ad intervalli, si piazzavano grosse pietre o tronchi d’albero che venivano chiamati<br />
termini... Il termine posto a terra era in qualche modo <strong>la</strong> religione domestica radicata<br />
al suolo, per sottolineare che quel suolo era per sempre di proprietà <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia...<br />
Una volta posto secondo i rituali, non esisteva potenza al mondo che potesse spostarlo”.<br />
Ci fu un tempo in cui casa e campo erano a tal punto “parte <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia che<br />
essa non poteva né per<strong>de</strong>rli né disfarsene” 6 . Come avrebbe potuto, dunque, <strong>la</strong> vista<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> casa e <strong>de</strong>l campo non ri<strong>de</strong>stare il ricordo di tutti gli eventi, profani o religiosi,<br />
che vi si erano svolti?<br />
Certo in un’epoca in cui <strong>la</strong> famiglia era l’unità sociale fondamentale è nel suo<br />
ambito che doveva venir praticata <strong>la</strong> religione e le cre<strong>de</strong>nze religiose si sono forse<br />
8
adattate all’organizzazione <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia e mo<strong>de</strong>l<strong>la</strong>te su di essa. Ma tutto sembra<br />
indicare che queste cre<strong>de</strong>nze esistevano già prima di essa o in ogni caso che sono<br />
penetrate in essa dall’esterno. Usener ha mostrato che accanto al culto <strong>de</strong>gli antenati,<br />
e forse prima che le grandi divinità olimpiche avessero preso <strong>la</strong> loro forma <strong>de</strong>finitiva,<br />
l’immaginazione <strong>de</strong>i contadini greci e romani popo<strong>la</strong>va le campagne di tanti esseri e<br />
potenze misteriose, <strong>de</strong>i e spiriti preposti a tutti i principali accadimenti <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita ed<br />
alle diverse fasi <strong>de</strong>i <strong>la</strong>vori agricoli 7 , i quali non avevano alcun carattere domestico.<br />
Quale che sia l’origine <strong>de</strong>l culto <strong>de</strong>i morti non c’è da dubitare che tra <strong>la</strong> natura <strong>de</strong>gli<br />
<strong>de</strong>i Lari, <strong>de</strong>i mani e di quelli <strong>de</strong>i che Usener chiama Son<strong>de</strong>r o Augenblicksgotter, non<br />
ci fossero stretti rapporti ed è possibile che i primi siano stati concepiti ad immagine<br />
di questi ultimi. In ogni caso e nonostante <strong>la</strong> differenza di questi culti <strong>de</strong>i luoghi dove<br />
erano celebrati, <strong>de</strong>i loro sacerdoti, nondimeno tutti erano compresi in uno stesso<br />
insieme di rappresentazioni religiose 8 .<br />
Ora questi modi di pensare religiosi si distinguevano dalle tradizioni familiari. In<br />
altri termini, il culto praticato nel<strong>la</strong> famiglia, anche presso quei popoli, corrispon<strong>de</strong>va<br />
a due tipi di atteggiamenti mentali. Da un <strong>la</strong>to, il culto <strong>de</strong>i morti offriva al<strong>la</strong> famiglia<br />
l’occasione di riunirsi, di comunicare periodicamente nel ricordo <strong>de</strong>i parenti<br />
scomparsi, e di pren<strong>de</strong>re maggiormente coscienza <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua unità e continuità.<br />
Dall’altro, quando, nello stesso giorno <strong>de</strong>ll’anno, in tutte le famiglie, seguendo riti<br />
più o meno uniformi, si evocavano i morti, li si invitava a condivi<strong>de</strong>re il pranzo <strong>de</strong>i<br />
vivi, quando l’attenzione <strong>de</strong>gli uomini si volgeva al<strong>la</strong> natura ed al tipo. di vita <strong>de</strong>lle<br />
anime <strong>de</strong>funte, essi partecipavano ad un insieme di cre<strong>de</strong>nze comuni a tutti i membri<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> loro città e di molte altre ancora; praticando il culto <strong>de</strong>i propri morti essi<br />
rivolgevano l’animo a tutto un mondo di potenze sovrannaturali, <strong>de</strong>l quale i mani <strong>de</strong>i<br />
loro parenti non rappresentavano che un’infima parte. Di questi due atteggiamenti<br />
solo il primo costituiva un atto di commemorazione familiare: coinci<strong>de</strong>va con un<br />
atteggiamento religioso, senza confon<strong>de</strong>rsi con esso.<br />
Nelle nostre società il genere di vita contadino si distingue ancora da tutti gli altri<br />
per il fatto che il <strong>la</strong>voro si compie nel quadro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita domestica e che <strong>la</strong> fattoria, <strong>la</strong><br />
stal<strong>la</strong>, il granaio restano tra le preoccupazioni principali <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia, anche se essa<br />
al presente non vi <strong>la</strong>vora. È quindi naturale che <strong>la</strong> famiglia e <strong>la</strong> terra non si stacchino<br />
l’una dall’altra nel pensiero comune. D’altra parte, dal momento che il gruppo<br />
contadino è legato al suolo, il quadro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> regione specifica e <strong>de</strong>l vil<strong>la</strong>ggio in cui<br />
abita s’imprime presto nell’animo <strong>de</strong>i suoi membri, con tutte le sue partico<strong>la</strong>rità, le<br />
sue divisioni, <strong>la</strong> posizione re<strong>la</strong>tiva <strong>de</strong>lle case e l’accaval<strong>la</strong>rsi <strong>de</strong>i po<strong>de</strong>ri. Quando un<br />
cittadino discute con un contadino si meraviglia che quest’ultimo individui le case ed<br />
i campi col nome <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia che li possie<strong>de</strong> e dica: questa è <strong>la</strong> proprietà <strong>de</strong>l tale,<br />
<strong>la</strong> fattoria <strong>de</strong>l tale; i muri, le siepi, i viottoli, i fossati costituiscono per lui i confini<br />
che separano i gruppi domestici e costeggiando un campo, egli pensa a coloro che lo<br />
seminano e lo arano, costeggiando un frutteto, a coloro che ne raccoglieranno i frutti.<br />
Ma se <strong>la</strong> comunità contadina raggruppata nel vil<strong>la</strong>ggio assegna in qualche modo<br />
col pensiero una porzione di suolo a ciascuna <strong>de</strong>lle famiglie che <strong>la</strong> compongono e<br />
stabilisce <strong>la</strong> parte che ciascuna di esse occupa al suo interno a seconda <strong>de</strong>l luogo nel<br />
quale essa abita e dove si trovano le sue proprietà, nul<strong>la</strong> prova che una simile nozione<br />
9
sia anche preminente nel<strong>la</strong> coscienza di ogni famiglia e che <strong>la</strong> vicinanza <strong>de</strong>i suoi<br />
membri nello spazio si confonda per essa con <strong>la</strong> coesione che li mantiene uniti.<br />
Prendiamo un caso nel quale questi due tipi di rapporti sembrano coinci<strong>de</strong>re più<br />
strettamente. Durkheim studiando <strong>la</strong> famiglia agnatizia, (quel<strong>la</strong> cioè che compren<strong>de</strong> i<br />
discen<strong>de</strong>nti maschili di un maschio) quale esiste ancora tra gli S<strong>la</strong>vi meridionali,<br />
quale è esistita in Grecia, osserva che essa si fonda sul principio che il patrimonio<br />
non può uscire dal<strong>la</strong> famiglia: si preferisce separarsi dagli individui (dalle figlie<br />
sposate, ad esempio) che dal<strong>la</strong> terra. “I legami che vinco<strong>la</strong>no le cose al<strong>la</strong> società<br />
domestica sono più forti di quelli che vinco<strong>la</strong>no ad essa l’individuo... Le cose sono<br />
l’anima <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia: essa non può disfarsene senza distruggere se stessa” 9 . Ne<br />
<strong>de</strong>riva forse, anche in questo regime, l’unità <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia si riconnette all’unità <strong>de</strong>i<br />
beni, e cioè che i membri di quest’ultima consi<strong>de</strong>rano che i loro legami di parente<strong>la</strong> e<br />
quelli che risultano dal possesso e dal<strong>la</strong> coltivazione in comune di una stessa terra,<br />
coincidono? Per nul<strong>la</strong>. Anche qui non bisogna confon<strong>de</strong>re, col pretesto che i<br />
componenti di una stessa stirpe vivono così raccolti e <strong>la</strong>vorano concordi sullo stesso<br />
suolo, due direzioni <strong>de</strong>l pensiero contadino, una che l’orienta verso i <strong>la</strong>vori agricoli e<br />
<strong>la</strong> loro base materiale, <strong>la</strong> terra, un’altra che, lo riconduce all’interno <strong>de</strong>l<strong>la</strong> casa e <strong>de</strong>l<br />
gruppo familiare. Indubbiamente il <strong>la</strong>voro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> terra si distingue da molti tipi di<br />
<strong>la</strong>voro industriale, perché riunisce per gli stessi compiti svolti negli stessi luoghi,<br />
invece di disper<strong>de</strong>rli, i componenti di una stessa famiglia o di famiglie vicine. Il<br />
contadino che mentre <strong>la</strong>vora con fatica, ve<strong>de</strong> i suoi, <strong>la</strong> sua casa e può dirsi: “questo<br />
campo è mio, queste bestie ci appartengono”, sembra mesco<strong>la</strong>re i<strong>de</strong>e agricole e<br />
familiari e si potrebbe cre<strong>de</strong>re in effetti, che dal momento che il suo <strong>la</strong>voro si compie<br />
nel quadro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita domestica, l’una e l’altra non si separino affatto nel suo<br />
pensiero. Ma non è così. Che egli spinga da solo l’aratro, che falci con i suoi parenti,<br />
che batta il grano con loro, che <strong>la</strong>vori nel pol<strong>la</strong>io, egli si ricollega, in realtà, e non può<br />
non ricollegarsi con il pensiero al<strong>la</strong> collettività contadina <strong>de</strong>l vil<strong>la</strong>ggio e <strong>de</strong>l<strong>la</strong> regione<br />
nel suo complesso, che compie i suoi stessi gesti e si <strong>de</strong>dica alle sue stesse<br />
operazioni, i cui membri, pur non essendo suoi parenti, potrebbero aiutarlo e<br />
sostituirlo. Poco importa, per il risultato <strong>de</strong>l <strong>la</strong>voro, che esso sia compiuto da parenti<br />
associati o da un gruppo di contadini senza legami di parente<strong>la</strong>. Il <strong>la</strong>voro, in realtà, ed<br />
anche il suolo, non portano il segno di una data famiglia, ma <strong>de</strong>ll’attività contadina in<br />
generale. Le ragioni che riuniscono i parenti nel <strong>la</strong>voro sono ben diverse da quelle<br />
che li riuniscono nel foco<strong>la</strong>re: sono i rapporti di forza fisici e non i rapporti di<br />
parente<strong>la</strong> che spiegano il fatto che cugini anche lontani <strong>la</strong>vorano insieme, mentre i<br />
nonni troppo avanti con gli anni o i bambini troppo piccoli restano a casa. Quando, in<br />
campi vicini, famiglie diverse approfittano di una bel<strong>la</strong> giornata per seminare o<br />
raccogliere, quando scrutano il cielo, quando si domandano se <strong>la</strong> siccità si protrarrà,<br />
se <strong>la</strong> grandine distruggerà le gemme, una vita comune si <strong>de</strong>sta e preoccupazioni<br />
analoghe riecheggiano. Sono il pensiero e <strong>la</strong> memoria contadina o <strong>de</strong>l vil<strong>la</strong>ggio che<br />
entrano allora in gioco, che aprono loro il tesoro <strong>de</strong>lle proprie tradizioni, <strong>de</strong>lle proprie<br />
leggen<strong>de</strong>, <strong>de</strong>i propri proverbi, che li obbligano a rego<strong>la</strong>rsi sulle divisioni tradizionali<br />
<strong>de</strong>l tempo, sul calendario e sulle feste, che fissano le forme <strong>de</strong>lle loro feste periodiche<br />
ed insegnano loro <strong>la</strong> rassegnazione, ricordando le sventure passate. Indubbiamente <strong>la</strong><br />
10
famiglia è sempre là, ma non è ad lei, in quel momento, che fa riferimento il pensiero<br />
contadino. O meglio, se esso vi fa riferimento, allora le preoccupazioni propriamente<br />
agricole e contadine improvvisamente spariscono, o almeno sono messe un po’ da<br />
parte; ognuno, tra i compagni di <strong>la</strong>voro cerca con lo sguardo i parenti più stretti,<br />
pensa a coloro che restano a casa; il suo orizzonte si limita ora ai suoi cari che si<br />
distaccano dal suolo e dal<strong>la</strong> comunità contadina, per trovare posto in un altro insieme,<br />
quello <strong>de</strong>finito dal<strong>la</strong> parente<strong>la</strong> e da essa so<strong>la</strong>. Acca<strong>de</strong> lo stesso in quelle veglie nelle<br />
quali ai membri <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia vengono ad aggiungersi amici e vicini: allora è lo<br />
spirito <strong>de</strong>l<strong>la</strong> comunità contadina che in qualche modo circo<strong>la</strong> da un foco<strong>la</strong>re all’altro:<br />
ma non appena gli amici si allontanano, i vicini si ritirano: allora <strong>la</strong> famiglia si ripiega<br />
su se stessa e nasce uno spirito nuovo, uno spirito non comunicabile alle altre<br />
famiglie e che non può irradiarsi al di fuori <strong>de</strong>l<strong>la</strong> cerchia <strong>de</strong>i suoi membri. Come<br />
potrebbe confon<strong>de</strong>rsi con <strong>la</strong> nozione di terra quale <strong>la</strong> compren<strong>de</strong> e <strong>la</strong> tiene viva <strong>de</strong>ntro<br />
di sé ogni contadino ed ogni comunità contadina?<br />
Si dice talvolta che l’evoluzione <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia è consistita nel fatto che essa è<br />
venuta progressivamente spogliandosi <strong>de</strong>lle funzioni religiose, giuridiche,<br />
economiche alle quali a<strong>de</strong>mpiva un tempo: il padre di famiglia non è più oggi il<br />
sacerdote, né il giudice, e neppure il capo politico <strong>de</strong>l gruppo domestico. Ma è<br />
probabile che anche all’origine queste funzioni fossero già distinte l’una dall’altra,<br />
che in ogni caso esse non si confon<strong>de</strong>ssero con <strong>la</strong> funzione <strong>de</strong>l padre in quanto padre<br />
e che i rapporti di parente<strong>la</strong> fossero diversi da quelli risultanti da queste altre forme di<br />
pensiero ed attività. Come avrebbero potuto dissociarsi se non vi fosse stata tra di<br />
loro, fin dall’inizio, una differenza di natura? Certo, esse hanno potuto contribuire a<br />
rinforzare o a modificare <strong>la</strong> coesione <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia, ma se esse hanno prodotto questo<br />
risultato, non è per nul<strong>la</strong> a causa <strong>de</strong>l<strong>la</strong> loro natura specifica. Dei genitori possono<br />
separarsi, una famiglia può divi<strong>de</strong>rsi, lo spirito di famiglia può in<strong>de</strong>bolirsi perché non<br />
si hanno le stesse cre<strong>de</strong>nze religiose o si è separati nello spazio, oppure perché si<br />
appartiene a categorie sociali diverse. Ma cause così diverse possono produrre lo<br />
stesso effetto solo perché <strong>la</strong> famiglia reagisce allo stesso modo in presenza di ognuna<br />
di esse. Questa reazione si spiega essenzialmente con <strong>de</strong>lle rappresentazioni familiari.<br />
La comunanza di cre<strong>de</strong>nze religiose, <strong>la</strong> vicinanza nello spazio, <strong>la</strong> somiglianza <strong>de</strong>lle<br />
situazioni sociali non sarebbero sufficienti a creare uno spirito di famiglia. Tutte<br />
queste condizioni hanno per <strong>la</strong> famiglia solo l’importanza che essa attribuisce loro.<br />
Ed essa è capace di trovare in se stessa <strong>la</strong> forza sufficiente ad ignorarle, a superare gli<br />
ostacoli che esse gli oppongono. Ancor meglio, capita che essa trasformi questi<br />
ostacoli in punti di forza, che essa si irrobustisca grazie alle resistenze stesse che<br />
trova all’esterno. Genitori costretti a vivere lontani l’uno dall’altro possono trovare in<br />
questa temporanea separazione un motivo per amarsi di più, perché non pensano che<br />
a riunirsi e fanno ogni sforzo a questo fine. Per superare <strong>la</strong> distanza creata tra loro<br />
dal<strong>la</strong> differenza di cre<strong>de</strong>nze religiose, dal<strong>la</strong> diseguaglianza di livello sociale,<br />
cercheranno di stringere i legami <strong>de</strong>ll’unione familiare. È vero, dunque, che i<br />
sentimenti di famiglia hanno una natura propria e distinta, e che le forze esterne non<br />
hanno presa su di essi se non nel<strong>la</strong> misura in cui essi stessi vi si prestano.<br />
11
3. I rapporti di parente<strong>la</strong> e <strong>la</strong> storia <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia. I nomi propri<br />
A cosa si riducono, infine, questo spirito e questa memoria familiari? Di<br />
quali eventi conservano <strong>la</strong> traccia, tra tutti quelli che si verificano nel<strong>la</strong> famiglia?<br />
Quali nozioni occupano in essi un posto di rilievo, tra tutte quelle che si intrecciano<br />
nel pensiero <strong>de</strong>i membri di un gruppo <strong>de</strong>l genere? Se si cerca un quadro di nozioni<br />
che ci faccia tornar in mente i ricordi <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita domestica, si pensa immediatamente<br />
ai rapporti di parente<strong>la</strong>, come sono <strong>de</strong>finiti in ogni società. Noi vi pensiamo in effetti<br />
continuamente, perché i rapporti quotidiani con i nostri cari, così come con i membri<br />
di altre famiglie, ci obbligano continuamente ad ispirarci ad essi. Essi si presentano<br />
sotto forma di un sistema ben connesso, che offre presa al<strong>la</strong> riflessione; nelle<br />
genealogie familiari c’è una, specie di logica: è questo il motivo per cui <strong>la</strong> storia <strong>de</strong>lle<br />
dinastie, <strong>de</strong>lle successioni e <strong>de</strong>lle alleanze all’interno <strong>de</strong>lle famiglie reali, costituisce<br />
un comodo sistema per ricordare gli eventi <strong>de</strong>l regno. Ugualmente, quando leggiamo<br />
un dramma ricco di peripezie ci troveremmo in difficoltà e ci sentiremmo ben presto<br />
smarriti se non conoscessimo da prima i personaggi e ciò che essi sono l’uno per<br />
l’altro.<br />
Se ci si limitasse al<strong>la</strong> parente<strong>la</strong> in sé, le re<strong>la</strong>zioni che <strong>de</strong>finiscono <strong>la</strong> famiglia<br />
mo<strong>de</strong>rna potrebbero in verità sembrare davvero troppo semplici perché ad esse<br />
possano agganciarsi i ricordi di tutto ciò che ci ha colpito, nel modo di essere <strong>de</strong>i<br />
nostri parenti, nelle loro parole, nelle loro azioni ed i ricordi stessi <strong>de</strong>lle nostre azioni,<br />
<strong>de</strong>lle nostre parole, <strong>de</strong>i nostri pensieri quando noi stessi ci comportiamo da parenti.<br />
Come potrebbe bastarmi il pensare di avere un padre, una madre, <strong>de</strong>i figli, una moglie<br />
perché <strong>la</strong> mia memoria ricostruisca l’immagine fe<strong>de</strong>le di ognuno di essi e <strong>de</strong>l nostro<br />
passato comune? Ma, per semplice che possa sembrarci, questo quadro si complica<br />
nondimeno quando allo schema generale di una famiglia qualsiasi <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra<br />
società, sostituiamo il disegno più minuzioso e <strong>de</strong>ttagliato <strong>de</strong>i tratti essenziali <strong>de</strong>l<strong>la</strong><br />
nostra famiglia. Si tratta allora in effetti di richiamare al<strong>la</strong> nostra mente non più solo<br />
le diverse specie o gradi di parente<strong>la</strong>, ma le persone che ci sono parenti a quel grado o<br />
in quel modo, con <strong>la</strong> fisionomia che siamo abituati ad attribuire loro nel<strong>la</strong> famiglia.<br />
Nel nostro atteggiamento nei confronti di ciascuno <strong>de</strong>i nostri cari, c’è questo, in<br />
effetti, di abbastanza curioso, che associamo in un unico pensiero l’i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>l<strong>la</strong><br />
posizione che essi occupano nel<strong>la</strong> nostra famiglia in virtù solo <strong>de</strong>l<strong>la</strong> parente<strong>la</strong> e<br />
l’immagine di una persona specifica ben <strong>de</strong>finita.<br />
Non vi è nul<strong>la</strong> di più astrattamente imperativo, niente <strong>la</strong> cui rigidità imiti<br />
maggiormente <strong>la</strong> necessità <strong>de</strong>lle leggi naturali, <strong>de</strong>lle regole che fissano i rapporti tra<br />
padre e figli, marito e moglie. Certo questi ultimi possono venir sciolti in casi<br />
eccezionali: il padre romano aveva il diritto di ripudiare i figli; i tribunali hanno<br />
l’autorità necessaria a <strong>de</strong>cretare <strong>la</strong> <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>nza paterna o il divorzio. Anche in questo<br />
caso <strong>la</strong> parente<strong>la</strong> o l’affinità <strong>la</strong>scia tracce nel<strong>la</strong> memoria <strong>de</strong>l gruppo e nel<strong>la</strong> società:<br />
chi è uscito in tal modo dal<strong>la</strong> sua famiglia è consi<strong>de</strong>rato da quest’ultima quasi un dannato<br />
sul quale essa riversa <strong>la</strong> sua esecrazione: come si spiegherebbe tutto ciò se egli le<br />
fosse divenuto improvvisamente estraneo o indifferente? In ogni caso finché non si<br />
12
esce dal<strong>la</strong> famiglia, a differenza di quanto acca<strong>de</strong> negli altri gruppi i cui membri<br />
possono cambiare e cambiano talvolta di posto in rapporto agli altri, si resta negli<br />
stessi rapporti di parente<strong>la</strong> con i propri familiari. Gli uomini possono passare da un<br />
mestiere all’altro, da una nazionalità ad un’altra, salire o scen<strong>de</strong>re nel<strong>la</strong> gerarchia<br />
sociale, i sudditi divenire capi ed i capi sudditi, un <strong>la</strong>ico può anche diventare prete ed<br />
un prete tornare <strong>la</strong>ico. Ma un figlio non diventerà padre che quando fon<strong>de</strong>rà. un’altra<br />
famiglia: anche allora egli resterà sempre il figlio di suo padre; si tratta di un tipo di<br />
rapporto irreversibile: ed ugualmente i fratelli non possono cessare di essere fratelli: è<br />
un tipo di unione indissolubile. In nessun altro caso il posto <strong>de</strong>ll’individuo appare<br />
così pre<strong>de</strong>terminato, senza <strong>la</strong> minima consi<strong>de</strong>razione di ciò che egli vuole e di ciò che<br />
è.<br />
Ma non esiste neppure un ambiente nel quale <strong>la</strong> personalità individuale sia più<br />
valorizzata. Non ce ne sono altri che consi<strong>de</strong>rino maggiormente ogni membro <strong>de</strong>l<br />
gruppo come un essere “unico nel suo genere” ed al quale non si potrebbe concepire,<br />
e non si concepisce, che se ne possa sostituire un altro. Una famiglia, da questo punto<br />
di vista, costituisce meno un gruppo di funzioni specializzate che un gruppo di<br />
persone differenziate. Certo noi non abbiamo scelto nostro padre né nostra madre, né<br />
i nostri fratelli e sorelle ed in molti casi solo apparentemente abbiamo scelto il nostro<br />
coniuge. Ma nell’ambiente re<strong>la</strong>tivamente chiuso costituito dal<strong>la</strong> famiglia, grazie ai<br />
contatti quotidiani che si hanno gli uni con gli altri, ci si esamina a lungo e sotto tutti<br />
gli aspetti. Si <strong>de</strong>termina così nel<strong>la</strong> memoria di ciascuno un’immagine singo<strong>la</strong>rmente<br />
ricca e precisa di ognuno <strong>de</strong>gli altri. Non è questa, quindi, l’area <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita sociale<br />
nel<strong>la</strong> quale meno ci si <strong>la</strong>scia dominare e guidare, nei giudizi che si formu<strong>la</strong>no sui<br />
parenti, dalle regole e dalle cre<strong>de</strong>nze <strong>de</strong>l<strong>la</strong> società, nel<strong>la</strong> quale li si consi<strong>de</strong>ra<br />
soprattutto per quel che sono, per <strong>la</strong> loro natura individuale e non in quanto membri<br />
di un gruppo religioso, politico od economico, nel<strong>la</strong> quale si tiene conto innanzitutto<br />
ed in modo quasi esclusivo <strong>de</strong>lle loro qualità personali e non di ciò che essi sono o<br />
potrebbero essere per gli altri gruppi che circondano <strong>la</strong> famiglia senza penetrarvi?<br />
Quando pensiamo ai nostri parenti, dunque, abbiamo in mente al tempo stesso<br />
l’i<strong>de</strong>a di un rapporto generale di parente<strong>la</strong> e l’immagine di una persona, ed è perché<br />
questi due elementi sono strettamente fusi che noi adottiamo nei confronti di ognuno<br />
di essi contemporaneamente un duplice atteggiamento, e che possiamo dire che i<br />
nostri sentimenti per essi sono al tempo stesso indifferenti al loro oggetto, dal<br />
momento che nostro padre e nostro fratello ci sono imposti, e tuttavia spontanei,<br />
liberi fondati su di una predilezione consapevole, perché al di là <strong>de</strong>l<strong>la</strong> parente<strong>la</strong>,<br />
troviamo nel<strong>la</strong> loro natura stessa ogni motivo per amarli.<br />
Dal momento stesso in cui s’ingrandisce grazie ad un nuovo membro, <strong>la</strong><br />
famiglia gli riserva uno spazio nel suo pensiero. Che egli vi entri per nascita,<br />
matrimonio, adozione, essa registra l’evento, che ha una data e si produce in<br />
condizioni partico<strong>la</strong>ri: da ciò nasce un ricordo iniziale che non scomparirà. Pii tardi,<br />
quando si penserà a questo parente, ora interamente assimi<strong>la</strong>to al gruppo, ci si<br />
ricor<strong>de</strong>rà <strong>de</strong> modo in cui vi è entrato e <strong>de</strong>lle riflessioni o impressioni che le<br />
circostanze partico<strong>la</strong>ri <strong>de</strong>l fatto poterono suscitare nei membri <strong>de</strong>l gruppo.<br />
Soprattutto, questo ricordo sarà stato risvegliato ogni volta che, nell’intervallo<br />
13
l’attenzione <strong>de</strong>i membri <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia sarà stata attratta dagli atti, dalle parole o<br />
semplicemente dal<strong>la</strong> persona di quel parente: essi non dimenticheranno mai ciò che<br />
egli è stato a tutta prima, quando è entrato nel loro gruppo e questo ricordo o questa<br />
nozione <strong>de</strong>terminerà il corso che seguiranno poi tutte le impressioni che egli potrà<br />
suscitare in loro. Così non c’è evento o persona di cui <strong>la</strong> famiglia conservi il ricordo<br />
che non presenti questi due caratteri: da un <strong>la</strong>to esso costituisce un quadro<br />
singo<strong>la</strong>rmente ricco e dotato di profondità, dal momento che vi ritroviamo le realtà<br />
che conosciamo personalmente grazie all’esperienza più intima; dall’altro ci obbliga<br />
a consi<strong>de</strong>rarlo dal punto di vista <strong>de</strong>l nostro gruppo, a ricordarci cioè <strong>de</strong>i rapporti di<br />
parente<strong>la</strong> che spiegano il suo interesse per tutti i nostri cari.<br />
Acca<strong>de</strong> per le persone e gli eventi <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia è ciò che si verifica in molti<br />
altri casi. Sembra che li si ricordi in due modi, sia che si evochino <strong>de</strong>lle immagini<br />
partico<strong>la</strong>ri, che corrispondono ognuna ad un solo fatto, ad un’unica circostanza: nel<br />
nostro caso, o l’intera serie <strong>de</strong>lle impressioni che serbiamo di ognuno <strong>de</strong>i nostri<br />
familiari e che spiega che noi gli attribuiamo una fisionomia originale e non lo<br />
confondiamo con nessun altro; sia che pronunciando invece i loro nomi si provi un<br />
senso di familiarità, come in presenza di esseri di cui conosciamo bene il posto<br />
all’interno di un insieme, <strong>la</strong> posizione re<strong>la</strong>tiva agli esseri ed agli oggetti vicini: nel<br />
nostro caso, <strong>la</strong> nozione di gradi di parente<strong>la</strong>, come si esprime in parole. Ma <strong>la</strong><br />
memoria familiare non si riduce, lo abbiamo visto, al<strong>la</strong> riproduzione pura e semplice<br />
di una serie di impressioni individuali, così come passarono un tempo per <strong>la</strong> nostra<br />
coscienza. Né d’altra parte essa consiste semplicemente nel<strong>la</strong> ripetizione di parole,<br />
nel<strong>la</strong> ripresa di gesti. Essa non risulta, infine, neppure da una semplice associazione<br />
di questi due tipi di dati. Quando <strong>la</strong> famiglia ricorda essa usa certo, <strong>de</strong>lle parole e fa,<br />
certo, riferimento a <strong>de</strong>gli eventi o a <strong>de</strong>lle immagini che furono unici nel loro genere:<br />
ma né queste parole, che non sono che movimenti materiali, né questi eventi o<br />
immagini remote, che non sono che oggetti virtuali di sensazione o di pensiero,<br />
costituiscono l’essenza <strong>de</strong>l<strong>la</strong> memoria: un ricordo di famiglia <strong>de</strong>ve essere altro: e<br />
<strong>de</strong>ve però orientarci verso quelle immagini e quegli eventi e, contemporaneamente<br />
fondarsi su quei nomi.<br />
Nul<strong>la</strong> ci dà meglio l’i<strong>de</strong>a di questo tipo di ricordi <strong>de</strong>i nomi propri, che non sono<br />
né nozioni generali né immagini individuali e che indicano al tempo stesso un<br />
rapporto di parente<strong>la</strong> ed una persona. I nomi propri somigliano ai nomi di cui ci si<br />
serve per <strong>de</strong>signare gli oggetti per il fatto di presupporre un accordo tra i membri <strong>de</strong>l<br />
gruppo familiare. Quando penso, ad esempio, al nome di mio fratello, mi servo di un<br />
segno materiale che non è di per sé privo di significato. Non soltanto è scelto in un<br />
repertorio di nomi stabilito dal<strong>la</strong> società, ognuno <strong>de</strong>i quali evoca nel pensiero comune<br />
taluni ricordi (santi <strong>de</strong>l calendario, personaggi storici che l’hanno portato), ma anche,<br />
per <strong>la</strong> sua lunghezza, per i suoni che lo compongono, <strong>la</strong> frequenza o <strong>la</strong> rarità <strong>de</strong>ll’uso,<br />
<strong>de</strong>sta <strong>de</strong>lle impressioni caratteristiche. Ne <strong>de</strong>riva che i nomi propri, benché scelti<br />
senza tener conto <strong>de</strong>i soggetti ai quali vengono dati, sembrano far parte <strong>de</strong>l<strong>la</strong> loro<br />
natura; non soltanto un nome cambia per noi per il fatto di essere portato da un<br />
fratello, ma nostro fratello stesso, per il fratto di portare quel nome ci sembra diverso<br />
da come sarebbe se si chiamasse in un altro modo. Come potrebbe questo verificarsi<br />
14
se il nome non fosse che una specie di etichetta materiale attaccata all’immagine di<br />
una persona o ad una serie di immagini che ci ricordano quel<strong>la</strong> persona? Bisogna che,<br />
al di là <strong>de</strong>l segno materiale, noi pensiamo, a proposito <strong>de</strong>l nome, a quello che esso<br />
simboleggia e da cui è d’altron<strong>de</strong> inseparabile. Ora se i nomi contribuiscono tanto a<br />
differenziare i componenti di una famiglia, è perché essi rispondono al bisogno che<br />
prova in effetti il gruppo di distinguerli per sé e di inten<strong>de</strong>rsi al tempo stesso sul principio<br />
ed il mezzo ditale distinzione. Il principio è <strong>la</strong> parente<strong>la</strong> che fa sì che ogni<br />
membro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia vi occupi una posizione fissa ed irriducibile ad ogni altra. Il<br />
mezzo è l’abitudine di <strong>de</strong>signare colui che occupa questa posizione con un nome. Il<br />
segno materiale in quanto tale gioca dunque un ruolo <strong>de</strong>l tutto accessorio: l’essenziale<br />
è che il mio pensiero si accordi allora con quelli che, nell’animo <strong>de</strong>i miei parenti,<br />
rappresentano mio fratello: il nome non e che il simbolo di questo accordo, di cui<br />
posso fare ad ogni istante, o di cui ho fatto da tempo l’esperienza: è a quest’accordo<br />
che penso, molto più che al<strong>la</strong> paro<strong>la</strong> stessa, sebbene <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> sia compresa in questo<br />
accordo. Il mio pensiero, dunque, e in tal caso singo<strong>la</strong>rmente ricco e complesso,<br />
perché è il pensiero <strong>de</strong>l gruppo alle cui dimensioni si al<strong>la</strong>rga per un attimo <strong>la</strong> mia<br />
coscienza. Sento allora che mi basterebbe pronunciare questo nome in presenza <strong>de</strong>gli<br />
altri parenti perché ognuno di essi sappia di chi sto par<strong>la</strong>ndo e si prepari a dirmi tutto<br />
ciò che sa di lui. Poco importa che io non svolga realmente quest’inchiesta:<br />
l’essenziale è che io <strong>la</strong> sappia possibile, che io resti, cioè, in contatto con i membri<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> mia famiglia. La maggior parte <strong>de</strong>lle i<strong>de</strong>e che ci passano per <strong>la</strong> mente non si rifà<br />
al sentimento più o meno preciso che potremmo, se volessimo, analizzarne il<br />
contenuto? Raramente, però, si giunge al termine di tale analisi, e in genere neppure<br />
<strong>la</strong> si porta molto avanti. Immaginando tuttavia di esaurire tale indagine, so bene che<br />
essa mi permetterà di sostituire al nome quell’insieme di impressioni partico<strong>la</strong>ri<br />
concrete che in epoche successive i miei parenti e io stesso abbiamo avuto di mio<br />
fratello, nel<strong>la</strong> misura in cui è possibile ricostruirle. Ci sono dunque davvero, dietro il<br />
nome proprio, <strong>de</strong>lle immagini che potremmo, in certe condizioni, far riaffiorare: ma<br />
questa possibilità <strong>de</strong>riva dall’esistenza <strong>de</strong>l nostro gruppo, dal suo persistere, dal<strong>la</strong> sua<br />
integrità. E questo il motivo per cui, in momenti diversi, sebbene nome continui a<br />
<strong>de</strong>signare per noi <strong>la</strong> stessa persona unita a noi dagli stessi rapporti di parente<strong>la</strong>, per le<br />
trasformazioni <strong>de</strong>l gruppo, per il fatto che <strong>la</strong> su esperienza di uno stesso parente al<br />
tempo stesso arricchisce di molte impressioni nuove e si impoverisce nei suoi<br />
contenuti, per <strong>la</strong> scomparsa di taluni testimoni, per le <strong>la</strong>cune che crivel<strong>la</strong>no <strong>la</strong><br />
memoria quelli che sopravvivono, il ricordo di un parente non racchiu<strong>de</strong>, in momenti<br />
successivi, lo stesso insieme di tratti personali.<br />
Cosa succe<strong>de</strong>rebbe se tutti i membri <strong>de</strong>l<strong>la</strong> mi famiglia sparissero? Conserverei<br />
per qualche tempo l’abitudine di attribuire un senso ai loro nomi. I effetti quando un<br />
gruppo, ci ha a lungo profondamente influenzati, noi ne veniamo talmente satura che<br />
anche quando siamo soli, agiamo e pensiamo come se fossimo ancora sotto <strong>la</strong> sua<br />
pressione. È un sentimento naturale perché una perdita recente solo al<strong>la</strong> lunga<br />
manifesta tutti i suoi effetti. Del resto, quand’anche <strong>la</strong> mia famiglia si fosse estinta,<br />
non potrei forse trovare <strong>de</strong>i parenti sconosciuti, o <strong>de</strong>lle persone che hanno conosciuto<br />
i miei parenti e per i quali questi nomi propri e questi cognomi potrebbero ancora<br />
15
avere un senso? Al contrario, man mano che i morti sprofondano nel passato, non è<br />
perché si allunga l’intervallo materiale di tempo che li separa da noi che i loro<br />
nomi cadono a poco a poco nell’oblio, ma perché non resta nul<strong>la</strong> <strong>de</strong>l gruppo al cui<br />
interno essi vivevano e che aveva bisogno di chiamarli. Soli si trasmettono e si<br />
ricordano quelli <strong>de</strong>gli antenati il cui ricordo è sempre vivo, perché gli uomini di oggi<br />
li venerano, e restano almeno fittiziamente in rapporto con essi. Gli altri si spiega<br />
forse così che i Greci abbiano avuto <strong>la</strong> ten<strong>de</strong>nza a dare ai nipoti il nome <strong>de</strong>l nonno;<br />
ma si esprime così anche il fatto che ci sono <strong>de</strong>i limiti all’interesse ed all’attenzione<br />
<strong>de</strong>l gruppo, il quale, togliendo ai morti il nome per darlo ai vivi, li cancel<strong>la</strong> dal suo<br />
pensiero e dal<strong>la</strong> sua memoria. L’uomo che non vuoi dimenticare i parenti scomparsi e<br />
si ostina a ripetere i loro nomi, viene a scontrarsi ben presto con l’indifferenza<br />
generale. Chiuso nei suoi ricordi, egli si sforza invano di mesco<strong>la</strong>re alle<br />
preoccupazioni <strong>de</strong>l<strong>la</strong> società attuale quelle <strong>de</strong>i gruppi di ieri: ma gli manca proprio<br />
l’appoggio <strong>de</strong>i gruppi scomparsi. Uno che ricorda, lui solo, quello che gli altri non<br />
ricordano somiglia ad uno che ve<strong>de</strong> quello che gli altri non vedono. È, per certi<br />
aspetti, uno in preda alle allucinazioni, che impressiona sfavorevolmente coloro che<br />
lo circondano. Di fronte al risentimento <strong>de</strong>l<strong>la</strong> società, egli tace ed a forza di tacere<br />
dimentica i nomi che non vengono più pronunciati attorno a lui. La società è come <strong>la</strong><br />
matrona di Efeso che impicca il morto per salvare il vivo. È vero che certi moribondi<br />
prolungano <strong>la</strong> loro agonia ed esistono <strong>de</strong>lle società che conservano più a lungo di<br />
altre il ricordo <strong>de</strong>i loro morti. Ma non c’è tra di esse, sotto questo aspetto, che una<br />
differenza di grado.<br />
4. La creazione di nuove famiglie. La famiglia e gli altri gruppi<br />
Abbiamo <strong>de</strong>tto che in ogni società, c’è un tipo di organizzazione che s’impone<br />
a tutte le famiglie, ma che in ogni famiglia si sviluppa d’altra parte uno spirito<br />
proprio, perché essa possie<strong>de</strong> <strong>de</strong>lle tradizioni che sono solo sue. Come potrebbe<br />
essere diversamente dato ché <strong>la</strong> memoria familiare non conserva solo il ricordo <strong>de</strong>i<br />
rapporti di parente<strong>la</strong> che uniscono i suoi membri, ma anche <strong>de</strong>gli eventi e dalle persone<br />
che hanno contato nel<strong>la</strong> sua storia? Le famiglie sono come tante specie di uno<br />
stesso genere e dal momento che ciascuna di esse si distingue dalle altre, può capitare<br />
sia che esse si ignorino, sia che si oppongano sia che si influenzino e che una parte<br />
<strong>de</strong>i ricordi <strong>de</strong>ll’una penetri nel<strong>la</strong> memoria di una o di diverse altre. Del resto poiché le<br />
cre<strong>de</strong>nze generali di una società raggiungono i membri <strong>de</strong>lle famiglie attraverso <strong>la</strong><br />
mediazione di quelli di loro che sono più direttamente coinvolti nel<strong>la</strong> vita collettiva<br />
esterna, può capitare o che esse si adattino alle tradizioni <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia o all’inverso<br />
che esse trasformino quelli di loro che sono più direttamente coinvolti nel<strong>la</strong> vita<br />
collettiva esterna, può capitare o che esse si adattino alle tradizioni <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia o<br />
all’inverso che esse trasformino queste stesse tradizioni. Il verificarsi <strong>de</strong>ll’uno o<br />
<strong>de</strong>ll’altro caso dipen<strong>de</strong> da un <strong>la</strong>to, dalle ten<strong>de</strong>nze <strong>de</strong>l<strong>la</strong> società più ampia,<br />
comprensiva di tutte le famiglie, che può o disinteressarsi più o meno di ciò che si<br />
verifica in esse, oppure (come certamente le società primitive) rego<strong>la</strong>re e control<strong>la</strong>re<br />
incessantemente <strong>la</strong> vita domestica, e, d’altra parte, dal<strong>la</strong> forza <strong>de</strong>lle tradizioni proprie<br />
16
di ogni famiglia che non sono senza rapporto con le qualità personali di coloro che le<br />
creano e le conservano.<br />
Se non abbiamo abbandonato i nostri genitori per fondare un’altra famiglia, se<br />
questi ultimi, personalità forti o figure partico<strong>la</strong>rmente originali, seppero comunicare<br />
e conservare al nostro gruppo una fisionomia ben distinta dagli altri, se, d’altra parte,<br />
per tutto il periodo in cui siamo stati in contatto con loro <strong>la</strong> loro natura morale ed il<br />
loro atteggiamento nei confronti <strong>de</strong>l mondo sociale circostante non sono mutati<br />
sensibilmente, essi stessi, le loro azioni i loro giudizi, i diversi casi <strong>de</strong>l<strong>la</strong> loro<br />
esistenza resteranno sempre in primo piano nel<strong>la</strong> nostra memoria. Anche se una<br />
famiglia subisce appena, tuttavia, l’influenza di altri gruppi, si producono in essa<br />
<strong>de</strong>lle trasformazioni inevitabili morti, nascite, ma<strong>la</strong>ttie, vecchiaia, rallentamento o<br />
accelerazione <strong>de</strong>ll’attività organica individuale <strong>de</strong>i suoi membri, che ne modificano,<br />
da un’epoca all’altra, <strong>la</strong> struttura interna. Si può immaginare che questi ultimi, o <strong>la</strong><br />
maggior parte di loro, non se ne accorgano, se, per esempio, invecchiano insieme e se<br />
si iso<strong>la</strong>no sempre più dagli altri e si rinchiudono nell’illusione di non essere cambiati<br />
tanto da par<strong>la</strong>re <strong>de</strong>i ricordi di un tempo come ne par<strong>la</strong>vano quando essi erano ancora<br />
recenti: il quadro nel quale essi li collocano non si è affatto modificato né arricchito.<br />
Spesso quelli di loro che non si iso<strong>la</strong>no completamente dalle altre società domestiche<br />
e dal<strong>la</strong> società circostante in generale constatano che i loro parenti non sono più oggi<br />
com’erano un tempo: essi correggono allora e completano l’insieme <strong>de</strong>i ricordi<br />
familiari opponendo alle frasi di testimoni invecchiati o poco sicuri, l’opinione di<br />
uomini di altre famiglie, ed anche analogie, nozioni d’uso e l’insieme <strong>de</strong>lle i<strong>de</strong>e<br />
accettate nel<strong>la</strong> loro epoca, al di fuori <strong>de</strong>l loro gruppo, ma attorno ad esso. E così che<br />
<strong>la</strong> storia non si limita a riprodurre il racconto fatto dagli uomini contemporanei agli<br />
eventi trascorsi, ma, di epoca in epoca, lo ritocca non solo perché dispone di altre<br />
testimonianze, ma per adattano ai modi di pensare, di rappresentarsi il passato <strong>de</strong>gli<br />
uomini <strong>de</strong>l presente.<br />
Quando un matrimonio separa dal gruppo domestico uno <strong>de</strong>i suoi membri, il gruppo<br />
da cui quest’ultimo è uscito ten<strong>de</strong> a non dimenticarlo; ma nel gruppo in cui entra egli<br />
si trova a pensare meno spesso a quei parenti che non sono più vicino a lui mentre<br />
nuove figure e nuovi eventi vengono al<strong>la</strong> ribalta <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua coscienza. È ciò ché si<br />
verificava soprattutto nell’antichità, per esempio nel<strong>la</strong> società greca e romana. Il<br />
matrimonio, allora, non creava una nuova famiglia, ma faceva entrare un nuovo<br />
membro in una famiglia antica: quest’ultimo prima doveva esser separato da un’altra<br />
famiglia antica e questa separazione radicale somigliava al<strong>la</strong> perdita di uno <strong>de</strong>i suoi<br />
membri imposta al gruppo dal<strong>la</strong> morte. A Roma <strong>la</strong> fanciul<strong>la</strong> che si sposa muore per <strong>la</strong><br />
famiglia <strong>de</strong>i suoi parenti, per rinascere nel<strong>la</strong> famiglia di suo marito. È questo il<br />
motivo per cui il matrimonio, almeno nei primi tempi, quando <strong>la</strong> famiglia restava<br />
l’unità sociale fondamentale, era un atto religioso e pren<strong>de</strong>va <strong>la</strong> forma di un rito,<br />
come tutti quelli che modificavano <strong>la</strong> composizione di un gruppo. “La donna così<br />
sposata — dice Fustel <strong>de</strong> Cou<strong>la</strong>nges — ha ancora il culto <strong>de</strong>i morti; ma non è più ai<br />
propri antenati che essa porta il banchetto funebre; el<strong>la</strong> non ne ha più il diritto. Il<br />
matrimonio l’ha completamente distaccata dal<strong>la</strong> famiglia di suo padre ed ha spezzato<br />
tutti i rapporti religiosi con essa. È agli antenati <strong>de</strong>l marito che essa porta l’offerta;<br />
17
essa appartiene al<strong>la</strong> loro famiglia, essi sono divenuti i suoi antenati. Il matrimonio<br />
l’ha fatta nascere di nuovo. Essa è da questo momento in poi <strong>la</strong> figlia di suo marito,<br />
filiae loco, dicono i giuristi. Non si può appartenere a due famiglie, né a due religioni<br />
domestiche <strong>la</strong> donna entra totalmente nel<strong>la</strong> famiglia e nel<strong>la</strong> religione <strong>de</strong>l manito” 10 .<br />
Indubbiamente, quando entra nel<strong>la</strong> famiglia <strong>de</strong>l marito, <strong>la</strong> donna non dimentica tutti i<br />
ricordi prece<strong>de</strong>nti: i ricordi d’infanzia sono impressi profondamente in lei; sono<br />
ri<strong>de</strong>stati dai rapporti che di fatto essa conserva con i parenti, i fratelli e le sorelle. Ma<br />
essa li <strong>de</strong>ve accordare con le i<strong>de</strong>e e le tradizioni che le si impongono nel<strong>la</strong> nuova<br />
famiglia. All’inverso, una famiglia Romana non si assimi<strong>la</strong>va una donna acquisita col<br />
matrimonio senza che l’equilibrio <strong>de</strong>l pensiero <strong>de</strong>l gruppo non ne fosse in qualche<br />
modo scosso. Non era possibile che con essa non penetrasse nel<strong>la</strong> famiglia in cui<br />
entrava una parte <strong>de</strong>llo spirito <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia d’origine. La continuità <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia<br />
non era spesso che una finzione. I matrimoni erano per ognuna di esse l’occasione per<br />
ripren<strong>de</strong>re contatto con il più vasto ambiente sociale dal quale essa ten<strong>de</strong>va ad iso<strong>la</strong>rsi<br />
e per aprirsi a nuove correnti di pensiero; è così che esse trasformavano le loro<br />
tradizioni.<br />
“Oggi <strong>la</strong> famiglia è discontinua: due sposi fondano una nuova famiglia e <strong>la</strong><br />
fondano in qualche modo su di una tabu<strong>la</strong> rasa”. Certo, quando con il matrimonio ci<br />
si inserisce in una sfera sociale più elevata, capita che si dimentichi <strong>la</strong> famiglia<br />
d’origine e che ci si i<strong>de</strong>ntifichi strettamente col gruppo domestico l’accesso al quale<br />
dischiu<strong>de</strong> un mondo più prestigioso. Quando, <strong>de</strong>lle due figlie <strong>de</strong>l père Goriot, una<br />
sposa un conte e l’altra un ricco banchiere, esse tengono il padre a distanza e<br />
cancel<strong>la</strong>no dal<strong>la</strong> memoria tutto il periodo <strong>de</strong>l<strong>la</strong> loro vita trascorso in un ambiente<br />
privo di qualità. Anche in questo caso si può dire che il matrimonio non ha creato<br />
nuove famiglie, che ha solo permesso a famiglie antiche di crescere con nuovi<br />
elementi. Ma quando due persone <strong>de</strong>llo stesso livello sociale si uniscono si confrontano<br />
tradizioni familiari di pari forza. Nessuna <strong>de</strong>lle due famiglie d’origine può<br />
rivendicare il diritto di assorbire il coniuge che proviene dall’altra. Dovrebbe<br />
<strong>de</strong>rivarne e ne <strong>de</strong>riva in effetti spesso, nelle nostre società in cui <strong>la</strong> famiglia ten<strong>de</strong> a<br />
ridursi al<strong>la</strong> coppia, che le famiglie <strong>de</strong>i genitori sembrano finire dove inizia <strong>la</strong> famiglia<br />
fondata dai loro figli. Dal che nasce una differenza di atteggiamento abbastanza<br />
rilevante tra le due. È conforme al<strong>la</strong> natura di una famiglia che non cresce più, che è<br />
giunta al suo termine non dimenticare quei suoi componenti che l’abbandonano e se<br />
non il trattenerli, almeno il rafforzare, per quel che dipen<strong>de</strong> da lei, i legami attraverso<br />
i quali essi le restano attaccati. I ricordi che essa rievoca allora e che si sforza di<br />
mantenere vivi in loro, traggono indubbiamente <strong>la</strong> loro forza dal<strong>la</strong> loro anzianità. La<br />
famiglia nuova è tutta rivolta al futuro. Essa avverte, alle sue spalle, una specie di<br />
vuoto morale: perché se ognuno <strong>de</strong>gli sposi si crogio<strong>la</strong> ancora nei suoi ricordi<br />
familiari di un tempo, dal momento che questi ricordi non sono gli stessi per l’uno e<br />
per l’altro, essi non possono pensarli in comune. Per elu<strong>de</strong>re <strong>de</strong>i conflitti inevitabili<br />
che nessuna norma accettata da entrambi permetterebbe di risolvere, concordano<br />
tacitamente di consi<strong>de</strong>rare abolito un passato nel quale non trovano elementi<br />
tradizionali atti a rinforzare <strong>la</strong> loro unione. In realtà essi non lo dimenticano <strong>de</strong>l tutto.<br />
Presto, quando avranno già dietro di sé una durata di vita comune abbastanza lunga,<br />
18
quando <strong>de</strong>gli eventi nei quali le loro preoccupazioni si sono mesco<strong>la</strong>te saranno sufficienti<br />
a fornire loro una memoria propria, allora tra i nuovi ricordi essi potranno far<br />
posto ai vecchi, tanto più che i loro parenti non saranno rimasti estranei a questa fase<br />
<strong>de</strong>l<strong>la</strong> loro esistenza nel<strong>la</strong> quale essi hanno posto le basi di una nuova famiglia. Ma<br />
questi vecchi ricordi si inseriranno in un quadro nuovo. I nonni, nel<strong>la</strong> misura in cui<br />
partecipano al<strong>la</strong> vita <strong>de</strong>l<strong>la</strong> coppia più recente, vi giocano un ruolo complementare. E<br />
in modo frammentario e quasi attraverso gli intervalli <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia attuale che essi<br />
comunicano ai nipoti i loro ricordi, e che fanno giungere loro l’eco di tradizioni quasi<br />
scomparse: non possono far rivivere per loro un insieme d’i<strong>de</strong>e ed una sintesi di fatti<br />
che non troverebbero più posto, in quanto insieme e sintesi, nel quadro in cui si<br />
muove attualmente il pensiero <strong>de</strong>i loro discen<strong>de</strong>nti. Non è senza sforzo, né talvolta<br />
senza sofferenze e travagli interiori che si opera tra due generazioni questa specie di<br />
frattura che nessun riavvicinamento o ritorno potrà sanare. Ora se fossimo di fronte<br />
solo a coscienze individuali, tutto si ridurrebbe ad un conflitto di immagini, alcune<br />
che ci catturano con il fascino <strong>de</strong>l passato, con tutti i nostri ricordi d’infanzia, con i<br />
sentimenti che i nostri parenti <strong>de</strong>stano in noi, altre con i legami <strong>de</strong>l presente, cioè con<br />
gli esseri apparsi di recente nel cerchio <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra esperienza. Di conseguenza, se le<br />
sensazioni e gli stati affettivi presenti sono stati abbastanza forti da far sì che gli<br />
individui sacrifichino il passato al presente e si strappino ai loro cari senza<br />
rappresentarsi con sufficiente vivi<strong>de</strong>zza il dolore che si <strong>la</strong>sciano alle spalle, non si<br />
spiega che essi si sentano di<strong>la</strong>cerati internamente e che il rimpianto assuma talvolta in<br />
essi <strong>la</strong> forma <strong>de</strong>l rimorso. D’altra parte se i ricordi s’impongono loro con pungente<br />
vitalità, se, come capita, essi sono mediocremente coinvolti e l’avvenire non si<br />
dipinge ai loro occhi di colori bril<strong>la</strong>nti, non si capisce come essi siano capaci di<br />
questo sacrificio.<br />
Ma non sono due tipi d’immagini, provenienti le une dal passato, le altre dal<br />
presente, sono due modi di pensare, due concezioni <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita e <strong>de</strong>gli uomini che si<br />
fronteggiano. Se al<strong>la</strong> logica familiare che obbliga l’uomo a consi<strong>de</strong>rarsi innanzitutto<br />
come un figlio egli non potesse opporne un’altra, che l’autorizza a consi<strong>de</strong>rarsi come<br />
un marito o come un padre, egli resterebbe in<strong>de</strong>finitamente all’interno <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua<br />
famiglia d’origine, o, se ne uscisse, sarebbe esposto a tutti i mah materiali e morali<br />
che colpiscono l’uomo iso<strong>la</strong>to. I suoi pensieri ed i suoi ricordi non troverebbero più<br />
posto in un quadro che impedisca loro di disper<strong>de</strong>rsi: essi durerebbero, cioè, il tempo<br />
stesso <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua passione o <strong>de</strong>l suo <strong>de</strong>si<strong>de</strong>rio o <strong>de</strong>lle circostanze che li favoriscono,<br />
senza fondarsi su nessuna cre<strong>de</strong>nza o concezione collettiva. In una società che non<br />
ammette che un Montecchi sposi una Capuleti, <strong>la</strong> storia di Romeo e Giulietta non può<br />
avere altra realtà che quel<strong>la</strong> di un’immagine di sogno. È diverso, invece, quando non<br />
si <strong>la</strong>scia una famiglia che per fondarne un’altra seguendo le regole e le cre<strong>de</strong>nze <strong>de</strong>l<strong>la</strong><br />
società che compren<strong>de</strong> tutte le famiglie, o più generalmente, per entrare in un altro<br />
gruppo.<br />
Quando un membro di una famiglia se ne allontana per aggregarsi ad un gruppo<br />
che non è una famiglia, ad esempio per chiu<strong>de</strong>rsi in un convento, egli trae <strong>la</strong> sua forza<br />
da una cre<strong>de</strong>nza religiosa che egli oppone allo spirito di famiglia. Allora gli eventi,<br />
giudicati dal punto di vista di un altro gruppo, lo saranno anche secondo altri principi,<br />
19
ispirandosi ad un’altra logica. Quando suor Angelica, in un momento in cui lo spirito<br />
di famiglia combatteva ancora nel suo intimo con il sentimento <strong>de</strong>i nuovi doveri,<br />
ricordava il giorno <strong>de</strong>lle visite a Port Royal, vi ve<strong>de</strong>va indubbiamente <strong>la</strong> prova più<br />
dura che aveva dovuto sopportare. Ma questo ricordo dovette a poco a poco<br />
inquadrarsi <strong>de</strong>l tutto naturalmente nel<strong>la</strong> storia <strong>de</strong>lle tappe <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua conversione ed al<br />
tempo stesso, nell’insieme <strong>de</strong>i suoi pensieri religiosi: esso divenne presto per lei e per<br />
i membri <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua comunità al tempo stesso una tradizione, un esempio e quasi un<br />
aspetto <strong>de</strong>l<strong>la</strong> verità. Qui in effetti si può dire che due concezioni <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita si<br />
fronteggiavano. Ma non acca<strong>de</strong> esattamente lo stesso, a quel che sembra, quando un<br />
membro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia l’abbandona per fondarne un’altra. In effetti mentre una<br />
ragazza che diviene monaca non ritrova nel chiostro, pur sotto altra disposizione o<br />
applicati ad altri oggetti, i pensieri di cui si nutriva nell’ambiente <strong>de</strong>i suoi, al<br />
contrariò quando un ragazzo o una ragazza si sposano si potrebbe cre<strong>de</strong>re che si rifacciano<br />
in fondo ad una logica i<strong>de</strong>ntica o anche al<strong>la</strong> stessa logica che hanno appreso<br />
all’interno <strong>de</strong>l<strong>la</strong> loro famiglia e tra i loro parenti. La famiglia, dopo tutto, non si<br />
riduce ad un insieme di funzioni che gli uomini di generazioni successive sono<br />
chiamati a compiere, l’uno dopo l’altro? Quel familiare che è stato un tempo il padre<br />
non lo è più o lo è a stento oggi, sia che sia scomparso sia che i suoi ragazzi abbiano<br />
sempre meno bisogno di lui. Come potrebbe il suo ricordo non impallidire, nel<br />
momento in cui egli diviene un nome, un viso, o semplicemente un essere che prova e<br />
per il quale si provano <strong>de</strong>i sentimenti che si spiegano meno con <strong>la</strong> funzione che con <strong>la</strong><br />
persona, che promanano dall’uomo piuttosto che dal padre e che sono indirizzati<br />
all’uomo piuttosto che al padre? Come potrebbe tutta <strong>la</strong> forza <strong>de</strong>ll’i<strong>de</strong>a di padre non<br />
gravare su colui che, nel presente, è consapevole di esserlo e di essere consi<strong>de</strong>rato<br />
come tale, nel senso pieno <strong>de</strong>l termine?<br />
La famiglia, tuttavia, non è una forma che da un momento all’altro cambia<br />
bruscamente di contenuto. Quando un figlio si sposa, non si sostituisce al padre come<br />
un re che ne succe<strong>de</strong> ad un altro. Una famiglia che si costituisce si pone inizialmente<br />
di fronte a quelle dalle quali i suoi due capi sono usciti, come una nuova fondazione.<br />
È solo a poco a poco e più tardi che il nuovo padre e <strong>la</strong> nuova madre i<strong>de</strong>ntificano le<br />
loro funzioni con quelle esercitate prima di loro dai loro genitori e questa i<strong>de</strong>ntità non<br />
appare mai loro che come una somiglianza più o meno stretta.<br />
Samuel Butler ha osservato che se si suppone che i ricordi si trasmettano dai<br />
genitori ai figli per via ereditaria, <strong>la</strong> loro esperienza ereditaria non può esten<strong>de</strong>rsi nel<br />
corso <strong>de</strong>l tempo, oltre il momento in cui essi sono stati concepiti, dal momento che a<br />
partire da quel momento non c’è più stata, tra loro ed i loro genitori, nessuna<br />
continuità organica. È questo il motivo per il quale, mentre i processi biologici<br />
verrebbero sviluppandosi con gran<strong>de</strong> sicurezza fino all’età adulta, essendo allora<br />
guidati dall’esperienza ancestrale, a partire dal momento in cui l’uomo è in età di<br />
procreare egli sarebbe preda <strong>de</strong>l<strong>la</strong> casualità <strong>de</strong>lle proprie esperienze ed il suo corpo<br />
non saprebbe più adattarsi così bene alle condizioni in cui <strong>de</strong>ve vivere. Potremmo<br />
dire, al contrario, che <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita <strong>de</strong>i nostri genitori non conosciamo, per esperienza<br />
diretta, che <strong>la</strong> parte che inizia qualche anno dopo <strong>la</strong> nostra nascita: tutto ciò che<br />
prece<strong>de</strong> non ci interessa per nul<strong>la</strong>; all’opposto, quando diventiamo noi stessi mariti e<br />
20
padri, invece, ripercorriamo una serie di stadi nei quali li abbiamo visti passare e ci<br />
sembra di poterci i<strong>de</strong>ntificare con quello che essi sono stati. Ma non è ancora dire<br />
abbastanza. C’è tutto un periodo, quello che corrispon<strong>de</strong> agli inizi <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nuova<br />
famiglia, in cui essa si oppone <strong>de</strong>cisamente al<strong>la</strong> famiglia più antica, perché è nuova e<br />
perché sembra aver bisogno di costituirsi una memoria originale al di fuori <strong>de</strong>i quadri<br />
tradizionali. È questo il motivo per cui è solo abbastanza tardi, quando essa ha perso<br />
in qualche misura una parte <strong>de</strong>l suo s<strong>la</strong>ncio originario, quando si avvicina il momento<br />
in cui anch’essa sta per generare, attraverso i suoi discen<strong>de</strong>nti, altri gruppi domestici<br />
che verranno distaccandosi da lei, che una famiglia pren<strong>de</strong> coscienza di non essere<br />
che <strong>la</strong> continuazione e quasi una nuova edizione di quel<strong>la</strong> dal<strong>la</strong> quale <strong>de</strong>riva. È<br />
quando un padre ed una madre si avvicinano al<strong>la</strong> vecchiaia che pensano di più ai loro<br />
genitori, in partico<strong>la</strong>re a ciò che costoro erano al<strong>la</strong> loro età e che, venendo a mancare<br />
ogni ragione per distinguersi da essi, sembra loro che i genitori rivivano <strong>de</strong>ntro di<br />
loro e che essi ne ripercorrano le tracce. Ma nel periodo <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua vita attiva e <strong>de</strong>l<strong>la</strong><br />
sua espansione <strong>la</strong> famiglia, rivolta al futuro o assorta nel presente, cerca di giustificare<br />
e rinforzare <strong>la</strong> sua indipen<strong>de</strong>nza nei confronti <strong>de</strong>lle tradizioni familiari<br />
appoggiandosi sul<strong>la</strong> più ampia società <strong>de</strong>lle altre famiglie contemporanee. E dunque<br />
proprio una logica ed una concezione <strong>de</strong>l<strong>la</strong> vita nuova, più ampia, e per questo<br />
motivo, all’apparenza almeno, più razionale, quel<strong>la</strong> che esiste nel<strong>la</strong> società e che essa<br />
oppone ai modi di pensare ed ai ricordi <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia o <strong>de</strong>lle famiglie originarie.<br />
Nel corso <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra vita siamo impegnati, contemporaneamente al<strong>la</strong> famiglia,<br />
anche in altri gruppi. Estendiamo <strong>la</strong> nostra memoria familiare in modo da farvi<br />
rientrare i ricordi <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra vita pubblica, ad esempio. Oppure ricollochiamo i<br />
nostri ricordi familiari nei quadri attraverso i quali <strong>la</strong> nostra società riscopre il suo<br />
passato. Questo equivale a consi<strong>de</strong>rare <strong>la</strong> nostra famiglia dal punto di vista <strong>de</strong>gli altri<br />
gruppi; o viceversa, ed a combinare contemporaneamente ai ricordi, i modi di pensare<br />
propri <strong>de</strong>ll’una e <strong>de</strong>gli altri. Talvolta prevale l’uno o l’altro di questi quadri e si<br />
cambia memoria come si cambiano punti di vista, principi, interessi, giudizi quando<br />
si passa da un gruppo all’altro. Dal momento in cui il bambino va a scuo<strong>la</strong> <strong>la</strong> sua vita<br />
scorre in qualche modo in due letti, ed i suoi pensieri si ricollegano seguendo due<br />
piani. Se egli ve<strong>de</strong> i suoi solo saltuariamente, <strong>la</strong> famiglia <strong>de</strong>ve far ricorso a tutta <strong>la</strong><br />
forza acquisita in prece<strong>de</strong>nza ed anche al<strong>la</strong> forza che le <strong>de</strong>riva dal fatto che essa dura<br />
più <strong>de</strong>l<strong>la</strong> scuo<strong>la</strong> e <strong>de</strong>l liceo, dal fatto che essa ci accompagna e ci contiene fino ai<br />
confini <strong>de</strong>l<strong>la</strong> morte, per conservare <strong>la</strong> sua parte di influenza. Ma lo stesso acca<strong>de</strong>, in<br />
grado maggiore o minore, quando il giovane o l’adulto si inserisce in altri ambienti,<br />
se questi ultimi lo allontanano dai suoi. Prima di entrare nel<strong>la</strong> vita pubblica, e dopo<br />
aver<strong>la</strong> <strong>la</strong>sciata, si basta a se stessi, ci si interessa soprattutto agli ambienti <strong>de</strong>l<strong>la</strong> nostra<br />
vita privata; <strong>la</strong> vita in qualche modo si interiorizza e con essa <strong>la</strong> memoria: essa si<br />
rinchiu<strong>de</strong> nei confini <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia. Presi dal pubblico, al contrario, si esce da se<br />
stessi e <strong>la</strong> memoria si dispiega all’esterno: <strong>la</strong> nostra vita, quindi, sono le nostre<br />
re<strong>la</strong>zioni e <strong>la</strong> nostra storia è <strong>la</strong> loro storia; le nostre imprese e le nostre distrazioni non<br />
differiscono da quelle <strong>de</strong>gli altri e non si possono raccontare queste e quelle<br />
separatamente. Quando si dice che <strong>la</strong> vita pubblica ci disper<strong>de</strong>, occorre inten<strong>de</strong>re<br />
l’espressione al<strong>la</strong> lettera.<br />
21
Indubbiamente si può essere impegnati nel pubblico solo a metà, o solo in apparenza.<br />
Ma si gioca allora un doppio ruolo e nel<strong>la</strong> misura in cui si è parte <strong>de</strong>l<strong>la</strong> società si<br />
accetta di ricordare come lei. Questa è indubbiamente l’evoluzione <strong>de</strong>l<strong>la</strong> maggior<br />
parte <strong>de</strong>gli uomini che si mesco<strong>la</strong>no e si confondono con il gruppo sociale all’interno<br />
<strong>de</strong>l quale svolgono <strong>la</strong> loro attività solo nel periodo corto ed occupato nel quale <strong>la</strong> loro<br />
vita professionale e mondana è al culmine. Allora, a differenza <strong>de</strong>l bambino, che non<br />
ha ancora dove per<strong>de</strong>rsi e <strong>de</strong>ll’anziano, che ha ripreso possesso di sé, essi non si<br />
appartengono più. Scorrete le memorie nelle quali un amministratore, un uomo di<br />
affari o di stato che svolse coscienziosamente <strong>la</strong> sua funzione, racconta i fatti che<br />
resero faticosi ed agitati i suoi anni: più che <strong>la</strong> sua storia è <strong>la</strong> storia di un gruppo<br />
sociale, professionale o pubblico. Non è tanto il contenuto quanto il tono e qualche<br />
osservazione (nelle quali d’altra parte ritroviamo spesso le reazioni di una cerchia di<br />
persone e l’animo di una cricca) e forse <strong>la</strong> scelta <strong>de</strong>gli avvenimenti che distinguono<br />
questo racconto individuale o quest’autobiografia da un <strong>la</strong>voro storico che ha per<br />
oggetto il racconto <strong>de</strong>i fatti così come sono stati visti da un gruppo di uomini e col<br />
significato che essi ebbero per loro. Quando si dice di uno scrittore che <strong>la</strong> sua storia si<br />
confon<strong>de</strong> con quel<strong>la</strong> <strong>de</strong>lle sue opere, ciò significa che egli non esce affatto dal mondo<br />
interiore che si è creato: ma quando si dice di un guerriero o di un medico o di un<br />
prete che <strong>la</strong> sua storia si confon<strong>de</strong> con quel<strong>la</strong> <strong>de</strong>lle sue imprese, <strong>de</strong>lle sue guarigioni,<br />
<strong>de</strong>lle sue conversioni, si <strong>la</strong>scia inten<strong>de</strong>re, al contrario, che egli non ebbe il tempo di<br />
rientrare in se stesso e che le preoccupazioni comuni alle quali egli fu più<br />
specificamente preposto o esposto per <strong>la</strong> sua funzione, furono sufficienti a riempirne<br />
l’animo.<br />
In molte circostanze in cui uomini e famiglie diverse partecipano in comune alle<br />
stesse distrazioni, agli stessi <strong>la</strong>vori, alle stesse cerimonie, l’evento li colpisce meno<br />
per quel che di esso resta nel<strong>la</strong> vita <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia che per quello che ne resta esterno;<br />
essi lo ricordano come un fatto impersonale. Ma lo stesso acca<strong>de</strong> quando in un<br />
gruppo di famiglie vicine si moltiplicano le re<strong>la</strong>zioni, sia, che, come nei vil<strong>la</strong>ggi<br />
contadini, esse siano riunite dal luogo in cui abitano, sia che, come nelle c<strong>la</strong>ssi alte,<br />
esse si fondino sul<strong>la</strong> stima <strong>de</strong>lle altre ed abbiano bisogno di mantenere e rinnovare<br />
attraverso il contatto con queste ultime, il senso <strong>de</strong>l<strong>la</strong> loro superiorità. Allora i<br />
membri di ogni famiglia introducono incessantemente nel pensiero <strong>de</strong>l proprio<br />
gruppo re<strong>la</strong>zioni, interpretazioni e giudizi presi a prestito dalle famiglie vicine. Cosa<br />
diviene <strong>la</strong> memoria <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia? Essa <strong>de</strong>ve compren<strong>de</strong>re al suo interno non uno ma<br />
più gruppi <strong>la</strong> cui importanza, e anche l’aspetto e le re<strong>la</strong>zioni reciproche, cambiano ad<br />
ogni istante. Dal momento che essa consi<strong>de</strong>ra gli eventi abbastanza notevoli da venir<br />
conservati e raccontati spesso dal punto di vista <strong>de</strong>gli altri, oltre che dal suo, essa li<br />
traduce in termini generali. Il quadrò di eventi che le permette di ritrovare i ricordi<br />
specifici <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia <strong>de</strong>l<strong>la</strong> quale è <strong>la</strong> memoria potrebbe forse distinguersi<br />
facilmente dai quadri specifici <strong>de</strong>lle altre famiglie, se ci si limitasse alle figure, alle<br />
immagini: si potrebbe così <strong>de</strong>limitare nello spazio il campo di ognuna e le si<br />
potrebbero assegnare solo quei corsi di eventi che vi si sono verificati, come in tante<br />
caselle distinte. Ma, lo abbiamo già <strong>de</strong>tto, il quadro <strong>de</strong>l<strong>la</strong> memoria familiare è fatto,<br />
più che di figure o d’immagini, di nozioni, nozioni di persone o nozioni di fatti,<br />
22
singo<strong>la</strong>ri e storiche, certo, ma che hanno d’altra parte tutti i caratteri <strong>de</strong>i pensieri<br />
comuni a tutto un gruppo ed anche a diversi gruppi. Così le tradizioni proprie di ogni<br />
famiglia si stagliano su di un fondo di nozioni generali impersonali e non è d’altron<strong>de</strong><br />
facile indicare il limite che separa le une dalle altre. Si capisce che una famiglia che è<br />
appena nata ed avverte soprattutto il bisogno di adattarsi all’ambiente sociale nel<br />
quale è chiamata a vivere volga le spalle alle tradizioni <strong>de</strong>i gruppi parentali dai quali<br />
si è appena emancipata e venga ispirandosi soprattutto a quel<strong>la</strong> logica generale che<br />
<strong>de</strong>termina le re<strong>la</strong>zioni <strong>de</strong>lle famiglie tra di loro. Ma dal momento che ogni famiglia<br />
ha presto una sua storia, dal momento che <strong>la</strong> sua memoria si arricchisce di giorno in<br />
giorno, i suoi ricordi, nel<strong>la</strong> loro forma personale, vengono precisandosi e fissandosi,<br />
essa ten<strong>de</strong> progressivamente ad interpretare a suo modo le concezioni che pren<strong>de</strong> a<br />
prestito dal<strong>la</strong> società. Finisce per avere <strong>la</strong> sua logica e le sue tradizioni che<br />
somigliano a quelle <strong>de</strong>l<strong>la</strong> società più ampia, perché <strong>de</strong>rivano da essa e perché le<br />
stesse continuano a rego<strong>la</strong>re i suoi rapporti con quest’ultima, ma che si distinguono,<br />
anche, da quelle perché si impregnano a poco a poco <strong>de</strong>l<strong>la</strong> sua esperienza specifica ed<br />
hanno, il ruolo di assicurare sempre più <strong>la</strong> sua coesione e garantire <strong>la</strong> sua continuità.<br />
NOTE<br />
I) Durkheim, Corso inedito sul<strong>la</strong> famiglia.<br />
2) Lo schiavo ed il cliente facevano parte <strong>de</strong>l<strong>la</strong> famiglia ed erano sepolti nel<strong>la</strong> tomba<br />
comune. Fustel <strong>de</strong> Cou<strong>la</strong>nges, La cité antique, 20° ed., p. 67, n. ed anche p. 127 e ss.<br />
3) Lacombe (Paul), La famille dans <strong>la</strong> société romaine, étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> moralité comparée,<br />
1889, p. 208 e ss.<br />
4) Fustel <strong>de</strong> Cou<strong>la</strong>nges, loc. cit., p. 64 e ss.<br />
5) Ibid., p. 68: “il diritto romano esige che se una famiglia ven<strong>de</strong> il campo ove è<br />
<strong>la</strong> sua tomba, essa resta almeno proprietaria di quel<strong>la</strong> tomba e conserva in eterno il<br />
diritto di traversare il campo per andare a compiere le cerimonie <strong>de</strong>l culto. L’uso<br />
antico era di seppellire i morti non in cimiteri o sul bordo di una strada, ma nel<br />
campo di ogni famiglia”.<br />
6) lbid.,p.73.<br />
7) Usener, Gòtternamen, p. 75.<br />
8) Usener riporta da Bahrios <strong>la</strong> storia di un contadino che si reca in città per<br />
implorare i grandi <strong>de</strong>i, perché sono più potenti di quelli <strong>de</strong>l<strong>la</strong> campagna. Ibid., p. 247.<br />
Fustel <strong>de</strong> Cou<strong>la</strong>nges, spiegando come <strong>la</strong> plebe “un tempo fol<strong>la</strong> senza culto, ebbe da<br />
un certo punto in poi le sue cerimonie religiose e le sue feste”, dice che “ora una<br />
famiglia plebea si costruì un foco<strong>la</strong>re... ora il plebeo, senza culto domestico, ebbe<br />
accesso ai templi <strong>de</strong>l<strong>la</strong> città”. La cité antique, p. 328.<br />
9) Durkheim, cit.<br />
10) Fustel <strong>de</strong> Cou<strong>la</strong>nges, op. cit., p. 47.<br />
23



![(Microsoft PowerPoint - Lezione 8b.ppt [modalit\340 compatibilit\340])](https://img.yumpu.com/15217439/1/190x135/microsoft-powerpoint-lezione-8bppt-modalit340-compatibilit340.jpg?quality=85)