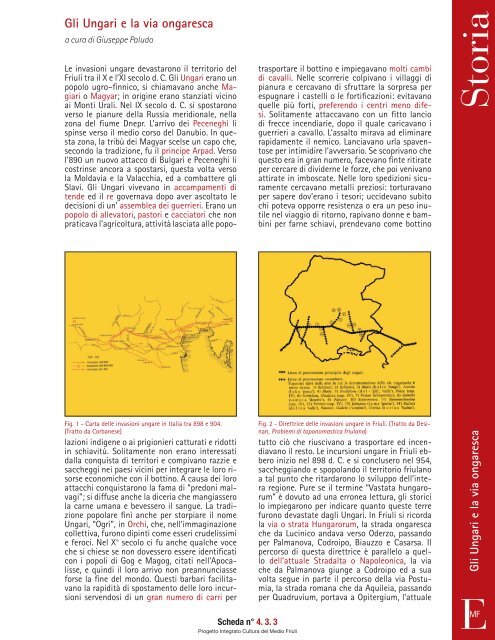Gli Ungari e la via ongaresca - Il Progetto Integrato Cultura
Gli Ungari e la via ongaresca - Il Progetto Integrato Cultura
Gli Ungari e la via ongaresca - Il Progetto Integrato Cultura
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> e <strong>la</strong> <strong>via</strong> <strong>ongaresca</strong><br />
a cura di Giuseppe Paludo<br />
Le invasioni ungare devastarono il territorio del<br />
Friuli tra il X e l’XI secolo d. C. <strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> erano un<br />
popolo ugro–finnico, si chiamavano anche Magiari<br />
o Magyar; in origine erano stanziati vicino<br />
ai Monti Urali. Nel IX secolo d. C. si spostarono<br />
verso le pianure del<strong>la</strong> Russia meridionale, nel<strong>la</strong><br />
zona del fiume Dnepr. L’arrivo dei Peceneghi li<br />
spinse verso il medio corso del Danubio. In questa<br />
zona, <strong>la</strong> tribù dei Magyar scelse un capo che,<br />
secondo <strong>la</strong> tradizione, fu il principe Arpad. Verso<br />
l’890 un nuovo attacco di Bulgari e Peceneghi li<br />
costrinse ancora a spostarsi, questa volta verso<br />
<strong>la</strong> Molda<strong>via</strong> e <strong>la</strong> Va<strong>la</strong>cchia, ed a combattere gli<br />
S<strong>la</strong>vi. <strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> vivevano in accampamenti di<br />
tende ed il re governava dopo aver ascoltato le<br />
decisioni di un’ assemblea dei guerrieri. Erano un<br />
popolo di allevatori, pastori e cacciatori che non<br />
praticava l’agricoltura, attività <strong>la</strong>sciata alle popo-<br />
Fig. 1 - Carta delle invasioni ungare in Italia tra 898 e 904.<br />
(Tratto da Corbanese)<br />
<strong>la</strong>zioni indigene o ai prigionieri catturati e ridotti<br />
in schiavitù. Solitamente non erano interessati<br />
dal<strong>la</strong> conquista di territori e compivano razzie e<br />
saccheggi nei paesi vicini per integrare le loro risorse<br />
economiche con il bottino. A causa dei loro<br />
attacchi conquistarono <strong>la</strong> fama di “predoni malvagi”;<br />
si diffuse anche <strong>la</strong> diceria che mangiassero<br />
<strong>la</strong> carne umana e bevessero il sangue. La tradizione<br />
popo<strong>la</strong>re finì anche per storpiare il nome<br />
<strong>Ungari</strong>, “Ogri”, in Orchi, che, nell’immaginazione<br />
collettiva, furono dipinti come esseri crudelissimi<br />
e feroci. Nel X° secolo ci fu anche qualche voce<br />
che si chiese se non dovessero essere identificati<br />
con i popoli di Gog e Magog, citati nell’Apocalisse,<br />
e quindi il loro arrivo non preannunciasse<br />
forse <strong>la</strong> fine del mondo. Questi barbari facilitavano<br />
<strong>la</strong> rapidità di spostamento delle loro incursioni<br />
servendosi di un gran numero di carri per<br />
Scheda n° 4. 3. 3<br />
<strong>Progetto</strong> <strong>Integrato</strong> <strong>Cultura</strong> del Medio Friuli<br />
trasportare il bottino e impiegavano molti cambi<br />
di cavalli. Nelle scorrerie colpivano i vil<strong>la</strong>ggi di<br />
pianura e cercavano di sfruttare <strong>la</strong> sorpresa per<br />
espugnare i castelli o le fortificazioni: evitavano<br />
quelle più forti, preferendo i centri meno difesi.<br />
Solitamente attaccavano con un fitto <strong>la</strong>ncio<br />
di frecce incendiarie, dopo il quale caricavano i<br />
guerrieri a cavallo. L’assalto mirava ad eliminare<br />
rapidamente il nemico. Lanciavano ur<strong>la</strong> spaventose<br />
per intimidire l’avversario. Se scoprivano che<br />
questo era in gran numero, facevano finte ritirate<br />
per cercare di dividerne le forze, che poi venivano<br />
attirate in imboscate. Nelle loro spedizioni sicuramente<br />
cercavano metalli preziosi: torturavano<br />
per sapere dov’erano i tesori; uccidevano subito<br />
chi poteva opporre resistenza o era un peso inutile<br />
nel <strong>via</strong>ggio di ritorno, rapivano donne e bambini<br />
per farne schiavi, prendevano come bottino<br />
Fig. 2 - Direttrice delle invasioni ungare in Friuli. (Tratto da Desinan,<br />
Problemi di toponomastica friu<strong>la</strong>na)<br />
tutto ciò che riuscivano a trasportare ed incendiavano<br />
il resto. Le incursioni ungare in Friuli ebbero<br />
inizio nel 898 d. C. e si conclusero nel 954,<br />
saccheggiando e spopo<strong>la</strong>ndo il territorio friu<strong>la</strong>no<br />
a tal punto che ritardarono lo sviluppo dell’intera<br />
regione. Pure se il termine “Vastata hungarorum”<br />
è dovuto ad una erronea lettura, gli storici<br />
lo impiegarono per indicare quanto queste terre<br />
furono devastate dagli <strong>Ungari</strong>. In Friuli si ricorda<br />
<strong>la</strong> <strong>via</strong> o strata Hungarorum, <strong>la</strong> strada <strong>ongaresca</strong><br />
che da Lucinico andava verso Oderzo, passando<br />
per Palmanova, Codroipo, Biauzzo e Casarsa. <strong>Il</strong><br />
percorso di questa direttrice è parallelo a quello<br />
dell’attuale Stradalta o Napoleonica, <strong>la</strong> <strong>via</strong><br />
che da Palmanova giunge a Codroipo ed a sua<br />
volta segue in parte il percorso del<strong>la</strong> <strong>via</strong> Postumia,<br />
<strong>la</strong> strada romana che da Aquileia, passando<br />
per Quadruvium, portava a Opitergium, l’attuale<br />
Storia<br />
<strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> e <strong>la</strong> <strong>via</strong> <strong>ongaresca</strong>
Storia<br />
<strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> e <strong>la</strong> <strong>via</strong> <strong>ongaresca</strong><br />
Oderzo. In Friuli sono ricordate anche altre vie<br />
ungaresche, nel pordenonese e vicino a Sacile.<br />
<strong>Gli</strong> <strong>Ungari</strong> infatti entravano in Friuli dal<strong>la</strong> valle<br />
del Vipacco, passavano per <strong>la</strong> nostra pianura<br />
e proseguivano per il Veneto e <strong>la</strong> Lombardia. La<br />
direttrice correva poco a nord del<strong>la</strong> linea delle<br />
risorgive ed attorno ad essa sorgono numerosi<br />
centri abitati molti dei quali, come Lonca e Virco,<br />
hanno nome di origine s<strong>la</strong>va, Bertiolo, nome<br />
di origine romano–germanica, F<strong>la</strong>mbro, nome di<br />
origine germanica: sono centri distrutti durante<br />
le invasioni e successivamente ricostruiti. Questi<br />
nomi si ritrovano anche piuttosto distanti dal<strong>la</strong><br />
attuale Stradalta: i vari gruppi degli invasori erano<br />
infatti tutt’altro che disciplinati e, mentre il<br />
grosso avanzava, molti razziavano lontano dal<strong>la</strong><br />
principale direzione di marcia. Le incursioni ungare<br />
mostrarono <strong>la</strong> debolezza e l’impotenza delle<br />
Fig. 3 - Carta delle invasioni ungare nel 951, 954 e 955.<br />
(Tratto da Corbanese)<br />
istituzioni feudali a contrastarle. Anzi, in due occasioni,<br />
nel 921 e nel 924 fu lo stesso re d’Italia,<br />
Berengario, che li chiamò per combattere le<br />
congiure dei propri feudatari. Solo i Patriarchi di<br />
Aquileia riuscirono in qualche modo ad opporsi<br />
a questi barbari: le cronache raccontano del patriarca<br />
Federico (900–922) che organizzò qualche<br />
campagna contro loro. La Chiesa di Aquileia<br />
si prese cura del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione terrorizzata dalle<br />
scorrerie e favorì <strong>la</strong> ripresa del<strong>la</strong> regione, organizzando<br />
<strong>la</strong> ricostruzione dei vil<strong>la</strong>ggi devastati. I<br />
patriarchi aquileiesi Rodoaldo (963–983) e Giovanni<br />
(984–1019) si impegnarono per ripopo<strong>la</strong>re<br />
il Friuli e fecero condurre nelle zone devastate<br />
un gran numero di coloni, in maggioranza s<strong>la</strong>vi,<br />
i quali, stanziati proprio accanto al<strong>la</strong> <strong>via</strong> ungaresca,<br />
ripresero <strong>la</strong> coltivazione delle terre. Finirono<br />
poi per integrarsi rapidamente con gli abitanti<br />
Scheda n° 4. 3. 3<br />
Bibliografia<br />
<strong>Progetto</strong> <strong>Integrato</strong> <strong>Cultura</strong> del Medio Friuli<br />
locali e oggi sono rimasti i nomi dei paesi e gli<br />
s<strong>la</strong>vismi nel<strong>la</strong> toponomastica a ricordare <strong>la</strong> loro<br />
venuta. La rinascita economica del<strong>la</strong> regione fu<br />
infine completata dal patriarca Poppo o Poppone<br />
(1019–1042). Nel 955 cessò <strong>la</strong> minaccia degli<br />
<strong>Ungari</strong>. Una loro spedizione in Baviera venne<br />
attaccata dall’esercito tedesco dell’imperatore<br />
Ottone I: l’episodio è noto come Battaglia di Lechfeld,<br />
nel<strong>la</strong> quale i predoni furono sconfitti e<br />
massacrati. Dopo questo episodio, non vi furono<br />
più incursioni. Attorno all’anno 1000 infine gli<br />
Ungheresi si convertirono al Cristianesimo e ciò<br />
contribuì a p<strong>la</strong>care <strong>la</strong> loro aggressività.<br />
• G. F. Ellero, Storia dei Friu<strong>la</strong>ni, Udine, Arti Grafiche<br />
Friu<strong>la</strong>ne, 1987<br />
• G. C. Menis, Storia del Friuli: dalle origini al<strong>la</strong> caduta<br />
dello stato patriarcale (1420), Udine, Società Filologica<br />
Friu<strong>la</strong>na, 1969<br />
• C. C. Desinan, Escursioni fra i nomi di luogo del Friuli,<br />
Udine, Società Filologica Friu<strong>la</strong>na, 2002<br />
• C. C. Desinan, Problemi di toponomastica friu<strong>la</strong>na:<br />
contributo I, Udine, Società Filologica Friu<strong>la</strong>na, 1976<br />
• T. Maniacco, Storia del Friuli: <strong>Il</strong> <strong>la</strong>voro dei campi, <strong>la</strong><br />
tradizione e le radici del<strong>la</strong> cultura contadina, le rivolte,<br />
del dramma dell’emigrazione e <strong>la</strong> nascita dell’identità di<br />
una regione il cui flusso scorre dentro i fiumi del tempo,<br />
Roma, Newton Compton, 1985<br />
• G. G. Corbanese, <strong>Il</strong> Friuli, Trieste e l’Istria: dal<strong>la</strong><br />
Preistoria al<strong>la</strong> caduta del Patriarcato d’Aquileia: Grande<br />
At<strong>la</strong>nte Storico Cronologico comparato,<br />
Udine, Del Bianco Editore, 1983<br />
• M. G. Arcamone... [et altri], Magistra Barbaritas:<br />
i Barbari in Italia, Mi<strong>la</strong>no, Garzanti - Scheiwiller, 1990<br />
Per ricercare e approfondire<br />
• Su una fotocopia del<strong>la</strong> carta del Friuli individua<br />
e segna <strong>la</strong> Stradalta: tracciata una linea con un<br />
pennarello, avrai trovato <strong>la</strong> direzione delle invasioni<br />
ungare (per farlo unisci i centri nominati nel testo).<br />
• Evidenzia con un altro colore i paesi che sono stati<br />
ricostruiti dopo le incursioni ungare.<br />
• Prova a raccogliere informazioni sulle leggende o le<br />
fiabe che riguardano gli orchi.