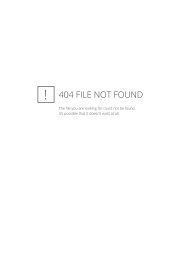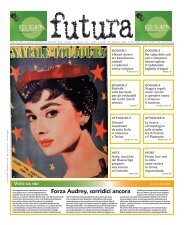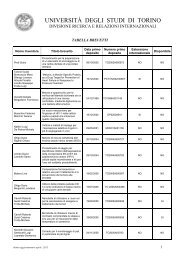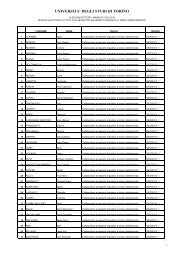LA ZONAZIONE DEL BAROLO - Università degli Studi di Torino
LA ZONAZIONE DEL BAROLO - Università degli Studi di Torino
LA ZONAZIONE DEL BAROLO - Università degli Studi di Torino
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong><br />
Moreno SOSTER, Andrea CELLINO<br />
Regione Piemonte, Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, Corso Stati Uniti, 21, 10128 <strong>Torino</strong>, I.<br />
Parole chiave: zonazione, vite, Nebbiolo, Barolo, vino.<br />
Key words: zoning, grapevine, Nebbiolo, Barolo, wine.<br />
1. OBBIETTIVO<br />
La Regione Piemonte, recependo le in<strong>di</strong>cazioni contenute nel Piano vitivinicolo<br />
nazionale <strong>di</strong> avviare una riqualificazione enologica in funzione della tipologia produttiva<br />
delle aree a più elevata vocazionalità, ha realizzato un progetto pluriennale (1994-2000)<br />
<strong>di</strong> caratterizzazione delle produzioni vitivinicole dell’area del Barolo in collaborazione con<br />
Istituzioni scientifiche ed Enti vitivinicoli operanti sul territorio piemontese. Avviando<br />
questo progetto la Regione Piemonte si proponeva <strong>di</strong> mettere a punto una metodologia<br />
conoscitiva <strong>di</strong> un’importante area vitivinicola che consentisse <strong>di</strong> avvicinarsi a eventuali<br />
iniziative <strong>di</strong> zonazione, o meglio <strong>di</strong> sottozonazione, su precise basi tecnico-scientifiche.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o effettuato in Piemonte, infatti, intendeva in<strong>di</strong>viduare, attraverso un’analisi<br />
pedologica, climatica, viticola ed enologica, gli elementi in grado <strong>di</strong> caratterizzare,<br />
cioè <strong>di</strong>stinguere, le produzioni vitivinicole atte alla produzione <strong>di</strong> Barolo nelle <strong>di</strong>fferenti<br />
zone facenti parte dell’area delimitata per tale DOCG (denominazione d’origine<br />
controllata e garantita). Va qui sottolineata con forza la finalità essenzialmente<br />
conoscitiva, <strong>di</strong>scriminatoria e non classificatoria, del progetto. L’obbiettivo primario era ed é<br />
quello <strong>di</strong> aumentare la conoscenza per metterla a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> chiunque la possa utilizzare<br />
al meglio per razionalizzare, sviluppare e valorizzare le produzioni della nostra regione.<br />
2. METODO DI <strong>LA</strong>VORO<br />
L’area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è coincisa con quella <strong>di</strong> produzione del vino Barolo DOCG. Si é<br />
costituito un gruppo <strong>di</strong> lavoro inter<strong>di</strong>sciplinare, dove ogni competenza scientifica e<br />
tecnica ha operato secondo una metodologia comune e con obbiettivi con<strong>di</strong>visi,<br />
contribuendo ad una corretta “lettura” del territorio e delle sue produzioni. Il gruppo<br />
<strong>di</strong> lavoro, coor<strong>di</strong>nato dalla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - ha visto la<br />
partecipazione <strong>di</strong>: <strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Torino</strong>, C.N.R., Istituti Sperimentali del<br />
Ministero Politiche Agricole e Forestali (Viticoltura ed Enologia) ora confluiti nel<br />
C.R.A., I.P.L.A., Associazioni Produttori Asprovit e Viticoltori Piemonte ora confluite<br />
nell’Associazione Vignaioli Piemontesi, Consorzio Tutela Barolo.<br />
QUAD. VITIC. ENOL. UNIV. TORINO, 28, 2005-2006
236<br />
Per definire 15 sottozone sperimentali, denominate Bricco Boschis, Brunate,<br />
Bussia, Cannubi, Cerequio, Fiasc, Gabutti, Gattera, La Rosa, Monvigliero,<br />
Pianpolvere, Pra <strong>di</strong> Po’, Ravera, Roncaglie, Vigna Rionda, si è partiti da tre tipi <strong>di</strong><br />
informazioni <strong>di</strong>sponibili: la cartografia pedologica, la <strong>di</strong>stribuzione geografica del vitigno<br />
‘Nebbiolo’, gli stu<strong>di</strong> esistenti e le conoscenze <strong>di</strong> operatori privilegiati sulla collocazione<br />
delle sottozone storiche.<br />
Un campione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong>mensionato in 30 vigneti omogenei, <strong>di</strong> cui 15 vendemmiati<br />
per realizzare le vinificazioni sperimentali, è stato reputato rappresentativo dell'intera<br />
area e al tempo stesso non così ampio da compromettere l’operatività del progetto.<br />
3. ATTIVITÀ SVOLTA<br />
3.1. Indagine pedologica<br />
M. SOSTER, A. CELLINO<br />
A partire dall’anno 1992-93 l’I.P.L.A. <strong>di</strong> <strong>Torino</strong> aveva eseguito uno stu<strong>di</strong>o e una<br />
cartografia pedologica (scala 1:25.000) sull’area del Barolo, dove ha in<strong>di</strong>viduato nove<br />
Unità <strong>di</strong> terre sulla base <strong>di</strong>: uso del suolo, geomorfologia e litologia, fotointepretazione,<br />
analisi chimica e fisica del terreno. Gli approfon<strong>di</strong>menti pedologici sono stati effettuati<br />
all’interno delle Unità più estese e rappresentative dell’area, denominate Castiglione<br />
Falletto, Serralunga, Barolo, La Morra, Novello (tab. 1) dove l’elemento saliente <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stinzione è la tessitura.<br />
Oltre alla Carta delle unità <strong>di</strong> terre (fig. 1) il lavoro pedologico ha portato alla<br />
definizione <strong>di</strong> carte tematiche su: esposizioni, pendenze, assolazione.<br />
Tab. 1– In<strong>di</strong>ci granulometrici - rapporto sabbia/(limo+argilla)- delle Unità <strong>di</strong> terre nell’area<br />
viticola <strong>di</strong> produzione del Barolo<br />
FINESTRE PEDOLOGICHE<br />
<strong>DEL</strong>LE UNITÀ DI TERRE LITOLOGIA TOPSOIL SUBSOIL<br />
A Castiglione Falletto Arenarie <strong>di</strong> Diano d’Alba 0,84 1,02<br />
B Serralunga d'Alba Formazione <strong>di</strong> Lequio 0,41 0,37<br />
C Barolo Marne <strong>di</strong> S.Agata Fossili 0,29 0,21<br />
D La Morra Marne <strong>di</strong> S.Agata Fossili 0,22 0,18<br />
H Novello Marne <strong>di</strong> S.Agata Fossili e<br />
Formazione <strong>di</strong> Lequio 0,35 0,33<br />
Fonte: I.P.L.A. <strong>Torino</strong>
<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 237<br />
Fig. 1 – Carta delle Unità <strong>di</strong> Terre del Barolo.
238<br />
3.2. Indagine climatica<br />
Le colline che producono il Barolo presentano un clima molto rappresentativo del<br />
territorio a Sud del fiume Po tra la pianura e le zone ad altimetria superiore presso la<br />
catena appenninica.<br />
La me<strong>di</strong>a delle precipitazioni annue è <strong>di</strong> 821 mm, con un massimo <strong>di</strong> 1488 (nel 1959)<br />
e un minimo <strong>di</strong> 366 (nel 1989).<br />
Si deve segnalare una <strong>di</strong>minuzione della piovosità negli ultimi 20 anni con una<br />
me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 684 mm.<br />
Per il periodo aprile-settembre le precipitazioni ammontano a 420 mm, con<br />
<strong>di</strong>stribuzione su 64 giorni <strong>di</strong> pioggia (7 in maggio, 5 in agosto e in settembre). Con<br />
la spazializzazione del dato è possibile rilevare un gra<strong>di</strong>ente positivo <strong>di</strong> precipitazioni<br />
da nord (pianura) verso sud (collina).<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista termico la zona è favorevole alla coltura della vite: l’in<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> Huglin è pari a 2270. L’anno più caldo dell'ultimo ventennio è stato il 1982 con<br />
un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> 2599 mentre uno dei più fred<strong>di</strong> è stato il 1996 (terzo anno del progetto)<br />
con 2051.<br />
Anche per le temperature c'è un gra<strong>di</strong>ente – più caldo a nord-est e più freddo a sudovest<br />
– ma va considerata l'orografia del territorio (fig. 2). Infine, per il triennio 1994-96,<br />
si è registrata una progressiva <strong>di</strong>minuzione delle temperature massime e un aumento<br />
della piovosità nel periodo vegetativo del 1996. Il 1994 e il 1996 sono state annate con<br />
una piovosità superiore alla me<strong>di</strong>a, mentre nel 1995 si sono avute precipitazioni con<br />
gran<strong>di</strong>ne su 4 vigneti-stu<strong>di</strong>o.<br />
3.3. Indagine viticola ampelografica<br />
M. SOSTER, A. CELLINO<br />
Le elaborazioni dei dati relativi agli aspetti varietali hanno consentito <strong>di</strong> definire<br />
cinque <strong>di</strong>stinti raggruppamenti, che si possono riferire con buona approssimazione ai<br />
tipi Michet, Rosè, Lampia a foglia incisa e Lampia a foglia intera a cui va aggiunto un<br />
ulteriore gruppo composto da alcuni vigneti con popolazioni miste ma <strong>di</strong>stinte dei due<br />
tipi <strong>di</strong> Lampia.<br />
La sottovarietà Lampia, nei suoi due tipi singoli o in associazione, è risultata la più<br />
rappresentata (ben 28 vigneti su 30) della popolazione presente nell'area del Barolo<br />
(fig. 3).<br />
Va segnalato che non sono mai stati riscontrati vigneti composti in prevalenza<br />
<strong>di</strong> Rosè, mentre solo due vigneti sono risultati composti in modo omogeneo dalla<br />
sottovarietà Michet.<br />
I 30 vigneti scelti come riferimento per le <strong>di</strong>verse sottozone sono risultati in genere<br />
sufficientemente rappresentativi dei vigneti delle proprie sottozone, come ha evidenziato<br />
l’indagine condotta su 50 vigneti ad essi limitrofi.
<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 239<br />
Fig. 2 – Somme termiche annuali dell'area <strong>di</strong> produzione del Barolo (me<strong>di</strong>a 1992-97).
240<br />
3.4. Indagine viticola agronomico-produttiva<br />
M. SOSTER, A. CELLINO<br />
I rilievi svolti per tre anni nell’area del Barolo DOCG hanno messo in evidenza<br />
un’elevata variabilità <strong>di</strong> alcuni parametri, in particolare relativi alla fertilità, allo<br />
sviluppo vegetativo e alla produzione. Le 15 sottozone in cui è stata <strong>di</strong>visa l’area si<br />
sono <strong>di</strong>mostrate fortemente <strong>di</strong>fferenziate per la maggior parte dei parametri stu<strong>di</strong>ati.<br />
Queste <strong>di</strong>fferenze possono derivare da <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni pedoclimatiche caratteristiche<br />
delle sottozone e dalle <strong>di</strong>fferenze nel tipo e soprattutto nell’intensità <strong>degli</strong> interventi<br />
agronomici effettuati nel vigneto.<br />
Un esempio del primo caso sono le misure <strong>di</strong> superficie fogliare (<strong>LA</strong>) effettuate a giugno<br />
(fig. 4), quando <strong>di</strong> norma ancora non sono stati svolti interventi <strong>di</strong> contenimento della<br />
vegetazione. Esempi del secondo caso sono le misure <strong>di</strong> superficie fogliare svolte ad<br />
agosto, che <strong>di</strong>pendono in buona parte dalle operazioni <strong>di</strong> cimatura, e le misure della<br />
percentuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>radamento. I dati suggeriscono che le <strong>di</strong>verse sottozone abbiano sullo<br />
sviluppo della vite <strong>degli</strong> effetti importanti, cui si sovrappongono gli effetti dei trattamenti<br />
operati dai viticoltori.<br />
Fig. 3 – Distribuzione sottovarietale del ‘Nebbiolo’ nell'area <strong>di</strong> produzione del Barolo.
<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 241<br />
Fig. 4 – Variabilità dell’area fogliare totale nei vigneti-stu<strong>di</strong>o.
242<br />
M. SOSTER, A. CELLINO<br />
Tab. 2– Principali variabili compositive delle uve e dei mosti rilevate nello stu<strong>di</strong>o.<br />
Parametri me<strong>di</strong>a min max dev. standard<br />
Antociani totali<br />
(mg/kg uva malvina monogl.cl.) 624 438 909 118,4<br />
Flavonoi<strong>di</strong> totali<br />
(mg/kg uve (+) catechina) 2594 1057 4226 1062,6<br />
Delfinina (%) 5,18 3,57 8,55 0,9<br />
Cianina (%) 13,97 7,84 21,41 3,1<br />
Petunina (%) 4,85 3,06 8,22 0,8<br />
Peonina (%) 48,11 34,80 58,49 6,5<br />
Malvina (%) 21,48 12,56 30,27 4,9<br />
Zuccheri (g/L) 226 196 245 10,6<br />
Aci<strong>di</strong>tà totale (g/L ac.tartarico) 8,6 6,4 11,9 1,4<br />
Acido citrico (g/L) 0,19 0,06 0,34 0,1<br />
Acido tartarico (g/L) 6,66 4,95 8,10 0,7<br />
Acido malico (g/L) 3,56 1,99 5,45 1,0<br />
Fig. 5 – Profilo sensoriale standard del vino Barolo definito dalla me<strong>di</strong>a dei valori minimi,<br />
massimi e me<strong>di</strong> calcolati per ciascun descrittore sensoriale.
<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 243<br />
Fig. 6 – Risultati della cluster analysis applicata ai valori standar<strong>di</strong>zzati dell’analisi sensoriale.
244<br />
3.5. Indagine enologica e sensoriale<br />
I principali aspetti dei mosti sono stati espressi come me<strong>di</strong>e delle <strong>di</strong>fferenti sottozone<br />
sperimentali e delle <strong>di</strong>verse annate ed accompagnati dalle relative deviazioni standard<br />
(tab. 2).<br />
Me<strong>di</strong>ando i dati dell’analisi sensoriale dei vini sperimentali delle tre annate è stato<br />
ottenuto un profilo standard del vino Barolo (fig. 5).<br />
L'elaborazione statistica dei risultati ottenuti dall'analisi compositiva dei mosti e<br />
sensoriale dei vini ha consentito la creazione <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> prodotti omogenei (3 per i<br />
mosti e 2 per i vini), <strong>di</strong>mostrando l'esistenza <strong>di</strong> una variabilità all'interno della produzione<br />
enologica del Barolo (fig. 6).<br />
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE<br />
M. SOSTER, A. CELLINO<br />
Una prima considerazione va fatta innanzitutto sul metodo <strong>di</strong> lavoro adottato:<br />
l’approccio inter<strong>di</strong>sciplinare alla ricerca è stato infatti riproposto con successo in altri<br />
comparti oltre a quello vitivinicolo e la Regione Piemonte lo ritiene una risorsa da<br />
utilizzare nel futuro ogni qualvolta nel sistema agricolo la ricerca intenda fornire soluzioni<br />
a problemi complessi, coerenti con l’evoluzione delle capacità produttive aziendali e<br />
con le aspettative del mercato.<br />
Questo comporta un cambiamento ra<strong>di</strong>cale nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> fare ricerca e nelle risorse<br />
necessarie per realizzarla.<br />
L'obiettivo primario della ricerca è stato quello <strong>di</strong> caratterizzare il Barolo DOCG<br />
verificando l'esistenza <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>fferenze compositive e sensoriali riproducibili nel<br />
tempo ed ascrivibili alle aree <strong>di</strong> provenienza. Si è dato maggior peso alla capacità<br />
<strong>di</strong>scriminante del vino, inteso come risultato finale delle <strong>di</strong>verse variabili (ambientali,<br />
biologiche, umane) in gioco, anziché basarsi sugli effetti <strong>di</strong>stintivi generati da una<br />
variabile specifica (suoli, in<strong>di</strong>ci bioclimatici, parametri enologici, ecc.). Questa<br />
impostazione <strong>di</strong>fferenzia il progetto Barolo dalla maggior parte delle esperienze <strong>di</strong><br />
ricerca rivolte alla zonazione viticola.<br />
Le 15 zone stu<strong>di</strong>ate si presentano piuttosto omogenee nella loro attitu<strong>di</strong>ne a produrre<br />
il vino Barolo e, alla luce dei risultati ottenuti, appaiono più una sud<strong>di</strong>visione storicotra<strong>di</strong>zionale<br />
che una sud<strong>di</strong>visione produttiva. L’area relativamente ristretta, l’ambiente<br />
climatico poco <strong>di</strong>fferenziato, i caratteri pedologici dalle <strong>di</strong>fferenze poco pronunciate,<br />
l’unicità del vitigno e soprattutto una vinificazione condotta in modo rigorosamente<br />
confrontabile, consentono <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare al massimo due o tre “famiglie” o gruppi <strong>di</strong><br />
uve e vini.<br />
L'andamento climatico <strong>di</strong> ogni anno, cioé il fattore “annata”, ha un’importanza<br />
fondamentale nella realizzazione dei vini Barolo sia per gli aspetti termici, <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azione<br />
solare e <strong>di</strong> pluviometria, che con<strong>di</strong>zionano lo sviluppo della coltura, sia per le influenze
<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 245<br />
che esercita sulla tecnica colturale. L'effetto annata rende poco apprezzabili le <strong>di</strong>fferenze<br />
ascrivibili ai siti sperimentali sulla base delle altre variabili in gioco. Da un anno all’altro il<br />
vino prodotto da una sottozona sperimentale ha mutato le proprie caratteristiche analitiche<br />
e sensoriali in maniera tale da fargli cambiare in molti casi la “famiglia” <strong>di</strong> appartenenza.<br />
Pertanto il numero troppo limitato <strong>di</strong> anni, tre, durante i quali si è svolta l’osservazione<br />
e la spiccata <strong>di</strong>fferenza fra le annate sconsigliano <strong>di</strong> trarre conclusioni definitive sul<br />
peso effettivo del fattore “annata”, evidenziato dall’interpretazione statistica.<br />
La spazializzazione del dato termico è stata condotta con strumenti <strong>di</strong> modellistica<br />
ormai datati – la geostatistica negli anni imme<strong>di</strong>atamente successivi allo stu<strong>di</strong>o ha<br />
compiuto progressi notevoli – e con pochi “punti” sul territorio per i quali si <strong>di</strong>spone <strong>di</strong><br />
serie storiche ampie e affidabili, essendo la maggior parte delle stazioni <strong>di</strong> rilevamento<br />
agrometeorologiche ancora abbastanza giovani.<br />
Il fattore pianta non è risultato avere effetti sensibili sulla variabilità delle uve e dei<br />
vini. La variabilità biologica, dovuta alla composizione sottovarietale del ‘Nebbiolo’<br />
ed alla <strong>di</strong>versità dei portinnesti utilizzati, è infatti tendenzialmente compensata dalle<br />
<strong>di</strong>fferenti pratiche colturali adottate in ciascun vigneto sperimentale.<br />
Anche i suoli, che presentano granulometrie piuttosto <strong>di</strong>fferenti e sono posti su<br />
esposizioni non omogenee, sembrano non avere una spiccata influenza su mosti e vini.<br />
In sostanza, nello stu<strong>di</strong>o in oggetto i vini prodotti dal medesimo vigneto sperimentale<br />
si collocano in gruppi <strong>di</strong>versi a seconda dell’annata. Tuttavia, si nota una <strong>di</strong>screta<br />
correlazione tra le caratteristiche tessiturali dei suoli dei vigneti stu<strong>di</strong>o e i gruppi<br />
in<strong>di</strong>viduati dalla cluster analysis dei dati sensoriali relativi ad una singola annata e<br />
quelli standar<strong>di</strong>zzati per i tre anni. Esiste quin<strong>di</strong> un effetto “suolo” su uve e vini, ma<br />
esso viene attenuato dagli altri fattori in gioco al punto tale da non risultare significativo<br />
in una elaborazione complessiva che cerchi <strong>di</strong> percepire la variabilità dell’areale sulla<br />
base della risposta <strong>di</strong>scriminante <strong>di</strong> mosti e vini.<br />
Si è giunti ad ipotizzare che le variabili ambientali (terreno, clima) e biologiche<br />
(pianta) abbiano un ruolo limitato rispetto alle variabili più strettamente legate alle scelte<br />
dell’uomo (gestione vigneto, vinificazione) nello spiegare la variabilità del vino Barolo.<br />
Semplicemente l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> una zona non può prescindere dal considerare il<br />
forte peso dell’interazione ambiente-uomo, ma questo pone sicuramente dei limiti ad<br />
un uso delle informazioni sin qui raccolte ed elaborate per un eventuale successivo uso<br />
ai fini <strong>di</strong> una zonazione. Da un lato non pare opportuno in<strong>di</strong>viduare delle zone sulla<br />
base <strong>di</strong> scelte umane che mutano nel tempo, dall’altro si hanno a <strong>di</strong>sposizione dei fattori<br />
più stabili quali il suolo e più omogenei quali il clima, che risultano avere un ruolo<br />
limitato nella caratterizzazione zonale del prodotto finale.<br />
È così più comprensibile la relativa omogeneità del vino Barolo sperimentale<br />
prodotto dall’areale oggetto dello stu<strong>di</strong>o, ma al tempo stesso si giustifica la variabilità<br />
del prodotto commerciale le cui caratteristiche possono venire grandemente influenzate<br />
dagli interventi dell’uomo, in vigneto e in cantina, capaci <strong>di</strong> esaltare le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong><br />
comportamento dei <strong>di</strong>versi ambienti produttivi.
246<br />
ZONING OF <strong>BAROLO</strong> AREA<br />
Abstract<br />
An inter<strong>di</strong>sciplinary study for the characterization of Barolo zones has been carried out for<br />
three years, financed by the Piedmont Regional Government. Fifteen homogeneous zones have<br />
been selected. The main factor influencing the Barolo quality wines is the vintage, followed by<br />
the human choices.<br />
Bibliografia sommaria<br />
M. SOSTER, A. CELLINO<br />
AA.VV. – 2000 – Schede pedologiche, schede climatiche, schede enologiche e sensoriali e<br />
considerazioni conclusive. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione<br />
del territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte –<br />
Agricoltura, suppl. al n. 24, 101-192.<br />
Gerbi V., Zeppa G., Rolle L., Ubigli M., Alessandria F. – 2000 – Caratterizzazione delle<br />
produzioni vitivinicole del Barolo. Aspetti enologici e sensoriali. In: M. Soster, T. Trevisan<br />
(eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong><br />
produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 75-86.<br />
Gerbi V., Zeppa G., Rolle L., Boni I., Petrella F., Piazzi M., Spanna F., Schubert A.,<br />
Lovisolo C. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del Barolo. Analisi<br />
statistica e valutazione delle interazioni tra i <strong>di</strong>versi aspetti considerati. In: M. Soster, T.<br />
Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del territorio, delle uve e dei vini dell’area<br />
<strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 87-104.<br />
Mannini F., Argamante N. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del<br />
Barolo. Ruolo del vitigno e del portinnesto. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per<br />
la caratterizzazione del territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione<br />
Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 55-64.<br />
Salan<strong>di</strong>n R., Petrella F., Piazzi M., Sciaccaluga M., Gribaudo L., Navone P., Boni I.,<br />
Vincenzino E. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del Barolo. Aspetti<br />
pedologici. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del territorio, delle<br />
uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 15-34.<br />
Schubert A., Lovisolo C. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del<br />
Barolo. Fasi fenologiche, sviluppo vegetativo e produzione del ‘Nebbiolo’. In: M. Soster, T.<br />
Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del territorio, delle uve e dei vini dell’area<br />
<strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura, suppl. al n. 24, 65-74.<br />
Soster M., Cellino A. – 2000 – Il progetto <strong>di</strong> caratterizzazione delle produzioni vitivinicole<br />
dell’area del Barolo. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del<br />
territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura,<br />
suppl. al n. 24, 9-13.
<strong>LA</strong> <strong>ZONAZIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>BAROLO</strong> 247<br />
Spanna F., Lovisetto M. – 2000 – Caratterizzazione delle produzioni vitivinicole del Barolo.<br />
Aspetti climatici. In: M. Soster, T. Trevisan (eds) Barolo. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o per la caratterizzazione del<br />
territorio, delle uve e dei vini dell’area <strong>di</strong> produzione. Quad. Regione Piemonte – Agricoltura,<br />
suppl. al n. 24, 35-54.